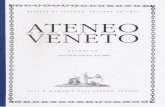Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014...
Transcript of Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014...
Deputazione di storia patria per le Venezie Calle del Tintor - S. Croce 1583 - 30135 Venezia
Deputazione Di storia patria per le Venezie
STUDIa cura di
alfreDo Buonopane - pietro Del negro - giuseppe gullino - gherarDo ortalli
7
anna CaroCCi
“Non si odono altri canti”leonarDo giustinian nellaVenezia Del QuattroCento
Con l’edizione delle canzonette secondo il ms. Marciano It. IX 486
VIELLA 2014
© 2014 – Deputazione di storia patria per le Venezie & Viella S.r.l.Tutti i diritti riservatiPrima edizione: novembre 2014ISBN 978-88-6728-321-7
Iniziativa regionale realizzata in attuazione della L. R. 5.9.1984, n. 51 - art. 11.
viellalibreria editricevia delle Alpi 32I-00198 ROMAtel. 06 84 17 75 8fax 06 85 35 39 60www.viella.it
Introduzione .................................................................................................. 7
I. Il politico e il poeta
1. Biografia di un patrizio umanista1. Leonardo dei Giustinian ................................................................................. 152. Gli studi del tempo libero .............................................................................. 25
2. La poesia di Leonardo Giustinian1. Un poeta popolare? ......................................................................................... 452. La produzione in volgare: canzonette, strambotti e laudi ......................... 61
3. Poesia come performance1. Poesia per musica nel Quattrocento: pionierismo di Giustinian .............. 732. Questioni e problemi intorno alla poesia per musica ................................ 793. Tra oralità e scrittura ....................................................................................... 88
4. La fortuna di Giustinian1. Una parabola .................................................................................................... 952. Le canzonette: Giustinian nei manoscritti ................................................... 963. Le canzonette: Giustinian a stampa .............................................................. 994. Ostacoli per un’edizione critica ..................................................................... 1015. Il quadro dei testimoni .................................................................................... 106
II. Una silloge di giustiniane
1. Giustinian secondo il ms. Marciano Italiano IX 4861. Motivazioni della scelta .................................................................................. 1132. Poesie presenti e poesie assenti .................................................................... 117
Indice
2. L’edizione del Marciano1. Descrizione dei testimoni .............................................................................. 1232. Criteri dell’edizione ......................................................................................... 125Le canzonette ........................................................................................................... 131
Bibliografia ..................................................................................................... 263
Indice dei nomi ............................................................................................. 273
Introduzione
È un poeta che parla d’amore, e ne parla nel modo e nel linguaggio più sem-plici. Quello che mette in scena è un amore che travalica i tempi, i luoghi e i dettagli della singola storia: una situazione che si può applicare a chiunque.
Leonardo Giustinian – politico, nobile, erudito, uno dei dotti del suo tempo, allie-vo di Guarino Veronese – sembrerebbe una figura estremamente rappresentativa della Repubblica di Venezia nel primo Quattrocento. È, invece, del tutto anomala. Perché questo nobile e colto politico compone e canta poesia per musica in volgare.
Le sue poesie non rispecchiano gli stilemi metrici, stilistici e contenutistici della lirica amorosa tradizionale, petrarchesca e poi bembesca: al contrario, sono componimenti – per le forme metriche che seguono come per il linguaggio – po-polareggianti. Fin troppo semplici, secondo la critica successiva. Ma, per circa un secolo, il successo che le accompagna è enorme: ce li tramandano ben oltre cento manoscritti e decine di antiche stampe. E tra i manoscritti troviamo oggetti di qua-lità bassissima e altri di pregio, decorati, miniati: perché Giustinian ha un successo di popolo, ma anche presso un pubblico colto e aristocratico. Due manoscritti con le sue poesie, ad esempio, fanno parte della biblioteca visconteo-sforzesca; un ambasciatore si adopera per avere copia delle canzonette; e intanto il popolo di Venezia le canta: alle feste, ai ricevimenti privati, per strada, fino ad arrivare al canto dei gondolieri.
Tutte queste poesie – perfino le laudi religiose – trattano d’amore. E quello di cui ci parlano è un amore vivo, concreto, basato su un desiderio di possesso che è tanto spirituale quanto fisico: un amore fatto di bellezza, sensualità, malizia, corteggiamento, ritrosia e naturalmente anche di rifiuto e dolore. Il tutto sullo sfondo di Venezia, appena accennata ma ben riconoscibile attraverso pochi tratti, lo scorcio di un canale, una calle in cui risuona, a notte fonda, un suono di passi, un ponte, una barca.
Questo sfondo appena abbozzato prende vita grazie agli esseri umani: una donna alla finestra che ascolta l’innamorato nel gelo della sera, i vicini che si prepara-no ad uscire al mattino presto, e potrebbero sentire i discorsi degli amanti, la madre che va a controllare che la figlia sia in camera, la domestica che offre il suo aiuto.
“Non si odono altri canti”8
Venezia è anche, naturalmente, la patria di Giustinian, il luogo in cui passa tutta la sua vita e nel quale le sue poesie nascono e si diffondono. All’inizio, anzi, è lui stesso a diffonderle, dal momento che si tratta di testi nati non per la lettura, ma per l’esecuzione, per la musica: ed è lo stesso Leonardo a comporre ed eseguire questa musica, cantando le sue canzonette e i suoi strambotti per Venezia, con l’accompa-gnamento di uno strumento a corda.
Sembrerebbe l’immagine di un menestrello, un giullare o un poeta per musica sul tipo di Serafino Aquilano. Invece Giustinian è un patrizio, membro di una famiglia tra le più antiche e prestigiose di Venezia: poesia e musica, per lui, non sono un mestiere, ma soltanto uno svago, un’occupazione da tempo libero. Come molti altri membri della sua famiglia si dedica ad una brillantissima carriera politica (che lo porta fino alla carica di procuratore di San Marco, immediatamente sotto il dogato) e a proficue attività commerciali. Oltre a questo, è tra i primi, nella classe dirigente veneta, a com-prendere l’importanza – anche per fini politici – di un’educazione umanistica: di qui gli studi con Giovanni Conversini, Gasparino Barzizza e Guarino Veronese, l’amore per le lettere classiche che lo accompagna per tutta la vita, e lo porta a stabilire e mantenere un costante, stretto legame con gli umanisti del primo Quattrocento, veneti e non; di qui il fatto di essere tra i primi a Venezia a dedicarsi allo studio del greco, e di possedere una delle biblioteche più fornite del suo tempo. Una figura del genere che si dedica alla composizione di poesia popolareggiante è davvero un’anomalia.
Soprattutto se consideriamo che Giustinian è, in ordine di tempo, il primo tra i poeti colti a dedicarsi alla poesia popolareggiante (solo nella seconda metà del seco-lo verrà il turno di poeti come Lorenzo de’ Medici, Luigi Pulci, Angelo Poliziano). La sua non è però una piatta ripresa di temi e metri della poesia popolare: nei suoi componimenti ci imbattiamo spesso anche in echi e reminescenze letterarie, che si intrecciano e saldano con gli elementi popolareggianti, formando un tutt’uno orga-nico. Questa compresenza di elementi ‘alti’ e di elementi ‘popolari’ ha fatto sì che la critica guardasse tradizionalmente a Giustinian come a un poeta che, lavorando per intarsio, integrasse volutamente all’interno del sostrato popolare tessere elevate, auliche. Come si vedrà nei capitoli successivi, è probabile che si tratti di un’interpre-tazione – almeno nella sua forma più estrema – piuttosto forzata: tutti gli elementi in nostro possesso indicano che la considerazione in cui Giustinian teneva i suoi stessi componimenti era bassa (cosa che contrasta nettamente con la teoria del labor limae o dell’intarsio), né c’è alcuna prova che sostenga la teoria del canzoniere d’autore; mentre la presenza di elementi alti, letterari, accanto alle caratteristiche popolareg-gianti dei testi, si può tranquillamente attribuire alla grande cultura del poeta. La teoria di Giustinian come conscio autore di un’operazione finalizzata ad elevare la poesia popolare pare piuttosto il risultato di una visione critica teleologica, che tende a vedere nel Quattrocento i semi, non ancora evolutisi ma già presenti, di quella che sarà la lirica cinquecentesca. Si tende insomma ad attribuire a Giustinian un tale livel-lo di programmaticità e di attenzione ai dettagli perché a tali aspetti ci hanno abituato
Introduzione 9
molti autori del secolo successivo. Tuttavia, un ritratto del genere non corrisponde alla sua figura: Giustinian è figlio di quell’ambiente estremamente variegato, ricco di correnti diverse e a volte contrapposte, che è la poesia del XV secolo, e tanto i suoi componimenti quanto il suo atteggiamento verso l’attività poetica lo dimostrano.
La produzione di Giustinian comprende strambotti, canzonette e laudi religiose. I tre generi sono caratterizzati da elementi di continuità fortissimi: l’esecuzione mu-sicale (forse addirittura l’utilizzo, per poesie con equivalente struttura metrica, della stessa musica), le forme metriche, lo stile, la lingua. Ad accumunarli è anche il suc-cesso: un successo che per circa un secolo è davvero travolgente, tale da oltrepassare largamente i confini della Repubblica di Venezia e da far sì che nemmeno Pietro Bem-bo, settant’anni più tardi, possa fare a meno di ricordarlo nelle sue Prose1. Il numero di manoscritti e poi di testi a stampa che ci tramandano le poesie giustinianee è altissimo. Paradossalmente, però, tanto successo è stato la causa della sfortuna di Giustinian: il quadro dei testimoni, numericamente così elevato, è il più delle volte qualitativamente scarso e ricco di contaminazioni; moltissime sono le difficoltà per ricostruire i rap-porti tra i testimoni e di conseguenza per identificare un corpus sicuro di testi autentici. Come risultato, non esistono edizioni critiche di nessuno dei tre generi cui si è dedica-to Giustinian, e anche le edizioni divulgative sono estremamente rare.
Particolarmente infelice è la situazione delle canzonette: nonostante dagli inizi del Novecento si siano susseguiti numerosi studi preliminari a un’edizione critica, gli enormi problemi con cui ci si è scontrati hanno fatto sì che tale edizione non vedesse mai la luce2. A tutt’oggi sussistono perfino ipotesi antitetiche riguardo alle modalità di composizione delle canzonette: una teoria ha spiegato la profonda divergenza tra testimoni come la traccia di una doppia redazione; un’altra, all’opposto, ha messo in dubbio l’esistenza stessa di un canzoniere d’autore. L’interrogativo è quindi se Giusti-nian abbia mai voluto raccogliere le sue poesie in un manoscritto o se invece le canzo-nette non siano state diffuse alla spicciolata, man mano che venivano composte3.
Davvero emblematico, in questo quadro, il commento di Enzo Quaglio, che parla di “dolorosa storia del successo arriso nella tradizione manoscritta alle canzo-nette di Giustinian”4. Non solo dolorosa, ma anche paradossale: dato che, dopo tan-to successo, le canzonette oggi non sono fruibili in nessuna edizione, critica e non. Per leggerle bisogna andare a cercarle nei brani antologizzati, o negli studi filologici, o in vecchissime e scorrette pubblicazioni5.
1. Bembo, Prose della volgar lingua, Gli Asolani, Rime, p. 112. 2. Si tratta dei contributi di Aldo Oberdorfer, Giuseppe Billanovich, Laura Pini ed Enzo Quaglio,
per i quali si rimanda ai capitoli successivi, in particolare a La fortuna di Giustinian.3. Le due teorie sono state formulate rispettivamente da Giuseppe Billanovich e Laura Pini.4. Quaglio, Da Benedetto Biffoli a Leonardo Giustinian, p. 164.5. È il caso dell’unica vera edizione esistente delle canzonette giustinianee, dove le poesie sono
pubblicate in una forma semidiplomatica che rende quanto mai difficile la lettura: Wiese, Poesie edite ed inedite di Lionardo Giustiniani.
“Non si odono altri canti”10
Ed è davvero un peccato. Perché Giustinian è un personaggio quanto mai inte-ressante, rappresentante esemplare di tutta una serie di tematiche di ampio respiro: rap-porti tra ‘poesia alta’ e ‘poesia bassa’, rapporti tra parola e musica, e ancora, rapporti tra Umanesimo e poesia volgare, tra Umanesimo veneziano e fiorentino, tra studi letterari e politica. E, soprattutto, è un autore ricco di un fascino tutto particolare:
Contini ha parlato per la poesia giustinianea di ‘impronta popolareggiante’: si coniughi la formula con l’intrinseca predisposizione scenica […] e con la categoria calviniana della ‘leggerezza’ e si otterrà la chiave del fascino che ancora oggi ci trattiene davanti alle opere di questo aristocratico e così affabile veneziano di più di cinque secoli fa6.
Un aggettivo qui attira particolarmente l’attenzione: affabile. È un ottimo ele-mento descrittivo tanto per la persona di Giustinian – lui, patrizio, ricco e potente, sempre pronto a venire in aiuto agli amici e sempre discreto, affettuoso e perfino umile nei toni delle sue lettere – quanto per la sua poesia. I suoi componimenti infatti si collocano sempre su un livello di mediana leggerezza, coinvolgono senza commuovere e divertono senza arrivare alla risata aperta. Non sprofondano mai nel pathos, né in quello dell’assoluta sublimazione quando l’amore è appagato né in quello della reale e sentita disperazione quando si tratta di lamenti d’amore. La po-esia giustinianea oscilla anche tra elementi reali e trasfigurazione poetica: non arriva mai alla volgarità, men che mai al grottesco; tuttavia ha tocchi di grande realismo, con particolari che la fanno guizzare di vita anche davanti ai nostri occhi di lettori moderni.
Le poche righe appena citate, di cui è autore Claudio Vela, hanno una tale capa-cità insieme riassuntiva ed evocativa che non ne sciuperò l’effetto riprendendo punto per punto gli elementi cui fanno cenno. Con l’eccezione di uno, di grande importan-za: la ‘predisposizione scenica’ delle poesie di Giustinian, e delle canzonette in primo luogo. È essenziale ricordare che siamo davanti a testi nati con la musica e destinati alla performance. Tale performance comprende ovviamente la musica, ma va anche oltre: riguarda le caratteristiche stesse delle canzonette, che contengono parti dialogate, presenza di più personaggi, addirittura didascalie. Elementi di teatro all’interno delle poesie. E, come ogni forma di performance, questi testi esigevano un pubblico: per le poesie profane, feste private con nobili e popolani (e poi il popolo le faceva pro-prie…); per le laudi, cerimonie religiose.
Da tutti questi elementi si capisce quanto peso avesse il momento dell’esecu-zione, il momento in cui questi testi venivano ‘messi in scena’ davanti a un pubblico. La musica, ma anche l’intonazione, le pause, il mimo: componenti perdute, ma la cui esistenza è fondamentale tener presente al momento della lettura.
A Leonardo Giustinian gli studi hanno sempre guardato con un interesse dop-pio: da una parte, per la sua figura, crocevia di così tanti nodi problematici fonda-
6. Vela, Poesia per musica, p. 404.
Introduzione 11
mentali per il primo Quattrocento; dall’altra, per la questione filologica che pongono i suoi testi, in primo luogo le canzonette, e che a tutt’oggi si può dire irrisolta. Siamo davanti a uno di quei casi in cui più importante che mai risulta l’alleanza tra la filo-logia e la letteratura: la filologia per entrare nel testo, la letteratura per supportare il testo stesso.
Seguendo questo criterio ho diviso il lavoro in due parti. La prima cerca di esaminare Giustinian da più prospettive: come patrizio, politico, umanista e poeta, ma anche all’interno del panorama storico e culturale in cui si muove e delle proble-matiche su cui permette di interrogarsi. La seconda parte è l’edizione di uno dei più importanti testimoni delle canzonette: il manoscritto Marciano Italiano IX 486, terza silloge per numero di testi delle giustiniane, contenente trentanove poesie. Come tutti i testimoni giustinianei presenta difetti e problemi a volte non risolvibili; tuttavia le sue caratteristiche intrinseche, unite con l’esistenza di un testimone collaterale a supportarne e integrarne la lezione, lo rendono senz’altro un candidato ideale per un’edizione – parziale ma già estremamente rappresentativa – delle canzonette di Giustinian.
Vorrei concludere con un dettaglio. Il Marciano Italiano IX 486, qui edito, è un oggetto di alta qualità, piccolo ed elegante, curato nella scrittura e nella mise en page, con le iniziali di ciascuna poesia decorate. Su uno dei fogli di guardia finali – i fogli bianchi posti all’inizio e alla fine del manoscritto per proteggerlo – una mano diversa da quella del copista ha scarabocchiato un verso di Giustinian; accanto, troviamo i classici disegni di cuori trafitti da una freccia, e il nome di una donna. Dunque uno degli antichi proprietari del manoscritto, probabilmente nel secolo che è seguito alla morte di Giustinian, ha letto quei versi semplici e fragili e se n’è sentito coinvolto, al punto da sovrapporli alla propria storia.
Non è infrequente trovare nei manoscritti testimonianze analoghe di antichi lettori. Ma l’immagine è così efficace nella sua semplicità, e così netto il contrasto tra l’elevata qualità del manoscritto e la povertà di questi disegni, che mi sembra un buon simbolo dell’effetto che ha avuto la poesia giustinianea: sul pubblico colto come su quello più umile.
***
Desidero ringraziare Pasquale Stoppelli e Gabriele Pedullà, fondamentali per ogni passo di questo lavoro.
![Page 1: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Non si odono altri canti. Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento, Roma, Viella, 2014 [Introduzione]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022515/6321b8cd807dc363600a1b39/html5/thumbnails/12.jpg)