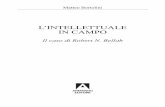Morfi “zeromorfi" in Pāṇini: un’introduzione alle regole specifiche di formazione con zero...
Transcript of Morfi “zeromorfi" in Pāṇini: un’introduzione alle regole specifiche di formazione con zero...
'" '" V\ ""
I-<
Ile ....l
l' V
'I o
... p...
~
:>lt ,-~
~.
'lr ;:::
"'1 ~~
Z
"" V
) ""I
I-<
'" )h
(:) ..... V
\
I-<
'?( =
~
1 8 .,
C'.
TIZIANA PONTILLO
"ZEROMORFI" IN P ÀNINI: REGOLE SPECIFICHE DI FORMAZIONE CON ZERO FONOLOGICO NELLA POSIZIONE DI DATI MORFEMI
0. La questione linguistica in cui si iscrive 1'oggetto della presente nota prende avvio dalla rilevazione di casi in cui precise funzioni morfologiche sono associate a significanti fonologicamente pari a zero. Tradizionalmente vengono portate ad esempio omofonie totali come in ingL tra il sg. sheep "pecora" e il pL sheep o tra il presente cut (cut "tagliare") e il preterito cut (BLOOMFIELD 1933, § 13.7 pp. 215-8), tra il sostantivo cheat "imbroglione" e il verbo cheat "imbrogliare" (KASTOVSKY 1969, p. 8), oppure l'assenza di marca flessionale in formazioni di caso come il voc. gr. Òo.rroQ < Òon;oQ-, nom. sg. ò6rrwQ (MEILLET 1903, p. 116), la formazione dei nomi radicali come gr. cpMy- + -ç > cpMl; (SAUSSURE 1879, p. 146), l'apparente caso di morfologia sottrattiva del gen. pL ceco SlOVI « slovo- / sloves-), nom. sg. slovo2 (che CLG, pp. 123 s. presenta come gen. pl. che ha "pour exposant zéro"3). Nell'ambito di tale tema, che sinteticamente è stato definito come "il problema zero in linguistica"4, si propone un confronto con 1'analisi degli stessi fenomeni che si ricava dalla grammatica di PaDini [= P]. In questa infatti si impiega quello che i linguisti di questo secolos hanno
1 Ceco slov < ps!. slovìi ( in luogo della forma piu lunga che ci si attenderebbe come esito regolare dal gen pl ie. *k'loy-es-om > protos!. *slay-es-am > ps!. slov-es-ìi). CLG, pp. 123 s. in effetti cita per confronto un errato nom. p!. slava: vedi DE MAURO 1972, n. 181.
o Ceco slavo < ps!. slavo < protosl *slay-as- < ie. *k'loy-os-: cfr. ANDERSEN 1994, pp. 461 s.
3Da CLG, pp. 123 s. si ricava immediatamente la distanza tra l'analisi sincronica e diacronica del medesimo esempio: "On voit donc qu'un signe matériel n'est pas néces-saire pour exprimer une idée; la langue peut se contenter de l'opposition de quelque chose avec rien; ici, par exemple, on reconnait le gén. p!. ien simplement à ce qu'il n'est ni iena ni ienIl, ni aucune des autres formes. Il semble étrange à première vue qu'une idée aussi particulière que celle du génitif pluriel ait pris le signe zéro; mais c'est justement la preuve que tout vient d'un pur accident. La langue est un mécanisme qui continue à fonctionner malgré les détériorations qu' on lui fait subir". Per altri casi apparenti di morfologia sottrattiva da spiegare invece come "accidenti storici" vedi DREssLER 1984.
4 Vedi MEIER 1961.
sVedi ad es. l'espressione "zero element" di BLOOMFIELD 1933, § 13.2 p. 209 (per il
130 Tiziana Pontillo
comunemente tradotto con "zero" in più di duecento regole e si procede a classificare con il medesimo termine comune lopa- diverse categorie, per le quali si provvede a una distinzione terminologica fondata sulla rilevazione delle peculiarità di ciascuna. Il modello di "zero linguistico" che ne risulta se può essere accostato a quello proposto da alcuni studi linguistici del Novecento, se ne distacca per un maggior grado di complessità, per l'estesa applicazione del concetto e allo stesso tempo per l'analitica descrizione dei diversi fenomeni linguistici per i quali si ricorre ad esso.
1. La prima regola di P relativa allo "zero fonologico" La regola di P che introduce lopa- è il sìltra- 1.1.60 "adarsanarrz <iti
i'ideso> lopaf:z"6. Con esso si assegna il termine tecnico lopa- alla "regola specifica" (adesa- = 1.1.56) che introduce al posto di un dato segmento linguistico la sua "non percezione" (adarsana-), intesa come "zero fonologico". Come accade per i termini tecnici della grammatica di P, anche lidesa- e lopa- indicano sia le regole sia il loro oggetto, ossia si riferiscono anche ai segmenti linguistici applicati a causa delle regole. In particolare lopa- indica, oltre la regola specifica detta, anche la realizzazione fonologica pari a zero che discende dall'applicazione della regola specifica7".
medesimo es. ingl. sheep sg. = sheep pl. per il quale è richiamato il metodo pa1:tiniano dello zero si usa l'espressione "zero-alternant" e "zero-feature" § 13.7 pp. 215-8), "zerosuffix" (relativamente ai "thèmes-racines") di COLLINDER 1962-8, p. 15, "linguistic zero" di AL-GEORGE 1967, p. 115, "zero" e "zero-morphemes" di STAAL 1969, p. 506, "concept de zéro" di Martinet 1969, p. 249, "signe zéro" di DE MAURO 1972, p. 380, "Zeroproblem" di SCHIFKO 1973, p. 1, "zero suffix" (relativamente ai nomi radicali) di ScHARFE 1977, p. 110, "'zero' notion" di PAP 1990, p. 30, "technique of zero" di P'"NDIT 1990, p. 19, "zero replacements" di CARDONA 1997 §79. ALLEN 1955 precisa invece la traduzione come "= 0": inteso infatti "=" come riferito alla corrispondenza tra il piano grammaticale e quello fonologico, Allen non ammette di introdurre" zero" come primo elemento ma solo come secondo elemento della "grmnmatical-phonological equation" "suffix = 0". La precisazione è ripresa da ROBINS 1997, p. 186 ("rappresentazione zero di un elemento o di una categoria") e da KASTOVSKY 1980, p. 215 ("the setting up of zero elements as surface representations of morphological categories"). FREI 1950, p. 188 n. 94, citando BLOOMFIELD 1933, RT e B, nega che lo zero sia stato introdotto da p e lo fa risalire a SAUSSURE 1879, ma segnala la traduzione ted. di lopa- come "Schwund".
6 Nell'ordine è però L1.41a prima regola~in assoluto che impiega il termine "Iopa-" per indicare una condizione che impedisce l'applicazione della regola precedente (L1.3).
7 D'altra parte è comune in p il procedimento secondo cui nella grammatica al posto di un composto si usa un sostantivo semplice corrispondente al determinante del composto: cfr. ad es. krt- per krdtinta- o taddhita- per taddhitlinta-.
"Zeromorfi" in palJini: regole specifiche di formazione ... 131
La documentazione relativa all'interpretazione terminologica di questa regola e delle regole che governano il procedimento di P detto comunemente della "sostituzione", che qui sono indicate come "regole specifiche", è esposta in PONTILLO 2001 a Cd.S., al quale si rimanda pure per alcune ipotesi di ricostruzione dei rapporti storici intercorsi tra P e i primi usi dello zero in morfologia attestati nella linguistica occidentale.
2. Tipologia delle regole di P relative allo "zero fonologico" Nei 212 siltra- operativi8 inerenti lopa- sono comprese regole speci
fiche di zero fonologico al posto di a. un fon09 (78 regole: in 52 casi si tratta di un fono finale, in 4 iniziale
e in 22 interno (il numero si riferisce alle regole e non alla proiezione sulle formazioni previste dalle regole e/o attestate nella lingua): - ad es. nel causativo della base knily- "essere umido" (knopayati) si ha lopa-
di y, non determinato morfologicamente dall'affisso -aya- di causativo, piuttosto (secondo VI.1.66) perché seguito da consonante diversa da y precisamente p (incremento assunto secondo VlI.3.36)1° ossia illopa- è determinato fonologicamente.
In 8 regole delle 78 si menziona il fono soggetto alla regola di lopaspecificatamente come parte di un morfema, precisamente di un dato suffisso:
- ad es. (secondo VII.3.72) si ha lopa- di a di -sa- di aor. sigmatico tema tic o prima di un suffisso che inizia per vocale: adhukpi (da duh-).
8 Nel numero non sono comprese né ovviamente le regole definitorie né le regole che indicano lopa- come condizione di applicazione di altre regole, nel complesso altre 33. Per l'analisi di tutti e 212 i siitra- e di K83 e M relativi a ciascuno di essi vedi T. PONnLLO, Allomorfi e morfema "Zeromorft" i11 Pill.1ini: sostituzione di morfemi con zero fonico, Tesi di Dottorato "Glottologia e Filologia" XII Ciclo - 1996-'99 - Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Milano, cap. III, pp. 159-384.
9 Non si usa il termine "fonema", perché le regole morfologiche di P non prevedono un piano astratto distinto da quello della realizzazione concreta per la fonologia, ma prendono in considerazione i foni, direttamente dalla lingua. Anche i termini gUI'Ja- e vrddhi- indicano realizzazioni concrete e rimandano a brevi liste di foni. Vedi sotto. I f~nemi sono enunciati su un piano astratto invece negli Siva-Siltra-, premessi alla grammatica di P. Cfr. in linea teorica e non paniniana BAZELL 1945-1949, p. 139; HOENlGSWALD 1946, p. 141.
10 La regola specifica di formazione con o nella posizione di u è invece determinata morfologicamente, dall'affisso seguente (di causativo).
132 Tiziana Pontillo
Alle 78 si aggiungono altre lO regole di "zero fonologico" applicato a una sequenza fonologica:
- ad es. (secondo VI.4.142) si ha lopd- di ti del tema debole vi7(Isati- "venti" prima di una serie determinata di affissi tra i quali -aka-: vin.zsati- "venti" + -aka> vi7(Is-aka- "fatto di venti parti" (lopa- di a di vin.zsa- per VI.4.143)
e altre 8 che prevedono lopa- della sillaba di raddoppiamento alla
quale non è attribuito un artha- "oggetto, significato" (cfr. p 1.2.45 s.): - ad es. (secondo VI.4.120) si ha lopa- della sillaba di raddoppiamento e si
applica e al posto di a tra singole consonanti in una base verbale il cui fono iniziale non sia sostituito prima dei sostituti di LIT (morfemi per le formazioni di perfetto) con anubandha- K e N: rm; - + LIT > ra-ralJ-atu5 > relJatu5 11•
b. un morfema grammaticale (115 regole)
ad es. (secondo VI.1.68) si ha lopa- delle terminazioni verbali per i tempi storici di II e III perso sg. -5 e -t: adhok (da duh- "mungere").
C. una "parola" (ai. pada-) (1 regolal2)
(secondo V.3.82) si ha lopa- di ajinam "pelle", secondo membro di un composto (che entra in composizione in stato tematico, ma la regola di P prevede lopa- di un pada-) e si applica il suffiso -ka-, per esprimere pietà nei confronti della persona che porta quel nome es. *vyaghrajina- > vyaghraka- "povero Pelle di tigre" (senza la regola V.3.82 vyaghraka- significherebbe "tigre piccola")13.
2.1. Una prima distinzione nelle regole morfologiche di P relative allo "zero fonologico"
Tra le regole di lopa- di morferni grammaticali sono distinti alcuni sottogruppi: le regole I.1.6l-63 separano
1) i casi in cui permane l'applicazione di regole sui foni della base
(definita in termini di confine morfemico come "ciò che finisce con
quel dato morfema"), che siano determinate dal morfema nella posi-
11 Lopa- è previsto anche per unità proprie solo del metalinguaggio, ossia per gli anubandlza- (contrassegni applicati ai morfemi nella grammatica di P) che subiscono lopasecondo P 1.3.9.
12 A questa vanno però aggiunte tre indicazioni indirette di lopa- di pada- indeclinabili (kim, ca, alw e l'intera lista elidi), che figurano come condizioni per l'applicazione di altre regole, rispettivamente in P VIII.1.45; 62 S.
13 Per l'interpretazione e l'analisi dell' evoluzione di tale tipo di lopa- di pada-, il cui uso è largamente esteso soprattutto per spiegare alcuni composti, nell'opera dei grammatici indiani successivi a P, vedi Deshpande 1985 e 1989, anche per l'opportuna distinzione tra casi di ellissi e casi di lopa-. Si tenga presente però che alcuni esempi ivi citati non sono veri casi di "sostituzione" con lopa- ma più semplici casi di "sostituzione".
"Zeromorfi" in PiilJini: regole specifiche di formazione ... 133
zione del quale è introdotto lo zero fonologico (P concepisce la sosti
tuzione di gUfJ.a- e v[ddlzi-14 corrispondenti alla vocale della base come
un effetto determinato dall'applicazione del suffisso seguente), quale
effetto determinato dallo stesso morfema,
2) da quelli in cui tale applicazione di regole sui foni della base non
permane. P propone così una quadruplice terminologia, che, recupe
rando il termine generico lopa-, lo pone in opposizione, solo in caso di
regola specifica di formazione con zero fonologico nella posizione di
dati morferni (e non altre unità), ad altri tre, rispettivamente: SLU, LUP e LUK. Le regole definitorie sono:
1.1.61 "pratyayasya l5 <adarsanalf/ iti a:desa:> luk-s1u-lupal:z", "Gli a:desaLUK, SLU e LUP denotano la non percezione al posto di un pratyaya- 'affisso"'.
1.1.6216 "pratyayalope pratyayalalepafJ.a", "prima di lopa- di affissol7 1e
14 Secondo P I.1.1 il termine tecnico v[ddlzi- denota la vocale ii e i dittonghi, ai, au; secondo P 1.1.2 gU1Ja- denota le tre vocali a, e, O. Nelle regole operative, secondo P 1.1.3, l'indicazione dei due rispettivi termini tecnici segnala il ruolo di "sostituti" delle vocali e dei dittonghi che esse denotano. Vedi MAGGI 1994 e bibliografia ivi citata.
15 Vt. 8 (M I, p. 160, r. 16) intende "pratyasya" introdotto per specificare che i termini tecnici usati si riferiscono ali' affisso intero, mentre M I, p. 160, rr. 17-9 dimostra che la precisazione è inutile, in quanto la limitazione si ricava dalla successione delle regole P VII.3.72 s., entrambe riferite al suffisso tematico di aor. sigmatico, ma comprendenti rispettivamente il termine tecnico lopa- e LUK. Vt. 9 (M 1, p. 160, r. 20) connette la menzione di Upratyasya" con il sutra- successivo (cfr. anche M I, p. 160, rr. 22 s., che pare approvare il Vt. 9, ma poi M I, p. 161, rr. 11 s. ammette la possibilità di omettere la menzione di upratyaya-" in P I.l.61 o s.). Cfr. anche K83, l, pp. 219-22, che dimostra operativamente con un es. (P 11.4.70) come la sola menzione di LUK faccia cadere la regola specifica sull'affisso e non su un altro morfema, per es. la base nominale, limitazione possibile proprio in virtù di P 1.1.61. Cfr. F III, pp. 205 ss. e SS III, pp. 175 5S. Senza la menzione di pratyaya- del siltra- si sarebbe inoltre esclusa la possibilità di applicarsi lopa- agli affissi, fatto smentito da ben 31 regole nel caso di interi affissi menzionati come tali, oltre agli 8 casi di lopa- di foni che sono parte di affissi.
16 È una regola di paribhiisii ossia U che insegna a interpretare o ad applicare propriamente altre regole": cfr. CARDONA 1997, § 103 p. 63.
17 Tale traduzione che tiene conto dell'uso metalinguistico delloc., previsto da P 1.1.66, si discosta da tutte le traduzioni consultate: B, p. 9; V I, p. 56; R I, p. 19; F III, p. 211; K, p. 24; S 2, p. 63. Sia per tutti gli esempi proposti nella discussione di P I.l.62 S. da Vt., M e K83 sia per tutte le regole operative di P relative allo zero fonologico applicato alla morfologia, si tratta sempre di pratyayalak;;aJ]a- applicato a quanto precede l'affisso al posto del quale si introduce lo zero fonologico ossia precisamente all'anga- definito a partire dall'affisso seguente, in linea con quanto emerge dalla discussione di P 1.1.63 di M. Non c'è ragione di escogitare una traduzione delloc. diversa da quella prevista da P 1.1.66.
I 134 Tiziana Pontillo
regole determinate da quell'affisso1s";
1.1.63 "<pratyayalope> na lumatal'lgasya <pratyaya1aksaJJan,1>", "<prima di lopa- di affisso> mediante termine tecnico che contiene LU, nonl9 si applicano <le regole determinate dall'affisso> del suo anga- (definito rispetto a quest'ultimo affisso)". La regola P I.1.62 può solo essere considerata un' eccezione alla regola P I.1.56,
che esclude le operazioni sui foni, e una restrizione (vedi M I, p. 165, IT. 10-13) dell'estensione ai casi in cui le operazioni siano di sostituzione con "zero fonologico" e siano determinate da un affisso, altrimenti la regola sarebbe superflua (cfr. OJlHARA 1958, pp. 7-10). P I.1.62 stabilisce limitatamente alle regole di zero fonologico nella posizione di un dato affisso, la validità della condizione di sthanivat(I.1.56) anche in caso di regole applicate ai foni dell'unità soggetta a "sostituzione" (cfr. M I, p. 161, r. 12; p. 163, IT. 12 S.)20. Si deve perciò distinguere l'effetto di 1.1.62 da quello di 1.1.56. Ad es. secondo I.1.56Ia funzione sintattica di nom., il genere m. e il numero sg. sono attribuiti a gomlm (gomat + -5) malgrado illopa- di sU (= -5) secondo VI.1.68. L'applicazione delle regole applicate ai foni della base determinate morfologicamente dall'affisso che subisce lopa-, in questo caso, secondo P VII.1.70, l'introduzione dell'agama- nuM (= -n-l, si verifica secondo 1.1.62.
Sembra scorretto affermare che P 1.1.63 neghi in assoluto l'applicazione di 1.1.62 a LUP, LUK e SLU, come DVIVEDI 1978, p. 78, ed è impreciso estendere ad "ogni operazione sulla base" la "proibizione" di 1.1.63 come ABH., p. 334. Anche RT II, p. 73 scrive che LUK in virtù di 1.1.63 sfugge al siitra- 62, senza porre alcuna limitazione, ma l'esempio che presenta riguarda l'esclusione della vrddhi- nella base (mr!3.ta[l subisce LUK di saP e la vrddhi- prevista prima di qualsiasi affisso per VI1.2.114 non si applica a mrj-). La traduzione qui proposta per 1.1.63, semplicemente sulla base di P 1.1.60, intende lopa- quale termine tecnico valido, se usato genericamente, anche per LUK, LUP e SLU21.
18Iak;;mla- indica" quello per cui qualcosa si riconosce" (vedi M I, p. 12, rr. 16 s.). Cfr. CARDONA 1997, § 850. Sulle implicazioni logiche e filosofiche del tennine vedi ad es. ALGEORGE 1969; MATILAL 1971, pp. 37; 60-2; 74; SIMONSSON 1976, p. 93; BAPAT 1993, p. 194. Il composto non è un tatpuruJ;a-, ma un bahuvrfhi- (vedi M 1, p. 161, r. 2). Cfr. SS III, p. 178; (R)03, p. 13 n. 3.
19 Per l'uso della negazione nei siltra- vedi CARDONA 1967, p. 54.
20 La bibliografia relativa a lopa- in P è sostanzialmente concorde nella definizione, ma forse sottintende alcuni aspetti del suo campo d'azione. Se si esclude l'articolo di OjlHARA 1958, non si trova un riferimento esplicito a P 1.1.56 e non si hanno precisazioni in merito alla funzione sintattica e al significato detenninati da lopa-. Cfr. RT II, p. 75; III, pp. 128 s.; ABH., p. 337; MISRA 1966, pp.23 s.; DAS 1985, pp. 131-37; PANDIT 1990, pp. 33; 87-8; SINGH 1991, p. 353; CARDONA 1997, § 103 pp. 63 s.
21 DVNEDI 1978, p. 77 non sarebbe d'accordo, classificando lopa-, LUK, SLU e LUP "synonyms" per "elision", pur non potendo essere sostituito nessuno dei quattro con un altro di essi. Sembrano d'accordo invece RT II, p. 75; SINGH 1991, p. 353; K, p. 24.
"Zeromorfi" in pa1Jini: regole specifiche di formazione ... 135
Due sono le interpretazioni proposte da M per" angasya" di questa regola: 1) si negano le operazioni previste dalla sezione dell'A.s.tadhyayz che ha "m1gasya", "al posto dell'ultimo fono dell' m1ga-" come adhikara- "regola di intestazione, che governa un gruppo di regole" ossia dal V1.4.1 alla fine del VII adhyaya-; 2) si nega ogni operazione (determinata fonologicamente) sull'angadefinito rispetto al pratyaya- "affisso" al posto del quale si applica lo zero fonologico con una regola specifica con un termine tecnico che contiene LU, con riferimento a 1.4.13: "yasmat pratyayavidhis tadadi pratyaye 'rtga", "anga-'base' è ciò che inizia con l'unità dopo la quale si applica la regola di affissazione, prima dell'affisso". I primi lO Vtt. e relativo M (M I, p. 165, r. 15 - p. 168, r. 17) menzionano operazioni sull'anga- che non si effettuano, malgrado siano insegnate al di fuori della sezione P VI.4.1-VI1.4.97, per sette delle quali sarebbe necessario aggiungere altrettante regole, nel caso che l'interpretazione corretta del sfltra- fosse la prima, e operazioni che non si applicano ma non a causa di I.1.63. Si presentano poi (M 1, p. 168, IT. 18 ss.) casi in cui al contrario non si applicano operazioni comprese nella sezione V1.4.1-VI1.4.97 (Vtt. 11 s.). M I, p. 169, r. 1 propone allora una lettura diversa del sfitra-: "yadi punar na lumata tasminn ity ucyeta", "Ma se ancora si dicesse: 'na lumata tasmin', 'non prima di quello (l'affisso al posto del quale è introdotto lo zero fonologico) mediante un termine tecnico che contiene LU'''. Si procede ad analizzare pro e contro di questa nuova formulazione del sfitra-, che si deve intendere più come una nuova interpretazione dello stesso, con riferimento a 1.4.13, che come una correzione del sfitra- ("tasmin" invece di "angasya"). Il Vt. 13 elenca alcuni casi che sembrerebbero non spiegati con la seconda interpretazione del sfitra-, ma M controbatte dimostrandone l'inconsistenza (M I, p. 169, rr. 6-10). L'interpretazione qui seguita è la seconda proposta da M. Cfr. BENSON 1990, pp. 1; 169.
2.2. Effetto dell'applicazione delle regole morfologiche di P rela
tive allo "zero fonologico" Nelle regole di "zero fonologico" relativo a morfema, quest'ultimo
mantiene A. il suo valore denotativo22
,
Nell' es. citato di lopa- relativo ai morfemi (adhok) si intende la II o la III perso sg. malgrado la terminazione verbale non disponga di una rappresentazione fonologica positiva; nell' es. citato di lopa- di una parte di un morfema (adhu~i) si intende il significato di aor., malgrado una parte del suffisso comunemente
liSi sceglie "denotazione" per essere fedeli all'ai. artlza- "significato" definito come "estensione", in quanto "oggetto" che P attribuisce ai morfemi (P 1.2.45 s.). Si scarta invece "senso" ("connotazione") che nella grammatica di P pare escluso per le singole unità
morfemiche.
ii
:1
r Il
136 Tiziana Pontillo
deputato a significarlo abbia una rappresentazione fonologica pari a zero; nell'es. citato di lopa- di una base nominale (vylighraka-) il tema semplice significa "povero Pelle di tigre", anche se il morfema lessicale che significa "pelle" non dispone di una rappresentazione fonologica positiva.
B. la sua funzione sintattica Nella formazione di vylighraka-, vylighra- ha valore di gen. dipendente da
ajina-, malgrado il nom. ajinam (pur in stato tematico ajina-, come richiesto dalle regole di composizione) non disponga di una rappresentazione fonologica positiva: in altre parole lo zero fonologico introdotto al posto di ajina- ha il valore sintattico di nom., tale da permettere al gen. vylighra- di dipendere da esso.
C la sua posizione (individuata in termini di confine morfernico) Ci sono regole che si applicano espressamente solo a morfemi che prece
dono uno dei morfemi con realizzazione fonologica pari a zero e tale "precedere" non si può valutare (su una posizione fonologicamente non rilevabile), se non sulla base della posizione del morfema cui si applica lopa-es. VI.1.10 "SLAU", "<raddoppiamento della base verbale> prima di SLU":
SLU è il morfema con realizzazione fonologica pari a zero introdotto al posto della vocale tematica secondo II.4.75 s.; in assenza di una realizzazione fonologica positiva, la sua posizione morfologica si può ricavare solo da quella della vocale tematica nella posizione della quale si introduce lo zero fonologico;
D. il suo effetto sulla base cui si applica (regole la cui applicazione è determinata dai morferni: è prevista però una distinzione tra regole determinate dal morfema "sostituito" con zero fonologico che includono o che viceversa escludono le operazioni sui foni della base)
adhok presenta il gU1Ja- o corrispondente a u di duh- (secondo VII.3.S6), determinato dalla terminazione verbale seguente, malgrado quest'ultima subisca lopa- (secondo V1I.3.72) e perciò risulti fonologicamente pari a zero.
Per i punti A, B. e C, è in virtù della regola I.1.56 che permangono le caratteristiche proprie del segmento nella posizione del quale si ha lo zero fonologico, dunque "a condizione che non si tratti di una regola applicata ai foni dell'unità sostituita" (analvidhau)23, mentre il punto D. dipende da 1.1.62. Dai punti A, B., C e D. (ossia dalla conservazione di alcuni aspetti del morfema al posto del quale si introduce lo zero fonologico), si ricava con chiarezza la necessità di rifiutare la traduzio-
23 Si noti che il gUlfa- o di U di duh- previsto nell'es. del punto D. non è determinato da un fono - s o t - secondo la regola P VII.3.86 ma da un qualsiasi morfema "terminazione verbale" secondo P VII.3.84.
"Zeromorfi" i11 Pli1Ji11i: regole specifiche di formazione ... 137
ne di lopa- come" elisione"24. La differenza tra la formazione con zero fonologico al posto di suffisso con termine tecnico Iopa- e quella con termini tecnici SLU, LUP e LUK si apprezza ad esempio dal confronto tra lopa- e LUK- di un analogo suffisso nell'applicazione di una mede-
sima regola25. es. sapta "sette": si tratta di una base in nasale (*sapta11-) e naturalmente di
un pl.; ci si attenderebbe una forma *sapta11-as. Secondo P VII.1.22 si ha LUK della desinenza di pl. per tutti i numerali dal sei in poi e tuttavia la formazione (pari fonologicamente alla base priva di desinenza) conserva la definizione morfologica di pada- (secondo I.4.14 "parola flessa"), tanto da subire lopa- di 11
(previsto secondo VIII.2.7 proprio in fine di pada-). La definizione morfologica di pada- (malgrado lo zero fonologico al posto della desinenza essenziale alla definizione) è garantita dalle regole I.1.56. La regola I.1.63 tuttavia impedisce l'applicazione di un'operazione sui foni della base determinata dal morfema "sostituito", operazione altrimenti prevista secondo VI.4.S ("in una base che finisce in -11 la vocale che precede si allunga nei casi forti, con l'eccezione del voc. sg."). La desinenza di caso forte è precisamente il morfema che ha subito LUK. Cfr. ad es. il tema rlija11- "re" che allunga secondo VI.4.S la vocale che precede 11 del tema, n al posto del quale si introduce lo zero fonologico (come nel caso di *saptan-) secondo VIII.2.7, da cui il nom. sg. è rlijli « rlijan + -s, desinenza di caso forte nom. m. sg., al posto della quale si introduce lo zero fonologico per VI.1.6S). Il pl. *saptan-as > *sapta11 > sapta non allunga la vocale davanti a 11 (che subisce lopa-) prima della desinenza di caso forte -as (perché la regola specifica di formazione con zero fonologico al posto di -as impiega il
termine tecnico LUK e non lopa-). L'effetto sui foni della base determinato dal suffisso al posto del
quale è introdotto lo zero fonologico, è garantito dal termine tecnico lopa- ma non da LUK. Di fronte all'assenza di effetti sui foni della base, determinati dai morfemi nella posizione dei quali si introduce lo zero fonologico mediante termine tecnico SLU, LUP e LUK si potrebbe dedurre di dover estendere lo zero, per questi casi, anche all'ambito morfologico, ma non è così. È vero che nel caso di Iopa-l'analogia morfologica tra una formazione con suffisso che prevede una realizzazio-
24 La traduzione è scelta invece da B, V, R, RT, Varma 1978, Das 1985, DP e anche in
tempi recentissimi da SEN 1999, p. 102.
25 5010 lopa- / LUK si trovano in condizioni di concorrenza nell'applic;;.zione di una medesima regola specifica di formazione con zero fonologico, non lopa- / SLU né lopa- / LUP. D'altra parte, rispettivamente LUK / LUP e LUK / SLU si trovano in condizione di
concorrenza tra loro.
l!
138 Tiziana Pontillo
ne fonologica positiva e una con suffisso fonologicamente pari a zero è più evidente, per l'effetto fonologico (determinato morfologicamente) sulla base (vedi riIjti. e anche l'es. del punto D.), che negli altri casi (cfr. saptg), ma l'analogia morfologica sussiste comunque 1) nella posizione occupata dallo zero fonologico, che è la medesima che altrove occupa il morfema nella posizione del quale si introduce lo zero (vedi sopra P VI.1.10), 2) nell'applicazione sulla base di regole determinate dai morferni - a patto che non siano regole applicate ai foni (vedi ad es. la definizione morfologica di pada- in saptan-+0 -as).
Infine un caso particolare di "zero fonologico" introdotto nella posizione di dati morfemi con il termine specifico lopa- (e non SLU, LUP e LUK) è costituito dalla regola di formazione di nomi radicali, semplici o come secondo membro di compost026, con affisso fittizio VI, la cui realizzazione fonologica è sempre pari a zero secondo VL1.67 "ver aprktasya <lopal:z>" (I.2.41:" aprkta ekiIl-pratyayal:z", "aprkta- è un affisso di un solo 'fono"'). VI è dotato di vari anubandha- che segnalano trattamenti diversi della base verbale cui si applicano (KVIP, KVIN, ryVI, VIT, ryVIN, VIe, CVI), che sono operativi, poiché lo zero fonologico al posto dei suffissi è introdotto con termine tecnico lopa- (P I.1.56 + 60 + 62).
es. II1.2.59: yuj- "unire" + KVIP > yUiz "unito"; bhZi- "splendere" + KVIP > bhZi- "luce"; IIL2.91 agni- "fuoco" + ci- "edificare" + KVIP + incremento -t (VI.1.71) > agnicit "altare del fuoco".
Un'ultima precisazione è necessaria a proposito del condizionamento previsto per le regole di !opa-, SLU, LUP e LUK di morfema. Esse presentano sempre un condizionamento morfologico o morfo-semantico, ad esclusione di cinque casi, forse riducibili a due:
1) p VI.4.105 "LUK di -hi quando la base finisce per -a-": es. paca "cuoci!" ma svapihi"dormi!"; 2) p VI.4.106 "LUK di -hl quando -u- finale di affisso non è preceduta da giunto consonantico": es. kurll "fa!" ma i'ipnuhi "raggiungi!" -la base verbale che finisce con -a- non è altro evidentemente che la forma tematica della base e la regola VI.4.105 potrebbe anche essere enunciata con riferi-
26 Essi per P rientrano in una classe specifica di composti (upapada-samlisa-), non esclusiva però dei composti a secondo membro radicale (cfr. P n.2.19; III.1.92) e nitya"necessari" ossia composti non sostituibili da un sintagma o da un derivato equivalenti. A proposito di quest'ultima peculiarità, rilevata secondo categorie differenti, cfr. ad es. SCHINDLER 1972, p. 8; BENEDETTI 1988, pp. 21 s.
"Zeromorfi" in Pil/Jini: regole specifiche di formazione ... 139
mento alla classe verbale, ma i suffissi -u- e -1111- (VIII e V classe verbale) sono introdotti come sostituti della vocale tematica -a- dalle regole IIL1.79 e III.1.73 e il condizionamento è morfonologico;
3) La regola P VI.3.65 introduce "LUK dei suffissi secondari -vin e matUP <prima degli affissi che iniziano per vocale = Y.3.58 i$.thaN = Y.3.55 e zyasUN = Y.3.57>": es.: sraki.s.tha- e srajlyas- (superlativo e comparativo di sragvin"inghirlandato") - il condizionamento fonologico enunciato pare in realtà superato dalla specifica menzione dei due suffissi che condizionano l'applicazione della regola;
4) p II.4.74 "<LUK = 11.4.58, in modo vario = II.4.73> anche di yaN (= -ya-) prima di aC": es.: lo-luv-a "che taglia insistentemente" (lu- "tagliare") -la tradizione grammaticale intende aC come suffisso primario dC = -a- e dunque si tratterebbe di condizionamento morfologico, ma gli esempi del commentario della K.asiM inducono a intendere aC come "vocale" e potrebbe trattarsi allora di un condizionamento morfonologico ("prima di affisso iniziante per vocale");
5) p VII.3.73 "preferibilmente LUK <di Ksa - = suffisso di aoristo sigmatico -sa- = VI1.3.73> dopo duh- "dare il latte", dih- "ungere"-, lih- "leccare", guh"nascondere" prima di una terminazione i'itmanepada- che inizia con dentale": es. adugdha forma preferita ad aduk.sata; adugdhZi/:! preferita ad adhuk.sathii/:!; adugd/wam preferita ad adhuk$adhvam; aduhranta preferita ad aduk$aranta - la condizione posta è solo apparentemente fonologica: si tratta solo di una formula breve per indicare le terminazioni verbali (i morferni) prima delle quali si applica la regola.
2.3. Ipotesi interpretativa delle regole morfologiche di P relative allo "zero fonologico"
Poiché tutte le regole di lopa- relativo ai morfemi prevedono la formazione con "zero fonologico" nella posizione di morfemi che in altre formazioni dispongono di una rappresentazione fonologica positiva e non si tratta di casi di zero morfologico, date le proprietà morfologiche che - come si è visto - il morfema mantiene, pur avendo rappresentazione fonologica pari a zero, si potrebbe adottare per tutti i morfi che discendono da tali regole il termine "zeromorfi"27. Si intenderebbe così
27 Cfr. BUBMANN 1983, p. 354, che s.v. Nullallomorph, prima di distinguere i casi in cui si deve necessariamente parlare di "allomorfi" nell'ambito dello "zero" in morfologia precisa: "([ ... ] auch leeres Morph, Null- bzw. Zéro-Element, Nullform, Nullmorph, und (irrtu"mlich) Nullmorphem)". Cfr. invece BUBMANN 1990, p. 536 che s.v. Nullmorphem segnala solo: "Auch: Leeres---7Morphem, Null-Form, Null-Flexion, Zero-Form" ed elimina ogni riferimento al lemma Nullmorph o Nullallomorph.
I, ·1,
1 1
'I, ' , I
140 Tiziana Pontillo
presentare ciascuno di tali "morfi" della grammatica di P quali "realizzazioni concrete fonologicamente pari a zero di dati morfemi", introdotti nella precisa posizione di quei morfemi28. Si scarta l'espressione "morfo zero"29, in quanto P, come si è visto, in tutte le sostituzioni dette, prevede la conservazione almeno di alcune proprietà morfologiche del morfema nella posizione del quale è introdotto lo zero fonologico. A maggior ragione non pare adatto "morfema zero", poiché nessuno dei casi di lopa-, LUK, SLU e LUP di affisso, presentati da P, è davvero isolabile in quanto morfema. Solo nel caso particolare di lopa- dell' affisso fittizio VI, infatti, lo zero fonologico si configura come un morfema autonomo, ma anch'esso è inquadrato nella categoria dei suffissi di derivazione primaria, per analogia sintattica e semantica (e morfologica, per quanto concerne la posizione) con i suffissi di derivazione primaria che hanno rappresentazione fonologica positiva. Ognuno dei morfemi VI (KVIN, KVlp, Wl, VII, NVIN, VIe, CVI) dispone di un unico morfo, che è uno "zeromorfo", ciascuno con specifiche caratteristiche nell'accento, negli incrementi, nel significato, nella diatesi, nella possibilità di essere composti con prefissi o basi nominali e talvolta con la restrizione di applicabilità ad una lista precisa di basi. L'effetto morfo-fonologico del suffisso al posto del quale si introduce lo zero fonologico è garantito dal fatto che la regola P VI.1.67 impiega il termine tecnico lopa- (cfr. P L1.62). La realizzazione fonologica di un morfema che sia soggetto anche a regola specifica di LUK, SLU, LUP può essere invece molteplice: si può considerare dunque di volta in volta un unico morfema con allomorfi differenti di cui uno è uno "zeromorfo" ossia la sua realizzazione fonologica è pari a zero.
2SSi confronti la definizione di "allomorph" di BUGMANN 1983,22: "Konkret realisierte Variante eines Morphems" e di "allomorfia" ad es. di ScALlSE 1994, p. 166: "una variazione di natura fonologica che non si può spiegare in termini esclusivamente fonologici. Essa riguarda una categoria lessicale maggiore o un affisso nel corso di un'operazione derivazionale". Cfr. anche le definizioni di LYONS 1971, p. 238 e MATTHEWS 1979, p. 110 e quella di "morfo" di TRASK 1993, p. 175 ("A piece of morphological material, consisting of a sequence of zero or more phonemes [ ... ]").
29 Si noti il passaggio da KASTOVSKY 1969, p. 8, contrario alla definizione del "Nullmorplzem" come "Allomorplz", a KAsToVSKY 1980, pp. 215-7, che invece ammette gli "zero allomorphs" distinguendoli dagli "zero morphemes". Cfr. "zero allomorph" per la "zero realization" del morfema di pl. del tipo ingl. sheep in KUMARASWAMI RAjA 1970, p. 43.
"Zeromorfi" in palJ.ini: regole specifiche di formazione ... 141
Ad es. SaP è un unico morfema (il morfo corrispondente è la vocale tematica per le formazioni verbali): come variante privilegiata si impiega il morfo -a- (es. bhav-a-tz) ma secondo P HA.72 si ha lo "zeromorfo" corrispondente (LUK di SaP ) per la II classe verbale (es. at-ti). Nel caso specifico della vocale tematica -a- per le formazioni verbali di pres., si può affermare che la selezione non sia solo su due altemative, tenendo in conto anche la III classe verbale (es. ju-ho-ti), per la quale entra in gioco un secondo "zeromorfo" (SLU di saP) per P I1.4.75. La selezione tra SLU e LUK è determinata da una lista di basi verbali e la distinzione tra i due è fondata sul diverso trattamento fonologico della base: raddoppiamento vs. non raddoppiamento (il raddoppiamento è fonologico poiché nel sistema di P, come si è visto, l'abhyasa- "sillaba di raddoppiamento" non è classificabile come morfema).
3. Classificazione ed esemplificazione delle regole operative di "zero fonologico" nella morfologia di P
Dalle 115 regole operative relative agli "zeromorfi" si ricava il seguente quadro complessivo: - 37 casi di lopa- , regola specifica di formazione con zero fonologico
nella posizione di un dato morfema reale (12 casi) o fittizio (VI: 25 casi), che determina a sua volta l'applicazione delle medesime .regole fonologiche sulla base previste per quel dato morfema. es. (V1.l.68): rajan- "re" > rajan (nom. m. sg. con lopa- di affisso sU - e a inve
ce di a secondo P VI.4.8) > raja (lopa- di fono n secondo VIII.2.7); es. (II1.2.59): yuj- "unire" + KVIP > yun"unito"
- 3 casi di SLU, regola specifica di formazione con zero fonologico nella posizione del morfema vocale tematica -a- (IL4.75-6; III.1.39), che determina a sua volta il raddoppiamento (VI.1.10). es. (II.4.75): hu- "sacrificare" > ju-ho-ti (formazione radicale con raddop
piamento di pres.); - 11 casi di LUP regola specifica di formazione con zero fonologico
nella posizione del morfema suffisso di derivazione secondaria, corrispondente a un uso metonimico di una base nominale. es. (IV.3.l66): jambil nome di un frutto derivato dal nome della pianta jambil
con zero fonologico al posto del suffisso -a- di derivazione secondaria 64 casi di LUK, regola specifica di formazione con zero fonologico nella posizione di diversi morfemi: - (1 regola) di suffissi di f.
Il, 142 TlZiana Pontillo
es. (I.2.49): badarmn "giuggiola" da badarI "pianta della giuggiola" (con zero fonologico al posto del suffisso di derivazione secondaria -maya- e del suffisso di f. -I);
- (1 regola) di desinenza nominale nella derivazione e nella composizione es. (11.4.71): plltrYyati "desidera un figlio" da plltran; + -ya- + -a- + ti;
ka.s.tasrita!1 "caduto in disgrazia" da kai5.tam + srita!1; - di desinenza nominale (e di f.) nella derivazione - (1 regola) degli indeclinabili es. (11.4.82): tatra salayam "in quella sala" (tad + zero fonologico al posto di
suffisso di f. + -tra suffisso con significato di loc.); - (1 regola) dei numerali indeclinabili es. (VII.1.22): .sa.t "sei" (con zero fonologico al posto di desinenza di pl.); - (1 regola) dei "casi diretti" sg. di temi neutri es. (VII.l.23): madhu (con zero fonologico al posto di -s di nom. sg. o di -am
di ace. sg.); - (1 regola) di una formazione di loc. nel vedico es. VII.1.39: carman (invece di carman-i: con zero fonologico al posto di -i di
loc. sg.); - (3 regole) di vocale tematica -a- e di suffisso di intensivo -ya-es. (II.4.72): atti "egli mangia" (ad- + -a-, suffisso cui è assegnato il signifi
cato di agente, al posto del quale è introdotto lo zero fonologico + terminazione verbale -ti);
- (5 regole) di suffisso di aor. -S-, -sa-es. (II.4.77): agat "andò" (aumento a- + ga- da gam- con le operazioni fono
logiche applicate alla base verbale previste per l'aor. + -s- suffisso di aor. sigmatico al posto del quale è introdotto lo zero fonologico + terminazione verbale -t );
- (l regola) di terminazione verbale nella formazione di aor. in -i es. (Vl.4.l04): akiiri "fu fatto" (aumento a- + -kiir- da kr- con le operazioni
fonologiche applicate alla base verbale previste per l'aor. + -i + terminazione verbale -ta, sostituita con zero fonologico);
- (1 regola) di terminazione verbale di perfetto nella formazione perifrastica dopo -am;
es. (II.4.81): Yk.san; cakre "desiderò" (i.s- "desiderare" con le operazioni fonologiche applicate alla base verbale + -am + zero fonologico al posto della terminazione verbale di perfetto -e);
- (2 regole) di terminazione verbale di II perso sg. dell'imperativo es. (VI.4.105): paca "cuoci!" (pac- + -a-, suffisso cui è assegnato il significato
di agente + -hi terminazione verbale di imperativo di II perso sg. al posto della quale è introdotto lo zero fonologico);
- (46 regole) di suffisso di derivazione secondaria
"Zeromorfi" in Pa~lini: regole specifiche di formazione ... 143
es. (11.4.63): Yaskiib "discendenti gotra- di Yaska!1"30 (per denotare un pl., zero fonologico al posto dell'affisso -a- introdotto per denotare un discenden-
te go tra- ).
Dal seguente schema di semplici esempi di ciascun tipo di zero
fonologico impiegato dalla morfologia di P, risulta forse più evidente
la netta differenza che esiste tra SLU, LUP, LUK e lopa- di affisso da
una parte e lopa- di affisso VI dall'altra. Le regole specifiche di forma
zione con zero fonologico sono nel primo caso orientate sull' asse oriz
zontale dello schema, nel secondo su quello verticale (e solo seconda
riamente su quello orizzontale). In altre parole il modello della forma
zione con zero fonologico (SLU, LUP, LUK e lopa-) al posto di un dato
affisso è un'analoga formazione con realizzazione fonologica positiva
del medesimo affisso, mentre il modello della formazione con zero
fonologico (lopa-) di VI è la base verbale cui si applica VI soggetto a
lopa- e d'altra parte VI si applica prendendo come modello un'analo
ga formazione di nome deverbale.
SLU di SaP (= voc. tematica -a- nelle formazioni di presente) lm-" sacrificare" bhu- "essere, diventare" ju-ho-ti (ju + hu + gUlJ.a della vocale della base + SLU di -a-) bhav-a-ti "egli è, diventa" (bhu + gUlJ.a
della vocale della base + -a- + ti)
LUP di aN (= suffisso di derivazione secondaria -a- + vrddhi- della vocale
della base) jmnbu- (base del f. jambU nome di pianta) jambu- (base del f. jambU nome di pianta)
jambu- (jambu f. nome di frutto) + LUPdi-a- jamb-a-va- (jambavam nt. nome di frutto
= jambu- + vrddhi- + -a- + -m) LUK di SaP (= voc. tematica -a- nelle formazioni di presente)
ad- "mangiare" bhu- "essere, diventare" at-ti (ad- + LUK di -a- + -ti) "egli mangia" bhav-a-ti "egli è, diventa" (bhu + gUlJ.a
della vocale della base + -a- + ti)
30 In tal caso la differenza da LUP consiste 1) nell'autonomia dei derivati con "zeromorfo" di tipo LUK rispetto alla base da cui derivano, autonomia che si riscontra qui nel numero diverso (pl. del derivato rispetto al sg. della base); 2) nella mancata esclusione dalla possibilità di denotare una "classe" oltre che un "individuale" (qui precisamente il gruppo dei discendenti maschi che virtualmente rappresentano l'antenato Yaska-).
i,
l,
144 Tiziana Pontillo
LUK di aD (= suffisso di derivazione secondaria -d- + vrddhi- della vocale della base)
jambu- (jambii nome di pianta) jambu- (jambii nome di pianta) jambu- (jambu nt. nome di fruttO)3! +
LUK di -a-
Lopa- di sU raja - (da rajan- per P VIII.2.7) "re" raja- (raja per P VI.4.8) + Iopa- di sU
(nom. m. sg.) Lopa- di VI
bhii- "splendere" bhii- "luce" (bha- + .1:::1+ Iopa- di VI)
jamb-a-va- (jambavam nt. nome di frutto = jambu- + v[ddhi- + -a- + -m)
deva- "divinità"
deva- + s (deva- + sU = nom. m. sg.)
da- "dare" da:l};::. "datore"
4. Lo zero in morfologia nella linguistica successiva a Bloomfield
Considerata la presente ipotesi di ricostruzione del modello di zero
di P, si può procedere a un confronto con alcune riflessioni sullo zero
in morfologia della linguistica del Novecento32, iniziando con l'evi
denziare alcuni punti salienti nel progresso della disciplina.
4.1. a) Fin dall'inizio di tali studi sullo zero è chiaro e talvolta - pro
prio per la novità del clima creato dagli emergenti studi di linguistica
sincronica - viene con forza ribadito, che l'ipotesi dello zero in morfo
logia non può che essere iscritto in una descrizione linguistica sincronica33•
Si veda ad es. BALLY 1922, p. 2: " On ne saurait assez insister sur le fait que le signe zéro s'explique uniquement par la linguistique statique". Cfr. tuttavia anche gli studi più recenti, ad es. ANDERSON 1992, p. 265: "Pretheoretically; at least, such "zero" elements are simply a way of designating a class of cases in
3J Per il nome del frutto della jamba P prevede tre formazioni differenti (con suffisso -a- e genere nt., con LUK del suffisso e genere nt. e con LUP del suffisso e dunque genere f. della pianta, rispettivamente secondo P IV.3.163; 165; 166).
32 Per una ricostruzione dell'uso dello zero in morfologia nella linguistica occidentale, soprattutto per quanto riguarda i suoi rapporti con il modello pa!,iniano, in Saussure, Meillet e Bloomfield, vedi PONTILLO 2001 a Cd.S.
33 Estranee dunque a tale prospettiva di zero in morfologia sono tutte le osservazioni condotte su fenomeni quali l'elisione in diacronia o l'allofonia quando si prenda una motivazione solo fonologica, ossia quando non si implichi un riferimento alla denotazione o alla funzione grammaticale dell'unità esaminata. Cfr. ad es. la classificazione di sei diversi generi di mutamento fonico con conseguenze sulla Struttura della lingua proposte da HOENIGSWALD 1946, pp. 138 s. Cfr. anche FREI 1950, p. 189.
"Zeromorfi" in PalJini: regole specifiche di formazione ... 145
which the formaI composition of a word does not match its relevant morphosyntactic contento In occasionaI cases it is possible to develop arguments that "zero" is a specific element of morphological expression, but in generaI specific motivation is lacking, and 0s are posited simply because a relevant category is not overtly reflected in words".
b) La formulazione fuorviante di "segno zero" per "significante
zero", nata da una singola attestazione di Saussure evidenziata come
errata e incoerente da GODEL 1957, p. 22034, ha un breve seguito negli
studi successivi fino almeno a SEBEOK 1979, p. 114, che ancora ritiene
necessaria una precisazione a proposito dei "segni zero": "In vari sistemi di segni, soprattutto nella lingua, un veicolo segnico può
talvolta - quanqo le condizioni contestuali sono appropriate - significare attraverso la sua stessa assenza, presentarsi, cioé, nella forma zero. I linguisti che usano l'espressione "segno zero" (vale a dire, fonema o allofono zero, morfema o allomorfo zero, e simili) debbono intendere o 'significante zero' o, molto più raramente, 'significato zero', mai però entrambi; se presa alla lettera la nozione di 'segno zero', avrebbe il carattere di un ossimoro" [ ... ] il ruolo dei veicoli segnici zero nei sistemi di comunicazione diversi da quello verbale non è mai stato analizzato adeguatamente"35.
c) Stabilita la necessaria condizione dell' opposizione sincronica tra
formazioni con significante positivo" e formazioni con "significante
34 Vedi già GODEL 1953, p. 35, che, confrontando le due definizioni di segno zero di BALLY 1932 e FREI 1950, ritiene che le due definizioni concordino essenzialmente, ma sottolinea la sostituzione da parte di Frei di signe con monème, sostituzione che approva "puisq'un signifiant zéro ne saurait etre divisible" e limita l'apparente mancanza da parte di Frei di attribuire "au signe zéro une piace déterminée dans le syntagme", poiché poco dopo Frei nota "qu'un phonème implicite est localisable dans la chane phonique". A p. 31, in apertura dell'articolo infatti Godei scrive: "Un signe zéro n'est pas simplement l'absence d'un signe au sens saussurien, c'est-à-dire de l'ensemble signifiant + signifié: c'est un signe implicite dont le signifié se dégage de rapports mémoriels ou discursifs, mais dont le signifiant n'admet aucune réalisation phonique: dans tch. zen, gén. plur. de zena, il y a une désinence zéro".
35 SEBEOK 1979, pp. 114 giudica errata l'osservazione di POHL 1968, pp. 34-6 secondo il quale gli abiti civili funzionano al grado zero quando vengono indossati in un contesto di uniformi: "questo significa confondere l'opposizione marcato / non marcato con l'opposizione zero/realizzato. [ ... ] L'esistenza di fonne zero nei vari sistemi di comunicazione non invalida, quindi, il classico modello bipartito del segno". Cfr. le riflessioni di PRIETO 1971, pp. 60 s. sul funzionamento dei "codici a significante zero",reso possibile solo da particolari emittenti quali "la nave ammiraglia" con il suo codice fonnato dalle bandiere e dalla loro assenza o dalle automobili in movimento con il loro codice a tre semi, formato dai lampeggiatori per la segnalazione della svolta a destra e a sinistra e dalla loro mancata accensione, come segnalazione della continuazione della marcia senza svolte.
i iii
146 Tiziana Pontillo
zero", diventano comuni le descrizioni di lingue o fenomeni o metodi di analisi anche assai diversi tra loro in cui compare il concetto di "suffisso zero", di "desinenza zero" o di altri "morferni zero"36. Si vedano alcuni es.
JAKOBSON 1939, p. 143 nota che in quasi tutti i paradigmi dei sostantivi russi si incontra una forma con desinenza zero. Se il nom. sg. ha "desinenza zero" (es. suprug "sposo"), allora il gen. pl. per evitare l'omonimia si appropria di una desinenza positiva (es. sllprug-ov), mentre la desinenza zero del gen. pl. è sopravvissuta nei sostantivi che distinguono comunque il gen. pl. dal nom. sg. es. ien : iena; vol6s : v6los; bojar : bojarin (oltre ai casi come questi di desinenza di nom. sg., di accento distinto, di suffisso di derivazione al sg., ce ne sono altri in cui la composizione del gen. pl. permette di distinguerlo dal nom. sg. - es. nom. sg. arsin nome di misura: gen. pl. arsin, ma quest'ultimo quasi sempre in composizione con un numerale)37.
HARRIS 1942, p. 170: "We divide each expression in the given language into the smallest sequences of phonemes which have we consider the same meaning when they occur in other expressions, or which are left over when all other parts of the expression have been divided off. [ ... ] The resultant minimum parts we call not morphemes, but morpheme altemants. It is useful to generalize this definition of morpheme altemant by taking sequence to mean not only additive sequence (the addition of phonemes), but also zero (the addition of no phonemes) [ ... ] In He cut it there is a zero morpheme meaning 'past time' after cut;. [ ... ] As in the case of ordinary additive morphemes, zero and the others can be recognized only by comparison with other morphemes".
SAPIR - SWADESH 1946, p. 107 individuano "zero forms"3S per la III perso sg. delle lingue Navaho, Yana e Nootka:
36 Non sempre è tuttavia usato il termine "zero": WHORF 1945, p. 2, ad es., introduce una bipartizione terminologica tra "phenotypes" e "cryptotypes", definiti rispettivamente "overt category having a formaI mark which is present (with only infrequent exceptions) in every sentence containing a member of the category" e "covert category [ ... ] marked, whether morphemically or by sentence-pattem, only in certain types of sentence and not in every sentence in wruch a word or element belonging to the category occurs". Cfr. BAZELL 1945-49, p. 144 n. l, che include la forma "zero" (accanto a quella "overt" e a quella "subtractive") nel concetto di "formative", in quanto "the expressive form of a morphological unit". Vedi anche MATTHEWS 1993, p. 88: "every PostBloomfieldian accepted that one altemant could be zero".
37 JAKOBSON 1939, pp. 144 ss. indaga sul "significato zero" in quanto controparte del significante zero. Una rilevazione del "significato nullo" di certi affissi si trova in CLC, pp. 181 s. Anche p distingue alcuni casi in cui il significato del suffisso è pari a zero nei derivati secondari: si tratta dei cosiddetti suffissi svarthikn- "dotati del significato proprio (della base)" corrispondenti ai taddhita- introdotti da P nelle regole V.3.96-4.67 con una sfumatura di significato. Cfr. ABH., p. 442; FILLIOZAT 1988, pp. 156 s.
3S FREI 1950, p. 188 discutibilmente le giudica corrispondenti a "segni zero".
"Zeromorfi" in Pii7Jini: regole specifiche di formazione ... 147
"An interesting phenomenon illustrated in our material is the use of zero forms for expressing one of the grammatical categories in a set. The Navaho .has no specific element for the third person subject, but it is nonetheless definitely implied by the absence of any first or second person element. The same is largely true in Yana and Nootka [ .. ·1. For third-person object, zero forms are even more common".
HJELMSLEV 1948, pp. 258-64 analizza le frasi nominali del tipo lat. "omnia praeclara rara", riconoscendo lo zero come espressione dei morfemi di presente, infectum e indicativo, che risultano presenti nel sintagma dalla prova di commutazione (cfr. HJELMSLEV 1968, p. 80), e interpolando i morferni di persona e di diatesi, morfemi comunque espressi con zero, mediante catalisi (Cfr. HJELMSLEV 1968, p. 101): "Ce zéro d'expression est une variante qui en des conditions déterminées prend la pIace des expressions explicites du me&ne élement (ou du me&ne groupe d'éléments". BAZELL 1949, p. 19 obietta però che il carattere di cliché della proposizione citata esclude l'analisi sintattica ordinaria ed è precisamente opposto al carattere di "evento" che invece vi si vorrebbe riconoscere.
Si giunge però a un certo punto alla postulazione di un numero eccessivo di "morferni zero"39.
Essa viene denunciata ad es. da NIDA 1948, pp. 415; 429; 438, il quale propone in casi come quelli dell'ingl. sang : sing, in cui sia riconoscibile come "overt distinction" un "replacement" della vocale radicale, l'individuazione di un "replacive morpheme" come significante corrispondente al diverso significato, piuttosto che ricorrere a una "covert distinction" (zero suffix) come "meaningcarrier" e definire al contrario "meaningless" la sostituzione di vocale, come invece propone di fare BLOCH 1947, pp. 407 S.40. HARRIS 1951, che pure indaga sulle ampie possibilità di estendere l'analisi con "zero"4!, ritiene (pp. 213-5) che in certi casi, per conservare la rappresentazione biunivoca degli elementi segmentati, si debba rinunciare ad analizzare i morferni in termini di zero42•
39 il rischio dell'ipotesi dello zero in morfologia è avvertito anche recentemente da ANDERSON 1992, p. 67: "If some morphological categories are marked by deleting or reordering existing material, rather than adding new phonological content, it is surely not possible to reduce all of morphology to affixation without trivializing the problem. [ ... ] TIùs leads to the proliferation of zero morphs [ ... ]".
40 Vedi però BAZELL 1949, pp. 16 s., a proposito della supposta contraddittorietà dell'analisi morfologica proposta da Nida, come si noterebbe dal cfr. con casi come l'ingL ieft: leave, in cui si trova sia la sostituzione sia l'usuale suffisso -I. NlDA 1948, p. 440, in realtà, nella classificazione dei morfemi, contempla anche la categoria "additive and replacive". BAZELL 1949, p. 17 tuttavia giudica non accettabile la soluzione di ritenere conciliabili i due morfemi applicati contemporaneamente con la stessa funzione.
4\ Vedi ad es. HARRlS 1951, p. 168.
.u HARRlS 1951, p. 337 inoltre distingue dagli "zero segrnents" i "voided elements",
Ili
148 Tiziana Pontillo
A p. 334 precisa: "True, this procedure is never unavoidable: in any corpus of material, it is possible to identify every linguistic element solely in terms of non-zero stretches of speech. [ ... ] In some cases, however, it is convenient to identify an element as representing an interchange of segrnents (i.e. the ornission of one stretch of speech and the addition of another in its pIace [ ... ]), rather than a simple addition. In other cases, we may recognize just the omission of a stretch of speech as indicating a linguistic element [ ... ] Finally, we may wish to set up a linguistic element to indicate the non-addition and non-omission of anything in a particular environment, i.e. to indicate a segrnent consisting of zero "43. Uno "zero segrnent" è definito (p. 335) in questi termini: "The basic condition for setting up a linguistic element representing a zero segment is: Given a class X containing stated members in stated environments A, the class may also be defined as always occurring in certain other environments B where its other members do not occur. Then zero segrnent, as a member of that class, occurs in each of these other environments B. [ ... ] Hence a zero segrnent in a given environment can only be a member of one class".
GODEL 1953, pp. 35-7 puntualizza che, per non contraddire il principio dell'arbitrarietà del segno, perché si supponga 0 nell'analisi morfologica, è necessaria non solo l'opposizione tra a e ab, per cui si ammetterebbe uno 0-père in un'opposizione del tipo père vs. beau-père, ma anche un'opposizione a / a0 o 0a che renda conto di due segni omofoni in opposizione (del tipo lat. contra preposizione / contra avverbio). GLEASON 1955, p. 76 distingue tra lo "0 allomorph" come quello che si rileva in "These sheep are" (confrontato con "This sheep is") rispetto al morfema di pl. {-Zjl e che definisce "a convenient device for entering all this into our description" e l'eventuale "0 morpheme" "that is, one in which there is no overt allomorph whatever", che giudica inutile e dannoso postulare ("If we are to make such free use of zero, there is no definable pIace to stop".
Analoga e lapidaria limitazione è posta da HAAS 1957, che fissa le due condizioni fondamentali per riconoscere lo "zero" come elemento morfologico: I. "zero must alternate with an overt form" e II. "zero must contrast with an overt form"44.
d) Presto non soddisfano nemmeno le limitazioni viste al punto c)
ed emerge l'esigenza di prendere in considerazione la categoria della produttività dell'" overt form".
considerati rispetto ai primi frutto di una tecnica opposta in quanto "replacing an element by zero". Per una rassegna dei contributi di Harris alla nozione dello zero in linguistica vedi MEIER 1961, pp. 110-2I.
43 Cfr. le analoghe osservazioni di NIDA 1946, p. 46 e KASTOVSKY 1980, pp. 215 s. +l Per alcune obiezioni ai limiti posti da GODEL 1953 e al I principio di Haas vedi
PRIETO 1977, anche se dal punto di vista morfologico gli argomenti non sono consistenti.
"Zeromorfi" in Piillini: regole specifiche di formazione ... 149
Saporta 1964 propone di aggiungere alla prima condizione (delle due formalizzate da HAAS 1957) che l'''overt form" sia anche produttiva o almeno meno marginale di quella analizzata45; così non si attribuirà un singolare zero a boy, man, pan ad es. perché datum (/ data) presenta un elemento che potrebbe essere considerato un morfema di singolare. Saporta dimostra tuttavia che anche tale condizione non è sufficiente: in spagn. il pl. ha normalmente -s dopo vocale (hombres "uomini") e -es dopo consonante (mujeres "donne"), ma quando la vocale non è accentata ed è seguita da -s non si ha un'''overt form" di pl.: 11l11eS "lunedì" sg. e pl.; paraguas "ombrello / -i". Non essendoci un morfema di sg., i due esempi sono ambigui e non sono in opposizione con un' "overt form". Egli nota inoltre che se anche non esplicitamente fissato, lo zero è riservato agli affissi di flessione46, dal momento che non si riconosce un allomorfo zero per gli avverbi derivati da aggettivi del tipo fast in he drives fast rispetto a $lorvly e quickly in analoghe proposizioni. La sua conclusione (p. 230) è la seguente: "Zero then is a device which has the effect of combining syntacticaIly sirni1ar sub-classes which are formally different, thus facilitating state-
ments of greater generality". Negli atti del Convegno di Linguisti del 1962 in cui si inserisce il citato con-
tributo di Saporta (1964), si registrano due interventi, di cui il secondo di R.H. Robins inizia con questa dichiarazione (p. 230): "The search for universally yalid conditions [ ... ] is likely to prove a vain one. It would be difficult to imagine any set of linguistic phenomena which could in no way be analyzed for-mally without recourse to zero, though, of course, there are many sets of which themost satisfactory analysis does make use of zero elements at some point". Egli limita la tecnica del "positing of zero elements" ad uno strumento disponibile ai linguisti, reso desiderabile per l'analisi di un buon numero di forme linguistiche. Egli ritiene che tale uso debba essere limitato perché sia efficace nel rendere elegante e simmetrica l'analisi: sarà giustificato l'uso per il pl. ingl.
"in contrast with vastly more numerous regular forms such as lamb,
lambs"47.
..sÈ dato noto che la tecnica dell'affissazione ("morfologia concatenativa") nelle varie lingue sia più comune delle altre tecniche: vedi LIEBER 1981; DRESSLER 1984; CUTLER -HAWKINS _ GILLIGAN 1985; DRESSLER 1992. In particolare DRESSLER 1984 classifica le diverse tecniche morfologiche in ordine alla naturalezza, partendo dal principio della" diaparomaticity" o "iconicità" della formazione: la conversione occupa il terzo posto dopo raffissazione e la modificazione e prima della sottrazione.
46 Diversa risulta la posizione di WILLlAMS 1981, p. 273 per il quale non esiste diffewu:a tra regole di derivazione e di flessione.
41 Anche NIDA 1948 e BAZELL 1949 mettono in guardia dall'uso indiscriminato dello zero in linguistica. Cfr. BLOCH - TRAGER 1942, p. 59 che presentano come una deviazione la "zero modification" in morfologia. MEIER 1961, p. 181 conclude la sua ricerca sulla problematica dello zero in linguistica, negandone l'utilità.
'l' , I
150 Tiziana Pontillo
e) Il problema delle condizioni da porre all'uso della categoria "zero" in morfologia pare risolto da un punto di vista descrittivo e terminologico con !'ipotesi di un "allomorphic zero". Si inquadra così lo "zero" in una serie di allomorfi, ponendo un chiaro limite all'uso del termine motivato da semplici opposizioni non funzionali a una sintetica descrizione linguistica.
NIDA 1946, p. 46 scrive: "When the structure of a series of related forms is such that there is a significant absence of a formaI feature at some point or points in the series, we may describe such a significant absence as 'zero'. [ ... ] A significant absence in an allomorphlc series may be called an allomorphic zero"4S.
KASTOVSKY 1969, p. 8 nega che il Nullmorphem possa essere definito un "Allomorph, dessen Status durch die Zugehorigkeit zu einem in anderen Piillen phonisch repriisentierten Morphem gekliirt ist" e lo classifica "ein eigensta··ndiges Morphem". Per gli es. ingl. del tipo sostantivo cheat da verbo cheat, presenta due possibili classificazioni: 1) "Konversion"49 o "Punktionverschiebung" (che evidenzia il mutamento di funzione o di classe della parola ma non mette in rilievo il mutamento semantico che implica es. cheat "imbrogliare" > cheat "persona che imbroglia"50; 2) "Determinans / Determinatum Verbindung"5l con "Nullmorphem" quale "Determinatum" es. cheat / 0 "qualcuno che imbroglia"52. L'ipotesi di KASTOVSKY 1969, pp. 9 s. per il "mor-
4S Nida stabilisce così che mentre per il sg. ingl. sheep si dovrebbe parlare di morfema zero, nel caso del plurale il termine corretto dovrebbe essere allomorfo zero. Una lontana anticipazione di tale bipartizione si può forse leggere in FREI 1950, pp. 162 e 187 nella coppia "signe zéro" ("signe" per "signifiant") - "signe intermittent".
49 La "conversione" quale processo tipicamente ingl. prevede tre principali casi: verbo> nome: lo jump > a jump; lo smile > a smile; nome> verbo: corner> lo corner; cream > lo cream; aggettivo> verbo: dry > lo dry; emply > lo e71lply; altri due sono: particella> verbo: oul > to oul; up > lo up; aggettivo> nome: bitler > a bitter; weekly > a weekly. Gli es. sono tratti da PAVESI 1994, pp. 61 s.
so Per le condizioni capaci di bloccare in ingl. la formazione di verbi senza suffisso di derivazione vedi CLARK-CLARK 1979, pp. 798-801.
51 Cfr. KASTOVSKY 1969, p. 2. Per la definizione di morfema e di sintagma cui ci si riferisce vedi KASTOVSKY 1969, p. 1. Cfr. MARCHAND 1966, p. 133; MARCHAND 1969, p. 31; LIPKA 1992, p. 84. Per la maggiore vaghezza semantica delle forme sintetiche rispetto a quelle analitiche vedi DRESSLER 1981, p. 425.
52 Favorevoli all'uso del termine "conversione" sono ad es. QUIRK _ GREENBAUM _ LEECH - SVARTVIK 1985, p. 1558 (Appendix I, § 1.43, n. a); BAUER 1979; BAUER 1983, p. 227; KATAMBA 1993, p. 55; IAMARTINO 1994, p. 65 n. 18. SCALISE 1990, p. 70 n. 2, preferisce al termine" conversione" che pure ricorda accanto a "trasposizione implicita" e "morfema zero", quello di "aggiunta nulla" che definisce "cambiamento della categoria lessicale
"Zeromorfi" in Palfini: regole specifiche di formazione ... 151
rema zero" comprende tre piani: morfologico, semantico e sintattic053• La definizione è "Das Nullmorphem fungiert als Determinatum eines morphologi$Chen Syntagmas an einer bestimmbaren Stelle dieses Syntagmas, das in Opposition zu anderen Syntagmen steht, in denen das Determinatum durch ein explizites Suffix markiert ist"54. KASTOVSKY 1980, pp. 215 ss. infine ammetle gli "allomorfi zero", distinguendoli dai "morferni zero "55: "The justification or these zero allomorphs from a surface structural point of view is relatively easy;since there are always overt realizations of the same morphological categor)' in other environments. The justification of zero morphemes is somewhat more difficult, however. Zero morphemes are usually postulated in derivatiomI morphology for the process termed conversion by some linguists, but more appropriatel)' called zero derivation" (KASTOVSKY 1980, p. 217).
f) Riflettendo sulla motivazione della cosiddetta "conversione", alcuni studiosi rilevano un singolare rapporto con categorie più comunemente intese come proprie della retorica.
In particolare vedi GUSMANI 1984: "Motivati sono da considerare dunque i derivati per aggiunta o sottrazione di morfema o per conversione (quindi anche le retroformazioni come ital. notifica, da notificare, e i derivati con mor(ema zero, come ingl. to phone), i composti di ogni genere e infine i nessi sintematici del tipo ingl. cold war. La motivazione consiste nel rapporto che lega il derivato o il composto o il sintema alla rispettiva forma di fondazione (o forma-base), costituita da un altro segno della lingua: tale rapporto può essere attuale al momento della creazione della parola motivata e col tempo esser-
allentato fino a non essere più avvertibile dai parlanti [ ... ]" (p. 17). "In più la
.~ l'aggiunta di affisso manifesto". PLAN!( 2000, p. 185 a proposito di es. di "convercome Feind "ostile" e "nemico" o Freund "amichevole" e "amico" sceglie per il membro della coppia la definizione di "zero-marked corresponding adjectives". ta stessa linea si colloca ad es. anche WURZEL 2000, p. 195, che a proposito di uno ~ di flessione nominale scrive: "AlI markers can also be zero" e a p. 203: "In this 1t\!:1i!b"lection, it is important that the zero-specification has the same value as positively ~>ecillE~d markers". Per i principi secondo cui si può stabilire la direzionalità nelle deri-
vedi MARCHAND 1974. Cfr. anche PAVESI 1994, pp. 47 ss. e LIPKA 1992, p. 85.
,; Per una precisazione sui casi di "elisione di morfema" determinata fonologicamente vedi KASTOVSKY 1980, p. 230 e KAsTOVSKY 1985, passi71l.
"Contemporaneamente a KASTOVSKY 1969, MARCHAND 1969, p. 359 elabora un'anadefinizione del "morfema zero". Anche OLSEN 1990 concepisce la conversione solo
<:ome un caso particolare di morfologia concatenativa, in quanto il morfema zero è fonok1;gicamente indeterminato, ma, agglutinato alla base, svolge la funzione di attribuire !;1!i.IA)vi tratti ad essa, in quanto testa della nuova formazione. Vedi anche LIPKA 1992, p. \%.
"La doppia classificazione è ricordata anche da MARTINET 1969, p. 249, che altrove U:$a. l'espressione "variante zéro" e "monème à signifiant zéro" (cfr. pp 68; 349; 390 e !l.;l~n 1960, p. 104).Vedi sopra le le ragioni per cui si sono scartati qui i due termini.
'I
152 Tiziana Pontillo
motivazione si combina spesso [ ... ] con fatti di metasemia" (p. 18) "Anche nel caso delle 'conversioni' il rapporto tra base e derivato può mutare nel tempo" (p. 22) 56.
CRoceo GALÈAS 1990, svolgendo uno studio di morfologia naturale sugli etnici italiani, verifica su questi ultimi i parametri di trasparenza morfotattica57 e di iconicità della formazione5S secondo i modelli della scala di naturalezza morfologica (p. 17) formulata da Dressler e giunge a definire (pp. 218 s.) non innaturale la "conversione" in base al principio dell' economia di espressione59, "particolarmente utile nel sottocodice temologico" (es. ingL to Xerox, to radio, to telephone, to paperclip) e in base ai vantaggi già individuati da Clark-Clark 1979, p. 802 per i verbi denominativi ingL con "conversione": "precision", "vividness", "surprise". Questi si addicono particolarmente alla conversione interpretata quale "metafora morfologica", secondo quanto CRoceo GALÈAS 1990, pp. 202-15 propone: "Denominando la conversione metafora morfologica intendo prospettare l'idea di una derivazione sintagmatica, ossia una derivazione il cui valore d'indessicalità è espresso dai sintagmi che rispettivamente identificano i due membri della coppia in conversione60
". La "conversione" secondo CRoceo GALÈAS 1990, p. 203 risulta così una "regola di formazione di parola" in cui a) il signans del derivato rappresenta inalterato il signans della base; b) il signatum del derivato è determinato sintagmaticarnente. Considerati i tratti caratterizzanti, la conversione è denominata metafora morfologica per analogia con la metafora semantica, per la quale il significato della parola soggetta alla metafora, paradigmaticamente inatteso, si ricava dal contestOi ad es. nel sintagma "la sera della vita", "sera" assume il significato sintagmatico di "età avanzata, vecchiaia", che non è proprio della parola di partenza. Nella metafora morfologica si ha un mutamento delle proprietà paradigmatiche del segno ossia si ha un cambiamento permanente di categoria grammaticale e di significato.
Secondo PAVESI 1994, p. 53: "In effetti la somiglianza tra metafora morfologica e semantica andrebbe ancor più accentuata visto che i nuovi significati
56 Cfr. il concetto e gli es. di "translation sans marquant" ("le marquant de la translation est zéro") di TESNIÈRE 1969, pp. 380 S. (TESNIÈRE 1969, pp. 36 s. descrive anche "faits syntaxiques [ ... ] sans marquant" - "ils ont le marquant zéro"). Alcuni risvolti stilistici del "segno-zero" sono invece già rilevati in KURYWWICZ 1936, pp. 80-91 e JAKOBSON 1939, pp. 145-7.
57Vedi CROCeo GALÈAS 1990, pp. 45-7.
5SVedi CROCeo GALÈAS 1990, p. 93.
59 Per il carattere controiconico e al contrario i vantaggi della riduzione del materiale morfematico presente in ciascuna unità lessicale in alcune formazioni tipiche dell'interlingua vedi BERRETTA 1986, pp. 47 s.; 55; 71 n. 34.
""Cfr. CROCeo GALÈAS 1990, p. 204 e la definizione di "conversione" di MEL'CUK 1976, p. 296, che CROCCO GALÈAS 1990 stessa cita come modello.
"Zeromorfi" in Pii1Jini: regole specifiche di formazione ... 153
sintagmatici acquistano statuto paradigmatico, quando da quella che è stata definita metafora stilistica si passa a quella lessicale, come in 'la gamba della sedia"'. PAVESI 1994, n. 19, p. 53 segnala tra le differenze fondamentali tra metafora semantica e metafora morfologica il fatto che per quest'ultima "il cambiamento di significato è predicibile" come per i nomi deverbali ("molto meno per la metafora semantica, benché anche in questo caso le possibilità di spostamento semantico non siano infinite").
4.2. Un confronto tra i modelli di zero citati e quello di P Si procede infine a rilevare quali elementi hanno in comune con il
~odello di "zero" di P quelli fin qui richiamati nel § 4.1. Con le lettere dell'alfabeto da a) a f) si rimanderà via via ai punti visti nel § 4.1. che ri.sultino pertinenti alle caratteristiche proprie del modello di P, che si esporranno in sintesi in questo paragrafo.
(a) (d) Anche !'ipotesi dello zero fonologico nella morfologia presentata da P si rende necessaria per la descrizione linguistica sincroni
in una formazione si suppone la presenza di un suffisso che non diSpone di realizzazione fonologica positiva, perché si riscontra un'aDalogia morfologica, sintattica e semantica con le formazioni che pre
,>~tano sincronicamente quel suffisso anche nel suo aspetto fonologie, nel caso di lopa- di VI, perché si rileva in sincronia un' analogia
fonologica (in alcuni casi addirittura l' omofonia) di un derivato pri.mano con una base verbale impiegata altrimenti.
Riprendendo per semplicità il caso di SLU e l'es. di ju-ho-ti, si vede COme lo zero fonologico sia introdotto nella posizione del morfema deputato alla denotazione dell'agente ossia saP (vocale tematica -a- non accentata). A tale morfema si attribuisce, con una regola a priori (P m.l.68) 62, la denotazione di agente, valida per tutte le formazioni verbali. La concreta realizzazione fonologica di saP è -a- solo nella I classe verbale: nella II si ha lo zero fonologico introdotto dal termine tecni
. co LUK (secondo P II.4.72 s.), nella III la stessa realizzazione fonologica ma introdotta dal termine tecnico SLU, nelle rimanenti classi verbali si
., Vedi sull'argomento ad es. PINAULT 1989, p. 323.
62In quanto sostituto di LA- secondo P IIL4.78, precisamente di LAT, secondo P 1lL4..69 la terminazione -ti può indicare un agente, un oggetto o un'azione impersonale. Secondo P IILl.68 -a- specifica che in questi casi si tratta di agente.
I
iii
154 Tiziana Pontillo
hanno altri morfellÙ comprendenti la vocale tematica o no, naturalmente a seconda che appartengano a una classe tematica o atematica, ma mai coincidenti con la vocale tematica -a- non accentata63. I morfi che ne discendono sono tutti comunque realizzazioni fonologiche (positive o pari a zero) dello stesso saP e dunque svolgono la medesima funzione sintattica e semantica di "agente". P perciò ha scelto di introdurre con una regola generale un morfema che in vero è realizzato come morfo, senza lopa- o sostituzioni con altri affissi, solo in una classe verbale (la I), ma la scelta pare spiegabile secondo tre ragioni, di cui la seconda e la terza coincidono con le linùtazioni poste da Saporta e altri: - la semplicità della formazione64 di pres. della I classe verbale, in cui
il rapporto è effettivamente biunivoco tra i morfellÙ e i loro significati, è' tale da prestarsi come modello, come regola, rispetto alla quale fissare tante altre regole capaci di presentare tutte le deviazioni da essa sotto forma di regole specifiche;
-la raccolta statistica dei dati che, come la "segmentazione" della lingua, P deve aver presuppost065 (non si può azzardare in quale forma, su quale patrimonio di testi e se svolta in prima persona o ricavata da studi o grammatiche altrui66), per poter disporre l'intera grammatica in forma di regole generali ed eccezioni, estensioni e restrizioni basa te sull'osservazione di analogie e differenze (cfr. CARDONA 1997 §§ 105-18; 667-9), per poter prevedere una segnalazione di opzioni con una triplice gradazione (vedi KIPARSKY 1979), induce a rilevare che la I classe comprende circa la metà del numero complessivo di basi verbali ai.67, 1059 su 1960 nel Dhiltupil.tha;
63 I morfemi caratteristici sono per la IV classe syaN, per la V snu, per la VI sa, per la VII snaM, per l'VIII u, per la IX sna, per la X l.1iC + saP.
"'Cfr. STAAL 1969 a, p. 484.
"Vedi MAHAVIR 1978, pp. 3 s.; THIEME 1982, p. 11; PINAULT 1989, p. 322; DESHPANDE 1990, p. 34.
66PANDIT 1971, pp. 207 s. ricorda a tale proposito a) l'episodio di Brhaspati, Indra e l'immenso elenco di parole raccontato in M (Paspasa: M I, p. 5, rr. 25 s.; cfr. F I, p. 7511), come alternativa ma anche come precedente modello rispetto a quello della grammatica di P; b) la notizia di Yuan Chwang a proposito della raccolta di un numero spropositato di parole da parte di P; c) la KMikiì relativa a P IV.1.114 (K83, che menziona una raccolta di parole resasi necessaria per la sua smrti-).
67Vedi BURROW 1955, p. 327. Nel Dhatupi'!tha sono 72 le basi della Il classe, 25 della III,
"Zeromorfi" in Pi11Jini: regole specifiche di formazione ... 155
produttività68 della I classe verbale, infine, pare decisiva, produtti"ità intesa sia nel senso di caratteristica propria dei neologismi, \ista la nota estensione crescente della I classe a danno delle altre {vedi i passaggi dalle classi atematiche ID, Vll, IX e dalla VI con applicazione del suffisso -sk' e- j-sk' 0- prevalentemente alla I classe tematica: THUMB 1958-78, I, 2, pp. 242-45)69, sia nel senso semplicemente quantitativo del termine, dato il corpus linguistico tendenzialmente chiuso che P sembra avere come punto di riferimento
il rapporto di P con il Dhiltupi1.tha vedi KATRE 1937-1938; RT I, p_ 168; con il GaJJapi1.tha, vedi RT I, p. 136; KIPARSKY 1979, p. 91; RADICCHI 1987)7°. Tenendo conto del carattere insieme produttivo ed evidentemente
del pres. di I classe, si può definire "regolare" la forQuesta deve aver funzionato da prototipo intorno al quale P
organizzato l'intero schema di pres. della I classe con denotazione un agente. Si noti d'altra parte che lopa- con le sue sottocategorie di
risulta comunque più produttivo di molte altre regole di affiselencate da P, dato che rende conveniente la descrizione di
istema di affissazione nei termini scelti da P72. (b.)(c.)(e.) Analizzati tutti i casi di lopa- presentati dalla grammatidi P è possibile applicare ad essi la definizione di "morfema zero"
IV, 34 della V, 143 della VI, 25 della VII, lO dell'VIII, 61 della IX, 395 della X (K, dunque 1059 basi della I classe contro le 901 complessive di tutte le altre.
1955, p. 111 controbatte le critiche alla liceità dell'introduzione dello zero proprio un argomento fondato sui dati statistici della lingua.
Per le definizioni di produttività si è tenuto presente KASTOVSKY 1986; CROCCO pp. 131-138; SCALISE 1994, pp. 106 s. e, per il rapporto tra "produttivita'" e
:'''_,nemi zero", SAPORTA 1964 e l'intervento di Robins sopra citati.
Si può considerare P un possibile testimone di tale fenomeno: cfr. l'opzione vedi-jl- dì basi classificate come appartenenti alla II classe - radicali - presentate non
formazioni di "congiuntivo" ma come forme di presente indicativo tematico di l in P II.4.73.
Naturalmente non si può escludere che P prenda in considerazione una motivaanaloga a quella individuata da GLEASON 1955, p. 75 per il pL del tipo ingL sheep, la percezione linguistica dei parlanti nativi.
"Un simile argomento è svolto per l'ingL da PAVESI 1994, p. 52.
'"" Per la necessità di limitare il numero di "elementi zero" da inserire nella descrilinguistica, necessità di cui P mostra - come si vede - di essere cosciente, vedi in SAPORTA 1964.
III
156 Tiziana Pontillo
di KASTOVSKY 1969, pp. 9 S., sostituendo però per le ragioni già esposte73 l'espressione "morfema zero" con "zeromorfo", fondandosi sulla definizione di "sintagma morfologico" di KASTOVSKY 1969, p. 1 ("das morphologische Syntagma" o "das Wortbildungs-syntagma"). Tenuto conto della distinzione, introdotta da P sia per la flessione sia per la derivazione, tra valore denotativo, funzione sintattica, posizione e regole applicate alla base determinate da ciascun suffisso, si analizzano tutti i suffissi (flessivi e derivativi) quali "unità che svolgono la funzione di un dato determinatum" (kiirakaJ4 con una data denotazione o altra autonoma classe di denotazione introdotta a priori da P, quali ad es. "genere femminile", "pluralità") di un sintagma morfologico, in quanto ogni pada- "forma flessa" risulta composto di più unità arthavat- "dotate di un 'significato', di un oggetto", considerate a due a due (es. base-suffisso> tema-desinenza) per la loro "relazione sintatticosemantica"75 (samarthya-: secondo 11.1.1 tale relazione è condizione necessaria alla formazione del pada-). Si rilevano infine contemporaneamente le relazioni di opposizione e di analogia (in alcuni casi di orno fonia) tra i sintagmi o tra i sintagmi e i morfemi confrontati da P.
Nel caso di lopa-, LUK, SLU e LUP di suffisso ossia degli allomorfi "zeromorfi" di dati morfemi, il grammatico rileva un rapporto di opposizione fonologica, di analogia semantica e sinta ttica e di analogia morfologica per lopa-, limitatamente alla posizione dei morfemi per LUK, SLU e LUP tra un sintagma morfologico con un dato morfema che svolge la funzione di determinatum e un sintagma morfologico in
73 Cfr. anche ALLEN 1955, p. 109, che (a proposito dell'es. ingl. pl. sheep) precisa il "suffisso zero" nel senso di "suffisso = zero fonologico".
74 La categoria sintattico-semantica dei kiirakn-, impiegata per la descrizione dei procedimenti grammaticali della flessione, della derivazione e della composizione, introdotta come una serie di "pseudo-meanings" which have been introduced to facilitate the transition from real meanings to case-endings" (BRONKHORST 1979, p. 153) prevede, come è noto, sei unità definite in 1.4.24; 32; 42; 45; 49; 54. Per una presentazione vedi KrPARSKY - STAAL 1969, p. 89, con le correzioni apportate da JOSHI 1971; CARDONA 1974; CARDONA 1976. Il termine kiirakn- si trova per la prima volta con il suo significato tecnico in P, ma non è definito: vedi CHATTER)I 1964, p. 367; CARDONA 1974, pp. 249-51; WEZLER 1976, p. 377.
75 Si segue qui l'interpretazione di DEHSPANDE 1980, pp. 8-29; DESHPANDE 1980 a, pp. 312-6; DESHPANDE 1985; DESHPANDE 1987, p.69; cfr. però KUN)UNNI RA)A 1957, p. 285; CARDONA 1967-1968, p. 319, n. 1; JOSHI-RooDBERGEN 1982, pp. 59 s.; MAHAVlR 1984, p. 9.
"Zeromorfi" in PiilJini: regole specifiche di formazione ... 157
identico, ma comprendente uno "zeromorfo", quale realizzazio:oncreta fonologicamente pari a zero dello stesso morfema, nella
di quel dato morfema76. Nel caso che tale "zeromorfo" sia un di derivazione denominale, dal sistema si ricava pure un' oppo
non sottolineata da P, del sintagma morfologico con il morfe-
base nominale. Nel caso dei vari morfemi VI, che dispongono ciascuno di un solo
pari a uno zeromorfo, P rileva l'analogia fonologica - in alcuni casi omofonia - ma l'opposizione
semantica, sintattica e morfologica sia tra il morfema (base verbale o, per CVI, nominale), al quale lo "zeromorfo" (quale realizzazione fonologica pari a zero di un morfema autonomo) VI (morfema fittizio la cui realizzazione fonologica è pari a zero e che svolge la fun.zione di determinatum) si applica, e il sintagma morfologico che
comprende tale" zeromorfo"; l"a..1!1alogia semantica, sin tattica e morfologica e l'opposizione fonolo
gica tra il sintagma morfologico con un dato morfema che svolge la funzione di determinatum e un sintagma morfologico in tutto identico ma comprendente uno "zeromorfo" nella stessa posizione occupata da quel dato morfema nell'analogo e opposto sintagma morfologic077 - es. ghrta-sprak- = 6 udaka-spars-étJ:z (P II1.2.58Ys. Le 37 regole di lopa- di affisso- reale (12) o fittizio (25) sono regole specifi
formazione con zero fonologico ma non semantico, non sintattico e neporfologico, sia per quanto concerne la posizione sia per quanto concer
.egole determinate da quell'affisso sulla base, lopa- introdotto nella posidi quel dato affisso. Le 3 regole di SLU sono regole specifiche di formacon zero fonologico ma non semantico, non sintattico e, per quanto conIa posizione dei morfemi e le regole determinate dai morfemi.applicate
7%'\!iedi sopra a proposito di P VI.1.10. Il ruolo della posizione è già sottolineato in 1932 § 248; FREI 1950, p. 173; GODEL 1953, p. 35. Un'analoga distinzione è rilevata anche da NlDA 1946, p. 46, che classifica però ~morfema zero" e "allomorfo zero" rispettivamente gli "zeromorfi" individuabili . sheep e nel pl. sheep (cfr. MEIER 1961, p. 133). Sembrerebbe essere sempre la "testa morfologica" a poter subire la regola specifi- lazione con zero fonologico al suo posto, mantenendos.i il suo valore sintatti
tico e morfologico, con la distinzione tra lopa- e LUK, SLU e LUP per l'effetto ~~=inato dal morfema (nella posizione del quale si introduce lo zero fonologico) sui
d<illa base nominale o verbale, definita a partire dal morfema "sostituito".
'III
,"
158 Tiziana Pontillo
alla base (escluse quelle applicate ai foni della base), neppure morfologico, SLU introdotto nella posizione del morfema vocale tematica -a-o Le 11 regole di p di LUp79 sono regole specifiche di formazione con zero fonologico ma non semantico, non sintattico e, per quanto concerne la posizione dei morfemi e le regole determinate dai morfemi applicate alla base (escluse quelle applicate ai foni della base), neppure morfologico, LUP introdotto nella posizione del morfema suffisso di derivazione secondaria -a- o -ka-. Le 64 regole di P di LUK sono regole specifiche di formazione con zero fonologico ma non semantico, non sintattico e, per quanto concerne la posizione dei morferni e le regole determinate dai morfemi applicate alla base (escluse quelle applicate ai foni della base), neppure morfologico, LUK introdotto nella posizione di diversi morfemi grammaticali di volta in volta specificati (inerenti la morfologia flessionale, derivazionale e della composizione). (f.) Nell'ambito degli "zeromorfi" P include con LUP l'uso metonimico di alcune basi nominali, con accostamento di un fenomeno linguistico di interesse grammaticale ad un altro squisitamente retorico, cogliendo un interessante rapporto tra derivazione linguistica e metasemia, rilevabile comunque in sincronia.
Alle formazioni con zero fonologico introdotto con termine tecnico LUP si adatta bene la definizione di "derivazione lessicale" (KURYtOWICZ 1936) e non "sintattica", in quanto la funzione sintattica della base è la medesima del derivato. Solo in un caso è segnalata una diversa combinabilità sintattica oltre che un mutamento semantico: P 11.3.45 stabilisce infatti l'uso della III vibhakti"desinenza di strum." (oltre che della VII - loc. - comunemente usata), per denotare il tempo, quando il suo nome derivi da quello di una mansione lunare, mediante suffisso di derivazione secondaria, al posto del quale è introdotto lo zero fonologico con termine tecnico LUP. Alle formazioni sembra potersi applicare anche la definizione di "conversione" come "metafora morfologica" di CROCCO GALÈAS 1990: si ha infatti "un mutamento delle proprietà paradigmatiche del segno ossia un cambiamento di categoria grammaticale e di significato", anche se si deve precisare che le categorie grammaticali oggetto della transcategorizzazione sono quelle paJ:.liniane dalla jati- "classe" al vise.sa- "individuale", categorie non sovrapponibili a quelle di aggettivo e nome. In special modo nel caso di V.3.98 e in particolare per gli esempi tratti dai commentari pare di trovare conferma almeno a due dei vantaggi elencati da Clark-Clark 1979 per i verbi denominativi derivati per conversione, "vividness" e "surprise", tali da contrastare la definizione di "innaturali" di tali derivati altrimenti "controiconici" (BERRETTA 1986). È certo però che P, fissando in regole alcune derivazioni metonimiche, abbia 1'effetto di toglier gran parte dell' efficacia e della sorpresa al risultato creativo retorico o poetico che ne dovrebbe deriva-
79 Vedi PONTILLO 2001 b C.d.5.
"Zeromorfi" in Pa1Jini: regole specifiche di formazione ... 159
così a una netta separazione tra uso linguistico e retorica e
li duplice modello di zero nella morfologia di p modello di p di "zero linguistico" applicato alla morfologia perli'mprende insieme - ma con appropriata distinzione - due tipi di ___ f:;U.
(" zeromorfi") di morfemi che dispongono anche di morfi
realizzati; ,;D"4lOirfemi che dispongono ciascuno di un unico morfo pari a uno " ";"'~-~morfo.
sempre sono state rilevate entrambe né tenute distinte dagli di linguistica inerenti che sono fioriti a partire dall'epoca di
1879 (al quale attribuisce la paternità dello zero linguistico ò~ a P). Tanto meno i medesimi contributi hanno operato con
le ulteriori distinzioni previste da P. >lu.erazioni limitate al primo tipo di "zeromorfi" (e spesso
si trovano ad es. in BLOCH-TRAGER 1942, pp. 59 s. ("zero modifiI "zero affix"; "zero change"; "zero suffix" per pL ingL del tipo K'\RRIS 1951, pp. 168; 213-5; 337 ("replacement by zero" sul
fonologico; "zero-segment" sul piano morfologico per l'es. ingL I eut); HAAs 1954, pp. 59; 77 n. 1 ("zero-juncture"; '''compo-
zero"; "fictitious presence of zero" per gli es. ingL pL sheep e prel cut); SAPORTA 1964 ("zero allomorphs" per avverbi del tipo ingL per nomi m. sg. del tipo spagn. senor); VENDRYES 1968, pp. 96 s.; ("désinence zéro"; "morphème zéro"; "degré zéro" "en matière
nel nom. sg. del tipo gr. cpwQ e JtaT~Q).
BALLY 1909, I, pp. 188 s. distingue la metonimia propria della comunicazione da quella propria dello stile. Si potrebbe verificare se - come ci si attende - la successiva registri uno scarso uso di queste precise metonimie o meglio regi-
non a scopo poetico ma semplicemente linguistico. Tale supposizione, al come indizio lo sviluppo del composto comparativo nella letteratura
in forme molto più complesse di quanto le regole di P e di quanto, signidefinizioni che sembrano ispirate a P, i primi testi di poetica prevedaad es. P 11.1.55 s. con BHaMAHA II, 32. Cfr. DESHPANDE 1977, p. 619;
pp. 163-5. Per P vedi anche Aigr. 1Ll, p. 252 fedele alla presentazione di 1886 § 220, p. 164 che invece interpreta il tipo puru:;asi11Jha- (previsto da P
un composto con gen. partitivo "un leone fra gli uomini", tipo in realtà proibito con questa analisi da P 11.2.10.
160 Tiziana Pontillo
TI secondo tipo di "zero linguistico" è rilevato nella formazione dei nomi radicali ( "thèmes sans suffixe") come "désinence zéro" già da SAUSSURE 1879 per gli es. gr. qay "adulatore", ptax "lepre", fl6x "fiamma" (p. 146) e per i temi ossitoni in al con "expulsion de l'a" (p. 182), ripreso come "suffisso zero" in CLC, p. 255 con l'es. gr. fl6x "fiamma" e usato successivamente più spesso come es. di "morfema zero" di P (vedi ad es. COLLINDER 1962-68, p. 15; KURYWWICZ 1964, p. 44). Probabilmente ha influito sulla scelta il contributo di ALLEN 1955, che presenta il modello di P proprio attraverso il caso di lopa- di VI, ma quest'ultimo suscita evidentemente interesse (o stupore) già nei primi linguisti che vengono a contatto con la grammatica di P, visto che in Bopp 1834, p. V, si cita (come es. di tecnica fuorviante dei "grammatici indigeni", che l'autore dichiara di non aver voluto seguire nella sua grammatica) il "fingirtes Suffix Kvip".
Nel CLC si trova anche il primo tipo con l'es. (pp. 123 s.) di gen. pI. ceco slov "delle parole" < asI. slovu e ien "delle donne" < asI. zenu81,
per il quale si usa l'espressione "exposant zéro" e "signe zéro"82, ma non sono affatto messi in rapporto i due tipi rilevati83. MEILLET 1903 usa "lo zero" effettivamente per descrivere una varietà di formazioni paragonabili a quelle della grammatica di P, senza tuttavia connetterle tra loro: usa l'espressione "desinenza zero" per il sg. del nom. e del voc. di sostantivi del tipo gr. 6ù:rrcoQ /6ùrwQ (p. 116), "suffisso zero" per la coniugazione atematica per i temi di preso e di aor. radicali e raddoppiati asuffissali (p. 169) e per i nomi radicali (pp. 218 s.). SAPIR 1921, usa "0" sia per individuare il suffisso e la terminazione verbale di ingI. I sing / sing! vs. sing-ing (p. 27) sia per individuare il suffisso, la desinenza di caso, genere e numero e la realizzazione fonologica pari a zero di un fono della base per il sostantivo "lat. cor + 0 + 0 + 0" (p. 29)"84. BLOOMFIELD 1933, § 13.7 pp. 215-8 usa "zero-alternant" e "zero-
81 L'es. è ripreso con la corretta sostituzione del termine "segno zero" da JAKOBSON 1939, p. 143 con l'espressione "desinenza zero", da KAsrOVSKY 1980, p. 215 e da RAPALLO 1994, p. 133 con l'espressione "significante zero" (vedi anche RAPALLO 1994, pp. 54 e 54 n. 3).
82 L'espressione è ripresa da BALLY 1922, pp. 2-5. 83 Cfr. GODEL 1953, p. 39.
.. L'espressione "zero-form" per la III perso sg. di verbi di alcune lingue amerindie è impiegato poi da SAPIR - SWADESH 1946, p. 107.
~'Zeromorfi" in Pii1Jini: regole specifiche di formazione ... 161
la desinenza di pI. ingI. del tipo sheep, per il suffisso di reterito ingI. del tipo cut, per la terminazione verbale della di preso ingI. del tipo can; per il suffisso di aggettivo posdei pI. del tipo "the boys"'. Una simile ampiezza di appli
uno "zero-segment" si trova solo più tardi ad es. in MEIER 1973.
studi recenti sullo zero linguistico sono svolti sulla lin-e sono prevalentemente inerenti il fenomeno detto anche
, ossia il secondo tipo. I numerosi contributi (ad es. i di KASTOVSKY 1969; MEL'CUK 1976; Clark-Clark 1979;
1984; QUlRK-CREENBAUM-LEECH-SVARTVIK 1985; OLSEN 1990; L"1. BRlGHT 1992, I, pp. 309 s.) del fenomeno della cosiddetta
non sembrano sempre tenere nella debita distinzione i "zeromorfi" individuati da P. La descrizione del fenomeno
mette in luce l'analogia fonologica e morfologica sintattica e semantica del derivato rispetto alla base,
ombra - pur presupponendole -l'opposizione fonologica e l'analogia sintattica e semantica del derivato con lo
rispetto ad altri derivati da basi diverse e più raramente base.
del secondo tipo, P sembra risolvere ante litteram il sollevato da NIDA 1948, p. 427. Dichiarando di adottare il generale di HOCKETT 1947, secondo il quale lo "zero" non
il solo allomorfo di un morfema, Nida nega la possibiin.riduare l'affisso derivativo applicato ai sostantivi del tipo
entre propone di riconoscere come morfema derivativo la di vocale. Nei casi previsti da P di nomi radicali ottenuti
verbale del tipo bhii- "luce" da bhii- "splendere" (con omoanche (ardha-)bhiij- "che partecipa della metà" da bhaj- (con
della vocale della base), P fornisce un' originale soluzione, morfemi fittizi VI, ciascuno con un unico morfo fonologi. a zero, capaci di determinare molteplici sostituzioni nella vocalica della base e nell'accento, grazie agli anubandha
\,T1 (KVIP, VI1J-, KVIN etc.) .
'"
162 Tiziana Pontillo
Il modello di P sembra così potersi applicare agli esempi" classici" della bibliografia inerente lo zero del primo e del secondo tipo. Nel primo tipo sia l'opposizione fonologica sia l'analogia morfologica, sintattica e semantica sono rilevate tra formazioni appartenenti alla medesima categoria sintattico-semantica derivate da basi diverse (es. ingl. sheep sg. : sheep + 0 pl. vs. / - lamb sg.: lambs pl.) e raramente dalla medesima base (es. ita. Montalcino (toponimo) > Montalcino (etnonimo) vs. / - Montalcinése)85. Nel secondo tipo, l'opposizione si rileva tra due omofoni appartenenti a categorie sintattico-semantiche differenti e l'analogia tra una singola formazione senza morfema derivativo, ma che risulta derivata sul piano sintattico e semantico, e altre con morfema derivativo (di una categoria sintattico-semantica da un'altra: es. ingi. cheat verbo vs. cheat + 0 sostantivo agente - bak + -er).
Rispetto all' obiezione richiamata da PENNANEN 1982, secondo cui lo "zero" non soddisfa la condizione necessaria per ogni segno linguistico di disporre, oltre che di un significato, di un significante almeno come allomorfo - lo zero infatti non mostrerebbe alcuna somiglianza morfologica o fonologica con le altre unità con le quali è classificato _ la soluzione di P di presentarlo come "zeromorfo", ossia come realizzazione fonologica concreta specifica di un dato morfema, pare superare la difficoltà, potendo l'adesa- avvalersi del supporto morfo-fonologico dello sthanin-, di cui esso occupa precisamente il posto.
Lo zero linguistico di P si configura così precisamente come il "segna-posto", paragonabile allo zero nel sistema posizionale in base dieci (posto a destra di un qualsiasi numero ne moltiplica il valore per dieci, posto a sinistra, seguito da una virgola, lo divide per dieci)S6. Nel caso proprio di regola specifica di formazione con zero fonologico introdotto con termine tecnico lopa- di pratyaya-, la "somiglianza" con il morfema nella posizione del quale esso è introdotto è morfologica in una misura ancora maggiore rispetto ai casi di SLU, LUP e LUK, perché l'effetto che ha sulla gradazione vocalica, accento o incrementi che
85 Gli es. sono appunto tratti dalla bibliografia inerente lo "zero linguistico" fin qui citata.
86 Per il confronto con lo zero matematico vedi ALLEN 1955; SCHARFE 1977, p. 110; PANDIT 1990, pp. 95-117; BRONKHORST 1994; KAPLAN 1999, pp. 57-85.
"Zeromorfi" in Piil:zini: regole specifiche di formazione ... 163
è il medesimo che determinerebbe il morfema nella posiquale è introdotto. studi citati infine non è sempre evidenziata la distinzione tra
nologico e morfologico dello zero linguistico, usandosi spesso l'espressione "morfema zero", pur distinguendosi
i morfemi dai morfi come realizzazioni concrete fonoloprimi. Rispetto a KASTOVSKY 1980, P prende in consideraziotale distinzione, rendendo necessaria la scelta di un termine a "morfema zero" ma anche da "morfo zero", poiché rende una differenza ulteriore tra "zero" che si rilevano nelle forominali e verbali per opposizione fonologica con formazio
dal punto di vista sintattico-semantico e morfologico e (principalmente) si rilevano invece in formazioni nominasizione sintattico-semantica e morfologica con basi analo-
tah.-olta identiche) ad esse dal punto di vista fonologico. Il terIJroposto qui è "zeromorfo" per entrambe le categorie di "zero"
nella morfologia - come in P è unico il termine tecnico comu-11.60 + 62), intese quale "realizzazione concreta fonologi-
pari a zero di un dato morfema nella posizione di quel dato . Dati i precedenti casi di adozioni di termini tratti dalla lin
ai. 57, si potrebbe forse anche per lo "zero" prendere in consil'ipotesi di impiegare in morfologia il termine lopa- invece
proposto "zeromorfo", tentando di adattare anche le distinzio(e la terminologia corrispondente) operate da P all'interno
categoria, verificando la funzionalità metalinguistica e descritmodello di P sulla morfologia di altre lingue88 •
una brevissima rassegna esemplificativa vedi PONTILLO 2001 a C.d.5. § l.
è difficile in via preliminare ind!viduare, ad es. nella lingua gr., formazioni essere descritte come casi di SLU (il tipo dei verbi atematici con raddop
fr. P II.4.75 s.), come casi di LUP (vedi PONTILLO 2001 b C.d.5.), come casi di flessione verbale la coniugazione atematica - cfr. P 11.4.72, in quella nomina-
i casi forti adesinenziali di sostantivi nl. del tipo aaTu "cittadella" - cfr. P c i loc. adesinenziali come gr. aLEv "sempre", avv. da loc. cfr. aLwv nom. tempo" - cfr. P VII.1.39, nella morfologia derivativa il tipo èi.j'LOV "pera" : amoç
p IV.3.163, nella composizione i primi membri di composto in stato tematiche flessi - cfr. P 11.4.71), come casi di lopa- (come termine tecnico specifico) di
"ad es. nel nom. m. sg. asigmatico dei temi della III declinazione con allunga-
),1, '
164 Tiziana Pontillo
6. Appendice: alcuni contributi alla ricostruzione del modello di zero nella morfologia di P
Il primo testo ad occuparsi sistematicamente dello "zero" in P è Aigr. II.2, § 1-15.
Risulta chiaro che la teoria appartiene alla linguistica sincronica e si distinguono i nomi radicali quali nomi verbali senza suffisso dai nomi con mutamento semantico senza un equivalente morfologico di tale mutamento. Sono presentate le diverse formazioni, secondo un ordine strettamente morfologico, i primi, e, per gruppi di significato paragonabile, i secondi, dato che aiuta a comprendere il fenomeno concretamente: sono indicati tra parentesi gli estremi dei sutra- di P o dei Vt. corrispondenti. Non risulta in alcun modo però che si tratta di regole morfologiche specifiche fissate rispetto a regole generali di formazione: non si richiama P LI.56 come regola di ordine superiore rispetto a LI.60-63. In compenso non si commette l'errore di tradurre "lopa-" come "Schwund" (B), "elision' (V), "amuissement, chute" (R; RT). Debrunner propone infine un'interessante lettura dei casi di LUP quale fenomeno sostanzialmente retorico, classificando le formazioni che ne risultano come "metonirnie"89.
Solo un anno più tardi esce il contributo di ALLEN 1955 già ricordato. Nel 1962-1963 escono due articoli di Pandit (PANDIT 1962; PANDIT 1962-1963), che, insieme con altre osservazioni presentate in PANDIT
mento della vocale finale del tema - cfr. P VI.1.68), come casi di lopa- di un suffisso fittizio di derivazione primaria (nel tipo più volte citato <pJc6l; o come II membro di composto e senza cambiamento della vocale della base nel tipo XÉQ-VLtjJ "abluzione"). È evidente tuttavia come l'adattabilità del modello debba essere ponderata e i riscontri di ciascuna categoria proposta da P vagliati con attenzione. Difficilmente il modello studiato per l'ai. potrà essere applicato di peso a repertori di lingue differenti, come è risultato da analoghe trasposizioni. L'obiettivo esula tuttavia dai fini della presente indagine.
89 Nella medesima direzione sembra andare la proposta di PENNANEN 1982, pp. 245 s. di definire "metonimia" e in particolare "pars pro toto" i composti balzuvrIhi- "composti attributi" intesi da MARCHAND 1969, pp. 13 s. come "Combinations with a compound determinans and a zero determinatum". p in effetti però individua una formazione con zero fonologico introdotto con termine tecnico LUK solo nel caso dello dvigu- "compo_ sto determinativo che ha come primo membro un numerale", mentre per i bahuvrIhiprevede un'altra soluzione: I1.2.24 "anekmll anyapadiirthe" (vedi RADICCHI 1982-1988, 2, p. 48). I Vt., come segnala RADICCHI 1982, 2, p. 49, propongono alcune integrazioni alla regola che impiegano il metodo di lopa-, ma non è deducibile da P lo stesso procedimento, tra le quali: "saptamyupamiinapurvapadasyottarapadalopa," ca". L'interpretazione dei ballUvrIhi- e dunque dei composti ritenuti più antichi nelle lingue ie. - come "mutazione della categoria grammaticale" si trova già in HOENIGSWALD 1937, p. 270.
'''2..701110rfi'' in Pfil,1ini: regole specifiche di formazione ... 165
nUOvi argomenti da lui accostati allo zero in P, precisae lo zero matematico, costituiscono la monografia del
:esso studioso, dal titolo "Zero in Pii1J.ini" (in modo particoargomenti inerenti il tema della presente ricerca, P ANDIT
20-42 coincide con PANDIT 1962; PANDIT 1990, pp. 43-75 con 1963, pp. 77-94). Nel 1967 Al-George pubblica un articolo
inquadrare la teoria linguistica dello zero in P in una più della forma. Esclusa evidentemente dagli scopi di quel
è ogni osservazione sulla portata linguistica del fenomeno daP.
1978 Varma pubblica una monografia dal titolo significativo and Elision". Si sostiene che lopa- sia un'elisione e adarsana- di m-appearance (i.e. 'non-occurrence')". La distinzione tra lopanon è usata come elemento-guida nella presentazione delle , si fa riferimento all'intera gamma di regole presentate da P.
!ilnsiderare che per LUP gli unici due es. citati sono IV.2.81 e 23; 37; 51 s.).
1981 è dedicato un intervento specifico nella Fifth World Sanskrit (DAS 1985). Permane quello che sembrerebbe un errore nel
:razione delle "regole specifiche di formazione con zero fonoome "elisioni", che presupporrebbero dunque una sequenza,
.ematizza ordinatamente la varietà dei fenomeni linguistici TI maggiore pregio della sintesi consiste nell' aver messo in
operazioni determinate sulla base dai suffissi malgrado siano Non si offre tuttavia una visione completa né delle definizioni delle regole operative effettivamente introdotte e sono pochi gli citati. Anche rimanendo nell'ottica dell'''elisione'', non sembra
la definizione di "elisione totale" di suffisso per i casi intro-P I.1.62: si dovrebbe comunque precisare che, dato il modo di
i suffissi come causa diretta di operazioni fonologiche sulla . si applicano, si tratti al più di "elisione parziale", avendo effetperazioni come se il suffisso fosse virtualmente presente.
però l'impostazione risponde all' esigenza di distinguein cui la regola di lopa- si applichi all'intero suffisso da quelli in
applica a solo uno o più foni del suffisso indicato.
1111,
166 Tiziana Pontillo
Dalle monografie e dalle opere generali di argomento pal).iniano viene concesso poco spazio all'argomento. Non si trova in genere una visione complessiva del fenomeno, anche per peculiarità quali il rapporto tra aspetto semantico, sintattico, morfologico e fonologico delle regole: non si sottolinea che i quattro termini sono definiti artha-samjfi.li e non sabdasan:zjiili: si fondano dunque sul "significato" e non sulla "forma". Si veda ad es. MrSRA 1966, pp. 23 s. e SrNGH 1991, pp. 93; 3539°. Solo RT II, 75 richiama il "significato", ma a proposito di lopa- di un pada- intero, ad esempio dell'avverbio interrogativo kim (VIII.1.45). La condizione di lidesa- e di sthlinivadbhava- è ricordata da ABH., p. 335 ma solo a proposito di lopa-91 •
Particolarmente illuminante è invece la trattazione del "positing zero replacement" di CARDONA 1997, § 670-6, che, pur non menzionando la distinzione terminologica tra lopa-, LUK, LUP e SLU (ma nel § 79 spiega I.1.62 s. come discrimen assoluto tra lopa- e gli altri tre termini), chiarisce l'origine e lo scopo del sistema dello zero in P. Fa notare come il procedimento di P secondo anvaya- "connessione" e vyatireka- "differenza" permetta di astrarre sia le basi sia gli affissi e di individuare formazioni che, pur mancando di espliciti affissi per il loro significato, possono essere paragonabili ad altri dotati di suffissi. Non si adotta un sistema in cui ci sono "morpheme-classes of allomorphs, including zero morphs": "In a derivational system like Pal).ini's, in which initial strings must contain bases with specific affixes, another procedure is preferable. Overt affixes are allowed to occur in initial strings, and they are subsequently replaced by zero". Secondo CARDONA 1997 è proprio l'astrazione di basi e affissi e l'assegnazione di significati particolari ad essi, mediante procedimenti del tipo anvaya- / vyatireka-, che impone la teoria del "positing zero replacements" per certi elementi nel sistema derivazionale di P. Non pare corretta tuttavia la presentazione del fenomeno come una sequenza.
'" MISRA 1966, ad esempio, si limita a descrivere due tipi di zero: illlO positivo (lopa-) e illlO negativo (LU-) e concepisce il primo come funzione capace di regolare sé e la formazione cui si applica e il secondo limitato a se stesso.
91 Relativamente al solo LUP, sono inspiegabili la mancata precisazione del tipo di suffisso, esclusivamente taddhita- "suffisso nominale di derivazione denominale", da parte di RT, ABH., MISRA 1966 e la seconda opzione proposta da ABH. per definire LUP: "disappearance of an affix or its part".
"'7ntlmflrfi" in Pa1Jini: regole specifiche di formazione ... 167
monografia di PANDIT 1990 è dichiaratamente studiare oi zero used by Pal).ini in its entirity" (p. 19). Le tesi fon-
in P è solo un "logical device" (p. 20); in P è anche un concetto positivo per la regola simmetri
dello zero permette di eliminare una regola specifi-
sulla "forma massima" e spiega con zero la minima e _ 23) 92;
distingue quale "a zero related to grammatical circum"~,,,--eSSityH rispetto all' avaslina- "absolute zero" (pp. 25 s.).
essere completamente d'accordo con il punto 2): poiché :onosciuta la differenza tra i due tipi di "zeromorfo", la
fonologica pari a zero è propria sia dei primi sia del né per i primi né per il secondo si esclude l'applicazione
di affissazione) simmetrica, piuttosto si applica una 5aZi.one) simmetrica la cui realizzazione fonologica è per i primi si ha una simmetrica realizzazione fonologi-monerna, nel secondo caso no, perché il morfema auto
solo uno "zeromorfo" come suo morfo. Non si escludi una regola né per i primi né per il secondo, piut
una regola specifica di formazione con zero fonologico 3) allora non è adatto evidentemente a descrivere
poiché la "forma massima" è astratta, ossia comprencon realizzazione fonologica pari a zero che non dà
maggiore, a meno di intendere appunto la "forma atta, virtuale93
• Non si può che concordare invece per il fatto che mentre avaslina- è uno zero richiesto
p. 57 55. che espone il concetto di "fattorizzazione" che nella spiegare r mluvrtti-: si procede alle formazioni linguistiche dopo
re com illle" .
rive indifferentemente "non-appearance" e "disappearance" senza distinguere i due concetti, dei quali il primo dovrebbe
'O:_~J. Dalle stesse pp. si deduce che Pandit intende lopa- come illl : iIIIlb"JOlnoarsa segue la scomparsa, ossia si ha una sequenza di opera-
,I
'1111
168 TlZiana Pontillo
dalla lingua, lopa- è uno zero richiesto dalla linguistica, ma non si trova una ragione di immaginare prima percepito e poi non percepito un morfema né di paragonare i due procedimenti sul piano linguistico. Avasana- è in opposizione con qualsiasi segmento linguistico, mentre lopa- è in opposizione con un preciso morfema. Solo il secondo è effettivamente uno zero linguistico.
Nel § 4.7 PANDIT 1990, a proposito dell"'express zero" "on the morphemic level" distingue "the loss of the morpheme (1) in the beginning (2) in the middle and (3) in the end"94. Inspiegabilmente nel § 4.8.2 limita solo a quest'ultimo un'ulteriore distinzione: "The end-morphemes are alI those which are applied at the end to form alI the verbal conjugational and nominaI declensional forms and primary (the krt) and secondary (the taddhita) derivatives. In the loss of these morphemes, P. has two technical divisions a) the potent or strong loss or zero and b) the impotent or weak loss or zero". "a) In the case of the potent or strong zero, the termination or the sound or any entity for that matter which disappears retains even after disappearing its potent power to bring about any modification viz. gur;a or vrddhi or accentuation etc. in the stem. The loss of such terminations is laid down by the express term lopa, defined in the generaI definition of 10pa viz. adarsana1(llopal:z 1.1.60". "b) As opposed to this, in the case of the impotent or weak zero, the termination after its disappearance loses its power ofbringing about any modification in the stem. The loss of such terminations is given by the three terms luk, s1u and lup defined in 1.1.61: pratyayasya luk-s1u-Iup".
È lecita la distinzione tra inizio, centro e fine per individuare la posizione del segmento sostituito con zero fonologico, ma è necessario precisare che non si tratta di una distinzione sottolineata da P, che non introduce infatti una terminologia propria per i tre casi distinti. La classificazione risulta addirittura fuorviante se non si tiene conto a priori di una netta separazione tra regole di lopa- di un fono o di un morfema, di un intero suffisso o di una parte dello stesso, di un fono menzionato quale parte di un suffisso o di un altro morfema oppure menzionato in assoluto. Anche gli es. della monografia sono tratti da ambiti diversi su questo piano, senza precisame le differenze.
94 Pandit in questa sezione non intende distinguere precisamente i pratyaya- flessionali da quelli di derivazione, poiché solo nella II Appendice (pp. 140-176) introduce tale dicotomia, designandoli rispettivamente con i termini" closing pratyaya-" e "non closing pratyaya-". Cfr. PANDIT 1989, 1,1, p. 7.
~Zs:onwrfi" in Par;ini: regole specifiche di formazione ... 169
"10ss of the morpheme in the beginning" PANDIT 1990, p. 30 Gasi di lopa- della sillaba di raddoppiamento, che P presenta invedi un mìga-; come es. di "loss of the middle morpheme", che spe!!hai which is inserted between the stem, verbal or nominaI, and
,ffre un caso di LUK di sIC (-s- di aoristo sigmatico atemaad altri casi, tutti di LUK di morfemi; solo per gli "endlopa- da LUK, SLU e LUP, per mostrare 1'opposizione tra
ng 10ss or zero" e "the impotent or weak 10ss or zero", ma regole di LUK come es. di "middle morpheme". In effetti sia
morplzeme" sia quelli di "end-morpheme" costituiscono, nella morfemi para- "che vengono dopo" (P Il1.1.1-2), in quanto
del resto su quali dati si fondi la monografia di PANDIT se presupponga una rassegna tipologica completa di SLU, LUP e LUK. A p. 105 infatti dichiara che la categorie di unità soggette a zero sono morferni,
indagine, condotta (almeno nelle intenzioni) su te disponibile in P, si è ricavato che il divario tra
,le di Iopa- di foni e quelle di Iopa- di morferni non è contro 116 (di cui 25 regole di lopa- di VIi 3 di SLU,
di LUK). Queste indicazioni sono tuttavia solo basate :sono regole che possono produrre forme teoricamente
:m.eno quelle che prevedono opzioni proprie di un'immentre PANDIT 1990 potrebbe fondarsi su una
dell'applicazione delle regole (o di un campione di . esposte in PANDIT 1971. Pandit potrebbe inol
alla varietà di categorie morferniche, che è indiscudi quella dei fonemi in qualsiasi lingua.
to scrive PANDIT 1990 a p. 33 (§ 5): "The sutra g zero defined by the word Iopa the power of .bcation is 1.1.62 [ ... ] and the sfltra, which pro-
.laid down by the terms luk, SLU and lup to exerciabout any modification, is 1.1.63 [ ... ]. It should be
this two-fold division of the zero is applied only not to any other category such as abhyasa or .ti or
sembra opportuno osservare che la presenP 11.62 s. è iinprecisa, perché" any modifica-
"jll!
Il,
170 Tiziana Pontillo
tion" è determinata da I.1.56 per qualsiasi tldesa- e non da 1.1.6295• Nel § 4.8.2 precisa "in the stem", ma manca un riferimento a I.1.56 e alla distinzione tra aspetto fonologico e non96•
Davvero utile è invece la lettura di Pandit 1990 del fenomeno di lopa- in termini di analisi posizionale, lettura che rende possibile l'avvincente prospettiva del confronto tra zero linguistico e matematico (pp. 95-117).
95 Che Pandit non abbia presente la connessione tra I.l.56 e 1.1.60-63 si deduce dall'osservazione di pp. 87 s.: per definire lopa- un tidesa- cita solo M.
% Vedi ad es. PANDIT 1990, pp. 34 s. Non sembra sufficientemente provata la presentazione del funzionamento di iopa- di affisso VI: (p. 33): "The same example of the end morpheme which is given above while discussing the express loss of an ap[kta-sound wiII do to show the working of the strong zero as well as the loss of the whole end-m orpheme. It wiII be seen (cf. the various stages in grammatical operations laid down there) that though the beginning 1.1 of the termination l.1vi goes away, it is capable of bringing about the vrddhi of the vowel viz. a in the root blwj since its disappearance takes pIace by the word iopa (cf. tasya iopab 1.3.9)". Vedi anche PANDIT 1990, p. 48. È vero che si applica l'operazione segnalata dall'anubandha- IJ, ma andrebbe verificato se il lopa- non si applichi all'intero morfema e dunque non sia da esçludere l'effetto di iopa- dell'anubandha- (1.3.9), perché la distinzione tra iopa- e LUK, SLU e LUP - come del resto scrive poco prima anche Pandit - è valida solo per i pratyaya- "affissi" (cfr. 1.1.61). La stessa confusione tra a/zubandha- "contrassegno" e segmenti linguistici risulta da pp. 67 s. È corretto invece quanto PANDIT 1990 scrive in proposito a pp. 33 s. Iliopa- di anubandha- tuttavia esula dall' oggetto della presente indagine, che è ristretta allo zero nella morfologia di p.
~ZiI __ lrfi" in Piil.lini: regole specifiche di formazione ... 171
LEGENDA
aor. = aoristo; es. = esempio; f. = femminile; gen. = genitinom. = nominativo; p./pp. = pagina/pagine; perso = per
preso = presente; r./ rr. = riga / righe; s. /5S. = = singolare; strum. = strumentale; voc. = vocativo.
con la maiuscola tutti i contrassegni (anubandha-), ogni :nella grammatica solo al fine di facilitare la pronuncia, ogni im:piieg<lto dai siltra- di P che non abbia una realizzazione
nella lingua, compresi gli affissi fittizi. Si è consci distinction between language and metalanguage
.' .graphical means" e dell'impossibilità allo stato .i ricostruire il metodo preciso di recitare i siltra- con la vocali nasalizzate e accenti introdotti a fini metalingui
p. 488): si impiegano comunque segni non proprii del 'ttura per realizzare graficamente una distinzione ria della grammatica indiana, ma decisamente pra-
alla Prof. C. Milani, che mi ha guidato per l'intedi dottorato - sui risultati della quale si basa que
costantemente letture e percorsi appro-intrapresa. Desidero ringraziare il Proi. U. Rapallo
la generosità e la pazienza con le quali hanno )mande e per le preziose osservazioni destinate al
errore sono invece la sola responsabile.
172 Tiziana Pontillo
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
ABH. = KV Abhyankar, A Dictionary oj Sanskrit Grammar, (Gaekwad's OrientaI Series 134), Baroda 19863•
Aigr. = Altindische Grammatik ; I = von J. Wackemagel, 1. Lautlehre, G6ttingen 1896; II,l = von J. Wackemagel, II, 1. Einleitung zur Wortlehre. Nominalkomposition, G6ttingen 1905; II,2 = von A Debrunner, II, 2. Die Nominalsuffixe, G6ttingen 1954; m,l = von A Debrunner und J. Wackemagel, III. Deklination der Nomina. Zahlw6rter-Pronomina, 1. Teil (Seite 1-368), G6ttingen 1929; m,2 = von A Debrunner und J. Wackemagel, m. Nominalflexion-ZahlwortPronomen, 2. Teil (Seite 368-602), G6ttingen 1930; N. 1 = von A Debrunner, Nachtriige zu Band I, G6ttingen 1957; N. II = von A Debrunner, Nachtriige zu Band ILl, G6ttingen 1957; R = R Hauschild, Register zur Altindischen Grammatik (Bd. I-III), G6ttingen 1964.
AL-GEORGE 1967 = S. AI-George, The Semiosis ojZero according to Pi11J-ini, "East and West" 17 (1967), pp. 115-124.
AL-GEORGE 1969 = S. AI-George, Sign (Lak!)aI).a) and Propositional Logic in Pi11J-ini, "East and West" NS. 19,1-2 (1969), pp. 176-193.
ALLEN 1955 = W.s. Allen, Zero and Pi11J-ini, "Indian Linguistics" 16 (1955), Chatterji Jubilee Volume, pp. 106-13.
ANDERSEN 1994 = H. Andersen, Le lingue slave, in A Giacalone Ramat e P. Ramat, Le lingue indoeuropee, Bologna 19942, pp. 441-79.
ANDERSON 1992 = S. R Anderson, A-Morphous Morphology, Cambridge 1992.
B = Pi11J-ini's Grammatik, hrsg., iibers., erL und mit versch. Indices versehen von O. B6htlingk, Leipzig 1887.
BALLY 1909 = Ch. BaUy, Traité de Stylistique française, 2 Volumes, Heidelberg 1909.
BALLY 1922 = Ch. Bally, Copule zéro et jaits connexes, "Bulletin de la Societé de Linguistique" 23 (1922), pp. 1-6.
BALLY 1932 = eh. Bally, Linguistique générale et linguistique francçaise, Paris 1932.
BAPAT 1993 = Theory oj Apoha and its Significance in Dharmaklrti's Philosophy, "Annals of the Bhandarkar OrientaI Research Institute"
__ ,J1rli;- in Pii1.lini: regole specifiche di formazione ... 173
lri4:iìIll!l!mll1t5!Wa Supplementary Volume, Poona 1994, pp.
Against Word-Based Morphology, "Linguistic
pp. 508 s. English Word-Formation 1983.
.t::J Bazell, On some asymmetries oj the linguistic " 5 (1945-49), pp. 139-45.
J Syntactic Relations and Linguistic Typology, de Saussure" 8 (1949), pp. 5-20.
Benedetti, I composti radicali latini. Esame storico e
rretta, Formazione di parola, derivazione zero, e dell'italiano lingua seconda, "Rivista Italiana
(1986), pp. 45-77. Sri Kavyalamki1ra, ed. tr. P-Y. Naganatha Sastri,
English Verb Inflection, "Language" 23,4(1947),
-= B. Bloch - G.L. Trager, Outline oj Linguistic 1942-Bloornfield, Language, London 1935 [New York
Grammatik der Sanskrita-Spraclze in kii.rze-
Glossarium Comparativum Linguae Sanscritae,
Encyclopaedia oj Linguistics (Editor in chief (Oxford University Press), 4 volL
Bronkhorst, The Role oj Meanings in Pi11J-ini's .t:inguistics" 40 (1979), pp. 146-157.
Bronkhorst, A Note on Zero and the Numerical i\ncient India, "Asiatische Studien - Études
pp. 1039-1042.
174 Tiziana Pontillo
BURROW 1955 = T. Burrow, The Sanskrit Language, London 1955. BUGMANN 1983 = H. BufSmann, Lexikon der Spraclzwissenschaft, Stuttgart
1983.
BUGMANN 1990 = H. BufSmann, Lexikon der Spraclzwissenschajt, Zweite, v611ig neu bearbeitete Auflage. Unter Mithilfe und mit Beitragen von Fachkolleginnen und -kollegen, Stuttgart 1990.
CARDONA 1967 = G. Cardona, Pti1J-ini's syntactic categories, "Joumai of the OrientaI Institute (Maharaja Sayajirao) University of Baroda" 16,3 (1967), pp. 201-215.
CARDONA 1967-1968 = G. Cardona, Anvaya and Vyatireka in Indian Grammar, "The Adyar Library Bulletin" 31-32 (1967-8), Dr. V. Raghavan Felicitation Volume, pp. 313-352
CARDONA 1974 = G. Cardona, PtilJini's Karakas: agency, animation and identity, "Joumal of Indian Philosophy" 2 (1974), pp. 231-306.
CARDONA 1976 = G. Cardona, Some Features of PalJinian Derivations in History of Linguistic Thought and Contemporary Linguistics, ed. H. Parre t, Berlin-New-York 1976, pp. 137-158.
CARDONA 1997 = G. Cardona, palJini. His Work and Its Traditions, 1. Background and Introduction, Delhi 19972•
CHATTERJI 1964 = K.c. Chatterji, Technical Terms and Technique of Sanskrit Grammar, Part I, Calcutta 1964.
CLARK-CLARK 1979 = E.Y. Clark - H.H. CIark, When nouns surface as verbs, "Language" 55 (1979), pp. 767-811.
CLC = F. De Saussure, Cours de linguistique génerale, publié par Ch. Bally et A Sechehaye, avec la collaboration de A Riediinger, Paris 1922 [Lausanne - Paris 1916].
COLLINDER 1962-8 = B. Collinder, Les origines du structuralisme, "Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis", n.s., I (1962-8), pp. 1-15.
CRoceo CALÈAS 1990 = G. Croceo Calèas, Gli Etnici italiani. Studio di morfologia naturale, Padova 1991 (Quaderni Patavini di Linguistica, Monografie, 9).
CUTLER - HAWKINS - GILLIGAN 1985 = A Cutler - J.A Hawkins - G.
Gilligan, Tlze Suffixing Preference: a Processing Explanation, "Linguistics" 23, 5 (1985), pp. 723-758.
DAS 1985 = K. Das, On Concept of Elision as a Phenomenon in Pa1J-ini's
1difìl!1l'>!M'la,t7" in Pa/Jini: regole specifiche di formazione ... 175
Proceedings of the Fiftlz World Sanskrit Conference, 21-26,1981, New Delhi 1985, pp. 131-37.
= M. Deshpande, Bespr. Patafijali's VyakaralJarmadharayalmika (P. 2.1.51-2.1.72), Edited with Notes by S.D. Joshi and J.AF. Roodbergen, Poona
Literaturzeitung" 72 (1977), pp. 618-622. M. Deshpande, Evolution of Syntactic Theory in
Syntax of the Sanskrit Infinitive -tumUN Studia 10), Ann Arbor 1980.
lv[ Deshpande, Recent Studies in Pataiijali's "Orientalistische Literaturzeitung" 75
Deshpande, El/ipsis and Syntactic Overlapping: illUzn Syntactic Theory, Poona 1985.
Deshpande, Pa1J-inian Syntax and the Changing $ Annals of the Bhandarkar OrientaI Research pp_ 55-98. I. Deshpande, Ellipsis in modern Linguistics and Bbandarkar OrientaI Institute" 70 (1989), pp.
Deshpande, Semantics of Karakas in Pavini: an and Linguistic Issues, in B.K. Matilal- P. related Studies: contemporary Researches and
ti Garib Dass OrientaI Series 84), pp. 33-57. Di,t~tii:ma:nJ ofSanskrit on Historical Principles (gen.
Foona 1976-78 IL Poona 1979.
Affixation, in International Encyc/opedia l,pp. 30 s. Studies in palJini. Teclznical Terms of the
176 Tiziana Pontillo
F = Le Mahabhafiya de Pataiijali avec le Pradlpa de Kaiya.ta et l'Uddyota de Nagesa, traduction par P. Filliozat, Pondichéry 1975-86-: FI = I, Adhyaya 1 Pada 1, Alznika 1-4; FII = II, Adhyaya 1 Pada 1, Almika 5-7; FIn = III, Adhyaya 1 Pada 1, Almika 8-9; FIV = IV; Adhyaya 1 Pada 2; FV = V, Adhyaya 1 Pada 3.
FILLIOZAT 1988 = P.S. Filliozat, Grammaire Sanskrite et Par;inéenne, Paris 1988.
FREI 1950 = H. Frei, Zéro, vide et intermittent, "Zeitschrift fur Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft" 4 (1950), pp. 161-191.
GLEASON 1955 ::= H.A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, New York 1955.
GODEL 1953 ::= R. GodeI, La question des signes zéro, "Cahiers Ferdinand de Saussure" 11 (1953), pp. 31-41
GODEL 1957 = R. GodeI, Les Sources Manuscrites du Cours de Lingl.listique Générale de F. de Saussure, Genève-Paris 1957.
GUSMANI 1984 = R. Gusmani, Motivazione linguistica, "Incontri Linguistici" 9 (1984), pp. 11-23.
HAAS 1954 = W. Haas, On defining Linguistic Units, "Transactions of Philological Society" London 1954, pp. 54-84.
HAAS 1957 ::= W. Haas, Zero in linguistic description, in Studies in Linguistic Analysis, Oxford 1957, pp. 33-53.
HARRIS 1942 ::= Z.S. Harris, Morpheme Alternants in ling1.listic Analysis, "Language" 18 (1942), pp. 169-80.
HARRIS 1951 = Z.S. Harris, Structural Linguistics, Chicago 1960 [=Methods in Structural Linguistics, Chicago 1951].
HJELMSLEV 1948 = L. HjeIroslev, Le verbe et la phrase nominale, in Mélanges de Philologie, de Littérature et d'Histoire anciennes offerts à f. Marouzeau, Paris 1948, pp. 253-8l.
HJELMSLEV 1968 ::= L. Hjelmslev, I Fondamenti della Teoria del Linguaggio, Intr. e Trad. di G.c. Lepschy, Torino 1968 [Wisconsin 1961].
HOCKETT 1947 = c.F. Hockett, Problenzs of l'vfOl"'nI»>mir
"Language" 23, 4 (1947), pp. 321-343. Analysis,
HOENIGSWALD 1937 = H.M. Hoenigswald, Su vazione e della composizione dell'Istituto Lombardo"(Lett) 15
mrotteri della deriNRendiconti
"Zeromorfi" in Pa1Jini: regole specifiche di formazione ... 177
HOENIGSWALD 1946 ::= H.M. Hoenigswald, Sound Change and Linguistic Structure, "Language" 22,2 (1946), pp. 138-143.
HUECKSTEDT 1995 = R. A. Hueckstedt, Nearness and Respective Correlation. A History of the Interpretations of As.tadhyayI VI.1.77: iko yar;. aei, Wiesbaden 1995.
lAMARTINO 1994 ::= La grammatica del lessico inglese: prospettive di analisi, in La grammatica inglese e il suo insegnamento, a cura di G. Porcelli (Quaderni del Centro di Linguistica dell'Università Cattolica, 6), Brescia 1994, 2, pp. 49-86.
JAKOBSON 1939 ::= R. Jakobson, Signe Zéro, in Mélanges de Lingustique offerts à Ch. Bally, Genève 1939, pp. 143-152.
JOSHI 1971 ::= D. M. Joshi, On expressing Karakas a propos of par;.ini 2.3.1, "Indian Linguistics" 32,2 (1971), pp. 107-112.
JosHI-RoODBERGEN 1982 = S.D. Joshi - J.A.F. Roodbergen, The Structure of the A;;.tadhyayT in Historical perspective, Proceedings of the Intemational Seminar on Studies in the A.s.tadhyayT of Pàl).ini, held in July 1981, ed. S.D. Joshi - S.D. Laddu, Pune 1982 (Publications of the Centre of advanced Study in Sanskrit-Class E, n° 9), pp. 59-95.
K ::= A.s.tadhyayT of Par;ini, ed. transl. S. Katre, Austin 1987. K83 = Kasika: Nyasa or Paiicika Commentary of Acarya Jinendrabuddhipada
and PadamaiijarT of Haradatta Misra on the Kasikiivrtti [Commentary on the A.s.tadhytiyT of Ptir;.ini] of Vamana-Jayaditya critically edited by S.D.D. sastri - K.P. Shukla, Varanasi 1983-85, 6 vols.
KAPLAN 1999 ::= R. KapIan, Zero. Storia di una cifra, Milano 1999. KASTOVSKY 1969 ::= D. Kastovsky, Wortbildung und Nullmorphem, "Lin
guistiche Berichte" I,2 (1969), pp. 1-13. KASTOVSKY 1980 = D. Kastovsky, Zero in Morphology: a Means of Making
up for Phonological Losses?, in J. Fisiak (ed.), Historical Morphology, The Hague 1980, pp. 213-50.
KASTOVSKY 1985 ::= D. Kastovsky, Deverbal Nouns in Old and Modern English: from Stem-Formation to Word-Formation, in J. Fisiak (ed.), Historical Semantics. Historical Word-Formation, Berlin - New York -Amsterdam 1985 (Trends in Linguistics. Studies and Monographs 29), pp. 221-261.
KASTOVSKY 1986::= D. Kastovsky, The Problem of Productivity in Word Formation, "Linguistics" 24 (1986), pp. 585-600.
178 Tiziana Pontillo
KATAMBA 1993 = F. Katamba, Morphology, Londonl993. KATRE 1937-1938 = S.M. Katre, Materials for a UJ7.i'ltuJ~tim
I, "Indian Culture" IV (1937-38), pp. 485-493. KIPARSKY 1979 = E Kiparsky, Pa7Jini as a Variationist, KIPARSKY - STAAL 1969 = E Kiparsky - J.F. Staat
Relations in Pa7Jini, "Foundations of Language" 5 KUMARASWAMI RAJA 1970 = N. Kumaraswami Raja,
unities in the linguistic analysis, "Indian Linguistics'" pp. 41-8.
KUNJUNNI RAJA 1957 = K. Kunjunni Raja, iilii1ì~}: Syntactic Unity, "Adyar Library Bulletin" 21
KURYWWICZ 1936 = J. Kury""owicz, Dérivatimz
Semantic
syntaxique (Contribution à la Théorie des Parties du D;k:all\u-~\ de la Societé de Linguistique" 37 (1936), pp. 79-92.
KURYWWICZ 1964 = J. Kuryl:owicz, The inflectionall R;til'l:'lI'~;rTM''S'. Indo-European, Heidelberg 1964.
LIEBER 1981 = R. Lieber, Morphological C01iversion Ttstrictive theory of the lexicon, in M. Moortgat - H.V. d. HuJ!.'1: - T. Hoekstra (eds.), The Scope of lexical Rules, Dordrecht 1981" pp. JlJI:U.-J:..uu.
LIPKA 1992 = L. Lipka, An Outline of English Edition, Tiibingen 1992.
LYONS 1971 = J. Lyons, Introduzione alla linguistica M = The Vyakarana-Mahabhashya of Patafijali ed. F. Kielhom
Osnabriick 1970 [Bombay 1880-85].
1971. l; il; ID,
MAGGI 1994 = D. Maggi, Sui Termini della LinguistiCA kttico-Imiiana GUl).a- e Vyafijana-, in Miscellanea di studi linguistici ~'~1Iter Belardi, Roma 1994, pp. 1043-1063.
MAHAVIR 1978 = Mahavir, Pa7Jini as Grammarian (1'vith TI!lIi'n!lICe fo compound formations), Delhi 1978.
MAHAVIR 1984 = Mahavir, Samartha Theory of St"11tence Derivation, Delhi 1984.
MARCHAND 1966 = H. Marchand, On attributive and Pr!:dj,;loltlf:t'lf:'
Adjectives and Some Problems Related to the DistiuctiClt, (1966), pp. 131-149.
MARCHAND 1969 = H. Marchand, The Categories and English Word-Formation, Miinchen 19692•
"Zeromorfi" in Pi17Jini: regole specifiche di formazione ... 179
MARCHAND 1974 = H. Marchand, A Set of Criteria for the establishing of derivational Relationship between Words· umnarked by derivational Morphemes, in D. Kastovsky (ed.), Studies in Syntax and WordFormation. Selected Articles by Hans Marchand, Miinchen 1974, pp. 242-252.
MARTINET 1960 = A. Martinet, Éléments de Linguistique générale, (Collection A. Colin, 349, Section de Littérature), Paris, 1960.
MARTINET 1969 = Linguistique. Guide Alphabhétique, sous la direction de A. Martinet, avec la collaboration de J. Martinet e H. Walter, Paris, 1969.
MATILAL 1971 = B.K. Matilal, Epistemology, Logic and Grammar in Indian Philosophical Analysis, The Hague - Paris 1971-
MATTHEWS 1979 = EH. Matthews, Morfologia. Introduzione alla teoria della struttura della parola, Bologna 1979 [Cambridge 1974].
MATTHEWS 1993 = EH. Matthews, Grammatical Theory in the United States from Bloomfield to Chomsky (Cambridge Studies in Linguistics, 67), Cambridge 1993.
(DE) MAURO 1972 = F. De Saussure, Cours de linguistique génerale, publié par Ch. Bally et A. Sechehaye, avec la collaboration de A. Riedlinger, Elldition critique préparée par T. De Mauro, Paris 1972.
MEIER 1961 = G.F. Meier, Das Zéro-Problem in der Linguistik (Schriften zur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung nr. 2), Berlin 1961-
MEILLET 1903 = A. Meillet, Introduction à l'etude comparative des langues indoeuropéennes, Paris 1903.
MEL'C:UK 1976 = 1. Mel'èuk, Die Konversion als morphologisches Mittel, in 1. Mel'èuk, Das Wort, I, Miinchen 1976, pp. 288-318.
MISRA 1966 = V.N. Misra, The Descriptive Technique of Pa7Jini, (Janua Linguarum. Studia Memoriae Nicolai van Wijk Dedicata. Series Practica xvrn), The Hague 1966.
NIDA 1946 = E.A. Nida, Morphology, the Descriptiv Analysis of Words, 2. Ed. Un. Michig. PubI. Ling. il, Ann Arbor 1946.
NIDA 1948 = E. Nida, The Identification of Morphemes, "Language" 24,4 (1948), pp. 414-41-
OnHARA 1958 = Y. Ojihara, Causerie Vyakara7Jique: 1.1.62 vis-à-vis de I.1.56, "Journal of Indian and Buddhist Studies" 6, 1 (1958), pp. 7-10.
180 Tiziana Pontillo
OLSEN 1990 = S. Olsen, Konversion als ein Kombinatorisclzer Wortbildungsprozefl, "Linguistische Berichte" 127 (1990), pp. 185-216.
p = PaDini, A.s.tadhyiiy7. L'opera è citata nell' edizione di Bohtlingk 1887. Vedi B.
PANDIT 1962 = M.D. Pandit, Zero in Piil;ÙÙ, "Joumal of the OrientaI Institute (Maharaja Sayajirao) University of Baroda" 11, 1 (1962), pp. 53-66.
PANDIT 1962-1963 = M.D. Pandit, Piir;.inian it sal1zjiili. A symbolic Zero, "Bulletin of the Deccan College Research Institute" 23 (1962-3), pp. 77-94.
PANDIT 1963 = M.D. Pandit, Some linguistic principles in Piir;.ini's Grammar, "Indian Linguistics" 24 (1963), pp. 50-69.
PANDIT 1971 = M.D. Pandit, Piir;.ini: Statistical Study oj Sanskrit Formations, "Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute" 52 (1971), pp. 175-209.
PANDIT 1975 = M.D. Pandit, FormaI and non10nnal in Pal.1ini, ff Annals of the Bhandarkar OrientaI Research Institute" 54 (1975), pp. 179-192.
PANDIT 1989 = M.D. Pandit, A Concordance of Vedic Compounds Interpreted by Veda, volI, Poona 1989.
PANDIT 1990 = M.D. Pandit, Zero in Piir;.ini, (Publications of the Centre of Advanced study in Sanskrit class. B n° 12), Poona 1990.
PAP 1990 = L. Pap, Sanskrit and Linguistics, in B.K Nfatilal- E Bilimoria (ed.), Sanskrit and related Studies: contempoTary ReseIlTChes and Reflections, Delhi 1990 (Sri Garib Dass Oriental Series 84), pp. 25-32.
PAVESI 1994 = M. Pavesi, Formazione di parole. La conversione in inglese L2, Milano 1994.
PENNANEN 1982 = E.V Pennanen, Remarks in Syntagma and WordFormation, "Folia Linguistica" 16 (1982), pp. 248-249.
PINAULT 1989 = G.-I. Pinault, PaTole articulée et vérité; TTavilUX à paTtir du corpus védique; Piir;.ini et l'enseignement grammatica1; PTocédés pa1J.inéens; Le système de pa1J.ini, in S. Auroux, Histoire des idées Linguistiques, 1, Liege-Bruxelles 1989, p. 293-40l.
PLANK 2000 = F. Plank, Morphological Re-activation and Phonological Alternations: Evidence for voiceless Restructuring in Gerrmall, in A. Lahiri (ed.), Analogy, Levelling, Markedness (Trends in Linguistics: Studies and Monographs, 127), Berlin-New York 2000, pp. 171-92.
"Zeromorft" in Pii1J-ini: regole specifiche di formazione ... 181
POHL 1968 = J. Pohl, Symbole et Langages 1: Le symbole, elef de l'humain, Paris 1968.
PONTILLO 2001 a C.d.5. = T. Pontillo, La prima ricezione del modello morfologico di Piir;.ini nella linguistica occidentale: il caso dello zero, in Idee e parole. Universi concettuali e metalinguistici, a cura di VOrioles (,'Lingue, linguaggi, metalinguaggio" 3, collana diretta da C. Vallini e V Orioles).
PONTILLO 2001 b C.d.S. = T. Pontillo, Derivazione metonimica con zeromorfi di tipo LUP in Piir;.ini, "Atti del Sodalizio Glottologico Milanese" XLI-XLII (2001), (seduta del 19 /06/2000) [C.d.5.].
PRIETO 1971 = 1.J. Prieto, Lineamenti di semiologia. messaggi e segnali, Bari 1971.
PRIETO 1977 = 1.J. Prieto, Signe Zéro, Absence de Signe et Analyse de l'Eanoncé en Signes, "Cahiers Ferdinand de Saussure" 31 (1977), pp. 185-203.
QUIRK-GREENBAUM-LEECH-SVARTVIK 1985 = R Quirk - R Greenbaum - S. Leech - G. Svartvik, A comprehensive Grammar of the English Language, London - New York 1985.
R = L. Renou, La Grammaire de Piir;.ini, traduite du Sanskrit avec des Extraits des commentaires indigènes, Paris 1947-1954,3 vols.
RADICCHI 1982-1988 = A. Radicchi, La teoria pa1J.iniana dei Samiisa secondo !'interpretazione delle scuole grammaticali indiane dal quinto alI'ottavo secolo d.C., Firenze 1982; 1988, 2 volI.
RADICCHI 1987 = A. Radicchi, On ga1J.ilpiiJhas and the gar;.apl{tha ascribed to Piir;.ini, in M. Deshpande (ed.), Par;.ini and the Veda, Panels of the VIIth World Sanskrit Conference, Leiden, August 23-29, 1987, gen. ed. J. Bronkhorst, voI. V, Leiden - New York - K0benhavn - K6ln 1991.
RAPALLO 1994 = U. Rapallo, La ricerca in linguistica, Roma 1994. RO = La Kiisikii-vrtti (adhyiiya I, pada 1): R01, R02 = l"et 2"Partie, trad.
et comm. par Y. Ojihara et L. Renou, Paris 1960; R(0)3 = 3" Partie, trad. et comm. par Y. Ojihara, Paris 1967.
ROBINS 1997 = RH. Robins, Storia della linguistica, Bologna 1997, Nuova Edizione a cura di Antonietta Bisetto. [trad. di A Short History of Linguistics, London, Longman 19974
] [I ed. A Short History of Linguistics, London 1967].
182 Tiziana Pontil1o
RT = L. Renou, Terminologie Grammaticale du Sanskrit, Paris 1942, 3 volL S = RN. Sharma, The A.s.tadhyayz oj par;ini, New Delhi 1987-95-: SI = I.
Introduction to the As.tadhyayI as a grammatical Device; S2 = II. English Translation oj Adhyaya one with Sanskrit Text, Transliteration, WordBoundary, Anuvrtti, Vrtti, Explanatory Notes, Derivational History oj Examples, and Indice; S3 = III. English Translation oj Adhyayas two and three with Sanskrit Text, Transliteration, Word-Boundary, Anuvrtti, Vrtti, Explanatory Notes, Derivational History oj Examples, and Indices, New Delhi 1995.
SAPIR 1921 = E. Sapir, Language. An Introduction to the Study oj Speech, New York 1921.
SAPIR - SWADESH 1946 = E. Sapir - M. Swadesh, American Indian Grammatical Categories, "Word" 2 (1946), pp. 103-112.
SAPORTA 1964 = S. Saporta, On the Use oj Zero in Morphemics, in Proceedings oj the Ninth International Congress oj Linguists, Cambridge August 27-31,1962 ed. H.G. Lunt, London-The HagueParis 1964 (Janua Linguarum. Studia Memoriae N.v.WijK dedicata ed. c.H. van Schooneveld, Series Maior XII), pp. 228-23l.
SAUSSURE 1879 = F. De Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, Leipzig 1879 [= 1878], in Recueil des publications scientifiques de F. de Saussure, Heidelberg 1922.
SCALISE 1990 = S. Scalise, Morjologia e lessico. Una prospettiva generativista, Bologna 1990 [Dordrecht 1988].
SCALISE 1994 = S. Scalise, Morjologia, (Le strutture del linguaggio), Bologna 1994.
SCHARFE 1977 = H. Scharfe, Grammatical Literature (A History of Indian Literature V,2), Wiesbaden 1977.
SCHIFKO 1973 = P. Schifko, Zero in der allgemeinen und romanischen Sprachwissenschajt, "Zeitschrift fur Romanische Philologie" 89 (1973), pp. 1-51.
SCHINDLER 1972 = H.J. Schindler, Das Wurzelnomen im Arischen und Griechischen, Wfuzburg 1972.
SEBEOK 1979 = Th. A. Sebeok, Contributi alla dottrina dei segni, Milano 1979 [= Bloomington 1976].
SEN 1999 = S.K. Sen, Word Ordering in the A.s.tadhyayz, "Joumal of rE Studies" 27, 1-2 (1999), pp. 101-103.
"Zeromorfi" in Pa/fini: regole specifiche di formazione ... 183
SIMONSSON 1976 = N. Simonsson, An Interpretation oj Apoha in relation to modern linguistic Thought, in Vasudhaiva Ku.tumbakam. Proceedings oj the ftrst International Sanskrit Conjerence, March 26th-31st 1972, ed. V. Raghavan, II, 2, New Delhi 1976, pp. 91-7.
SINGH 1991 = J. D. Singh, Par;ini: His Description oj Sanskrit. An Analytical Study oj the A.s.tadhyayI, New Delhi 1991.
SPElJER 1886 = J.S. Speijer, Sanskrit Syntax, Leiden 1886. 55 = v.P.S. Subrahrnanya 5astri, Lectures on Pataiijali's Mahabha.sya, I
(ahnika I-III) Annarnalainagar 1944; II (ahnika IV-VI) Annarnalainagar 1951; III (ahnika VII-IX) Tiruchirapalli 1955; IV (lihnika X-XIV) Tiruchirapalli 1956; V (ahnika XV-XXII) Trruchirapalli 1957.
5TAAL 1969 = J.F. 5taal, Sanskrit Philosophy oj Language, in Linguistics in South Asia (Current Trends in ~inguistics, 5), ed. T. A. Sebeok, The Hague - Paris 1969, pp. 49<1'.;.531.
STAAL 1969 a = J.F. Staal, rev. B. Shefts, Grammatical Method in Par;ini: his Treatment oj Sanskrit present Stems, New Haven 1961.
TESNIÈRE 1969 = L. Tesnière, Eléments de Syntaxe Structurale, Paris 1969. THIEME 1982 = P. Thieme, Meaning and Form oJ the Grammar oJ pa1J.ini,
"Studien zur Indologie und Iranistik" 8-9 (1982), pp. 3-34. THUMB 1958-78 = Handbuch des Sanskrit. Mit Texten und Glossar. Eine
Einfohrung in das Sprachwissenschaftliche Studium des Altindischen VOn
A. Thumb, I. Band, I. Teil: Grammatik. 1. Einleitung und Lautlehre von R Hauschild, Heidelberg 1958; II. Teil: Formenlehre von R. Hauschild, Heidelberg 1959; II. Band. Texte und Glossar, Heidelberg 1978.
TRASK 1993 = RL. Trask, A Dictionary oj Grammatical Terms in Linguistics, London and New York 1993.
V = Pal.fÌI1.Ì, The A.s.tadhyayz oj Plir;ini, ed. transL S.c. Vasu, Delhi 1988 [Allahabad 1891].
VARMA 1978 = S. Varma, Plir;ini and Elision, being An Analytical Study oj Par;ini's Sfltras on Lopa (Elision) Sanskrit, Hoshiarpur 1978 (Panjabi University Indological Series 12).
VENDRYES 1968 = J. Vendryes, Le langage. Introduction linguistique à l'h istoire, Paris 1968 [Paris 1923].
Vt. / Vtt. = Varttika. L'opera è citata nell'edizione di Kielhom 1880-85. VediM.
184 Tiziana Pontillo
WEZLER 1976 = A. Wezler, Some observations on the Grammatical Terminology oJ Paryini (Marginalia Zll Paryini's Ai'.tadhyayI II), in German Scholars on India, II, Delhi-Bombay-Calcutta-Madras 1976, pp. 361-379.
WHORF 1945 = B.L. Whorf, Grammatical Categories, "Language" 21,1 (1945), pp. l-Il.
WILLIAMS 1981 = E. Williams, On the Notion "Lexically Related" and "Head oJ a Word"?, "Linguistic Inquiry" 12 (1981), pp. 245-274.
WURZEL 2000 = W.D. Wurzel, Inflectional System and Markedness, in A. Lahiri (ed.), Analogy, Levelling, Markedness (Trends in Linguistics: Studies and Monographs, 127), Berlin-New York 2000, pp. 193-214.