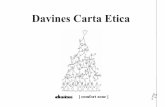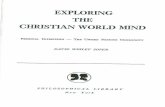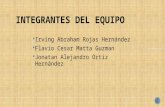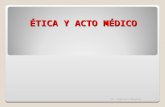Maritain etica
Transcript of Maritain etica
Angelo Campodonico L’etica generale di Jacques
Maritain. Osservazioni a margine
Premessa
Volendo trattare dell’etica generale di
Jacques Maritain – etica generale può essere
oggi un’espressione un po’ desueta, ma non ne
trovo una migliore – prenderò in
considerazione sinteticamente le due opere
principali del nostro in questo ambito: La
filosofia morale. Esame critico dei grandi sistemi, frutto di
una serie di lezioni tenute a Princeton nel
1959 in un contesto che deve aver
particolarmente stimolato il filosofo
francese, e le Nove lezioni sulle prime nozioni della
filosofia morale, frutto di un corso tenuto a
Parigi nel 1951. Altre opere significative che
le precedono e che interessano il nostro tema,
sulle quali però non mi soffermo, sono Scienza e
saggezza del 1935 e Ragione e ragioni del 1948. V’è
un nesso stretto fra le due opere principali.
Maritain ha scritto La filosofia morale pensando di
scrivere un’opera sistematica che in effetti
non è stata mai scritta, ma che è anticipata
dalle Nove lezioni. Cercherò di mostrare in
1
questo saggio come la filosofia morale di
Maritain possa essere interessante, come
risponda anche a certi problemi sollevati
dalla filosofia morale a lui successiva e
dalla concreta esperienza morale di oggi con i
suoi problemi che interpellano la riflessione
filosofica sulla morale. Non voglio entrare
nella questione del rapporto teologia morale -
filosofia morale perché non mi pare
eccessivamente interessante e soprattutto
perché nelle opere che prenderò in esame non
se ne parla in modo approfondito.
Suddividerò questo contributo in due parti:
una riguarda La filosofia morale, ovvero la
trattazione in chiave soprattutto speculativa
dei grandi sistemi morali, la seconda riguarda
la proposta morale di Maritain come emerge
soprattutto, ma non solo, nelle Nove lezioni. In
realtà nel primo volume, che è posteriore
cronologicamente, è già presente una proposta
speculativa e Maritain ne è consapevole. Anche
per questa ragione mi soffermerò molto sulla
prima parte. In entrambi i casi si tratta di
osservazioni a margine senza la pretesa di
trattare in modo esauriente questi temi.
1) La filosofia morale. Esame storico e critico dei grandi
sistemi
2
In generale Maritain inquadra
opportunamente la filosofia morale all’interno
delle scienze e della filosofia, dei gradi del
sapere pratico, ma con una particolare
attenzione alla funzione regolativa della
metafisica. La filosofia morale non si può
isolare da un lato dalla dimensione della
costrizione sociale e psicologica (quella
dimensione che oggi è studiata anche dalla
neuroetica – allora ignota) e neppure,
dall’altro, dalle vette dell’apertura al
trascendente. Maritain non ignora i rapporti
con la società, la religione, le scienze
umane, la psicologia e l’antropologia
culturale. In questo egli, nato nel clima del
primo positivismo, è assai vicino a noi,
ovvero al naturalismo contemporaneo. Non solo:
egli prova a distinguere i diversi approcci
sul piano epistemologico. Si tratta di
distinguere per unire secondo il titolo di una sua
opera famosa1. Forse oggi si tratta ancor più
e in primo luogo di distinguere nell’unito (piano
esistenziale-esperienziale) – è in crisi,
infatti, l’unità dell’uomo, l’unità della sua
esperienza – per poi distinguere per unire (piano
epistemologico). La non distinzione e la
1 Cfr. Distinguere per unire. I gradi del sapere, Morcelliana,Brescia 2013.
3
mancanza di unità fra razionalità pratica e
razionalità speculativa, fra esperienza morale
e filosofia morale, e fra le diverse forme
della razionalità pratica (arte ed etica)
provocano una dannosa confusione di piani o
un’assolutizzazione di singoli piani come
Maritain mette in luce nella sua ultima
produzione2. In particolare: v’è una
differenza fra esperienza morale che prescinde
dalla metafisica e filosofia morale che non ne
prescinde. Ma veniamo alla sua lettura di
alcuni autori e filoni classici della
filosofia morale.
Maritain evidenzia il fatto che la
filosofia greca classica è nettamente separata
dalla religione greca che critica. Del resto
la stessa filosofia cristiana riprenderà la
filosofia greca classica e non la mitologia
pagana. Egli sottolinea l’importanza del
rapporto desiderio di felicità, desiderio del
bene nell’interpretazione di Socrate, Platone
e Aristotele: «Felicità e bene sono
identificati, ma è insistendo in primo luogo
sul Bene; è il Bene che costituisce la
2 Cfr. Approches sans entraves, scritti di filosofia cristiana, CittàNuova Roma, 1977, soprattutto vol. II. Cfr. il miocontributo A. Campodonico, Esperienza e metafisica. Verso un'eticadella ragione, in Jacques Maritain. Riflessioni su una fortuna, a c.di A. Campodonico e L. Malusa, Franco Angeli, Milano1996, pp. 63-80.
4
felicità»3. Ma questo resta per lo più
implicito, il che costituisce, secondo
Maritain, un limite di Aristotele4. Nella sua
etica la finalità non ha il primato solo
nell’ordine dell’esercizio: essa è il criterio
supremo nell’ordine stesso della
specificazione, cioè nella stessa
determinazione della bontà morale della
condotta umana5; di qui un certo rischio,
secondo il filosofo francese, di cadere
nell’utilitarismo6. Maritain ha il merito a
questo proposito di precisare la nozione di
fini infravalenti: nell’etica classica non si
tratta per lo più di meri mezzi in senso
strumentale, ma di fini veri e propri seppur
subordinati a un fine supremo7. Tanto per fare
un esempio: seguire una lezione non è un mero
mezzo in senso strumentale al fine di
diventare filosofi. Maritain sottolinea poi le
differenze dell’etica di Aristotele rispetto
alla sua ripresa scolastica da parte di
Tommaso:
la morale cristiana è una morale dellabeatitudine, ma prima di tutto e soprattutto è una
3 La filosofia morale. Esame critico dei grandi sistemi, Morcelliana,Brescia 1999, p. 284 Cfr. Ibid., p. 485 Cfr. ibid. p. 536 Cfr. p. 537 Cfr. p. 131.
5
morale del Bene divino sommamente amato8.
La saggezza stoica ed epicurea poi sono
interpretate come ascesi filosofica. Si
trattava di “scuole pratiche di saggezza”9.
Significativamente questi sono temi ripresi in
epoca più recente da Pierre Hadot a proposito
della filosofia greca antica interpretata come
ascesi filosofica10.
Trattando poi dell’etica cristiana
Maritain osserva:
È dannoso sempre essere a metà cristiani.L’impatto del Cristianesimo vivifica la ragione(senza renderla infallibile) quando la ragione sinutre della sostanza del Cristianesimo. Quandoessa s’ingrassa con i residui del Cristianesimo,l’impatto del Cristianesimo fa deviare laragione11.
Vale anche qui l’adagio secondo cui “corruptio
optimi pessima”. Trattando dei rischi del
cristianesimo nella contemporaneità
secolarizzata, Maritain parlerà dei cristiani
mondanizzati che vivono oggi secondo un ideale
misto e contraddittorio12. Così nella prima
modernità il saggio stoico è una figura bella
8 Ibid., p. 103.9 Cfr. p. 9210 Cfr. P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 1988.11 Ibid. p. 114.12 Cfr. p. 167
6
e pronta per una civiltà cristiana fattasi
ormai antropocentrica13.
Interessante, in particolare, appare la
lettura di Kant che, conoscendo Maritain il
contesto statunitense, si serve di un autore
come Patton, più tardi valorizzato anche in
Italia, ma allora piuttosto sconosciuto. Kant
è interpretato acutamente come filosofo che
reagisce a una certa lettura bassamente
eudemonistica del Cristianesimo in nome di
un’etica troppo purificata, influenzata a sua
volta dal Cristianesimo. Il fascino dell’etica
kantiana sta nel fatto che
se le mani dell’uomo sono egoiste e rapaci èun ideale disinteressato (qualunque cosa nepensino gli pseudo realisti) che fa più presasui suoi sogni e perfino sul suo pensiero14.
Ma
Kant ha cercato una morale del disinteresseassoluto, tagliando fuori in definitiva lamoralità come tale dall’ordine dell’amore; con ciòla tagliava fuori dall’ordine della finalità, edal perseguimento del bene finalizzatoredell’azione, che altro non era, ai suoi occhi cheil perseguimento del piacere15.
Per Kant le attrattive empiriche contaminano
la morale: 13 Cfr. p. 118.14 Ibid. p. 12315 Ibid. p. 123.
7
Il piacere, e anche il desiderio del piacere,possono accompagnare l’atto morale. Ma non possonoavere alcuna parte formale, alcuna partemotivazionale nell’intenzione dell’atto morale16.
Kant per di più non distingue tra piacere e
felicità17. Sussiste invece per l’etica
cristiana e per Maritain l’obbligazione morale
a scegliere la vera felicità18.
Kant replica alle dottrine del puro amore
nella loro forma più estrema. Ma la nozione
kantiana di autonomia esigeva che il fine
ultimo venisse escluso dalla sfera propria e
costitutiva dell’etica19. L’amore, infatti, è
eteronomo. Kant – sottolinea Maritain - ha
costruito il suo sistema morale solo
nell’ordine della causalità formale:
In breve, in virtù di una trasposizione dellamorale cristiana tradizionale in termini di puraragione, il rispetto per la legge o l’ossequio perla legge ha preso nell’etica kantiana il postodell’amore di Dio al di sopra di tutto il propriodella morale cristiana tradizionale: proprio comela bontà senza limiti della buona volontà,all’interno dell’agente morale, ha preso il postodella bontà infinita del Fine ultimo assoluto aldi sopra di esso 20.
Per Maritain, essendo una creatura, 16 Ibid. p.125.17 Ibid.18 Cfr. p. 126.19 p. 12920 Ibid. p. 131.
8
l’uomo raggiunge la sua autonomia progressivamentee sempre rimanendo sottomesso alla legge di unaltro, a una legge che non dipende da lui, bensìdalla natura e dall’autore della natura 21.
La ragione per Maritain come già per Tommaso è
regola immediata degli atti umani. Si tratta
di un primo grado di autonomia22:
Un uomo che ama veramente è più autonomo di unuomo che rispetti l’imperativo categorico senzaamore23.
Maritain evidenzia il venir meno della
nozione di bonum honestum: il buono e bello
degli antichi e dei medioevali è stato
sostituito dall’obbligazione. Per Kant
l’etica della beatitudine[…] è ancoracontaminata dall’eudaimonismo pagano […]:l’etica di Kant, pur essendo puramentefilosofica, sarà più cristiana dell’eticacristiana tradizionale. Che opera in fondo aquesta etica della Ragion pura, è una speciedi ipercristianesimo senza Cristo, un fermentocristiano dissenzializzato dal quale tutto ilcontenuto di fede è stato eliminato, ma checontinua ad agire24.
L’etica kantiana è un’etica del solo valore,
ma non dell’oggetto, ma dell’atto25. 21 Ibid. p. 131.22 Ibid. p. 131.23 Ibid. p. 132.24 Ibid. p. 140.25 Ibid. p. 144.
9
Importante in questa lettura di Kant è la
distinzione scolastica, ripresa da Maritain,
di ordine dell’esercizio dell’atto e di ordine della
specificazione26. All’ordine di specificazione
corrisponde il valore, la causalità formale e
all’ordine dell’esercizio la causalità finale.
Possiamo notare che la distinzione fra ordine
dell’esercizio e ordine della specificazione presenta
significative analogie con il tema proprio
della contemporanea etica analitica del
rapporto fra ragioni o giustificazioni da un lato e
motivazioni dall’altro e, in questo ambito, fra
internismo ed esternismo, distinzione presente
nell’etica analitica successiva27. Inoltre
Maritain svolge di fatto una critica alla
nozione di autolegislazione kantiana come
avviene esplicitamente in Modern Moral philosophy
di Elizabeth Anscombe, saggio che è quasi
contemporaneo all’opera di Maritain e che ha
avuto una insospettata fortuna, dando origine
alla cosiddetta “etica delle virtù”28. Egli
parla a questo proposito di «esaltazione
illusoria dell’obbligazione morale che
trasformava il timor di Dio in termini di pura
26 Per esempio, a p. 211.27 In etica si parla di internismo quando nelle ragioniper agire è implicita anche la motivazione e diesternismo quando ciò non ha luogo. Sotto questo profiloKant s’inserisce nell’internismo, Hume nell’esternismo.28 Cfr. p. 214
10
filosofia»29.
Poi, seguendo un ordine cronologico, appare
interessante la valorizzazione del legame con
l’esperienza morale ordinaria che Maritain
riconosce agli empiristi inglesi (in
particolare ad Adam Smith). Gli empiristi,
tuttavia, non comprenderebbero la nozione di
bene onesto, (ciò che è in sé amabile) che non è
né l’utile né il piacevole.
Nell’interpretazione dell’etica di Hegel
merita attenzione la sottolineatura del
passaggio dall’assolutizzazione dell’individuo
dovuta al clima religioso luterano all’eticità
dello Stato che fa da surrogato alla Chiesa.
L’individuo moderno, isolato dalla comunità
ecclesiale, ha bisogno di appoggiarsi a
un’altra comunità, quella statale.
La morale positivistica di August Comte
poi rappresenta per Maritain una reazione alla
normatività della morale di Kant30. In
generale: Maritain legge il sociologismo in
etica come ultimo residuo della reazione alla
normatività esagerata di Kant. Egli vede
nell’etica della modernità un’oscillazione tra
il kantismo nella sua purezza normativa e il
sociologismo, inteso come riduzione della
morale all’esistente (etologia morale). Il
29 Ibid. p. 21430 Cfr. p. 409
11
positivismo ha il merito di non accettare la
separazione kantiana fra universo della
libertà e universo della natura31, pur
assumendo il generale pregiudizio
antiteistico. Maritain scorge il rischio di
leggere l’evoluzionismo darwiniano come capace
di fornire i criteri stessi del giudizio della
moralità32.
Infine Maritain tratta di tre reazioni alle
grandi sistemazioni razionalistiche:
Kierkegaard, Sartre, Dewey. Su Sartre, in
particolare, vorrei soffermarmi brevemente.
Sartre è criticato per la netta
contrapposizione fra universale e particolare
che contraddistingue la sua etica che non a
caso ignora la virtù della phronesis o prudentia:
«senza la legge universale e il precetto
incondizionato, infatti, la prudentia andrebbe
galleggiando senza mai approdare». 33 Ma Sartre
è valorizzato da Maritain quando sottolinea il
tema della prima opzione della libertà o
opzione fondamentale che è alla base
dell’etica e che
la persona compie come separata dal mondo e
31 Cfr. p. 46232 Cfr. p. 46433 Ibid., p. 149. Cfr. p. 459: In Sartre «la moraledella situazione misconosce la prudentia come la leggeuniversale».
12
con la quale essa senza nulla quaggiù a cuiappoggiarsi, assume da sé l’onere di sé conuna scelta radicale (che porta in realtà albene nel quale essa fa consistere il suo Beneultimo)34.
Questo tema della prima opzione della libertà si
trova, secondo Maritain, significativamente
già in Tommaso quando tratta della scelta che
compie il fanciullo, e assume nel suo pensiero
un ruolo significativo35.
34 Ibid, p. 46035 Cfr. Summa theologiae Iª-IIae q. 89 a. 6 co: «Èimpossibile che il peccato veniale si trovi in un uomoinsieme con quello originale senza un peccato mortale.E la ragione è che, prima degli anni della discrezione,l‘età che impedisce l‘uso della ragione scusa l‘uomodal peccato mortale: per cui a maggior ragione lo scusadal peccato veniale, qualora commettesse delle colpeveniali nel loro genere. Quando invece l‘uomo cominciaad avere l‘uso di ragione non viene scusato né dallecolpe veniali, né dal peccato mortale. Ma la prima cosache allora si presenta alla sua mente è il deliberaredi se stesso. E se uno ordina se stesso al debito fine,con la grazia riceve la remissione del peccatooriginale. Se invece non ordina se stesso al debitofine, secondo la discrezione di cui è capace aquell‘età, pecca mortalmente, poiché non fa ciò che èin suo potere. E da allora non ci potrà essere in luiil solo peccato veniale senza il mortale se non dopoche ha conseguito la remissione di tutti i peccatimediante la grazia». Per Maritain un corretto atteggiamento etico siradica in quella prima opzione della libertà comecapacità di assecondare o meno l'innata tendenza albene, di cui egli ha trattato più volte La primaopzione della libertà, che ha luogo sul pianodell'atematico, quando è in favore del bene porta consé, secondo Maritain, una conoscenza puramente pratica,preconcettuale, ma formale, attuale, consapevolesoltanto allo stato virtuale, di Dio quale Bene chedispone il cuore alla conoscenza concettuale di Dio,secondo l'espressione evangelica "Qui facit veritatemvenit ad lucem".
13
L’ultima parte della Filosofia morale è
dedicata a Henry Bergson, un autore
particolarmente amato da Maritain. Di Bergson
Maritain nota che l’accentuazione della
dicotomia fra morale chiusa e morale aperta
presente ne Le due fonti della morale e della religione,
benché significativa, di fatto sottrae spazio
alla filosofia morale vera e propria. Tanto è
vero che Bergson non menziona mai il tema
della legge naturale. Egli scorge o
costrizione sociologica e psicologica o
libertà dello spirito, scartando il piano
mediano della moralità vera e propria. Si ha
nel suo pensiero una distinzione netta tra
quello che appartiene alla pressione sociale e
quello che appartiene all’aspirazione. A questi
due estremi si collegano da un lato la morale
chiusa conformista, dall’altro quella aperta
ovvero la morale della santità36. Nella prima
polarità rientra anche un Cristianesimo della
mera legge37. Possiamo rilevare una somiglianza
tra la morale chiusa e quello che dicono oggi
le ricerche nell’ambito della psicologia
sociale, della neuroetica o della morale
evoluzionistica38. Alla natura umana in senso
36 Cfr. Ibid. pp. 490-1.37 Cfr. Ibid. p. 520.38 Cfr., per esempio, sul peso delle appartenenze nellavita sociale, J. Haidt, Menti tribali. Perché le brave persone sidividono su politica e religione? Codice, Milano 2013.
14
classico e alla legge naturale Bergson come i
positivisti contro cui reagisce non è
veramente interessato. In genere non lo è
neppure all’obbligazione intesa in senso
strettamente morale.
Maritain conclude, rilevando che il bonum
honestum, il fine proprio della vita morale,
sta alla morale come l’essere sta alla
filosofia. Di una cosa così semplice e ovvia
non si prende facilmente coscienza. Questo
spiega il fatto che così spesso lo si
trascuri.
2) Le Nove lezioni sulle prime nozioni della filosofia morale
Prendiamo ora in considerazione
sinteticamente alcuni temi presenti nella
proposta etica maritainiana, ma già suggeriti
nella sua esposizione dei grandi sistemi. Un
primo punto riguarda il sociologismo cioè la
pretesa di un’etica “scientifica” meramente
descrittiva, ovvero un’etologia che espunga di
fatto la dimensione normativa. Maritain si
chiede a questo proposito come possa
sussistere un’etica che non sia normativa:
Tutti i dati presentati dalla sociologiapresuppongono l’esistenza del sentimentodell’obbligo morale che esiste nella coscienzadegli individui preliminarmente a ogni incidenza
15
sociologica. E proprio per questo che la pressionesociale e i sentimenti collettivi possonopenetrare nel campo interiore della moralità; essipossono assumere la forma di un dovere nellacoscienza individuale, perché la pressione socialee i sentimenti collettivi vengono per così direcolti, captati da quel preesistente dinamismodell’obbligazione morale[…]39.
Infine il sociologismo si autodistrugge nel
senso che nessuna società può vivere senza una
base comune di convinzioni morali40. S’impone
aristotelicamente in questa prospettiva una
padronanza politica e non dispotica
dell’inconscio41. In opposizione al
sociologismo Maritain afferma poi che si
richiede la sapienza metafisica per
giustificare la morale sul piano dell’etica
filosofica42. Occorre in ogni caso riconoscere
che sull’esperienza morale sono possibili
diversi livelli di riflessione, di cui quello
superiore richiede la sapienza metafisica, e
che una certa precomprensione metafisica e
antropologica è presente già ai livelli
inferiori dell’esperienza morale.
Un secondo tema importante è quello del
primo atto della libertà cui si è accennato trattando
di Sartre. Maritain nota:
39 Cfr. Nove lezioni sulle prime nozioni della filosofia morale, Vita ePensiero, Milano 1979.40 p. 63.41 p. 66-42 Cfr. ibid., p. 67.
16
La scelta del vero fine della vita umana è insitao incarnata in un atto radicale di libertà,destinato a comandare l’attività morale fino a chel’atto stesso non verrà revocato[…]43.
Così il bambino che scopre che dire la bugia è
male, scopre la dimensione del bene onesto.
Interessante è l'idea che, tendendo al bene
onesto, si tende implicitamente a Dio, anche
quando non se ne è consapevoli. L’etica apre
alla dimensione religiosa (si tratta della
dialettica del primo atto di libertà).
In terzo luogo, trattando della legge
naturale, Maritain fa riferimento a due
categorie d’inclinazioni: quelle radicate
nella natura animale dell’uomo e altre che
emanano dalla natura razionale dell’uomo:
Esse presuppongono le inclinazioni istintive – adesempio l’istinto animale di procreazione[…]mapresuppongono che queste tendenze e inclinazioniistintive siano state prese e trasferite neldinamismo delle apprensioni dell’intelletto[…]lanatura è passata per il lago dell’intelletto(funzionante inconsciamente) 44.
Queste inclinazioni
sono stabili nelle loro proprie radici, cioènella ragione, e nella misura in cui la vitadella ragione prevale, non hanno alcuna stabilità
43 Ibid. p. 17044 Ibid. p. 100
17
nella sfera propriamente animale o biologica45.
Come conosciamo, quindi, i valori morali? In
concreto a partire dall’esperienza degli
altri, di alcuni altri. Per esempio: vedendo
un uomo che agisce in un modo che troviamo in
accordo con la ragione. I giudizi di valore
operanti nella coscienza etica dell’umanità
non sono “per modo di conoscenza” , sono
primariamente e anzitutto dei giudizi per modo
d’inclinazione46 . La nostra intelligenza
giudica per conformità alle inclinazioni che
sono in noi per modo non concettuale. Si
tratta della valorizzazione da parte di
Maritain di quella conoscenza non concettuale
o per connaturalità che in Tommaso è presente
anche se da lui non viene tematizzata molto
soprattutto in ambito morale47.
Significativa è la riflessione
maritainiana sulla naturalità del principio
d’incesto che ha dalla sua delle ragioni che
si possono argomentare. Nel complesso Maritain
è assai attento all’antropologia culturale, al
cosiddetto “regime notturno” all’inconscio e
al preconscio. Egli conosceva bene il pensiero
45 Ibid., p. 10146 Cfr. p. 10347 Cfr. R. Caldera, Le jugement par inclination chez Saint Thomasd'Aquin, Vrin, Paris 1980; M. D’Avenia, La conoscenza perconnaturalità in San Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 1992.
18
di Levy Bruhl e anche di Levi Strauss.
Maritain ribadisce a proposito dei vari
condizionamenti culturali, tabù ecc. che
[…]la pressione sociale ha presa sulla vita moraledell’uomo solo perché risveglia e fissa unsentimento che invece non è di origine sociale48.
Maritain evidentemente non crede che si
possa naturalizzare la dimensione normativa, ma
solo alcuni suoi contenuti concreti. Inoltre
per avere presa sull’esistenza i valori devonoessere inseriti nel dinamismo della nostranaturale e necessaria tendenza alla felicità49.
Infine Maritain pone a tema la necessaria
correlazione nell’uomo fra diritti e doveri,
correlazione particolarmente attuale oggi a
fronte dell’esaltazione dei soli diritti e di
fronte alla tematica dei cosiddetti “diritti
degli animali”. Egli osserva a questo
proposito:
Se gli animali avessero dei diritti in base alprincipio della correlazione assolutabisognerebbe dire che avrebbero dei doveri…Ma noiabbiamo dei doveri verso di essi, senza che loroabbiano dei diritti…vi è in essi un abbozzo diquello che saranno i diritti […]50.
48 Ibid. p.14349 Ibid., p. 14650 Ibid. 204 e ss.
19
3. L’etica di Jacques Maritain oggi
Molti problemi dell’etica contemporanea,
che oggi è in gran parte etica influenzata
dalla correnti filosofiche presenti in quel
mondo anglosassone che Maritain frequentava,
sono già affrontati e in certa misura risolti
dal filosofo francese. Ma la scarsa
comunicazione esistente fra le diverse
tradizioni di pensiero, una volta passato
soprattutto quel momento di felice fusione in
seguito alla fine della seconda guerra
mondiale, fa sì che certe somiglianze e certe
possibili risposte a problemi ancora vivi non
siano adeguatamente conosciute e valorizzate.
In sostanza l’etica di Maritain è ancora poco
conosciuta in Italia al di fuori di ristrette
cerchie confessionali.
In particolare: meritano attenzione il
passaggio dall’inconscio della coazione e
della necessità e soprattutto dalla dimensione
da Maritain tematizzata come preconscio spirituale,
attraverso la morale naturale, alla libertà
dello spirito51. Si tratta di un cammino che
51 La differenza fra inconscio e preconscio spirituale si basasul fatto che mentre il secondo può essere esplicitatonella riflessione, il primo non può esserlo. Cfr. J.Maritain, Quattro saggi sullo spirito umano nella condizioned’incarnazione, Morcelliana, Brescia 1978.
20
non salta le tappe. S’impone cioè l’esigenza
di un legame fra emozioni e ragione, fra
inclinazioni e norme morali, fra emozioni e
virtù. In questa prospettiva il tema del bene
morale si coniuga opportunamente con quello
del bello, rispondendo a un’istanza oggi assai
sentita. Maritain offre, così, degli elementi
significativi per rispondere con nuovi
strumenti all’esigenza che ancora oggi
s’impone in filosofia morale di rispondere
alla rigida alternativa tra emotivismo,
favorito dal naturalismo evoluzionistico e
dalle neuroscienze da un lato, e
razionalismo della norma e dei diritti
dall’altro, se vogliamo alla rigida
alternativa tra l’etica di Hume e quella di
Kant.
21