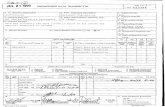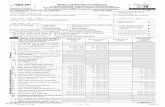Marc'Antonio Gattinon, "I travagli d'amore"
Transcript of Marc'Antonio Gattinon, "I travagli d'amore"
Marc’Antonio Gattinon
I TRAVAGLI D’AMORE
edizione critica e commento a cura di
Gabriele Zanello
Società Filologica FriulanaUdine
%LEOLRWHFD�GL�VWXGL�OLQJXLVWLFL�H�ÀORORJLFL
17
Società Filologica FriulanaBiblioteca di studi linguistici e filologici
diretta daFederico Vicario
Il presente volume è stato pubblicato con il contributodel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
© 2015 - Società Filologica Friulana «Graziadio Isaia Ascoli» Via Manin, 18 - I 33100 UdineTel. 0432 501598 - Fax 0432 511766www.filologicafriulana.it [email protected]
ISBN 9788876362057
SOMMARIO
R. Pellegrini, Malacarne e dintorni. Escursioni linguistiche in Marc’Antonio Gattinon p. 7
Premessa » 31
Introduzione » 33
Nota al testo » 61
I travagli d’amore » 85 Interlocutori » 89 Prologo » 91 Atto primo » 95 Atto secondo » 125 Atto terzo » 155 Atto quarto » 187 Atto quinto » 215
Analisi linguistica » 245 Friulano » 245 Veneziano » 306 Buranello » 320 Bergamasco » 324 Grazianesco » 329 Pedantesco » 350
Repertori lessicali » 357 Friulano » 358 Veneziano » 414 Buranello » 449 Bergamasco » 453 Grazianesco » 457 Pedantesco » 508 Toscano » 514
%LEOLRJUDÀD » 531
Indice dei nomi » 553
MALACARNE E DINTORNIESCURSIONI LINGUISTICHE IN MARC’ANTONIO GATTINON
nella lingua del forlano, nei spropositi del Gratiano e nell’accortezza e burle d’un astuto ragazzo prendersi piacere… (Prologo 17)
Propongo in epigrafe uno stralcio del Prologo, dove l’autore dichiara l’obiettivo del suo lavoro (prendersi piacere) e i mezzi impiegati. Lo stralcio esibisce subito il gusto della simmetria, del ritmo bilanciato (nella lingua… nei spropositi… nell’accortezza e burle…), strategia di rilievo in larga parte della commedia. Lo VWUDOFLR�SHUDOWUR��VDFULÀFDQGR�OD�JLUDQGROD�LPSD]]LWD�GL�OLQJXH��VSHFLH�O·LGLROHWWR��il parossismo paronomastico, quella sorta di dislalia iperbolica che caratterizza il graziano), girandola solo allusa e delibata, che connota in modi accesi I travagli d’amore di Marc’Antonio Gattinon, privilegia tendenziosamente (ma non senza XQ�IRQGR�GL�YHULWj��XQ�ÀORQH��FKH�LO�JUDVVHWWR�SURYYHGH�D�VRWWROLQHDUH��WUDGHQGR�FRVu�l’interesse primario della lettura, il suo vettore, e disegnando anche il percorso che mi ha portato alla scoperta di Gattinon: non senza precipitare qualche azzardo.
È stata una pagina di Nicola Mangini, in anni non più prossimi, a additarmi il nome di Gattinon1��0DQJLQL�HYRFD�FRQ�ÀQH]]D�OR�VIDOGDPHQWR�GHOOH�UHJROH��«quella mescolanza dei generi e degli stili, che resta una delle connotazioni pre-cipue di questa età», che nella commedia porta ad assimilare «elementi propri dell’Arte, come nella commedia I travagli d’amore di M. Antonio Gattinon di Latisana». I travagli d’amore, che Mangini giudica testo «esemplare» (il Prologo accerta il favore – e anzi l’opzione consapevole – per l’«uso moderno»). Ma nella pagina di Mangini mi ha catturato un altro snodo: «sulla traccia di una vicenda scombinata e fuori da ogni logica, accanto ai personaggi usuali della commedia erudita troviamo i tipi/maschere dell’“improvvisa” e della commedia popolare (oltre a Pantalone e a Graziano, ci sono un servo che parla in friulano rustico, un facchino bergamasco e un pescatore di Burano). È naturale quindi che l’elemento FKH�ÀQLVFH�FRO�SUHYDOHUH�q�LO�GLYHUWLPHQWR�OLQJXLVWLFRª��'RYH�D�LQFLGHUVL�QHOOD�memoria, rimuovendo persino il secondo titolo di Gattinon, quell’Amorosa che pure Mangini menziona, è «un servo che parla in friulano rustico», una formula che pure solleciterebbe la postilla, sfuggito ai repertori. Un personaggio che si DIÀDQFD�D�$JQROR�GHOOD�Pace di Marin Negro. Il «servo che parla in friulano ru-
1 N. MANGINI, La tragedia e la commedia, in Storia della cultura veneta, diretta da G. ARNALDI e M. PASTORE STOCCHI, Il Seicento, 4/1, Vicenza, Neri Pozza, 1983, p. 317.
RIENZO PELLEGRINI
Malacarne e dintorni. Escursioni linguistiche in Marc'Antonio Gattinon
Rienzo Pellegrini8
VWLFRª�VL�q�ULYHODWR�SRL��FRQ�XOWHULRUH�VRUSUHVD��QRQ�XQD�ÀJXUD�VELDGLWD��FRQÀQDWD�in ranghi gregari, ma un personaggio corposo e sanguigno, intraprendente (e magari sgangherato), con uno spazio non ristretto di battute e di presenza scenica. Tessera di spessore nella storia degli usi scritti del friulano.
Malacarne, il «servo che parla in friulano rustico», è personaggio composito: nella commedia si fa carico di funzioni diverse, vantando competenze multiple, che QRQ�WHQGRQR�DOOD�RUJDQLFLWj�GL�XQ�SURÀOR�FRHUHQWH��DOOD�VDOGH]]D�GL�XQD�SVLFRORJLD�GHÀQLWD��PD�REEHGLVFRQR�DOOH�XUJHQ]H�GL�XQD�FRPLFLWj�FKH�VL�ULVROYH�QHO�OD]]R��nella gag. Malacarne è millantatore e vigliacco, mezzano, non in totale armonia con un costume che vorrebbe dirsi (e essere) contadino, sia pure di contadino LQXUEDWR��H�OD�VXD�ÀVLRQRPLD�DPPHWWH�YLVFKLRVLWj�EXUOHVFKH�H�ULYROL�GL�EODVRQH�etnico. Malacarne si traveste da spaccalegna, mestiere socialmente plausibile e topico, se Le arti che vanno per via nella città di Venezia di Gaetano Zompini documentano, nel 1785, il friulano come spaccalegna: «Per tagiar tuto l’ano e legne, e zochi / Vegnimo dal Friul nostro paese / La strussia è granda e se ne chiapa pochi», tra realtà osservata e gerarchia proverbiale.
I primi tentativi di trascrizione, la forma più probatoria di lettura, di necessità un corpo a corpo con il testo, ne hanno svelato il virtuosismo arduo, il gioco acro-batico delle lingue in scena, la saturazione intellettualistica del graziano, intreccio GL�RVFXULWj�YROXWH�H�FDOFRODWH��XQD�VÀGD�DOO·LQWHOOLJHQ]D��8QD�SURYRFD]LRQH�FKH�non tollerava rinunce, inducendo peraltro all’ipotesi di demandare la ricerca a XQ·DOWUD�HWj��/H�FRVH�VRQR�DQGDWH�DOWULPHQWL��H�FRQ�YDQWDJJLR���XQD�WHVL��QHO�ÀOR�dunque della continuità (e, insieme, di una sana discontinuità). I travagli d’amore allestiti da Zanello sanno intrecciare scrupolo e sensibilità, la fatica degli spogli OLQJXLVWLFL��XQD�ELEOLRJUDÀD�FRVSLFXD�VRWWR�FRQWUROOR�H�OD�WHQDFLD�LQWHUSUHWDWLYD��un commento che sbroglia, appianando e rendendo accessibile un testo irto di VRÀVWLFDWL��PD�DQFKH�FDS]LRVL��WUDERFFKHWWL��8QD�EHOOD�DFTXLVL]LRQH�SHU�OD�ÀORORJLD�IULXODQD��H��YD�GD�Vp��QRQ�SHU�OD�ÀORORJLD�IULXODQD�VROWDQWR��
A margine de I travagli d’amore�KR�DYXWR�PRGR�GL�ÀVVDUH�XQ�DSSXQWR�YHORFH��veloce e forse precipitoso. Riporto le poche righe:
Si consideri comunque in prima battuta l’istanza teatrale. È la scena veneziana a fornire il lemma più compiuto. Accanto all’italiano alto dei giovani innamorati, al veneziano di Pantalone, al bergamasco di un facchino, al graziano, nel 1622 (Venezia, Reghettini) I travagli d’amore, commedia «non men curiosa che dilettevole» di Marco Antonio Gattinon da Latisana, ma attivo a Venezia, propongono con mano generosa anche il friulano. Malacarne, nome parlante, come parlanti sono i nomi di genitori e ascendenti, è servo non timido e non impacciato. La sua presenza in scena è anzi invadente e screanzata, da bullo più che da contadino inurbato, e i suoi monologhi sono a tratti torrentizi. Si osservi intanto uno scambio tra Pantalon e Malacarne suo servo [segui-
Malacarne e dintorni. Escursioni linguistiche in Marc'Antonio Gattinon 29
da La Geva�GHO�ÀRUHQWLQR�$OHVVDQGUR�$OOHJUL��LQL]LR�GHO�;9,,�VHFROR���SDUODQR�GL�«Organo sessuale femminile (per la somiglianza tra la zolla erbosa e il pube)»19. Per persembul�VL�ULGXFH�FRVu�OD�GLVWDQ]D��YLVWD�OD�FRQJUXHQ]D�FRQ�OD�SDUWLFRODULVVL-ma «zolla erbosa», ma non si placano (e anzi si accendono) gli interrogativi: La Geva�GL�$OOHJUL�FRPH�IRQWH"�8QD�FDWHQD�LQWHUWHVWXDOH�GL�FXL�VIXJJH�O·DQHOOR�XWLOH"�2�DXWRQRPD�LQL]LDWLYD�GHOOR�VWHVVR�*DWWLQRQ"�1RQ�VL�WUDWWD�FRPXQTXH�GL�PHWDIRUD�acclimatata in friulano, ma introdotta dall’esterno, mentre sembrerebbe radicata nel perimetro locale la locuzione che si sta per prendere in considerazione.
E che si direbbe priva di ambivalenze, di sottintesi, pur se arieggia un dettato gnomico (e, insieme, sibillino): «In ogni muut la strade di Palme a Cervignan è curte e si sta poo’ a ionzi là» [In ogni modo la strada da Palma a Cervignano è breve e ci si mette poco a giungere là»] (III 189). Il commento tace, ma il repertorio suggerisce per Palmanova una «allusione a ‘essere impalmati’», per Cervignano una «allusione a ‘essere cornuti’». Si deve dedurre che al matrimonio (meglio, alla SURPHVVD�GL�PDWULPRQLR��VHJXH�UDSLGDPHQWH�O·LQIHGHOWj��GD�SDUWH�GHOOD�GRQQD�"�,O�contesto tollera l’ipotesi (e ne esce rafforzato), ma è sentenziosità fortuita, estro VLQJROR�GL�0DODFDUQH��R�SDWULPRQLR�FRQGLYLVR"�$QFKH�QHO�GHWWDJOLR��XQ�IULXODQR�JHQXLQR��VSHFFKLR�GHO�SDUODWR��R�FUHD]LRQH�G·DXWRUH"
9RJOLR�SHUz�FRQJHGDUPL�FRQ�O·XOWLPD�EDWWXWD�GL�0DODFDUQH��ÀQ�TXL�SHU�PH�VWHOOD�polare, anche se il percorso è scivolato poi lungo altri sentieri, con il grumo di oscurità che si annida nella formula augurale:
L’allegreezze e lu dolzoor ch’iò provi cun sta viola violada di Violanta es tant grant, signù, FX�Lz�QR�SXHV�VTXDVL�VÁDGDVVDD��QR�FX�FKLDWDD�SDUDXOLV�R�FLULPRQLLV�GL�ULQJUDWLDXXV��0D�Lz�GLUDL��H�gnestre usanze: Dio vusalom (V 226).
[La contentezza e la delizia che io provo con questa viola violata di Violante è tanto grande, signore, che quasi non riesco a respirare, nonché trovare parole o cerimonie per ringraziarvi. Ma GLUz��DO�PRGR�QRVWUR��'LR�YL�VDOYL��"�@
L’epilogo è ambiguo: a Malacarne è concessa come sposa Violante, pur se Pantalone rivendica una sorta di diritto di comproprietà. Il livello è sostenuto, solenne, con doppio ritmo binario («L’allegreezze e lu dolzoor ch’iò provi…», «chiataa paraulis o cirimoniis…») e soprattutto con il tour allitterante («sta viola violada di Violanta»), insolito per le corde di Malacarne. Il sigillo è nei modi della VFKLHWWH]]D��GHOOD�IDPLOLDULWj�FRGLÀFDWD��e gnestre usanze. Lasciando però in punta una formula che si sottrae alla trasparenza, che si nega alla comprensione immediata:
19 V. BOGGIONE e G. CASALEGNO, Dizionario letterario del lessico amoroso. Metafore eufemismi trivialismi, Torino, Utet, 2000, p. 440.
Rienzo Pellegrini30
Dio vusalom��H�OD�WUDGX]LRQH�q�FRVWUHWWD�DO�SXQWR�GL�GRPDQGD��©'LR�YL�VDOYL��"�ª��R�QRQ�SLXWWRVWR�XQ�SL��FRQJUXR�¶'LR�YH�QH�UHQGD�PHULWR·�R�¶'LR�YL�EHQHGLFD·"��
Locuzioni simili si incontrano in Giuseppe Strassoldo («Almèns, o Diò i è l’on», «cu Diò t’è ’l bon», nella edizione curata da Giovanni Lorenzoni, «ma sta chun to parint chu Dioo ial lon» in un sonetto che ho avuto modo di pubblicare io stesso), locuzioni che non sembrano collimare con il «Dio vi salvi» postulato (e per il friu-lano vorrebbero forse un Dio vus al om)20. In Strassoldo pesano i vincoli metrici, la costrizione della rima, ma è palpabile l’opacità del sintagma. Un buon lavoro (e questo di Zanello è un ottimo lavoro) si valuta anche per la puntualità con cui sa circoscrivere le zone buie, il muro della crux: positivo anche in presenza di una resa (provvisoria). Ma non c’è dubbio, anche se il senso sfugge e un chiarimento resta da esperire, che si tratti di formula beneaugurale cristallizzata e di uso medio. E perciò anche qui, a dispetto dell’enigma, si può concludere con: Dio vusalom (o vus al om che sia). Comunque e gnestre usanze.
Rienzo Pellegrini
20 Cfr. R. PELLEGRINI, Strassoldo Giuseppe, in Nuovo Liruti cit., pp. 2411-2417.
PREMESSA
Le testimonianze sul friulano in scena non riescono a superare, nel Cinquecento, i limiti dovuti al loro carattere episodico e marginale. L’esperienza più rilevante, La Pace�GL�0DULQ�1HJUR��QDVFH�VRWWR�LO�VHJQR�GHO�SOXULOLQJXLVPR�H�LQFRQWUD��ÀQR�ai primi decenni del Seicento, una discreta fortuna editoriale. Tuttavia la presenza della parte del servo friulano, già in sé non cospicua, è stata riconosciuta come fortuita. Essa dunque, pur essendo per diversi aspetti eloquente, poco informa sui rapporti con il Friuli. L’individuazione di due commedie del latisanese Marc’Antonio Gattinon, una delle quali ospita interventi tutt’altro che accessori di un estroverso villano friulano, cambia il panorama del primo Seicento e lascia spazio a suggestioni di ampia portata. Sebbene l’orizzonte editoriale sia ancora quello veneziano, non può non colpire la convergenza con gli interessi multiformi e le poliedriche in-clinazioni di Giovan Battista Donato, veneziano di nascita, friulano d’adozione e aperto a scambi di respiro non limitato: una convergenza che mette in discussione l’eccezionalità delle due vicende e induce a prendere nuovamente in esame lo scenario culturale della bassa pianura friulana. La prima delle due commedie di Gattinon costituiva l’oggetto della tesi di dottorato in Ladinistica e plurilinguismo che ho discusso nel 2005 presso l’Uni-versità degli Studi di Udine e che in questa sede propongo in forma rielaborata e aggiornata. Sono indagati nell’introduzione il contesto di origine delle opere di Gattinon H�O·LQGROH�GHO�ORUR�SOXULOLQJXLVPR��FRVu�FRPH�HPHUJRQR�GDO�PDWHULDOH�GRFXPHQ-WDULR�FKH�q�VWDWR�ÀQRUD�SRVVLELOH�UHSHULUH�H�GDL�QXPHURVL�VWXGL�VXOOD�FRPPHGLD�QHO�Cinquecento e nel Seicento. Oggetto principale della tesi è l’edizione dei Travagli d’amore, qui accompagnata da un commento che mira a un’interpretazione appro-fondita del testo. L’analisi delle lingue e, in parte, l’esplorazione delle strategie stilistiche sottese ai dialoghi, agevolano l’osservazione degli elementi di fedeltà DO�UHDOH�H�GL�ÀQ]LRQH�FRPLFD�H�FDULFDWXUDOH��'DJOL�VSRJOL�OHVVLFDOL��LQÀQH��HPHUJH�lo spessore apprezzabile delle varietà che compongono questo saggio inedito di plurilinguismo teatrale. Al prof. Rienzo Pellegrini, che della tesi è stato il relatore, rinnovo profonda gratitudine per avermi proposto un argomento impegnativo e a lui molto caro, e per avermi guidato con saggezza e sensibilità nell’esplorazione. Molte persone mi sono state vicine con suggerimenti e consigli determinanti per lo svolgimen-to del lavoro: ricordo in particolare Maria Cristina Cescutti, Giorgio Faggin, Roberto Frisano, Vinicio Galasso, Lucia Lazzerini, Claudio Lorenzini, Carla
Premessa32
Marcato, Marco Menato, Laura Nascimben, Marco Prandoni, Lorenzo Renzi, Tullio Telmon, Laura Vanelli e Piermario Vescovo. Esprimo a questi studiosi, e anche a quanti hanno seguito il lavoro con attenzione e cura, un ringraziamento cordiale e caloroso. Per Giorgio Ferigo, con il quale avrei volentieri continuato a discutere le pagine di Gattinon, un ricordo colmo di affetto, pur nell’amarezza di un distacco prematuro e sofferto. � (VSULPR�LQÀQH�DOOD�6RFLHWj�)LORORJLFD�)ULXODQD��QHOOH�SHUVRQH�GHO�SUHVLGHQWH�Federico Vicario e del direttore Feliciano Medeot, tutta la mia riconoscenza per l’interesse manifestato verso questo lavoro e per averne reso possibile la pubbli-cazione.
G. Z.
INTRODUZIONE
L’autore
I registri canonici della pieve abbaziale di Latisana non restituiscono la data di nascita di Marc’Antonio Gattinon1. Lo stato in cui versano i volumi non consente peraltro di escludere con certezza che egli sia nato in tale località2, anche perché rimane privo di registrazioni l’arco cronologico compreso tra il 1573 e il 14 marzo 1577, entro il quale potrebbe essere collocato con una buona approssimazione, in base alle fasi successive, l’anno di nascita3. È invece nota la paternità, che si desume da un legato del 28 marzo 16324: Marc’Antonio è figlio di Andrea, il cui nome compare nell’anagrafe canonica anche a proposito di una Menega che muore il 7 aprile 16025. Dal matrimonio con una certa Tiberia nascono almeno quattro figli: Giacinto (b. il 19 luglio 1604, m. il 23 settembre 1605)6, Elisabetta (b. 18 VHWWHPEUH�������P�����JLXJQR������"�7, Andrea (n. 2 ottobre 1610, m. 8 aprile
1 Per altri profili biografici sull’autore cfr. ZANELLO Gattinon e GALASSO Marc’Antonio Gattinon.2 Archivio della pieve abbaziale di Latisana (d’ora innanzi: APL); il primo dei registri battesimali,
non numerato, riguarda gli anni tra il 1557 e il 1573, ma molte carte sono strappate ed è evidente che altre risultano mancanti; il secondo reca l’indicazione: Battesimi libro primo. Da 14 marzo 1577 sino anno 1600. Le trascrizioni seguono anche qui i criteri adottati nell’edizione della commedia. Sono grato all’abate pievano di Latisana, mons. Carlo Fant, il quale ha agevolato con ogni premura le mie ricerche.
3 Vinicio Galasso ritiene verosimile che sia giunto «a Latisana da Venezia nel tardo Cinquecento, con o al seguito del padre Andrea» (GALASSO Marc’Antonio Gattinon p. 54).
4 APL, Libro di governo della veneranda chiesa. Principia nell’anno [1627], c. 38v.5 APL, Libro primo morti. Incomincia l’anno 1600 sino l’anno 1609, cc. non numerate, lettera M:
«7 april [1602]. Morite Menega; stava con messer Andrea Gatinon».6 APL, Libro secondo battesimi��F����Y��©$Gu����OXJOLR�������-DFLQWR�H�%RQDYHQWXUD��ILROR�GH�PHVVHU�
Marc’Antonio Gatinone et de madonna Tiberia sua consorte, fu batizato da me pre Battista Quarta-ro; fu compare messer Andrea Camuffo, comadre madonna Angelica Gordin». Libro primo morti incomincia l’anno 1600 sino l’anno 1609, cc. non numerate, lettera I: «23 settembrio [1605]. Morite -DFLQWR��ILRO�GH�PHVVHU�0DUF·$QWRQLR�*DWWLQRQHª�
7 APL, Libro secondo battesimi��F����U��©����VHWWH�PEULR�>"@�>����@��,VDEHWD��ILJOLROD�GH�PHVVHU�Marc’Antonio Gattinone et de madonna Tiberia sua consorte, fu batizata da me Giovanni Battista Quartaro ecconomo; fu compadre l’eccellente m(astr)o medico il signor Zaneto Bertolisio da Sacile, comadre madona Isabeta Dionori». Libro quinto morti. Incomincia primo settembre 1678 sino l’anno 1696��F������©$Gu����GHWWR�>JLXJQR@�������/D�VLJQRUD�(OLVDEHWWD�*DWWLQRQL�GL�TXHVWD�terra, d’anni 70 incirca, nella comunione di santa madre Chiesa, riceuti li SS. Sacramenti di peni-tenza, eucaristia et estrema unzione da me suddetto curato [Pietro Sbaiz], rese l’anima al Signore il giorno antecedente, et hoggi il suo corpo fu sepolto nella chiesa di S. Croce con l’assistenza di me suddetto». L’indicazione dell’età proposta dal registro non collima con il calcolo basato sugli estremi biografici, ma, poiché molte delle operazioni per il calcolo dell’età annotate sui libri sono
Introduzione34
1654)8, Anna (n. 16 settembre 1612)9; l’ultima figlia, Michela (b. 29 settembre 1621)10, nasce invece dall’unione con la serva.
Dalle carte dell’Archivio notarile antico, conservate presso l’Archivio di Stato di Udine, si ricava che Gattinon inizia ad esercitare la professione notarile nel 159611. Alcuni anni dopo, in una data non meglio precisata, gli viene affidato l’incarico di cancelliere della giurisdizione di Latisana12, ufficio che nel 1601 risulta ancora mantenuto da Giovanni Pasquali13.
Il 10 settembre 1628, nell’adunanza del «consiglio generale chiamato d’Ar-ringo», Gattinon viene eletto, tra i membri «di dentro la Terra», nel magnifico
inesatte proprio di un decennio, anche in questo caso è probabile l’errore e che quindi si tratti proprio della Elisabetta di Marc’Antonio che nasce nel 1606. Il nome Elisabetta, Lisabetta o Isabetta non compare in altri casi. Cfr. anche Matrimoni libro secondo. Incomincia l’anno 1600, 11 novembre, termina l’anno 1640, 7 febbraio��F����U��©$Gu����GHWWR�>IHEEUDLR�����@��)X�FHOHEUDWR�LO�PDWULPRQLR�tra il signor Franzesco, figliolo del quondam signor Gierolamo Quartaro, et la signora Isabeta, figliola del signor Marcantonio Gattinoni, da me pre Franzesco Vespa piovano et vicario foraneo, fatte le tre publicationi, secondo il sacro concilio di Trento, nella chiesa della Sabbionera, presenti il signor Silvio Caprili et il signor Brandiso Grandis et molti altri». La chiesa di Santa Croce (sec. ;,9�"���;9,,,���RUD�GLVWUXWWD��VL�WURYDYD�DOO·LQFLUFD�GL�IURQWH�DOO·DWWXDOH�SDOD]]R�FRPXQDOH�
8 APL, Libro secondo battesimi��F���Y��©�����DGu���RWWREUH��$QGUHD��ILJOLROR�GHO�PHVVHU�0DUF·$QWRQLR�Gattinoni et della signora Tiberia sua moglie, fu battezato da me pre Francesco Vespa et tenut’al VDFUR�IRQWH�GDO�VHU�%DVWLDQ�6EDL]�HW�GD�PDGRQQD�%HWWD�'LDQRUD��QDFTXH�DGu���GHWWRª��Libro terzo morti. Incomincia l’anno 1630 sino l’anno 1659, c. 4v: «8 aprile 1654: il signor Andrea Gattinoni».
9 APL, Libro secondo battesimi��F���Y��©$Gu����VHWWHPEUH�������$QQD��ILJOLROD�GHO�VLJQRU�0DUF·$QWRQLR�Gattinoni e della signora Tiberia sua moglie, fu battizata da me pre Francesco Vespa pievano et WHQXW·DO�VDFUR�IRQWH�GDO�PHVVHU�%DVWLDQ�6EDL]�HW�OD�PDGULQD�/XFLHWWD�*URWWD��QDFTXH�DGu����GHWWRª��
10 APL, [Libro terzo battesimi@��F����U��©$Gu�GHWWR�>���VHWWHPEUH�����@��0LFKLHOD��ILJOLROD�GHO�VLJQRU�Marc’Antonio Gattinoni et di Maria sua serva, battezata da me pre Gregorio Lunardi; fu compare signor Zacaria Penzo et comare donna Prudentia».
11 Archivio di Stato di Udine, Archivio notarile antico (d’ora in poi rispettivamente ASU e ANA), b. 2686 (dal 19 agosto 1596 al 24 agosto 1613), b. 2687 (dal 1618 al 23 aprile 1633).
12 «A quei tempi la Terra di Latisana era sottoposta alla giurisdizione feudale delle potenti casate veneziane Vendramin e Mocenigo, rappresentate in loco da un capitano, al quale erano delegate le funzioni amministrative, giudiziarie e di polizia, assistito da un cancelliere, assai spesso un notaio. Per intrecci matrimoniali e compravendite fondiarie, nel corso del Seicento il feudo fu frazionato in parti (o carati, complessivamente ventiquattro) fra varie famiglie veneziane compatrone, tra queste temporaneamente anche il casato Lando» (GALASSO Marc’Antonio Gattinon p. 54). Per approfon-dimenti cfr. anche: CASSI Tre secoli; cfr. anche GALASSO Latisana pp. 59-122, MORASSI Economia e società in Friuli pp. 73-75.
13 ASU, Cancelleria giurisdizionale dei Vendramin e consorti (inv. num. 43), b. 4, vol. 8. Il fondo della Giurisdizione di Latisana (1553-1878) consta di sei buste. Esso contiene e ciò che resta di quel grande archivio e una piccola parte delle carte prodotte in questo lungo periodo dalla Cancelleria giurisdizionale dei Vendramin e consorti. Nel 1965 e 1966, in seguito alle alluvioni, l’archivio comunale è stato danneggiato dall’acqua e la parte storica quasi completamente distrutta. Cfr. A. TAMOS, L’archivio storico del Comune di Latisana, «La bassa», XIV (1993), 26, pp. 95-96.
Introduzione 59
centrata sull’uso del linguaggio nativo aveva ormai smarrito ogni vigore»83; la nuova temperie culturale «tendeva irreversibilmente, anche se conosce particolari momenti e luoghi di reazione, a relegare l’uso del dialetto a livello culturalmente subalterno, sempre più costretto tra il parodistico e l’osceno»84. Ormai il percorso è compiuto, e nello sfruttamento del significante a fini edonistici e di rappre-sentazione caricaturale dei personaggi si riconosce uno dei tratti distintivi della stagione in cui si collocano le prove letterarie di Gattinon.
Nella varia e articolata fenomenologia tipologica del plurilinguismo teatrale, Folena ha individuato «tre opposizioni e contrasti, ciascuno dei quali dà luogo a particolari effetti comici di disfunzioni e disturbi della comunicazione linguistica scenica, per la non-competenza o imperfetta competenza dei codici rispettivi: quegli equivoci linguistici, qui pro quo, paronomasie, che costituiscono uno dei luoghi prediletti di tutto il teatro comico»85. Il primo contrasto fa leva innanzitutto sulla variabilità diastratica e dunque può esplicarsi in molti modi, sfruttando ogni possibile gradualità, anche sociale, per opporre colto a incolto, lingua dominante o dialetto egemone o lingua aulica, a lingua subalterna o dialetto locale, ovvero urbanitas e rusticitas. Le altre due opposizioni si pongono sul piano orizzontale e diatopico. La seconda è una antinomia interregionale e riguarda l’incontro di dialetti di città e regioni diverse; prende di mira i tratti municipali e li conduce alla stilizzazione e alla tipizzazione delle maschere linguistiche fissate nella comme-dia dell’arte. La terza svolge lo stesso procedimento ma a livello internazionale, opponendo all’elemento indigeno ciò che di esotico è presente in realtà urbane generalmente conosciute come babeliche86.
È evidente che il gioco linguistico dei Travagli d’amore è strutturato intorno alle prime due antinomie, benché definizioni univoche siano chiaramente impra-ticabili. Nei dialoghi la coppia alto/basso contrappone, ad esempio, il veneziano di Pantalone e il dialetto di Burano parlato dal pescatore Comello, o il pedantesco di Pomponio e l’italiano stentato di Volpino. Il toscano parlato dagli innamorati ammette consistenti sfumature diafasiche, mentre l’uniformità colloca su poli opposti la lingua di Pancrazio, Polidoro, Periandro e Aquilio e quella delle ser-ve Florida e Violante. Sfuggono ad una classificazione gli esiti della collisione tra l’idioma di Graziano e il parlato di Polidamante o tra quello di Pomponio e
83 PADOAN Commedia rinascimentale veneta pp. 211-212. Emblema di questi abusi artificiosi è la commedia Li diversi linguaggi del romano Virgilio Verucci (1608), nella quale ogni personaggio parla una lingua diversa.
84 PADOAN Commedia rinascimentale veneta p. 213.85 FOLENA Le lingue della commedia p. 133.86 Cfr. FOLENA Le lingue della commedia pp. 133-135.
Introduzione60
OD�OLQJXD�GL�3DQFUD]LR�R�)ORULQGR��,QIDWWL�LO�SHGDQWH�H�O·DYYRFDWR�HVLELVFRQR�Vu�un armamentario colto, ma i loro sforzi rocamboleschi lo fanno precipitare nel patetico e nel meschino.
Di questa prima opposizione potrebbe partecipare anche il rapporto fra il pa-drone Pantalon e il servo Malacarne. Se, per un verso, soltanto un accurato appro-fondimento potrebbe forse chiarire la reciproca posizione assunta da veneziano e friulano nella Latisana di inizio Seicento, appare necessario tenere in debito conto il dato scenico, che, collocando la vicenda a Padova, mette a confronto un villano inurbato e un presunto mercante che in quella città si è trasferito. Il maldestro tentativo, da parte di Malacarne, di parlare il veneziano (ma dietro esortazione del padrone, IV 107) fa pensare a una collocazione subalterna del friulano, che tuttavia non appare trattato con intenzioni blasoniche; a rincalzo, trova spazio nella commedia anche la rivendicazione patriottica (seppure in relazione alla lingua di Graziano: «Ovvè, lenghe friulane bedenette, cu di dut lu triviars dal mont ees la plui belle!», II 131), che reclama per la lingua di Malacarne, se non una superiorità, almeno un confronto paritario con il veneziano.
L’egemonia del dialetto della città lagunare travolge anche il bergamasco del facchino Zambon, sul quale si condensano acidi non meno corrosivi di quelli che attaccano il Graziano e il pedante. Mi sembra comunque che anche in questo caso l’incontro si assesti ormai su un piano orizzontale e che la prevalenza del fine caratterizzante preluda ai tipi della commedia dell’arte, dichiarando in un certo senso anche la nuova posizione del veneziano nella commedia.
Alla luce di quanto finora si è osservato, si può tentare una lettura plausibile per il fine dichiarato dall’autore per mezzo del Prologo: «nella lingua del forlano, nei spropositi del Gratiano e nell’accortezza e burle d’un astuto ragazzo prendersi piacere» (Pr. 17); anche qui l’impegno nella realizzazione del plurilinguismo non è più rivolto tanto alla tipizzazione, che ormai discende facilmente da pochi tratti allusivi ben riconoscibili, quanto alla sollecitazione parodica e alla moltiplicazione sfrenata dei piani di divertimento.
NOTA AL TESTO
L’editio princeps
Gli esemplari delle commedie di Marc’Antonio Gattinon finora conosciuti non sono numerosi1. Quelli dei Travagli d’amore, ben più rari, si possono ricondurre a due edizioni veneziane pubblicate a dieci anni di distanza l’una dall’altra. Il frontespizio della princeps è contenuto entro una ricca cornice tipografica, che reca nella parte superiore lo stemma di Francesco Lando, inquartato d’argento e di nero2, compreso tra due putti-tritoni alati che soffiano ciascuno in una tofa o buccina; nella parte inferiore trovano posto altre due figure: il putto a destra suona una lira da braccio e cavalca un pesce di grandi dimensioni; nella figura a sinistra si potrebbe riconoscere una Venere nascente che, adagiata su una con-chiglia che fluttua sulle onde del mare, con la mano destra copre il seno e con la sinistra regge tre oggetti non chiaramente identificabili3; sulla conchiglia si legge la firma dell’incisore Francesco Valesio4:
c. a1r: I | TRAVAGLI | d’Amore | COMEDIA | del Signor | M. Antonio Gattinon | da Latisana. | Opera non men curiosa, | che diletteuole. | IN VENETIA, | Presso Angelo Reghettini | Con licenza, e Priuil. | 1622
Colofone: assente.Formula collazionale: 12°; A-G12; 74 cc.Impronta: re,& ten- a-i- Fiad (3) 1622 (A)Contenuto: A1r: titolo. A1v: bianco. A2r: ALL’ILLUSTRISSIMO | mio Signore, Sig. e Patron | Colendissimo, | Il Sig. Francesco Lando. A3v: INTERLOCUTORI. A4r: PROLOGO. A7r: ATTO PRIMO. B9r: ATTO SECONDO. C11v: ATTO TERZO. E1r: ATTO QUARTO. F1r: ATTO QUINTO. G9v: IL FINE. Titolo corrente: PROLOGO; ATTO | [PRIMO] [SECONDO] [TERZO] [QUARTO] [QUINTO]
1 Per il censimento degli esemplari, che naturalmente è da considerarsi provvisorio, mi sono servito per l’Italia dei dati del Metaopac Azalai Italiano (in linea all’indirizzo http://azalai.cilea.it/mai/), per l’estero di quelli del Karlsruher Virtueller Katalog (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html); queste banche dati sono state consultate l’ultima volta il 30 novembre 2014. Inoltre ho fatto riferimento ad altre opere e cataloghi cartacei o in linea di biblioteche italiane o straniere.
2 CROLLALANZA Dizionario storico-blasonico II p. 7.3 I tre oggetti appaiono simili a spilloni; potrebbero anche essere anemoni (uno degli attributi di
Venere), ma il loro aspetto non è quello di un fiore.4 Nato a Bologna nel 1560 circa, fu attivo a Venezia nella prima metà del Seicento come disegnatore
e incisore.
04
Nota al testo62
Esemplari noti: Pesaro, Biblioteca Oliveriana, B 12-07-35 (catalogo on line; editori Reghettini e Sarzina); Paris, Bibliothèque nationale de France, 8-RE-3896 (catalogo on line; editori Reghettini e Sarzina, s.d.); London, British Library, 1071.k.13.(7.) (catalogo on line; editore Reghettini); 7RURQWR��-RKQ�3��5REDUWV�5HVHDUFK�/LEUDU\��5DUH�%RRN�&ROOHFWLRQ��LWS�VPE�����FDWDORJR�RQ�OLQH��editore Reghettini, 1623). Esemplari esaminati: Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Dramm. 668 (catalogo on line; editore Reghettini; sul frontespizio la data del 1622 è corretta manualmente in 1623); Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 4982-A.AltMag (catalogo on line; editori Reghettini e Sarzina; sul frontespizio la data del 1622 è corretta manualmente in 1623).
Alcuni esemplari recano, in una fascia ricavata sotto la cornice tipografica, la seguente dicitura, che attesta la presenza di un’altra emissione:
IN VENETIA, PRESSO GIACOMO SARZINA.
Oltre all’incisione piuttosto elaborata che, nel frontespizio, contiene il titolo, si riscontrano fregi e iniziali ornate (nella dedica, nel prologo e all’inizio dei singoli atti). I caratteri appaiono alquanto ordinati, mentre i refusi manifesti sono di numero relativamente contenuto. La data di stampa e quella della dedica a Francesco Lando coincidono; è dunque ragionevole supporre che si tratti di una prima edizione5.
Emendamenti alla princeps
Fra i guasti più vistosi sono ben riconoscibili i tipici accidenti tipografici. La lezione del 1622 trascritta di seguito coincide con la stampa, l’emendamento con l’edizione qui offerta.
1622 Emendamento proposto Dedica maturità dell’opra immaturità dell’opraPrologo 17 conuenir con[tra]venirI 3 me faceste ne facesteI 4 splenderò spenderòI 16 Quid possunt Quid poscunt I 23 Pol. PANCRATIO
I 34 nec latum un ouem nec latum unguemAudiame Andiame
5 Nonostante gli interventi riscontrati sui frontespizi dei due esemplari esaminati (e l’indicazione del FDWDORJR�LQ�OLQHD�GHOOD�-RKQ�3��5REDUWV�5HVHDUFK�/LEUDU\�GL�7RURQWR���OD�GHGLFD�D�)UDQFHVFR�/DQGR��datata al 29 settembre 1622, condurrebbe a escludere che la correzione adegui la data di stampa, magari interpretando more veneto il 1622.
Nota al testo82
si sono risolte in forma unita le oscillazioni delle congiunzioni e delle locuzioni avverbiali (per ciò ĺ perciò, poi che ĺ poiché, ne anco ĺ neanco, hor mai ĺ hormai, in darno ĺ indarno, in somma ĺ insomma, là onde ĺ laonde, mal grado ĺ malgrado, pur troppo ĺ purtroppo, tal volta ĺ talvolta, altre tanto ĺ altretanto, altra tanto ĺ altratanto, dentre part ĺ d’entrepart, a punto ĺ apunto, sopra tutto ĺ sopratutto, da per tutto ĺ dapertutto…, ma acciò che);
si rimedia alle altre spaziature irregolari e alle incertezze tipografiche, frequenti nelle battute in friulano e nella lingua di Graziano: biel a vual ĺ biel avual, ch’al hore ĺ ch’alhore ‘che allora’, da pruuf ĺ dapruuf, dentre part ĺ d’entrepart, e darot ĺ ed arot, in caluriit ĺ incaluriit, in quintri ĺ inquintri, in travignij ĺ intravignii, mal fattor ĺ malfattor, ville vuarbe ĺ Villevuarbe…;
le grafie del grazianesco e del friulano hanno richiesto particolare attenzione, soprattutto nella coerente separazione di pronomi, negazioni, congiunzioni e articoli e nell’impiego di segni diacritici, cosicché, pur mantenendo sostanzialmente i grafemi dell’originale, la divisione delle parole risulta profondamente modificata;
nei casi in cui siano presenti diversi elementi clitici (p. es. i pronomi dativo e oggetto nel friulano), si è preferita l’univerbazione quando l’unione mostra chiari cambiamenti fonologici (es. mal ‘me lo’); il clitico è rimasto separato nei casi in cui sia univocamente riconoscibile e isolabile (p. es. il clitico dativo di 3 s. i); per il femminile, anche in presenza di un’unica parola fonologica, l’apice ha la funzione di ricordare la presenza di altre forme (es. al’, ala) segnalando la caduta della vocale e l’appoggio alla vocale iniziale della parola successiva;
l’uso delle maiuscole è stato adeguato alle consuetudini moderne, ma nei casi di polisemia si è cercato di lasciar trasparire l’allusione agli eventuali nomi propri soggetti a deformazione burlesca;
l’interpunzione è stata completamente rinnovata, e rimane dubbia in pochi casi in cui sono possibili interpretazioni diverse o sensibili sfumature; si sono quindi introdotti il punto esclamativo, i tre punti (ad indicare interruzione o sospensione del discorso), le virgolette.
Il rinvio alle opere teatrali segue questi criteri: l’atto è indicato mediante numero romano, mentre il numero arabo rinvia all’entità minima numerata dal curatore, cioè la scena, la battuta o una parte di essa (o il verso nelle opere in poesia); eventuali rinvii a intere scene sono precedute dall’abbreviazione sc.
Le battute in friulano, veneziano, buranello, bergamasco, grazianesco e pedantesco sono state tradotte in modo pressoché sistematico a piè pagina. A motivo della molteplicità dei piani semantici riconoscibili negli interventi di Graziano, è stato necessario articolarne in modo più complesso la traduzione: oltre alla deformazione burlesca, tradotta in modo letterale, viene proposta fra
Nota al testo 83
parentesi tonde l’interpretazione del contenuto reale, che nell’eloquio appare talora completamente travisato e distorto; del terzo livello semantico, costituito dalle eventuali allusioni a sovrasensi osceni, si dà conto anche nel commento.
Nell’apparato, che chiosa il testo ed evidenzia le questioni che rimangono aperte, le opere e le edizioni moderne sono citate normalmente senza alcun in-tervento; le virgolette basse adottate da PRATI Voci per i significati sono sostituite da apici, il maiuscoletto e il maiuscolo di BOERIO sono trasformati in corsivi, mentre si aggiunge il corsivo al maiuscoletto dei nomi dei personaggi all’inizio delle battute citate dalle commedie e dai dialoghi. Sulle citazioni dall’Amorosa di Gattinon e dall’anastatica del Discorso di Banchieri si interviene secondo i criteri adottati per i Travagli.
All’illustrissimomio signore, signor e patron
colendissimo,
il signor Francesco Lando
Quella benignità singolare (tacerò l’altre virtù ed heroiche attioni di vostra signoria illustrissima per non mi sommergere nel vasto e profondo oceano delle sue lodi) con la quale ella si rende non pur ammirabile nel conspetto del mondo, ma con soave e amorosa violenza desta altresì e sospinge gl’animi e i cuori degl’huomini ad ambire la gratia e a bramare la protettione di vostra signoria illustrissima, spinse me ancora a dedicarmi suo humile ma divotissimo servo, e hora m’invita a publicare sotto i fortunati auspicii del felice suo nome questo mio, non dirò parto, ma aborto concepito nel tempo de’ miei verd’anni, tenuto sin al dì d’hoggi involto nelle tenebre e fascie dell’oblio, e hora esposto alla luce, per volontà di chi mi può comandare, col nome e iscrittione de’ Travagli d’amore. Iscusi vostra signoria illustrissima, la prego, questa mia (forse troppa) confidenza, e accetti il dono di questa primitie del sterile mio ingegno, e nella immaturità dell’opra riconosca la maturità dell’affetto mio riverente, supplendo ella, con la grandezza dell’incomparabile sua humanità e con la generosità dell’animo invitto, ove la picciolezza del dono e la bassezza dell’ingegno mio non giongono, con che fine augurandole dal Cielo felice avenimento d’ogni suo desiderio, humilmente quanto devo le bacio le mani.
Di Latisana, il dì 29 settembre 1622.
Di vostra signoria illustrissima
humilissimo e obligatissimo servitore
Marc’Antonio Gattinon
INTERLOCUTORI
PROLOGO
PANCRATIO padre di FlorindoFLORINDO innamorato di PantasileaPOLIDORO soldatoPERIANDRO padre di RosmondaROSMONDA amante di FlorindoAQUILIO medicoFILIPPINO ragazzoPOMPONIO pedanteVOLPINO ragazzoPOLIDAMANTE amante di PantasileaGRATIANO
VIOLANTE [serva di Micasta]PANTALON padre di PantasileaPANTASILEA amante di FlorindoFLORIDA serva [di Pantalon]MALACARNE villano, forlanoZAMBON bergamascoBarba COMELLO pescaor da Buran
1 L’invito al silenzio, al pari di altri aspetti di questo prologo, è usuale. 2 Secondo un comportamento comune nei prologhi, il forestiero rifiuta di andarsene; cfr.
l’atteggiamento dello Spagnuolo nel prologo di PICCOLOMINI Amor costante (BORSELLINO Commedie I pp. 300-307).
11 Per rispondere alle richieste del Forastiere, il Prologo introduce a questo punto una riflessione teorica, poetica e drammaturgica, ricapitolando le caratteristiche della commedia e preparandosi a rispondere agli ulteriori rilievi dell’interlocutore. L’opera insiste su due azioni principali, l’una seria e l’altra faceta (verosimilmente riconoscibili nell’amore impedito tra Florindo e Rosmonda e nell’innamoramento senile, utilitaristico e grottesco, di Pantalone per Micasta); la seconda costituisce una sorta di digressione rispetto alla prima, dalla quale peraltro dipende.
PROLOGO
Si finge ch’un giovane forastiere stia sedente sul palco della scena e che dalla medesma scena venga uno per far sgombrar esso palco da’ fanciulli, e dice:
1 PROLOGO Silentio, signori, silentio, per cortesia, ch’ora si darà principio! Andate giù, fanciulli, andate giù! [al forestiero] E voi, galanthuomo, che IDWH�Oj"�&KH�SURVRQWLRQH�q�OD�YRVWUD�DG�RFFXSDU�LO�SDOFR"
2 FORASTIERE Con le buone, caro fratello, ché necessità e non prosontione mi fece salir qui, perché, non trovando ov’io potessi commodamente stare, presi partito di montar qua su.
3 PROLOGO Questo non è luoco per voi, havendosene a servire i recitanti, però andate giù.
4 FORASTIERE Sapete pure ch’in simili occasioni non solamente è atto di cortesia e di buona creanza, ma di debito insieme l’honorar i forastieri e il dar loro commodità di luoco, però lasciatemi, vi prego.
5 PROLOGO Mi spiace di non vi potere lasciare e gratiarvi come vorreste, ma IDUz�Vu�FKH�QRQ�YL�PDQFKHUj�OXRFR�
6 FORASTIERE Havevo pur il gran desiderio di sentire questa vostra comedia. 7 PROLOGO Il levarvi di qua per comodarvi altrove non impedisce che non la
possiate ascoltare. 8 FORASTIERE Son contento d’andarvi, ma ditemi prima il titolo dell’opera. 9 PROLOGO S’è compiacciuto l’autore di titolarla I Travagli d’Amore. 10 FORASTIERE L’iscrittione è vaga e curiosa, ma vorrei anco sapere se sarà breve
e se participerà del faceto congionto col serio conforme all’uso moderno. 11 PROLOGO Farete voi questo giuditio quando ascoltata l’haverete. Mi giova
però credere che, per esser formata sopra dui accidenti, e introducendosi in essa diversità di persone e di linguaggi, participerà dell’uno e dell’altro, e vi potrebbe piacere.
ATTO PRIMO
SCENA PRIMAPancratio e Polidoro
1 PANCRATIO Se sapeste, messer Polidoro mio caro, la cagione del travaglio che FRVu�LQWHUQDPHQWH�PL�FUXFFLD��QRQ�YL�PHUDYLJOLDUHVWH�SHU�DYHQWXUD�GL�TXHVWD�insolita mia malinconia.
2 POLIDORO Io l’istimo gravissima, perché so c’havendo il forte ed heroico animo di vostra signoria profondato le radici nello scoglio della virtù e della FRVWDQ]D��QRQ�SXz�Vu�GL�OHJJLHUL�GDOOD�IRU]D�G·LPSHWXRVL�YHQWL�GL�TXDOVLYRJOLD�avversità o dolore esser abbatuto o crolato. Ma s’egli è vero, come è verissimo, che la communicatione de’ travagli arrechi al patiente alcun solevamento, io la prego che di participarli meco si compiaccia.
3 PANCRATIO Pensai farlo senza che voi ne faceste alcuna instanza, non havend’io con altro oggetto eletta e ricercata la persona vostra in questo mio viaggio che per rasserenare la densa nebbia de’ miei foschi pensieri col beneficio dell’aura di qualche amorevole ricordo e fruttuoso consiglio vostro.
4 POLIDORO Il giuditio ch’ella fa del mio consiglio non è argomento d’alcun PLR�PHULWR��PD�Vu�EHQH�GROFH�LQJDQQR�GHOOD�VXD�PROWD�DIIHWWLRQH��6DSSLD�SHUz�ch’io per lei spenderò volentieri ogni mio talento, qual egli si sia, e anco O·LVWHVVD�YLWD��Vu�FRPH�RFFRUUHQGR�YHGUj�GDJO·HIIHWWL�
5 PANCRATIO 9L�ULQJUDWLR�LQILQLWDPHQWH�H�VDSSLDWH�FKH��Vu�FRPH�LQ�HVWLPDUYL�huomo saggio, fedele e mio grande amico io so di non essermi ingannato, FRVu�YRL�QRQ�GRYHWH�SXQWR�GXELWDUH�GL�QRQ�WURYDU�LQ�PH�VHPSUH�TXHOOD�corrispondenza d’affetto e di gratitudine d’animo ch’a’ vostri meriti ed al mio obligo si conviene. Udite: nella città di Viterbo, come sapete, tra l’altre famiglie nobili e antiche, quella del signor Periandro Fedeli e la nostra de’ Brancadori tengono il primo luogo, seben fra sé medesime per lo passato furono di poca o dirò niuna convenienza. Avvenne hor fa tre anni che Rosmonda, figliuola del signor Periandro, all’hor d’età ancor tenera, o fosse perché qualche occulta cagione l’inclinasse, o che la conformità del sangue la inducesse, o pure perché la vicinanza de’ nostri palagi, porgendole commodità opportuna di frequente vedere Florindo mio figlio, le ne desse occasione, basta, che dell’amor del medesimo Florindo fortemente s’accese, e, come il proprio degli amanti sia il desiderio di veder sempre l’amato oggetto, FRVu�)ORULQGR�H�5RVPRQGD�TXDVL�PDL�VHPSUH�DOOH�ILQHVWUH�DPRUHJJLDQGR�VL�trovavano. S’avvide il signor Periandro e minacciò Florindo che d’amar
I travagli d’amore96
Rosmonda egli desistesse, e a me fece intendere che lo frastornassi, quando che no si sarebbono le nemicitie passate tra la sua e nostra famiglia rinovellate. Io, desideroso di pace e di quiete, stimai bene mandar Florindo allo studio di Bologna, meco stesso nell’animo divisando che l’assenza fosse potente mezo di rallentare l’incendio d’amore. Non ha giovato, perché, con lettere temprando le pene della lontananza, lo hanno come vive bragie entro le ceneri reciprocamente conservato, laonde fu di mestieri levarlo da quello studio e condurlo in questa città sotto la disciplina del signor Pomponio, mastro di lettere humane, ove sin al presente dimora.
6 POLIDORO Quando Amore, con l’acutezza de’ suoi fieri strali, ha piagato il cuore d’alcuno amante, io credo, signor mio, che poco giovi la distanza o O·LQWHUYDOOR�SHU�ULVDQDUOR��0D�FKH�Q·q�VHJXLWR�SRL"
7 PANCRATIO La figlia, senza far motto ad alcun dei parenti o de’ famigliari, s’è levata di casa e di lei haver non si può novella veruna; perciò il padre, c’ha preso sospetto che per cagione e opra di Florindo si sia fuggita, avampa d’ira e di sdegno, non trova riposo nell’animo, vuol romper la pace e va mille insidie tessendo contra Florindo mio. Ho però io stimato ispediente di venire con la scorta vostra a provedere alla sua e mia salute. Hora considerate s’io ho giusta cagione di viver doloroso.
8 POLIDORO Mi spiace il vostro travaglio, il quale veramente è grande, ma sarebbe vie maggiore senza dubbio quando il signor Florindo havesse in questa partenza havuto parte.
9 PANCRATIO Siamo nello stesso, perché il signor Periandro per certissimo lo tiene. Questa, s’io non m’inganno, del signor precettore è l’habitatione. Avertite di non far sapere a Florindo o ad altra persona che Rosmonda sia partita e, s’egli qualche informatione di lei v’addimandasse di gratia, di non conoscerla fingete.
10 POLIDORO Non occorre ch’io m’iscusi fingendo, perché veramente non la conosco.
11 PANCRATIO Tanto meglio, dunque. Bussate. 12 POLIDORO [bussa alla porta di Pomponio] Tich, tich, toch, toch.
I travagli d’amore108
62 «La accompagno con i migliori auguri. Vada con le colombe di Venere e con i pavoni di Giunone».
66 «Via, ora hai provato il vivere e le abitudini di casa mia, conosci il salario che ti voglio dare e il servizio che devi svolgere. Ti rimane di farmi sapere il tuo nome, quello del tuo signor padre e il tuo luogo di nascita perché possa, ad ogni buon conto, prendere nota sul registro».
67 «Volentieri, signore. Mio padre si chiamava barbe Bartolomeo di Badoccli spaccacapello di Villaorba, e mia madre si chiamava la agne Biagia, che fu figlia del barbe Giacomo Tentimbon di Forame di sotto, e io, a chi mi chiama, rispondo per Malacarne».
barbe: per un ampio quadro su etimologia e valori di questo nome di parentela cfr. almeno HEINEMANN Studi�SS�������������Badoccli: cfr. FAGGIN s.v. badocli: «1. (propriam. colui che non è ancora divenuto compare) minorenne, in minore età, minore […] 2. inetto, incapace, buono a nulla, salame» (p. 45); Nuovo Pirona s.v. Badòcli, badògli: «Uomo senza spirito e senza esperienza. Badòcli = Chi non è ancora divenuto compare: Iscî di badocli = Diventar SDGULQR��HQWUDUH�LQ�FRPSDUDWLFR��H�SHU�HVW��$PPDOL]]LUVL��VFDOWULUVLª��S���������sclappechiaviel: lett. ‘spaccacapello’; cfr. Nuovo Pirona s.v. Ciavêl, ciavél, ciavêli: «Sclapâ il ciavêl, per estrema SDUVLPRQLD�QHOOR�VSHQGHUHª��S����������Villevuarbe: cfr. Nuovo Pirona s.v. Vileuàrbe: «topon. nella loc. Chei di Vileuàrbe� �,O�VRQQRª��S�����������hume: il Nuovo Pirona s.v. Ùme rinvia a Màri, ma cita esempi da Tommaso Sabbadini, dall’Anonimo udinese del sec. XVI e da Ermes
61 PANCRATIO &RVu�PL�SURPHWWR�H�OH�EDFFLR�OH�PDQL� 62 PEDANTE Optimis ominibus te prosequor. Vada con le colombe di Venere e
con li pavoni di Giunone. 63 PANCRATIO &KH�YL�SDUH��PHVVHU�3ROLGRUR��GL�TXHVWR�SUHFHWWRUH" 64 POLIDORO Per mia fé ch’egl’è il roverscio di quanti pedanti habbia conosciuto
e praticato giamai, e mi pare che non sia fuor di proposito il partito che vi ha raccordato di congiunger Florindo con la figlia di quel personaggio venetiano.
65 PANCRATIO Non può riuscirmi per alcuna maniera utile il farlo. Tuttavolta, SHUFKp�QRQ�VL�GHYRQR�FRVu�IDFLOPHQWH�VSUH]]DUH�OH�RFFDVLRQL��DQGLDPR��FKH�non mancherò di prendere le debite informationi e faccia Dio poi quel che sia meglio.
SCENA SETTIMAPantalon e Malacarne suo servo
66 PANTALON Orsù, ti ha mo provao il viver e l’usanza de casa mia, ti sa il salario che te voggio dar e la servitù che ti ha da far. Resta che ti me facci saver il to nome, quel de to missier pare e ’l liogo del to nascimento azzò che possa, per ogni bon respetto, far nota in libro.
67 MALACARNE Vulintiir, signù. Miò pari si clamave barbe Meu di Badoccli sclappechiaviel di Villevuarbe e me hume si domandave l’agne Blasie, cu fo fie dal barbe Iacum Tentimbon di Foram di sot, e iò, a cui cu mi clame, rispuint par Malechiarn.
Atto primo 109
di Colloredo (p. 1245); in aggiunta cfr. anche la Furlanata di Marc’Antonio Barutti (ZANELLO Versi friulani p. 93 nota 47); il termine non sembra superare il Seicento (con l’eccezione di oma nell’ertano), ma in sincronia sopravvive nel ladino centrale (ùma), per il quale si dovrà tener conto dei rilievi riferiti s.v. in EWD vol. VII (pp. 215-216). Ma cfr. i rinvii proposti da HEINEMANN Studi p. 141. ��Tentimbon: cfr. Nuovo Pirona s.v. Tentimbòn: «Fior d’angiolo: Phyladelphus coronarius L., coltivato nei giardini fino alla regione submontana e qua e là inselvatichito nelle siepi e nei luoghi selvatici. […] Orgoglio di apparire […]. Anche per Bellimbusto, orgoglioso» (pp. 1182-1883); in questa accezione cfr. anche BOERIO s.v. Tientimbòn: «T. Fam. Bel cero; Bel cesto; Bel fusto; Cero; Fantoccio, dicesi per ironia d’uomo che si tenga bello – Bellimbusto; Un bell’imbusto; Un bel cece; Tulipano; Tulipo, dicesi in ischerzo a Colui che abbia in sè opinione di bello. In altro sign. Vanerello; Attoso; Lezioso; Inzibettato; Narciso inzibettato; Profumato, Giovane che sta sulla caricatura e sull’attillatura affettata» (p. 748). Cfr. anche Giovan Battista Donato: «gra’ mercè de sta vuoga che traghetta / el mio nome al pontil d’i tienti in bon» ([CLI]. Al mio..., in NASCIMBEN Giovan Battista Donato�S����������Foram di sot: oltre all’evidente allusione al basso corporeo (sulla quale cfr. almeno GDLI 6 p. 147 s.v. forame ‘ano, deretano’; e foramina culi in PACCAGNELLA Macaronee p. 128 e 129), si noti che Foràn è toponimo diffuso (Forame di Attimis, e, come nome comune, in Foràn di làndri, Foràn da la gjaline; cfr. Nuovo Pirona s.v., p. 333 e p. 1754), sfruttato in senso ambiguo anche nel Testamint di barba Pisul Stentadizza di Donato: «Alla bassa de chist pays del Foran di Iuliu» (PELLEGRINI R. Variazioni linguistiche p. 214; NASCIMBEN Giovan Battista Donato p. 122, con commento a p. 128); ma tutto il Testamint è percorso da deformazioni e parodie carnevalesche in linea con quelle presenti in TXHVWD�FRPPHGLD����Malechiarn: una rapida indagine nei registri canonici della pieve abbaziale di Latisana permette di verificare che il cognome Malacarne è alquanto diffuso nel Seicento. Peraltro qui si condensano molteplici valori semantici, parzialmente chiariti in III 58-59.
68 «Ti dirò il vero, io: quel fior d’angelo del buco di sotto mi gusta, ma quel Malacarne con quel UDQGHOOR�QRQ�PL�ILQLVFH�GL�SLDFHUH��2KLEz��FKH�QRPL�GD�VFRQJLXUDUH�VSLULWL�VRQR�TXHVWL"ª�
69 «Piano, adagio, padrone, non vi meravigliate. Ascoltate: i miei antenati sono stati grandi uomini, YHGHWH��GDEEHQH�H�RQRUDWL��HG�q�SURSULR�FRVu��SHU�LO�FRUQR�GHO�EXH�ª�
70 «Ti credo senza che tu giuri. Tutti però villani, voglio insomma dire abitanti e uomini di campagna». 71 «Niente affatto villani, e neppure di campagna. Io vi ripeto, potta di santo barile, che erano di
famiglia e di razza onorata. È però vero, poi, che le disgrazie li hanno sempre inseguiti». cali: la voce ha carattere eufemistico; letteralmente significa ‘caglio’ ed è attestata dal Nuovo
Pirona anche in espressioni assimilabili a Nol val un câli «Non vale un’acca» (s.v., p. 93).� ��� ©&RPH�VDUHEEH�D�GLUH"�(UDQR�DQFKH�GLVJUD]LDWL��QRQ�q�YHUR"ª�
68 PANTALON Te dirò il vero, mi: quel tentimbon del buso de sotto me garbizza, ma quel Malacarne con quel battocchio no me finisse da piaser. Ohibò, che QRPL�GD�VFRQ]XUDU�VSLULWL�[p�TXHVWL"
69 MALACARNE Plaanch, adasi, paron, no vi smaraveiat. Uldiit: iu mie’ vieris son VWDD]�JUDQFK·�KXPLJQ��YHGp��GDEHQ�H�G·DXQRU��HG�DO�q�FXVu��DO�TXDU�GL�EXz�
70 PANTALON Te ’l credo senza che ti te sconzuri. Tutti però villani, voio mo dir habitaori e homeni de villa.
71 MALACARNE Un cali e no villans, né di ville. Iò vus torni a dii, pofà seente Barile, cu a ierin di iint e di razze anorade. Al è ben ver mo cu lis disgratiis iur son simpri currudis dauur.
72 PANTALON &R·�VDUDYH�D�GLU"�,�JKLHUD�DQFKH�GHVJUDWLDL��Q·q�YHUR"
1 di Tantalo e di Titio: Tantalo è il potente re della Lidia (o della Frigia). È noto per il supplizio a cui fu sottoposto, ma varie sono le versioni dei favolisti sulla causa che determinò la terribile condanna: precipitato nell’Ade, fu immerso nell’acqua fino al mento, ma se lo sventurato voleva bere, l’acqua si ritirava; sul capo gli pendevano frutti prelibati che si innalzavano non appena egli levava in alto le mani per coglierli. Tizio è invece il gigante figlio di Zeus e di Elara; cercò di usare violenza a Leto e fu ucciso da Apollo e Artemide, corsi in aiuto della madre. Precipitato anch’egli nell’Ade, fu condannato ad avere roso da due avvoltoi il cuore, continuamente ricrescente.
ATTO SECONDO
SCENA PRIMAPolidamante solo
1 [POLIDAMANTE] 6RQR�FRVu�JUDQGL�L�WRUPHQWL�FK·LR�VHQWR��FRVu�DPDUH�O·DQJRVFLH�FK·LR�SUXRYR�H�FRVu�LQWROOHUDELOL�OH�SHQH�FK·LR�SDWLVFR�SHU�TXHVWD�DOWUHWDQWR�crudele quanto ostinata, ch’io sto per dire che non habbia l’inferno, per ultimo supplicio de’ miseri dannati, scempio, stratio o struggimento al mio pari, non che maggiore, e, se mi fosse lecito, direi esser di gran lunga più infelice di Tantalo e di Titio, perché se all’uno i voraci avoltoi rodono il core, a me infinite solecitudini, assai più forti d’alcun rostro d’uccello, stratiano continuamente le viscere, e se l’altro, seguendo lo scherno dell’esca avara e del fallace ruscello, patisce eterna fame e sete, le rimane almeno dall’acque correnti e dai pendenti frutti speranza di satiarsi; ma io non pure il bramato mio fine non poso conseguire, ma neanco il convenevole suo mezo sperare. Ah, che di te solo doler mi debbo, o Amore, e della iniqua tua e troppo dura OHJJH��FK·DOO·DPDWR�QRQ�ULDPDU�SHUPHWWH��0D�FKH�GLFR�LR�G·$PRUH"�(�GL�TXDO�OHJJH�SDUOR�H�GL�FKL�PL�ODPHQWR"�6·$PRU�DOWUR�QRQ�q�FK·XQ·RWLRVD�YRJOLD��L�suoi strali un van desio, la sua legge una rete invisibile d’inganni e il premio GL�OXL�GRORUH�H�SHQWLPHQWR��HG�LR�VDUz�Vu�IROOH�H�FRVu�SD]]R�FKH�YRJOLD�SL��OXQJR�WHPSR�VHJXLU�DOOD�FLHFD�XQ�IDQFLXO�FLHFR��XQ�IDYRORVR�'LR"�'XQTXH�D�WDQWD�YDQLWj�PL�IDUz�VHUYR"�&HUFKHUz�FKL�P·RGLD��DPHUz�FKL�PL�WRUPHQWD��VHJXLUz�FKL�PL�IXJJH�H�SUHJKHUz�FKL�QRQ�P·DVFROWD"�$K��QRQ�ILD�PDL�YHUR��Dirò dunque a quegli occhi di lucidissimi raggi coronati: Armatevi pur per altro cuore di fiamme e di strali, ch’io spero che la lontananza spegnerà il vostro cocente fuoco e rintuzzerà con l’oblio l’accutezza de’ vostri avelenati strali.
I travagli d’amore126
2 «Sono contento che tu gradisca e approvi questa mia decisione di sposarmi di nuovo». 3 «Capperi, eccome la approvo! Ascoltate: a mio parere, né il latte, né il miele, né le carrube,
QHSSXUH�LO�FRQIHWWR�GHJOL�VSH]LDOL�QRQ�q�FRVu�GROFH�Qp�FRVu�VDSRULWR�TXDQWR�O·DFFRPSDJQDPHQWR�GHOOD�donna. E che ciò sia vero voi lo vedete: innanzitutto che l’uomo vive in amore, in consolazione e in carità con la sua mogliettina ed è in suo potere lavorare il suo terreno quando vuole, senza paura che il guardiano glielo sottoponga a pignoramento; e inoltre, se gli duole una sola unghia del piede, la moglie, che lo desidera forte e sano, lo cura, lo consola, lo cerca, lo gratta, lo bacia e gli friziona la schiena finché gli ritorna la buona voglia e l’appetito».
menaa: per la valenza oscena cfr. DLA s.v. Menare 3 p. 316, e DV s.v. menàr num. 17 (pp. ������������spicigars: emendo da spicigras, ma la forma attestata nel Nuovo Pirona è spicïâr, con dileguo della velare.
4 «Veramente dici il vero». 5 «Al contrario poi, se l’uomo sta di propria volontà senza la cara donna, è sempre irascibile,
non ha mai un’ora di bene. Se vuole mangiare una minestra di legumi, se la deve mondare completamente da solo, se lo strumento è unto e sporco, se lo deve ripulire ancora da solo e, se vuole fare una polenta, sempre da solo deve menare la mestola e raschiare il paiolo».
iotte: cfr. Nuovo Pirona s.v. Jòta, jòte: «Sorta di minestra carnica composta di broade, del tipo particolare colà in uso, rammollita nell’acqua, quindi pestata (cfr. pestadizza), e cotta con fagioli, latte allungato e condimento di burro o lardo, con l’aggiunta di farina gialla finché tutto prenda la consistenza del zuf = farinata. […] la composizione dev’essere stata assai varia entrandovi SHUz�FRVWDQWHPHQWH�L�IDJLROLª��S����������liums: cfr. Nuovo Pirona s.v. Lïùm, lïùms: «Legume» (p. 529). Per le valenze secondarie cfr. DLA s.v. Minèstra: «Organo sessuale femminile» (pp. 330-331); Fagiòlo p. 179, Pisèllo�S���������su l’imprest è ingrassinaat: cfr. DLA s.v. Arnése p. 23, Struménto p. 570, Unto e Untume�S�������FRQ�HYLGHQWL�ULVYROWL�RVFHQL�����al scuegn bel sol
SCENA SECONDAPantalon e Malacarne con una manarra, cugni e mazzuola
2 PANTALON Me piase che te piasa e che ti laudi sta mia deliberation da remaridarme.
3 MALACARNE Cali, e di ce sorte ch’iò la loldi! Uldiit: al non è, pal miò credi, Qp�OX�ODW�Qp�OD�PLO��Qp�OLV�FDUREXOLV��QLDQFK·�OX�FRQIHW�GDL�VSLFLJDUV�FXVu�GRO]�Qp�FRVu�VDYXULLW�FX�q�OX�PHQDD�GH�IHPLQH��(�FK·DO�VHH�OX�YHU�YR�YHGLV��FX�l’hom viif, prime, in amor, in consolation e in caritaat cu la soo feminuzze, ed è in soo libertat di lavoraa lu so terren quant ch’al vul, senze poure cu lu uardian iu’ tueli lu pegn; seonde, s’a i dul un’ongle sole di piit, la muiir, cu lu brame fuart e san, lu miedie, lu console, lu ciir, lu russe, lu busse ed a iur freie la schene fin cu iur torne la bune voie e lu pitich.
4 PANTALON Veramente ti disi il vero. 5 MALACARNE Al cont[r]aar po, su l’hom sta di so pueste senze la chiare femine,
all’è simpri grintoos, al non ha mai un’hore di ben. S’al vul mangiaa une iotte di liums al sala scuegn biel sol remondaa, su l’imprest è ingrassinaat e sporch, al sal scuegn biel sol faa net e, s’al vul faa une polente, al scuegn bel sol menaa la mescule e raspaa la chialderie.
ATTO TERZO
SCENA PRIMAGratiano solo
1 [GRATIANO] Platon magna carobb, Quintilian tettò l’uliv, Seneca piantò l’arch, Celi Rodegin fè la bionda, Valeri sug Antonio, Corneli stè tacit, il botter fu in zardin, il traccagnot pres la campana e monsignor dè fuoch alla casa, vien po JL��GH�Ou�&HVDU��JL��GH�Ou�&DPLO�H�JL��GH�Ou�GDU�>"@�H��FRQ�TXHLVW��$OEHUW�DQGz�a Fiorenza, Marsili fè il cign e Giuda cavalcò avant, e dopp queist fu fuor d’
1 «Platone mangia carrube, Quintiliano succhiò l’ulivo, Seneca piantò l’arco, Celio Rodegino IHFH�>"@�OD�ELRQGD��9DOHULR�DVFLXJD�$QWRQLR��&RUQHOLR�ULPDVH�]LWWR��LO�ERWWDLR�IX�LQ�JLDUGLQR��LO�WUDFDJQRWWR�SUHVH�OD�FDPSDQD�H�PRQVLJQRUH�GLHGH�IXRFR�DOOD�FDVD��YLHQH�SRL�JL��GL�Ou�&HVDUH��JL��GL�Ou�&DPLOOR�H�JL��GHYH�GDUJOL�>"@�H��FRQ�TXHVWR��$OEHUWR�DQGz�D�)LUHQ]H��0DUVLOLR�IHFH�LO�cigno e Giuda cavalcò avanti, e dopo di questo fu fuori di sella Michea, palma rende l’oliva e D�0DGULVLR�q�OD�JDUD�>"@��H�ILQDOPHQWH�XQD�FDWHUYD�GL�*UHFL��GL�6SDJQROL�H�GL�)UDQFHVL�XQDQLPL�e concordi han lasciato scritto per cosa chiara che a voler condurre al confine un pangrattato e perfezionare un nega l’ozio che sia d’imporcanza, bisogna certificabilitudinitissimamente e indubitabilitudinitissimamente avere e possedere mia madre sul letto di volontà, e in questo non c’entra niente del Danubio, niente di Firenze e niente di Ferrara [ferro grattato], perché lo stesso è stato confermato e sigillato da Baldo vecchio e da Balduino, da Giasone, Covarogna e Felino, dall’inforcato del Varotto e dal Dino, da Giovanni fabbro, da Cristoforo porco e da Andrea facchino, sopra la lingua di manzo del testo, nella legge “È pericoloso”, nel paragrafo “Negoziando”, nel codice “Sulle cloache e le latrine”, dove notabilmente si culinclude che per guardarsi dal male, andare per il mondo e avere del bene è di mestiere avere giaco, zucca e crivello, e questo è noto e manifesto a molti: che, sotto credenza di calli e di podagra i poveretti soffrono di buon morbo gallico, di buon male di Napoli e di buon usufrutto della disonestà; e perciò dice testa di vacca, campo lungo e acqua pendente, sopra un capitale di Mercuriale, che D�FRVWRUR�QRQ�FL�YXROH�DOWUR��SHU�DVVRWWLJOLDUOR�>"@�H�SHU�VSXUJDUVL��FKH�LO�FDORUH�GL�XQD�VWXID��OD�siccità del pan biscotto, l’asprezza dell’acqua del legno santo e la vita di un galeotto, e chi non lo crede domandi al nostro Pantalone».
(«Platone, Macrobio, Quintiliano, Tito Livio, Seneca, Plutarco, Celio Rodigino, Flavio Biondo, Valerio, Svetonio, Cornelio Tacito, il Botero, Guicciardini, il Tarcagnota, il Campana e monsignor 'HOOD�&DVD��YLHQH�SRL�*LXOLR�&HVDUH��*LXOLR�&DPLOOR�H�*LXOLR�'DULR�>"@�H��FRQ�TXHVWR��$OEHUWDQR�da Firenze, Marsilio Ficino e Guido Cavalcanti, e dopo questo fu Florisello di Nichea, Palmerino di Oliva e Amadigi di Gaula, e infine una moltitudine di greci, di spagnoli e di francesi unanimi e concordi hanno lasciato scritto per cosa certa che per voler condurre a buon fine un trattato e concludere un affare d’importanza, bisogna certamente e indubbiamente avere e possedere memoria, intelletto e volontà e in questo non c’entra alcun dubbio, alcuna fiducia e alcuna verità, perché lo stesso è stato confermato e suggellato da Baldo il vecchio e da Baldovini, da Giasone, Covarrubia e Felino, dall’Infortiatum dell’Alvarotti e del Dino, da Giovanni Fabro, da Cristoforo Porcio e da Andrea Fachinei, sulla glossa del testo, nella legge “È pericoloso”, nel paragrafo “Negoziando”, nel codice “Sulle cloache e le latrine”, dove inequivocabilmente si conclude che per guardarsi dal male, andare per il mondo e avere fortuna bisogna possedere giaco, zucca e cervello, e questo è noto e manifesto ai molti: che, sotto l’aspetto di calli e di podagra, i poveretti soffrono di buon mal francese, di buon male di Napoli e del buon frutto
� �� ©,Q�PRGR�FKH��GL�PDQLHUD�FKH�GDOO·DXWRULWj�GL�LQJHJQL�FRVu�IHOLFL�H�LQVLJQL��GL�DXWRUL�FRVu�FHOHEUL�e tanto rinomati, devi avere ragionevolmente non soltanto ammesso ma anche compreso e ben HVDPLQDWR��ULPRVVD�RJQL�DPELYDOHQWH�LQFHUWH]]D��FKH�VLD�FRVuª�
ancipite dubitatione: qui ‘ambivalente incertezza’, ma cfr. SCROFFA Cantici p. 211 «ancipite ‘incerto, dubbioso’», con rinvio a Dal Gorgo VI (recte IV) 8 (p. 65), e «‘pericoloso’», in Giroldi VIII 9 (p. 75); inoltre COLONNA Polifilo passim.
3 «Ah, ah, mi fai sganasciare!». 5 «Il parallelo non è di rude ingegno, ma non è valida la conseguenza, cioè che Amore sia dio, né
cosa buona, ma invece un appagamento mediocre, una voglia perniciosa derivante dall’abbondanza di pane [Cerere] e vino [Bacco], dalla quale prende poi forza ogni pensiero vile, sozzo e lascivo. Questa svuota la mente da ogni sapere e lo riempie di errore, e questo è quel seme fetido, fecondo d’ogni male, che guasta, infetta e indebolisce tutto il genere umano».
ATTO QUARTO
SCENA PRIMAPomponio pedante, Florindo suo discepolo
1 POMPONIO Ita ut��GL�PDQLHUD�FKH�GDOO·DXWRULWj�GL�Vu�IHOLFL�HG�H[LPLL�LQJHJQL��GL�FRVu�FHOHEUL�H�WDQWR�PHQWRYDWL�DXWRUL��GHYL�UDJJLRQHYROPHQWH�KDYHUH�QRQ�SXU�persuaso ma, remota ogni ancipite dubitatione, comperto ed esploratissimo FKH�FRVu�VLD�
2 FLORINDO Anzi, tengo costantemente il contrario, cioè ch’Amore sia gran nume e possente in cielo, in terra, in mare e nello inferno, compagno ed emulo della morte, e a ciò mi muove lo intendere che l’istessa figura, quasi armi e simbolo, attribuiscono all’uno ch’all’altra.
3 POMPONIO Ah, ah, cachinari me facis. 4 FLORINDO Non ridete, signore, ché vi lo farò toccar con mani. Ditemi: la
PRUWH�QRQ�q�D�WXWWL�FHUWD�H�DPRUH�D�WXWWL�JHQHUDOH"�/D�PRUWH�LQHVRUDELOH�FKH�WXWWL�DWWHUUD�H�DPRU�FUXGHOH�FK·D�QLXQR�SHUGRQD"�/D�PRUWH�QRQ�VL�SXz�IXJJLUH�e contra amore non val fugga o scampo. La morte cieca sdegna di vedere le differenze de’ mortali, bendato Amore che disuguaglianza non cura. Con la falce adunca la morte, Amor con l’arco curvo. Morte senza adombramento, Amor nudo. E finalmente, se l’angoscie e i dolori sono i precursori della morte, i tormenti e i guai prevengono gl’effetti d’Amore.
5 POMPONIO Il paralello non è di rude ingegno, ma la conseguenza non vale, FLRq�FK·$PRU�VLD�GLR��Qp�FRVD�EXRQD��PD�Vu�EHQH�XQ�GLOHWWR�FRPPXQH��XQD�pernitiosa voglia procedente dall’abondanza di Cerere e di Bacco, di che prende poi forza ogni vile, feda e venerea cogitatione. Questa evacua la mente d’ogni sapere e lo riempie d’errore, e questo è quel seme fetido, fecondo d’ogni male, che guasta, infetta e labefatta tutto il lignaggio humano.
� �� ©$PRUH��DK"�$PRUH��6HEEHQH�VL�GLSLQJD�IDQFLXOOR�H�QXGR��q�SHUz�XQ�JUDQ�SDODGLQR�H�XQ�ILHUR�Orlando, nutrito di lacrime, vestito di sospiri, armato di fiamme di fuoco. Chi non ha provato le sue ferite stia alla larga dalle sue stoccate. Adesso tocca a me, pazienza! Mi secca molto che un forestiero, un pettegolo, un vanesio mi sia venuto a intralciare. Ma non la voglio lasciar passare, signornò, non la lascerò mai passare, smaschererò ben io questo messer Florindo, lo farò ben io andare più che di passo a fiorire nel suo paese! Racconterò tutta la storia al chiarissimo signor SRGHVWj��PLR�FRPSDUH��JOL�GRPDQGHUz�XQ�VXIIUDJLR�R�XQ�PDQGDWR�SHQDOH�H�FRVu�OR�IDUz�ILODUH�SL��che di fretta fuori da questa città!».
el se depenze puttin e nuo: sull’immagine, assai frequente, cfr. anche CARAVIA Naspo Bizaro I 124: «Amor si se depenze per un puto, / nuo per nuo da no stimar do fave, / ma col so arco HO�WUj�IUH]]H�D�O·RUEHVFD����FK·HO�SDVVD�HO�FXRU�D�FKL�FRQ�HVVR�WUHVFDª��S����U�����intrigar i bisi: sull’espressione, che vale ‘intralciare’, cfr. BOERIO s.v. Intrigàr p. 351, e DV s.v. bìso1 num. 2 «‘dare impaccio’» (p. 187), con esempi da MAGGI Tradimento amoroso IV 10 («infrascare i bisi») e CALMO Travaglia II 3 (II 44 nell’edizione di Vescovo, p. 96: «si le intrigasseno bisi con Lionora», in schiavonesco); brevi annotazioni in CORTELAZZO Contributo p. 183.
ATTO QUINTO
SCENA PRIMAPantalon solo
1 [PANTALON] $PRU��DK"�$PRU��6HEHQ�HO�VH�GHSHQ]H�SXWWLQ�H�QXR��HO�[p�SHUz�un gran palladin e un fiero Orlando, nodrio de lagrime, vestio de sospiri, armao de fiamme de fuogo. Chi no ha provao le so feriie staga a largo dalle so stoccae. Adesso la tocca a mi, patientia! Me despiase ben ch’un forastier, un pettegolo, una frasca me sia vegnuo a intrigar i bisi. Ma no la voio comportar, missier no, no la comporterò mai, e ’l chiarirò ben mi sto missier Florindo H�·O�IDUz�EHQ�PL�DQGDU�Su�FKH�GH�SDVVR�D�VILRUL]DU�LQ�WHO�VR�SDHVH��5DFFRQWHUz�tutta la historia al clarissimo signor podestà, mio compare, ghe domanderò XQ�VXIIUDJLR�R�XQ�PDQGDWR�SHQDO�H�FXVu�LO�IDUz�VFDSLQDU�Su�FKH�GH�SUHVVD�IXRUD�de sta cittae!
SCENA SECONDAFlorindo solo
2 [FLORINDO] So che l’hanno havuta stretta il signor dottor Gratiano e il mio PDHVWUR��&UHGR�FKH�V·LPDJLQDVVHUR�G·KDYHU�L�]DIIL�GLHWUR��FRVu�VRQR�IXJJLWWL�chi qua, chi là correndo. Et io, per disacerbare il mio amoroso tormento, sono per questa città ito spatiando, seben indarno, posciaché il pensier mio VWD�VHPSUH�ULYROWR�D�FROHL�FKH��Vu�FRPH��TXDQGR�YHU�PH�JLUDVVH�SLHWRVH�OH�
I travagli d’amore242
218 «Va’, Viola, obbedisci al signor padre». 219 «Comincerò da questa parte. Nuora mia cara, figlia mia benedetta, prendete questo bacio. Oh,
FDUR�TXHO�YLVHWWR��%DFLDWHPL�DQFKH�YRL��QRQ�YL�YHUJRJQDWH��FRVu��FRVu��XQ�DOWUR«�%DFLDPL�DQFKH�tu, Malacarne, sulla nuca».
����� ©6H�YRJOLR�EDFLDUYL�LO«�TXDVL�PH�O·DYHWH�IDWWR�GLUH��&KH�JHQHUH�GL�FHULPRQLD�q�TXHVWR"�/DVFLDWH�che si volga verso di me, potta di giudeo, se devo essere io lo sposo! Perché questo baciarla tanto e palpeggiarla in questo modo non mi va troppo bene e, per dirvi la santa verità, questo matrimonio con questo modo di procedere non mi piace».
malfiale a sto muut: per il significato di malfiaa ‘manipolare, palpeggiare’ cfr. PELLEGRINI R. Stella p. 121, nota al v. 234 del testo 57 (CLXXVIII): «E reffreschiaat che io mi foi un pooc, / E iee la chiossa un pooc mi malfià»; la traduzione segue la proposta di A. Giacomini (STELLA Poesie friulane); la variante Smalfïâ (e Smarfïâ) è attestata da Nuovo Pirona: «Gualcire palpeggiando, brancicare» (p. 1056), con esempi da Zorutti e Del Puppo. Per l’etimologia la Heinemann osserva (richiamando GAMILLSCHEG Romania Germanica II p. 289): «Parimenti got. è GAMALWJAN ‘maciullare’, che in friul., unico idioma in cui compare, rimane conservato, tramite EXMALVIARE, in smalfiâ ‘conciare per le feste’» (HEINEMANN Studi p. 135).
221 «Portatela via, baciala anche tu! Basta, ora, o là, Malacarne! Discrezione! Credo che tu la morsichi, YHUR"�1RQ�YRJOLR�PLFD�FKH�PH�OD�VWUDSD]]L�WDQWR��VDL�ª�
����� ©4XHVWD�q�DQFRUD�SL��EHOOD��&KH�QRQ�SRWUz�IDUH�D�PLR�PRGR�FRQ�PLD�PRJOLH"�&KH�FRVD�GHYH�HVVHUH"�&KL�VDUj�LO�SDGURQH"ª�
SUHVHQ]D�GHO�]XGHVH��3HUz�WL��0DODFDUQH��QR�WH�FKLDPDU�Su�GHL�VFKLDSSDFDYHOOL�ma, al primo parto che succederà de sta fia generis masculini, in memoria della mia persona ghe metteré nome Pantaloncin de Malacarne Bisognosi; e FRVu��GH�KHUHGH�LQ�KHUHGH�PDVFROR�LQ�LQILQLWR��Vu�FKH�VHPSUH�VH�WURYL�XQ�FKH�col nome de Pantaloncin rappresenti la mia persona e conservi l’antighitae della mia fameggia. In essecution mo de quanto ho dito, feve in qua tutti do: vu, quella zovene, a man zanca e ti, Malacarne, a banda destra.
218 MALACARNE Va’ là, Viole, ubidis al signor pari. 219 PANTALON Scomenzarò da sta parte. [inizia a baciare Violante] Niora mia
cara, fia mia benedetta, tolé sto baso. Oh, caro quel visetto! Basème anche YX��QR�YH�YHUJRJQp��FXVu��FXVu��XQ�DOWUR«�>a Malacarne] Baseme anche ti, Malacarne, da drio la coppa.
220 MALACARNE S’iò vuei bussauus lu… quasi cu mal havees fat dii. Ce stampe GL�FLULPRQLH�HV>H@�DFKHVWH"�/DVVDDW�FX�D�VL�YROWL�LQTXLQWUL�GL�PH��SRIDD�]XGLRR��s’hai da iestri iò lu nuiz! Parcè cu sto bussale tant e malfiale a sto muut no m’ha tro’ dal bon e, a diuus la seente veretaat, sto matrimoni cun sto muut di procedi no mi plaas.
221 PANTALON Tiotela via, basela anche ti! Basta, mo, o là, Malacarne! Discrettion! &UHGR�FKH�WL�OD�PRUVHJKL��PL��Q·q�YHUR"�1R�YRJJLR�PLJD�FKH�WL�PH�OD�VWUDSSD]]L�tanto, sastu!
222 MALACARNE &KHVWH�q�SOXL�ELHOOH��&X�QR�SRUUDL�IDD�D�PH�PXW�FXQ�PHH�PXLLU"�&H�KD�GD�LHVWUL"�&XL�VDUj�OX�SDURQ"
Atto quinto 243
223 «Io, principalmente, come più vecchio, e poi tu come mio adottivo». 224 «Dico della sposa, io!».����� ©&·q�IRUVH�TXDOFKH�GXEELR"�$QGDWH�D�FDVD�WXWWL�H�GXH�H�LPSHJQDWHYL�D�SUHSDUDUH�OH�QR]]H�FKH�
desidero, ché, a dispetto del torto che mi è stato usato, siano fastosissime e di gran spesa». 226 «La contentezza e la delizia che io provo con questa viola violata di Violante è tanto grande,
signore, che quasi non riesco a respirare, nonché trovare parole o cerimonie per ringraziarvi. Ma GLUz��DO�PRGR�QRVWUR��'LR�YL�VDOYL�>"@ª�
Dio vusalom: per la comprensione di questa espressione possono tornare utili alcuni versi di Giuseppe Strassoldo: in Io paiares un solt, di zintil hom, al v. 5 si legge: «ma sta chun to parint chu Dioo ial lon» (PELLEGRINI R. Due sonetti S�������WUDGRWWR�©FKH�'LR�OR�EHQHGLFD��"�ª�S������nota 11). Nell’edizione di Lorenzoni sulla «Rivista della Società Filologica Friulana» V (1924) si trovavano anche «Almèns, o Diò i è l’on» (v. 62) e «cu Diò t’è ’l bon» (p. 105).
227 «Non dire altro. Fa’ quello che ti ho detto, ché io adesso voglio andare a invitare alcuni miei amici. E voi, signori, che siete qua presenti, se vi degnate di rallegrarvi per le nostre nozze, vi invito davvero tutti e tutte, con patto, però, che portiate con voi pane, vino, companatico e per giunta un mocenigo per pagare i confetti. Intanto questi giovani recitanti e io, insieme e unanimemente, ringraziamo infinitamente la bontà e la cortesia delle nobiltà vostre, che si siano GHJQDWH�GL�SUHVWDUH�FRVu�JUDWR�H�EHQHYROR�DVFROWR�DOOD�QRVWUD�LJQRUDQ]D��(�'LR�YL�EHQHGLFD�H�YL�dia una buona quaresima».
mozenigo: BOERIO s.v. Mocenigo: «Nome d’un’antica Moneta Veneta stampatasi l’anno 1475 sotto il Doge Pietro Mocenigo. Dicevasi anche Lira Moceniga e da alcuni Lirazza fina, e valeva soldi venti; e verso il 1523, soldi 24» (pp. 419-420); cfr. anche DV s.v. mocenìgo pp. 834-835.
223 PANTALON Mi, principalmente, come più vecchio, e po ti come mio addottivo. 224 MALACARNE Iò dii de nuizze, iò! 225 PANTALON 0R�FKH��JKH�[p�GXEELR"�$QGp�D�FDVD�WXWWL�GR�H�VIDGLJKHYH�GD�
preparar le nozze le qual voio, ché, a confusion del torto che me xé stà usao, sian superbissime e de gran spesa.
226 MALACARNE L’allegreezze e lu dolzoor ch’iò provi cun sta viola violada di Violanta es tant grant, signù, cu iò no pues squasi sfladassaa, no cu chiataa paraulis o cirimoniis di ringratiauus. Ma iò dirai, e gnestre usanze: Dio vusalom.
227 PANTALON No star a dir altro. Fa’ quel che t’ho dito, ché mi adesso voio andar a invidar diversi mii amisi. [rivolto agli spettatori] E vu, signori, che se’ qua presenti, se ve degné da galder delle nostre nozze, ve invido da bon seno tutti e tutte, con patto, però, che porté con vu pan, vin, companadego e un mozenigo arente da pagar le confetture. Intanto questi zoveni recitanti e mi, insieme e in solidum, ringratiemo infinitamente la bontae e la cortesia delle nobiltà vostre, che le s’abbia degnao da prestar all’ignoranza nostra FRVu�JUDWD�H�EHQLJQD�DXGLHQ]D��(�'LR�YH�EHQHGLJD�H�GDJD�ERQD�TXDUHVLPD�
IL FINE
ANALISI LINGUISTICA
FRIULANO
GRAFIA
Si registra1 conservazione di h etimologica in galanzhumign III 73, haunor III 83, havee (in tutte le forme), hom II 3 (e homenat II 66, humign I 69, homini V 153), honoraat II 19 (e honorade III 79, ma anche anorade I 71), hoore II 19 (e hore II 5, horis I 87), host III 69 (e hosch’ III 73), hume I 67, humor V 209, malhoore II 19. A indicare la velare finale è regolarmente impiegato il digramma -ch, ma nella maggior parte dei casi è stato eliminato l’apice che seguiva h nella stampa: alch II 18, antichs I 99, aricch III 187, badaluch II 18, becch III 195 (e bech III 189), bleech V 209, deschs III 79, fresch III 79, fuuch II 44, incarch III 73, intrich I 79, lambich I 89, larch II 50, lunch II 18 (e lunchs III 195), March I 95, massanch III 179, pitich II 3, plaanch I 69 (e planch I 91), pooch I 141, prattichs V 209, sbricchs I 107, sclappezocchs II 18 (e sclappezochs, sclappezoochs II 19), scocchs I 95, secch III 79 (e seecch III 79), sorch III 79, sporch II 5, stich V 209, strolich I 87, zooch II 52. Per indicare l’occlusiva palatale finale (comunemente chiamata anche “postpa-latale”) si registra ancora -ch, ma, quale marca specifica, si è conservato anche l’apice, che, quasi sempre nell’originale, segue h: anch’ I 75, ducch’ III 79 (e duuch’ III 73, ma anche ducc’ III 79), duquanch’ I 99, granch’ I 69, hosch’ III 73, nianch’ II 3 (ma anche nianc’ III 79), quanch’ III 195, tanch’ III 189, ma anche tocch’ ‘che [egli] inzuppi’ III 79. Per l’occlusiva palatale sorda iniziale si ricorre al trigramma chi-: chia’ I 95, chiadee III 173, chiadins II 50, chiaaf II 42, chialaat I 99, chialt II 44, chiamarute I 95, chiaminaat IV 170, chiammare III 203, chiamoz III 195, chiandelle I 79, chiane I 91 (e chiannis II 40, chianeulis II 19), chianton III 79, chiappave II 19, chiar I 73 (‘caro’ e derivati), chiarn I 141, chiase I 91, chiat V 209, chiataa V 226 (e forme flesse), chiattii’ III 79 (e chiattive III 73), chiavallat II 56, chiavron III 195, chiavuz V 209, chiazzi V 209 (e altre forme derivate da *chiazzaa), chiazze
1 In questa sezione mi limito ordinariamente a rinviare, per ciascun esempio, a una sola occorrenza (di solito la prima). Per gli altri riscontri, si veda il repertorio lessicale.
Analisi linguistica246
‘ramaiolo’ III 35, chiose I 103; in corpo di parola ancora -chi-: blanchie V 209 (e blanchis II 50), bocchie I 73, bradaschis V 209, cerchiaat II 19 e cerchiassis III 59, clocchie III 205, fallischie III 185, filistocchie II 13, forchiassude V 209, fottecchie V 24, freschie II 26, manchie V 209, marchiandariie I 85, marchiat III 79, pochie I 83, recerchie III 195, schialde II 7 (e schialdi II 44), schialle V 209, sclappechiaviel I 67, secchie II 19, tocchiaa V 24 (e forme flesse), vacchie III 195, zoonchi III 185, zucchie II 58; anche da ti secondario: lassichi II 19, muovichi III 101, sbicchiaa I 91, schiù II 18; con tramite italiano: minchionaat I 123; in posizione finale, oltre a -ch’, anche -gn’: agn’ ‘anche’ III 65 (nell’originale compare sempre con l’apice). Per la sonora iniziale la grafia adotta ghi-: ghiallinis III 205, ghiambaa I 95 (e forme flesse), ghiattis II 126, ghiavaat V 209 (e ghiave III 69), ma giat III 59; in corpo: donghie I 141, mangiaa II 5 e mangie III 35, presumibilmente angistarutte I 91. Non è molto frequente l’impiego di ch- davanti a vocale non palatale: chasì II 19, chà II 19, chalderie III 101 (ma è plausibile l’integrazione di i per rendere l’occlusiva palatale: cfr. chialderie II 5), qualchu II 19; con elisione nel pron., agg. e cong. ch’ (passim). È invece corrente la conservazione del nesso -TJ-: consolation II 3, differentie I 83, disgratiaat III 44, disgratiis I 71, gratie I 121, information V 203, patentie I 117 e patientie II 148, potentiate I 107, ringratiauus V 226, satisfattion V 209, sirvitial I 143, vitiose III 89 (ma comenzaa III 69, quinzarai III 63, quinzade II 56, quinzassi III 63, scomenzi V 209, scomenzaat II 72, scominzarai I 73, uffici I 111, ecc.). Per la labiovelare, primaria e secondaria, si usa il digramma qu: qual III 69 (e quai V 209), qualchi I 97 (e qualche V 183, qualchu II 19, qualchidun III 175), quanch’ III 195, quante III 41, quar I 69 (e quars III 195), quarnette I 75, quarz V 209, quasi I 87, quattri III 201, quees II 50, quel II 80 (‘quello’, frl. altera-to), quenti III 156, queste I 99 (e cheste I 103), quintri I 95, quinzarai III 63 (e quinzade II 56), quinzaassi III 63, quinzidure III 35; cinquante I 75, duquanch’ I 99, indaquarzees I 91, inquarnaaz III 195, inquintri II 40 (e inquintre V 151), squasi V 226, squidudis I 95. Poche le eccezioni: indacquarz V 185 (e forme da *indacquarzissi), recuuardi II 74 (con reguuardi II 11 e revuardi IV 106).
La doppia vocale rappresenta, seppure non sistematicamente, la lunga in posizione forte.
aa è regolare: � in alcuni nomi e aggettivi: braaf V 209, caritaat II 3, chiaaf II 42, contraar
II 5, paas I 143, parentaat V 209, pofaa II 18 (e puofaa I 93, ma anche pofà
Friulano 247
I 71), veretaat III 195 (ma anche veretat III 75), vuluntaat III 39; �� negli infiniti: alaa V 151, ammazzaa III 171, buttaa V 209, chiataa V 226 (ma
anche chiattale II 50), clamaa III 175, coltaa I 81, comenzaa III 69, comperaa III 195, confessaa III 35, contaa I 73, cornaa I 79, curaa III 97, daa II 18, dismintiaa II 68, doperaa I 143, emplaa I 85, entraa II 15 (ma entrà III 69), faa II 5, faami II 19, faal II 19, fidaa III 83, freolaa II 60, ghiambaa I 95, ietaa II 44, imparaa I 95, ingrumaa I 85, iudaa III 83, laa I 91, lambicaa I 89, lavoraa II 3, levaa V 211, mangiaa II 5, maridaa III 67, maridaassi III 73, menaa II 3, montaa I 107, neiaa II 82, paiaa I 95, provaa III 75, puartaa I 95, raspaa II 5, reffreschiaam II 19, remondaa II 5, sbicchiaa I 91, sborraa III 39, scietaa III 79, sclappaa II 72, scodolaa II 23, semenaa V 209, settaa IV 104, sfladassaa V 226, sglizziaa II 23, spettaa III 71, staa III 35 (ma stà V 189), stentaa V 209, svodaa I 85, tacconnaa V 209, taiaa II 42, tiraa II 23, tocchiaa V 24, tornaa II 19, trammudaassi III 201, trattaa II 18, voltaa II 92, vosaa II 19;
�� negli imperativi: aspettaat III 79, chialaat I 99, chiaminaat IV 170, coman-daami I 143, domandaat III 73, dubitaat III 41, favellaat I 107, fidaat III 93, indusiaat III 75, lassaat III 37, lassaassi III 83, mandaassi III 79, pensaat I 139, perdonaami III 183, segnaassi I 91, sintaassi II 101, tocchiaat I 141, tornaat V 24, vuardaat I 107;
�� nei participi passati: ammazzaat III 185, bastonaat III 160, cerchiaat II 19, chialaat II 48, chiazzaat I 117, daad II 54, disgratiaat III 44, disturbaaz II 66, ghiavaat V 209, honoraat II 19, ingrassinaat II 5, inquarnaaz III 195, intrigaat V 185, laat II 18 (e laaz I 87), lassaat II 126, maridaad I 95, menaat I 141, menzonaat II 76, minchionaat I 123, piaat I 95, saccagnaat I 117, scomenzaat II 72, siarraat I 95, staat II 19 (e staaz I 69, ma anche stat I 103, sta’ III 173), sunaat I 89, tiraat II 60 (ma anche tirat V 209), tornaat I 87, trammudaat II 19;
�� nell’indicativo presente: 1 s.: faas III 185 (ma anche fas V 209); 3 s.: displa-as III 175; 2 pl.: degnaas II 56, falaas I 123, fevelaas III 95, fidaas III 205, pensaas III 95, perdonaas I 137, puzzaas II 74, suspiraas III 83;
�� nel congiuntivo presente: 2 pl.: mostraas III 175, provaas III 69, tornaas III 201.
La doppia manca:�� in accat III 75, agar V 209, avual I 95, biat II 50, brumal IV 102, calendar
I 139, centennar III 69, chiar ‘caro’ I 73 e chiars ‘cari’ III 73, chiat V 209 (ind. pres. 3 s.), claf IV 108, clar V 209, deventad III 79 e deventat II 19, estat I 89, fas V 209 (ma anche faas III 185, ind. pres. 1 s.), fossal V 209, has V 203 (ind. pres. 2 s.), innamorat III 205, intosseat I 95, invidiat I 89, lavorat
Friulano
Analisi linguistica302
Congiuntivo passato3 s.: see stade II 23.
Congiuntivo trapassato1 s.: fos staat V 3; 3 s.: foos staat II 50.
Condizionale presente3 s.: saris I 93 (anche interr. II 18).
Condizionale passato3 s.: sarees stat I 103.
Participio passatostaat I 91, stat I 103, sta’ III 173; stade II 23; staaz I 69.
Infinito presenteiestri I 103.
Infinito passatoiestri staat V 151.
STRATEGIE STILISTICHE
Diversamente da quanto permettono gli altri personaggi della commedia, che risentono di un progressivo cristallizzarsi in tipi fissi o comunque godono di una fortuna letteraria più marcata, per individuare le scelte stilistiche che caratterizzano la presenza del villano Malacarne non ci si può avvalere del confronto con altre opere. Al di là del codice che lo contraddistingue, infatti, questo personaggio friulano riveste un ruolo assai difficilmente paragonabile a quello dei contadini ruzantiani, ma in qualche misura diverso anche da quello dei servi inurbati pre-senti nelle commedie di Calmo. Tuttavia, come si avrà modo di notare in merito a Pantalone, anche nel caso di Malacarne alcuni aspetti linguistici richiedono di essere posti in relazione con alcune sue caratteristiche psicologiche. Inoltre, è necessario segnalare non soltanto che il potenziale comico della figura discende in gran parte dalla sua relazione con il padrone, suo interlocutore privilegiato, ma anche che alcuni tratti caratteriali sono ad esso comuni e di conseguenza si riflettono in scelte stilistiche affini o speculari.
Il vocabolario ingiurioso ed esclamativo
Uno dei principali elementi di affinità è l’inclinazione al linguaggio triviale; tuttavia, mentre nel caso di Pantalone esso sembra essere strettamente legato al carattere collerico del personaggio, Malacarne si lascia influenzare dal padrone,
Analisi linguistica306
VENEZIANO
La lingua di Pantalone non ostenta fenomeni che possano ricondurla in modo incontrovertibile al tipo urbano; piuttosto, l’esiguità degli scarti che la distinguono dal buranello fanno pensare anche per essa a una collocazione lagunare o almeno periferica rispetto al cuore della città, o addirittura a una caratterizzazione plebea del personaggio, a dispetto della nobiltà ostentata40. Quale riferimento per il veneziano segnalo alcuni tratti essenziali, in particolare quelli che lo distinguono dalle altre varietà venete41: �� si conservano parzialmente antichi dittonghi da vocale aperta, talora con il
passaggio di -uò- a -iò-; salvo in casi rari, non è attestata metafonesi per le vocali chiuse e e o;
�� resistono le vocali atone anche in fine di parola, tranne -e degli infiniti e, in genere, in parole originariamente piane, dopo nasale o liquida; -o cade dopo nasale, e anche, seppure con eccezioni, dopo liquida, in particolare negli esiti dei suffissi; in ogni caso le consonanti non devono costituire esito da riduzione di doppie o gruppi consonantici;
�� l’esito del suffisso latino �ăULX�è -èr, non -àro come in altre varietà;�� il participio passato della coniugazione in -a(re) esce in -à (nel veneziano
antico in -ào), rispetto a quello delle altre coniugazioni in -ùo e -ìo; �� il sistema consonantico prevede la l evanescente;�� è frequente la caduta delle consonanti intervocaliche (esiti delle occlusive
intervocaliche originarie);�� la mancanza delle geminate è generalizzata;�� LQ�DOFXQL�FDVL��/-��WHQGH�D�HYROYHUH�LQ�DIIULFDWD�SDODWDOH�VRQRUD�DQ]LFKp�LQ�
vocale palatale (famégia anziché faméia); �� in sincronia c e g davanti e, i del latino sono ridotte a sibilanti (probabilmente
attraverso una fase antica con affricate dentali);�� si conserva -s nella forma interrogativa di 2 s.;�� la 2 s. futuro in -à, non in -è come in altre varietà venete;�� si riscontra il participio passato in -ésto (podésto ‘potuto’, credésto ‘creduto’),
GLIIXVR�LQ�DOWUH�YDULHWj�PRGHUQH��FRVu�FRPH�OD�GHVLQHQ]D�-émo per la 1 pl. estesa a ‘essere’ e ai verbi di I coniugazione;
40 Cfr. CORTELAZZO Uso.41 Cfr. MARCATO Veneto pp. 300-301, PRATI Etimologie pp. XLII-LIV, STUSSI Venezien pp. 127-130,
ZAMBONI Veneto pp. 9-31, ZAMBONI Venezien pp. 529-530, ZAMBONI Caratteristiche pp. 20-31; poche note in CALMO Lettere pp. CXXXV-CLVI; su questioni particolari del veneziano documentario cfr. anche SATTIN Ricerche sul veneziano e STUSSI Testi veneziani.
Analisi linguistica314
143, ti orinarà III 107, ti riuscirà I 142, ti vederà II 43, vignerà IV 105, ti vorrà III 3655. La 1 s. del condizionale presente è quella arcaica da inf. + HABUI: darave II 134, doverave V 161, farave III 36, porrave III 200, torrave II 134, vorrave I 84, ecc.56
Nella 2 s. del condizionale presente si ha regolarmente serviressi V 194, toressi III 145, vorressi IV 153, ma soprattutto la forma interrogativa vorravestu I 118, con la base della 1 s., la conservazione di -s e il clitico della 2 s. I gerundi di alcuni verbi non di I coniugazione testimoniano traccia dell’e-stensione analogica di -ando, proprio della I: siando V 217, fagando IV 97. Per i metaplasmi di coniugazione: ottegnuo II 61, tegnir II 121 (o tignir II 110). Nell’alternanza delle forme riconducibili a lassar I 92 e *lagar (lagao IV 143, lagando III 200) appaiono prevalenti le prime57.
STRATEGIE STILISTICHE
Per il risvolto più strettamente stilistico alcuni aspetti del linguaggio di Pan-talone richiedono di essere posti in stretta relazione con alcune sue caratteristiche psicologiche, seguendo un percorso già individuato e tracciato da Pietro Spezzani58. Oltre ai tratti caricaturali e talora giocosi del personaggio, che contribuivano in modo efficace al raggiungimento degli effetti comici, anche le diverse sfaccet-tature e declinazioni del linguaggio di Pantalone ne mettevano in luce alcuni aspetti del temperamento.
Il vocabolario ingiurioso
La componente più importante dell’eloquio di Pantalone, seppure in apparente contrasto con la giocosità di cui si è detto, è rappresentata dal lessico triviale, che per un verso conferisce alla lingua del personaggio un’indole più espressionistica
55 Cfr. ZAMBONI Caratteristiche p. 27.56 Cfr. ZAMBONI Caratteristiche p. 28.57 Sulla questione relativa alle due forme cfr. la sintesi di D’Onghia in CALMO Saltuzza pp. 194-195
nota 50.58 Cfr. SPEZZANI Il primo repertorio pp. 44-54, e soprattutto SPEZZANI Il linguaggio pp. 65-118. L’analisi
è stata condotta dallo studioso su opere di epoche diverse e riferibili sia alla commedia dell’Arte, sia alla tradizione teatrale più propriamente veneziana; nel secondo saggio, in particolare, Spezzani ha ordinato i materiali linguistici di due opere del romano Giovanni Briccio, La dispettosa moglie e Il Pantalon imbertonao, che presentano la maschera rispettivamente nella parte del padre di famiglia e in quella del vecchio innamorato. Riguardo al primo dei due saggi, invece, e in particolare alle pp. 34-42, segnalo che nella commedia di Gattinon non si incontrano l’artificio verbale del bischizzo (o bisticcio), il recipe o ricetta scherzosa, le filastrocche in versi sdruccioli.
Analisi linguistica320
naggi (come il pedante o il dottore). Si tratta di tendenze auliche, o di locuzioni maccheroniche, fidenziane o esotiche. Nella commedia in esame, tuttavia, questi esempi sono piuttosto rari, mentre talvolta si registrano alcune “tirate” cattedratiche (come quella di III 200 sulle «cosse cornue»): «un consortio carnal e spiritual e un fideicommisso d’amor e caritae che resti a perpetua rei memoria» V 217, «al primo parto che succederà de sta fia generis masculini» V 217.
BURANELLO
Dalle poche battute pronunciate da Comello emerge a stento la fisionomia conservativa di questa varietà periferica, riconducibile al veneziano lagunare ma assai sensibile all’interferenza. In ogni caso non sono consistenti i tratti che la differenziano dal dialetto di Pantalone testimoniato in questa commedia, cosicché si sospetta anche per quest’ultimo una non meglio definita collocazione periferica. Segnalo di seguito soltanto alcuni degli aspetti tipici del buranello: innanzi-WXWWR�LO�PDQWHQLPHQWR��SL��PDQLIHVWR�ULVSHWWR�DO�YHQH]LDQR��GHL�GLWWRQJKL�GD�Đ� ŀ�tonici; la mancanza di l evanescente; la tendenza alla caduta delle consonanti r, l, n in fine di parola (e in particolare, in sincronia, della nasale), con il completo dileguo di r rimasto finale negli infiniti verbali; l’articolo determinato s. m. è lo (nel veneziano el), con allomorfo in enclisi -l, mentre il pl. è li; il pronome soggetto della 3 pl. m. è li, di rado i; nelle forme di 1 pl. e 2 pl. dell’imperfetto, del congiuntivo e del condizionale si riscontra un pronome atono enclitico; nei condizionali è alquanto frequente la caduta di v in -ave; i participi passati s. m. terminano in -ào61.
VOCALISMO
� /D�FRQVHUYD]LRQH�GHL�GLWWRQJKL�GD�Đ� ŀ�WRQLFL�LQ�mantien (3 s.) III 128, com-muodo III 165, fuora III 128, puoco III 130, puol (3 s.) III 132 è comune al ve-neziano parlato in questa commedia da Pantalone (ma nel veneziano la soluzione non dovrebbe essere altrettanto evidente)62.
61 Alcune rassegne dei tratti specifici si possono reperire in MARCATO Veneto p. 301, ZAMBONI Veneto pp. 33-35, ZAMBONI Venezien p. 529; poche note in CALMO Lettere pp. CLIV-CLVI; annotazioni in CORTELAZZO Esperienze pp. 54-55.
62 Cfr. ZAMBONI Caratteristiche p. 22, ZAMBONI Veneto p. 33.
Analisi linguistica324
BERGAMASCO
A partire dalla «tradizione facchinesca»70, l’impiego del bergamasco in funzione espressionistica si fa sempre più cospicuo e arricchisce una tradizione che ora lo avvicina al pavano dei personaggi provenienti dalla campagna, ora lo contrappone alla lingua della dominante, più o meno contrassegnata in senso urbano: «la fonetica bergamasca coopera attivamente alle finalità espressionistiche con le sue inesauribili risorse di suoni palatali e di parole tronche»71. In realtà in questa commedia i tratti del bergamasco di Zambon sono appena sufficienti a rappresentare il personaggio; di conseguenza non soltanto rimane esclusa ogni intenzione di fedeltà dialettologica nella resa, ma sembra vacillare anche l’ipotesi di una approfondita competenza in tale varietà da parte dell’autore72. A questo proposito si deve tenere presente che ai due personaggi bergamaschi della seconda commedia di Gattinon (L’Amorosa��VWDPSDWD�QHO��������6HQ]DEH]]L�H�0LVVLHUVu��servitori dei mercanti veneziani Pisandro e Albigerio, non è riservato più un ruolo marginale; la consistenza delle battute postula anzi una pratica ormai non occa-sionale ed è sintomo di maggiore scioltezza. D’altra parte il bergamasco ha avuto scarsa fortuna nell’uso letterario in Friuli. Il precedente, seppure non cospicuo, è dato ancora dai versi del Donato, i quali rivelano padronanza delle caratteristiche salienti, pur rimanendo muti sui tramiti dell’acquisizione73. In ogni caso nulla smentisce quanto afferma Maria Corti a proposito di un «fenomeno tipico delle culture di coiné quattrocentesche» che si servono del dialetto a fini artistici: «da un lato, quanto il dialetto acquista in estensione, perde in concentrazione, il che equivale a dire che, non essendo perfettamente posseduto come parlata nativa, EHQVu�RUHFFKLDWR��HVVR�SUHVHQWD�VXO�SLDQR�JUDPPDWLFDOH�XQD�FRQWDPLQD]LRQH�FRQ�elementi generici di una più ampia coiné regionale; d’altro lato, le finalità di parodia letteraria conferiscono a testi in dialetto i caratteri di un plurilinguismo di marca espressionistica»74. Pur riconoscendo che nella commedia il materiale
70� &RVu�LQGLFDWD�GD�0DULD�&RUWL�FKH�QH�KD�VRQGDWR�OH�RULJLQL��FIU��CORTI Strambotti pp. 278-279. 71 CORTI Strambotti p. 283.72 Osserva D’Onghia a proposito della Moschetta come anche in quel caso, come in altre situazioni,
«il bergamasco – usato per lo più da scrittori non bergamaschi – sia sottoposto a un certo tasso di distorsione espressiva e caricaturale» (RUZANTE Moschetta p. 36). Quello delle ultime commedie calmiane, invece, occupa una posizione intermedia tra il bergamasco più scialbo delle numerose stampe popolari cinquecentesche e quello ruzantiano, che mostra «caratteristiche che hanno preciso ULVFRQWUR�LQ�TXHO�GLDOHWWR�FRVu�FRPH�FL�q�QRWR�VX�EDVL�GRFXPHQWDULHª��FRVu�QHJOL�DSSXQWL�OLQJXLVWLFL�di D’Onghia in CALMO Saltuzza p. 207).
73 Cfr. il saggio Variazioni linguistiche in Giovan Battista Donato, in PELLEGRINI R. Ancora tra lingua e letteratura.
74 CORTI Strambotti pp. 274-275.
Grazianesco 329
Infinito presentedir III 154, tegnir III 150, vegnirv III 146.
esser
Indicativo presente3 s.: no l’è III 150; f.: l’è III 104; n’è (interr.) III 114; 2 pl.: se’ III 142.
Congiuntivo presente1 s.: che mi sia III 154.
Infinito presenteesser III 152.
GRAZIANESCO
Nella sua espressione più consueta, che è quella della commedia dell’Arte e della Ridicolosa, il tipo comico del dottore richiama il pedante dell’erudita cinquecentesca77, con il quale condivide la condizione di bersaglio di quanti irri-dono la finta scienza degli addottrinati o ne stigmatizzano la pretesa di esercitare, mediante il sapere, un controllo culturale sulla povera gente e sui malaccorti78. Progressivamente il personaggio diviene anche un doppione del primo vecchio (Pantalone o Magnifico)79, e tale abbinamento si consolida con la graduale scom-parsa del pedante dalle scene e il costituirsi di altre coppie come quelle degli Zanni e degli Innamorati. In merito al rapporto fra il tipo del pedante e quello del dottore, Ireneo Sanesi coglie una vera e propria identità80 e Silvio D’Amico rileva quantomeno affinità
77 Ho tentato una sintesi in ZANELLO Dottor Graziano, dove si presenta il tipo comico del dottore a partire da una disamina che prende in considerazione i nomi, le ipotesi sulla nascita della maschera, le diverse teorie sulle origini geografiche e sulla lingua, le prime apparizioni documentate sulle scene.
78 Sui rapporti, invece, tra la figura del dottore da strapazzo e quella dello strologo, cfr. LAZZERINI La figurina pp. 68-69.
79 È il caso di questa commedia di Gattinon, nella quale compaiono tanto il pedante Pomponio quanto Pantalone e Graziano.
80 «Infatti, il Dottore, che altro non è se non il pedante della commedia erudita, e che, in origine, si chiamò di preferenza Graziano, assumendo poi vari nomi e prediligendo in ultimo quello di Ba-lanzon, rappresenta il tipo dell’ignorante borioso che, mentre vuol far pompa della propria dottrina, sproposita allegramente e infilza l’una dietro l’altra le più stravaganti sciocchezze» (SANESI La commedia II p. 83).
Analisi linguistica330
di carattere81; secondo Vito Pandolfi, invece, un aspetto fondamentale di Grazia-no consisterebbe proprio «nella novità del tipo rispetto alla figura del pedante (che del resto in alcuni scenari compare a lato del dottore) per la sua raggiunta fisionomia artistica»82. Insieme con Pantalone e con lo Zanni, il dottore è la maschera fissa più fre-quente sulle scene della commedia Ridicolosa e di quella dell’Arte83. Il theatro delle favole rappresentative di Flaminio Scala (1611)84 lo vede partecipe nella maggior parte dei casi; egli compare inoltre in quasi la metà degli Scenari di Basilio Locatelli (1617 e 1622)85, e degli Scenari più scelti d’istrioni86; nelle raccolte successive la sua fortuna è alquanto minore87. Sono le origini, o almeno il percorso formativo, a fare del dottore l’emblema, naturalmente comico, della sapienza del celebre studio di Bologna, «città sceno-grafica e teatrale, dottorale e studentesca, ma anche popolaresca e giullaresca, sapiente ed equivoca, seria e parodistica, accademica e ciarlatanesca»88. Gene-ralmente rimane vago l’ambito di specializzazione: la competenza del Dottore abbraccia tutti i campi dello scibile umano, ma discende principalmente dalla giurisprudenza, come sembra indicare anche la parodia dei codici nascosta sotto l’appellativo di Graziano delle Codeghe e in quelli simili. Nella maggior parte delle opere, e dunque anche nel caso di Gattinon, i lineamenti che contraddistinguono la parlata di Graziano non permettono di fare altro che collocarla genericamente sulla frontiera tra una varietà emiliano-romagnola, peraltro (iper)caratterizzata con i fenomeni percepiti come peculiari da un ascoltatore, e una lingua artificiale, pesantemente vincolata da deforma-zioni che amplificano le potenzialità semantiche del lessico e arricchita anche
81 Cfr. D’AMICO Storia del teatro drammatico II p. 107.82 PANDOLFI Commedia dell’arte II p. 9.83 Inoltre Graziano è «personaggio della Commedia dell’Arte ampiamente presente nella tradizione
plurilingue genovese» (TOSO Utilizzo ideologico p. 71, che rinvia anche a TROVATO Maschera di Graziano, e, più in generale, ad ACCORSI Letteratura dialettale in Emilia Romagna pp. 735-770, e soprattutto pp. 748-750).
84 Cfr. PANDOLFI Commedia dell’arte II pp. 166-244, e V pp. 213-223.85 Cfr. PANDOLFI Commedia dell’arte V pp. 223-252; Graziano è in quarta posizione, dopo l’onnipre-
sente Pantalone, Zanni e Burattino.86 Cfr. PANDOLFI Commedia dell’arte V pp. 252-276.87 Cfr. PANDOLFI Commedia dell’arte V pp. 276-358.88 CAMPORESI Maschera di Bertoldo p. 261. E ancora: «Il dottore saccente, figlio di giullari e di istrioni, VL�DGGRWWRUz�D�%RORJQD�LQ�XQD�GDWD�LPSUHFLVDWD��FRVu�FRPH�YROHYD�LO�JHQHUH�FRPLFR��8Q�DQRQLPR�poeta, quando volle tracciarne origine e parentado, arrivato all’anno della laurea, coerente con la lezione giullaresca, storpiò in modo incomprensibile (e non poteva essere diversamente) la data: Gratianus vero addotoratus est | in Bologna, dal trent, l’ann del bsest» (p. 259); cfr. anche CAMPA-NELLI Dottor Balanzone p. 71.
Grazianesco 349
riguarda, in misura minore, anche Graziano, per esempio quando parla delle scarse competenze dell’allievo del pedante, alludendo invece a ben altre abilità: «Lu n’ YDO�D�]RVWUDU�Qp�D�FDYDOFDU�Qp�D�IDU�DOFXQ�DWW�GD�FDYDOLHU��QL�qO�YHUG"ª�,9�����$OWURYH�il sovrasenso, quando non fa leva su lemmi tipicamente ambigui come ‘giostrare’ e ‘cavalcare’, si intuisce a partire dalla traduzione dell’intera frase (cfr. IV 36: ©D�JK·�IDVu�PD]RUPLHQW�LQGXULU�OD�PDWHULD�H�XVFLU�OD�UHWHQWLYDª���$QQRWR�FKH��SHU�quanto riguarda Graziano, questo genere più semplice di materiali testuali è il meno diffuso, perché il personaggio scivola irrimediabilmente in deformazioni che trasformano il senso letterale da serio a ridicolo e postulano la presenza di una valenza seria occultata dalla contraffazione (cfr. ©QL�qO�YHUG"ª IV 38). E infatti, in una seconda e ben più diffusa tipologia, il significante è alterato in modo tale che il senso letterale appaia burlesco e derivi dall’equivoco creato dalla deformazione, mentre, per giungere al significato serio e reale del significante soggiacente, l’ascoltatore deve sottoporsi spesso a uno sforzo considerevole, poiché tale senso è nascosto sotto quello letterale e varca sovente i limiti della intelligibilità. Per esempio, in «Contention di fratti ch’ s’ tratta avant la madr del demonio» IV 126, al senso letterale burlesco (‘contesa di frati che si tratta davanti alla madre del demonio’) è sotteso il significato serio (‘condizione e patti che si trattano prima del matrimonio’), che Graziano, nella propria ignoranza, non è stato in grado di esprimere adeguatamente, rendendo in tal modo necessaria la chiosa di Pantalone (che si trova, puntualmente, nella battuta 127); il senso letterale deriva dalla traduzione di ogni singola parola (e non necessariamente di tutte), ma non è indispensabile un legame logico tra le parole o un senso complessivo della frase. Il significato serio è nascosto, difficile da intravedere, ed è emblematico il fatto che spesso Graziano, lungi dal precisare e rafforzare il significato, continui a distruggerlo, quasi vanificando la comunicazione. L’ultimo caso è quello più ricco e complesso, in quanto fonde i due precedenti. Sono infatti compresenti i tre livelli, vale a dire, oltre al senso letterale burlesco, un sovrasenso osceno e un significato serio e reale sotteso. Si prenda in esame l’esempio seguente: «[…] al va confortand ognun ch’a n’ debba piar la maroella s’una grossa fazza d’ lezenda, d’ficil a intrar, las culinclud, al fin, co ’n po’ d’oli d’ patienza […]» I 47; il senso letterale non può che risultare burlesco a causa della deformazione: «[…] va confortando ognuno che non debba pigliare le emorroidi se una grossa faccia di leggenda, difficile a entrare, le occlude, alla fine, con un po’ d’olio di pazienza […]»; invece non è semplice ricostruire il significato se-rio: «[…] va esortando ognuno che non debba pigliare la novella. Se una grossa faccenda [o anche: se un grosso affare], difficile a entrare, la conclude, alla fine, con un po’ di pazienza […]»; il sovrasenso metaforico consiste nell’allusione al rapporto passivo, e la sua comprensione è agevolata da elementi del senso
Analisi linguistica350
letterale (occludere le emorroidi, olio, pazienza…) e da altri del significato serio (‘faccenda’ o ‘affare’). Da quest’ultimo esempio emerge in modo evidente come il comico del senso letterale derivi dalla sua illogicità (ossia dall’accostamento incongruente delle parole più strane), e come la logicità del sovrasenso si possa restituire facilmente, a differenza di quella del significato serio. Si può infine osservare che lo sfruttamento della lingua a fini comici, operato attraverso la deformazione (e quindi passando attraverso il comico del significante), riduce l’illogico significato letterale a «zero», e realizza dunque una forma particolare di comico del significato133; l’attenzione dell’ascoltatore che desidera cogliere l’oggetto della comunicazione è conseguentemente costretta a fluttuare fra i diversi livelli compresenti nel materiale linguistico.
PEDANTESCO
Più che di tratti linguistici in senso stretto, per il pedante è preferibile parlare di strategie stilistiche – forse ormai di maniera – con particolare riferimento a quelle che governano la mescidanza di italiano aulico e latino nella quale Pom-ponio si esprime134; in questa breve analisi mi soffermo soltanto sugli aspetti che riguardano direttamente il linguaggio.
Latino conclamato
L’uso del latino conclamato, elemento fondamentale del pedantesco, può essere classificato secondo alcune tipologie abbastanza ben definite:�� innanzitutto abbondano le vere e proprie citazioni, tratte generalmente da Ci-
cerone o comunque dai classici più noti: «quæ vos cura coquit et sub pectore versat?» I 29 (CICERO Cato maior seu de senectute I 1, che cita a sua volta gli Annales di Ennio), «conscientia rectæ voluntatis maxima est consolatio rerum incommodarum» I 34 (CICERO Epistulae ad familiares VI 4), «Ah, potius pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras, immo vehementer excrucior» IV 7 (VERGILIUS Aeneis IV 25), ecc.; si osservi come non si tratti di formule cancelleresche o giuridiche, come avviene nel caso di Graziano, ma di frammenti in gran parte letterari;
133 Cfr. ALTIERI BIAGI Comico p. 39.134 Costituisce fondamentale scenario anche per queste brevi note lo studio del pedante offerto in
STÄUBLE Parlar per lettera.
Pedantesco 351
�� fra questi tasselli si possono distinguere alcune sentenze e formule da manua-le: «Recte cogitas, conforme a quello del filosofo: prius est dividere quam diffinire» IV 23, «Ignorantia omnium malorum causa» IV 67, «argumentum ab autoritate affirmative est validissimum» IV 67 (in genere sono esatte, diversamente da alcune fra quelle di Graziano: «ch’ s’ possa trovar in totius orbem terrarum» III 9);
�� compaiono altrettanto numerose espressioni latine di libera ideazione che sostituiscono completamente sintagmi in italiano e si inseriscono nel discorso LQ�SHUIHWWD�FRHVLRQH��VHQ]D�VROX]LRQH�GL�FRQWLQXLWj�VLQWDWWLFD��©&RPH�GHJQR"�Meæ sunt partes d’honorare la persona vostra» I 41, «Ritorni, ch’io l’aspetto procul dubio æpulis accumbere nostris» I 50, «Quem tenes vitæ cursum, Florinde, michi minime probatur, oportet igitur pro viribus obstes alla forza di questo fanciullo alato» II 25, ecc.;
�� sono usuali le voci latine subito tradotte in italiano non tanto per favorire la comprensione da parte dell’interlocutore quanto in ossequio al gusto pedantesco della ridondanza: «Qui rumores, che vociferationi» I 16, «Absit, Dio guardi!» I 20, «sed, ma» I 20, «attamen, nientedimeno» II 25, «Ita ut, di maniera che» IV 1, ecc.;
�� fra queste spiccano alcune tessere isolate, di solito cristallizzate già nell’anti-chità e quindi entrate nell’uso: «Me dius fidius» I 24, «mehercle» I 34, «nec latum unguem» I 34, «usu et mancipio» I 36, «immo» I 58, «Ergo, igitur» II 31, «idest» II 31, «hoc est» II 31, «O terque quaterque misero Florindo» IV 15, «Prosit. In primis et ante omnia» IV 21, «Vi niego precise» IV 67, «oportet considerare» IV 67, «eo magis» IV 69, «optare quid amplius» V 142, ecc.135.
Latinismi
Allineo soltanto alcune delle voci che contribuiscono a comporre la fisionomia del linguaggio artificiale del pedante; fra esse si potranno riconoscere almeno, secondo il carattere del prelievo, le voci tratte di peso dal lessico latino e adattate con morfologia italiana (advenienti I 16, facinore IV 69, domino I 22…), le voci portate nell’italiano senza mediazioni, neppure grafiche (ianua IV 78, muliercula IV 13…), le voci che esistono in un italiano eletto o arcaico, e che possono con-servare residui grafici inequivoci o aver attraversato mutamenti fonetici (cernere ‘vedere’ I 18, cogitatione IV 5, externi I 16, exulata IV 69, labefatta IV 5…), ecc.: alienigini I 16, bissena et altera IV 67, architriclinio IV 91, compedi IV 79,
135 Cfr. ALTIERI BIAGI Comico pp. 50-51.
REPERTORI LESSICALI
Il materiale ordinato in questa sezione è suddiviso secondo le sette parlate presenti nella commedia, ma con attenzioni diverse per ciascuna di esse. Tutte le forme di friulano, buranello, bergamasco e grazianesco confluiscono nei relativi spogli, e dunque per queste varietà il repertorio ha carattere sistematico. Per il veneziano, il pedantesco e il toscano la scelta operata, pur essendo nel comples-so piuttosto larga, predilige i vocaboli notevoli per il risvolto lessicografico. In particolare si escludono le preposizioni, le congiunzioni, gli articoli (fatto salvo quello determinativo in veneziano) e l’intercalare mo, che compare in un numero altissimo di casi – e anche in friulano – con sensibili sfumature di significato; lo VSRJOLR�GHO�WRVFDQR�QRQ�FRPSUHQGH�L�SURQRPL��FRVu�FRPH�TXHOOR�GHO�JUD]LDQHVFR�tralascia gli inserti latini. Per ogni voce si dà conto di tutte le occorrenze e del significato, in particolare qualora la forma sia diversa dall’italiano; nei casi più eloquenti o problematici, si forniscono anche alcuni esempi relativi alla fraseologia. I rinvii recano, come di consueto, il numero d’atto in numero romano e il numero di paragrafo in cifre arabe. Illustrazioni linguistiche più approfondite compaiono nell’appara-to, ordinariamente in corrispondenza della prima attestazione della voce nella commedia; il simbolo � indica dunque le voci e le espressioni annotate nel commento. Come da prassi, le preposizioni articolate, quando presenti, sono accorpate alla voce relativa alla semplice. Per i verbi si segnala anche il clitico nei casi in cui figura, separato, in proclisi. Per un elenco dei pronomi soggetto enclitici si rinvia all’analisi linguistica. Alcune lacune nei paradigmi dei verbi ‘essere’ e ‘avere’ sono state colmate con le forme verbali in cui essi svolgono la funzione di ausiliari. Soltanto le forme verbali dell’infinito sono state ricostruite. Per il bergama-sco, nell’incertezza degli esiti, e in presenza di dar, dir, esser, si ripristinano gli infiniti dei verbi mantenendo la -r e non innalzando la vocale media alta nella seconda coniugazione. Per il buranello, varietà assai sensibile all’interferenza, le forme dell’infinito ricostruite cancellano la vibrante, a sottolineare lo scarto dal veneziano in un quadro che peraltro oscilla: convivono infatti andar, patir, sentar, smaltir (da smaltirle) e daa, esse (da esseme), faa, pagaa, vegnii. L’asterisco, che segnala soltanto gli infiniti verbali, viene impiegato ogni-qualvolta si sia intervenuto, anche con una modifica leggera, sulle forme date dall’originale: perciò gratiarvi è ricondotto a *gratiare, fraporvi dà *fraporre, ringratiauus dà *ringratiaa (con la lunga finale altrove testimoniata in friulano), ma viodilu dà viodi; la ricostruzione degli infiniti dei riflessivi o dei medi friulani,
Repertori lessicali358
o di alcuni derivati da verbi latini che terminano in �VFđUH, -sci, è basata sulle forme piene testimoniate (quinzassi, trammudaassi…): vi… fidaa dà *fidaassi, cagnosseve è ricondotto a *cagnossi.
FRIULANO
a1 (ad, prep.; s. m. al, all’ + voc.; s. f. alla, alle, all’ + voc., e; pl. m. ai); a: I 67, 71, 77, 81, 85, 87, 91, 95, 99, 101, 143; II 18, 19, 23, 42, 50, 60, 72, 92, 126; III 35, 37, 69, 71, 73, 75, 79, 99, 175, 177, 183, 185, 187, 189, 195, 201; IV 102, 108, 170; V 3, 24, 153, 155, 189, 209, 211, 220, 222; ad: I 85, 95, 143; II 18, 23; III 201; V 151, 209; s. m. al: I 69, 79, 91, 95, 123, 143; II 5, 7, 44, 105, 126; III 59, 69, 79, 83, 168, 171, 193, 195; V 151, 209, 218; all’: II 40; III 79; V 211; s. f. alla: III 162; alle: III 48; all’: II 18; e: I 129; III 83; V 226; pl. m.: I 91; III 73
al mai: ‘mai’ II 7, all’inquintri: ‘al contrario’ 40; alla fé di me: ‘in fede mia’ III 162a2 (pron. sogg. 3 s. m.; ĺ anche al2, all’2, l’3): I 81, 91, 141; III 79; V 207a3 (pron. sogg. 3 s. f.; ĺ anche la2): I 87, 93, 103, 121, 141; II 3, 13, 19, 23, 50,
56, 64, 74, 76, 80, 126, 146; III 48, 59, 73, 75, 189, 191, 205; V 24, 199, 209, 213, 220
a4 (pron. sogg. 3 pl.; ĺ anche 3 pl. m. ai2): I 71, 73, 75, 89, 91, 95, 97, 101; II 50, 66; III 73, 93, 195; V 24, 209
*accadee ‘accadere’, ‘succedere’; ind. pres. 3 s.: accat III 75acemut ‘come’: III 177acheel, achel, achiel (pron. e agg.) ‘quello’; acheel: II 50, 62; III 35; V 213;
achel: III 95, 173; V 209; achiel: III 193acheest, achest (s. f. acheeste, acheste; pl. f. achestis; pron. e agg.) ‘questo’ (ĺ
anche chest, sto); s. m. acheest: III 95; achest: I 75, 87; II 148; III 168; s. f. acheeste: I 87; acheste: I 83; V 220; pl. f.: I 95
achichì ‘proprio qui’ (ĺ anche chichì): V 207acusì�¶FRVu·��,����������,,���ad (prep.) ĺ a1
adasi ‘adagio’: I 69adduis ‘addosso’: II 72adesso (friul. alterato) ‘adesso’: V 155adiestri ‘lesto’, ‘agile’: II 52 plui –: ‘più lesto’, ‘meglio’ II 52agar ‘solco’: V 209aghe ‘acqua’: I 89, 91; II 19, 58
Friulano 359
agn’ (ĺ anche anch’) � 1. ‘anche’: I 91, 95, 97, 123; III 69, 71 � 2. (– mo) ‘an-cora’: III 65
agne ‘zia’: I 67, 93agriculture ‘agricoltura’: III 187ah (esclam.): I 73, 91, 117, 138; II 74; III 160, 168; V 185, 205ai1 (prep. art.) ĺ a1 ai2 (pron. sogg. 3 pl. m.; ĺ anche 3 pl. a4): III 93, 195; V 209 dade ch’– han: ‘data che hanno’ III 93, ch’– hebbin: ‘che abbiano’ 195; denant cu – haibin
fat: ‘prima che abbiano fatto’ V 209 ai3 (sost.) ‘aglio’: III 77, 79aiar ‘aria’: III 79al1 (prep. art.) ĺ a1
al2 (pron. sogg. 3 s. m.; ĺ anche a2, all’2, l’3): I 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 99, 103, 109, 117, 139; II 3, 5, 7, 18, 19, 23, 40, 42, 50, 58, 60, 66, 72, 82, 117, 126; III 35, 71, 73, 79, 91, 97, 171, 173, 175, 195, 197, 199; IV 102; V 153, 155, 183, 193, 209; a precedere sogg. f.: I 83; II 19, 126; V 191
moie, moie, – è pochie differentie: ‘via, via, c’è poca differenza’ I 83; ma – è l’hoore ch’iò scomenzi a vosaa: ‘ma è ora di iniziare a gridare’ II 19, a devedai ch’– no vadi al seont de mote: ‘nel proibirle di andare secondo la spinta’ 126; l’importa ch’– siga della moneda dentru! ‘importa che dentro ci sia del denaro!’ V 191
al3 (pron. ogg. 3 s. m.) ‘lo’ (ĺ anche il2, ’l2, l’4, lu2): I 109; II 72, 148; IV 170 vus – vuei mantignii: ‘ve lo voglio ribadire’ I 109; vus – dirai a chiase: ‘ve lo dirò a casa’ II
72, vus – hai ben det, iò: ‘ve l’ho pure detto, io’ 148; vus – dirai: ‘ve lo dirò’ IV 170al’1 (pron. ogg. 3 s. f.) ‘la’ (ĺ anche ala, l’5, la3): V 153, 207 i – hai ben pettada, mi, a vostra fiola: ‘gliel’ho proprio assestata, io, a vostra figlia’ V 153,
cui vus – à menade viie?��¶FKL�YH�O·KD�SRUWDWD�YLD"·����al’2 (pron. ogg. 3 pl. f.) ‘le’ (ĺ anche lis2): III 175 i – hai megnestradis su pe schene: gliele ho assestate sulla schiena III 175ala (pron. ogg. 3 s. f.) ‘la’ (ĺ anche al’1, l’5, la3): I 89, 91 né iur – distudaas: ‘né gliela spegnessero’ I 89, ed al i – rompè fur de man: ‘e gliela ruppe
in mano’ 91alaa ‘andare’ (ĺ anche laa); cong. pres. 1 pl.: aliin I 129; IV 170; inf.: alaa V 151alch ‘qualcosa’: II 18; V 24, 207, 209ale ‘ala’: I 99, 101alfin ‘infine’: I 81algun (pl. m. alguns) ‘qualcuno’, ‘alcuno’; s. m.: II 40; III 79, 195; IV 104; pl.
m.: V 209alhore ‘allora’: III 79all’1 (prep. art.) ĺ a1
Repertori lessicali414
VENEZIANO
abondante ‘abbondante’: I 122accettar ‘accettare’, ‘accogliere’; ind. pres. 1 s.: accetto I 144; V 177; cong. pres.
2 pl.: accetté V 215; inf.: accettar IV 135*accommodare ‘sistemare’; cong. pres. 1 s.: accommoda IV 99*acconsentir ‘acconsentire’; ind. pass. pross. 3 s.: ha acconsentio IV 99accordao ‘accordatosi’, ‘intesosi’: V 208aceccao ‘accecato’: V 208 addottivo ‘adottivo’: V 223adoperar ‘adoperare’, ‘impiegare’; ind. pres. passivo 3 pl.: i sé adoperai III 200;
ind. imperf. 3 pl.: i addoperava I 84; inf.: adoperar IV 167*adottar ‘adottare’; ind. pres. 1 s.: adotto V 217*aidar ‘aiutare’; ind. pass. pross. 3 s.: ha aidao III 172; imper. 2 pl.: aideme III 166*aiutar ‘aiutare’; imper. 2 s.: aiutate II 39Alban ‘Albano’ III 127 �algun ‘qualcuno’, ‘altro’: I 140 Mi vituperoso? Mi? Né – de’ mii?��¶,R�YLWXSHURVR"�,R"�2�TXDOFXQR�GHL�PLHL"·�>"@�,����alla ‘ala’; ‘alla’: I 112 (doppio senso in officiali alla villa I 116)allegramente ‘rapidamente’, ‘disinvoltamente’, ‘tranquillamente’: I 128; IV
107; V 192alto (avv.) � 1. ‘in alto’: I 74 � 2. ‘a voce alta’: IV 123altramente ‘in modo diverso’: I 124altratanto, altrotanto ‘altrettanto’; altratanto: III 192; altrotanto: V 177*alzarse ‘alzarsi’; imper. 2 s.: alzate V 190ambassaori ‘ambasciatori’: I 140amigo (pl. amisi) ‘amico’; s.: III 36, 170; pl.: V 227amor: III 204; V 1, 200, 217 che vegna d’–: ‘che venga dal cuore’ III 204 �ampla ‘ampia’: I 128an ‘ah’: V 206ancuo ‘oggi’: II 149andar ‘andare’; ind. pres. 1 s.: vago III 176; V 161; ind. pres. 2 pl. interr.: andeu
IV 97; ind. fut. 3 s.: l’andarà V 152; cong. pres. 2 s.: che ti vaghi III 176; cong. pres. 3 s.: vaga II 136; cong. pres. 1 pl.: andemo I 144; II 136; III 204, 206; imper. 2 s.: va’ I 78, 96; II 10; III 109, 141, 147, 149, 186; V 159, 164, 182; vaghe V 182; vala II 12; imper. 2 pl.: andé II 136; IV 127; V 225; inf.: andar I 142; II 39; III 36; V 1, 162, 184, 227
va’ t’appica: ‘va’ ad impiccarti’ III 141, va’ al bordello: ‘va’ al bordello’ 186; va’ pur drio:
Veneziano 415
‘va’ avanti’; ‘procedi’ I 78; no son stao pì bon d’andar drio la lettera: ‘non sono stato più capace di continuare la lettera’ II 39; andé drio: ‘andate avanti’ IV 127
anemal (pl. anemali) ‘animale’; s.: III 202; pl.: III 196, 200 anemo ‘animo’: I 126; II 12, 14Antartico: III 200antiga ‘antica’: I 122antighitae (s.) ‘antichità’: V 217aponto (avv.) ‘appunto’: III 36; IV 153*appellarse ‘appellarsi’; ind. pres. 1 s.: m’appello II 103*appicarse ‘appendersi’, ‘impiccarsi’; cong. pres. 2 s.: che t’appica III 180;
imper. 2 s.: t’appica III 141 arecordo ‘accordo’: V 194arente ‘accanto’, ‘per giunta’: V 174, 227argomento ‘interpretazione’: I 126*arivar ‘arrivare’; ind. pass. pross. 1 pl.: semo arivai III 109arma (pl. arme) ‘stemma’; s.: I 100, 104, 140; pl.: I 98 armao ‘armato’: III 159, 176; V 1arme ‘armi’: III 155, 178, 186Artico: III 200ascendenti: I 106*ascoltar ‘ascoltare’; ind. pres. 3 s.: ascolta II 14; imper. 2 s.: ascolta I 108aseno ‘aseno’: IV 123*aspettar ‘aspettare’; ind. pres. 1 s.: aspetto I 98; III 113; V 188; ind. fut. 1 s.:
aspettarò II 10; aspetterò II 136; ger. pres.: aspettando III 184assae � 1. (avv.) ‘molto’: II 136 � 2. (agg.) ‘molti’: III 200*assalir ‘assalire’; ind. pres. 3 s.: assalisce IV 95*attaccar ‘appendere’; cong. pres. passivo 3 s.: che ve sia attaccà IV 141*attender ‘attendere’; cong. pres. 1 pl.: attendemo III 36audienza ‘ascolto’: V 227avanti ‘avanti’, ‘prima’: IV 127, 163*avanzar ‘avanzare’, ‘rimanere’; cong. pres. 1 pl.: avanzemo V 177 avanzemo sto puoco de tempo: ‘ci rimane un po’ di tempo’ V 177*avanzarse ‘essere in credito’; ind. fut. 2 s.: ti avanzarà III 143*avertir ‘badare’; imper. 2 s.: averti II 10*averzer ‘aprire’; cong. imperf. passivo 3 s.: che mi no fossi averto II 149; imper.
2 s.: averzi II 144avisar ‘avvisare’; imper. 2 s.: avisame II 43; inf.: avisarme IV 99aviso ‘avviso’: II 158; IV 101*azonzer ‘soggiungere’; imper. 2 s.: azonzeghe II 12
Buranello 449
ziogo ‘gioco’: II 71zo ‘giù’: II 8, 75; III 159zoccolar ‘scalpicciare’; inf.: zoccolar V 198*zogar ‘giocare’; ind. pres. 1 pl. interr.: zoghemio II 71; IV 113zonta ‘sovrappiù’: III 115 la – monterà pì della carne: ‘il sovrappiù costerà più della carne’ III 115*zonzer ‘giungere’; ind. pass. pross. 3 s.: la xé zonta V 184zorno ‘giorno’: III 186; V 190zotto ‘zoppo’: IV 95zovene (s. f. zovane e zovene; pl. m. zoveni; pl. f. zovene; agg. e sost.) ‘giovane’;
s. m.: II 12; III 176; V 177; s. f. zovene: IV 95; V 217; zovane: IV 95; pl. m.: V 227; pl. f.: IV 95
zudese ‘giudice’: V 217zudio ‘giudeo’: IV 143
BURANELLO
a (prep.): III 124ah (interiez.): III 169altra (agg.): III 167andar ‘andare’; ind. pass. pross. 3 s.: xé andà III 124; inf.: andar III 124*avee ‘avere’; ind. pres. 3 s.: ha [piao] III 124, ha [bisognà] III 124, ha [dao]
III 165
barba ‘zio’, ‘barba’: III 124ben (avv.) ‘bene’: III 134 besogno ‘bisogno’: III 122, 128 fa de –: ‘serve, è necessario’ III 122, 128*bisognaa ‘bisognare’, ‘essere necessario’; ind. pass. pross. 3 s.: ha bisognà III 124Brustolao (lett. ‘abbrustolito’): III 124 �
carissimo (s. f. carissima); s. m.: III 122, 132, 136, 165; s. f.: III 136*cascaa ‘cascare’; ind. pass. pross. 3 pl. interr.: seu cascao III 165che1 (congiunz.): III 128, 132, 136, 167, 169che2 (pron. e agg.): III 122, 128, 136, 165chi (pron.): III 124, 165Chioza ‘Chioggia’: III 124commuodo ‘come’: III 165
Repertori lessicali450
compagnia: III 124con: III 136conto: III 136 no tegno – con vostra signoria: ‘non tengo conto con vostra signoria’ III 136cosa � 1. (sost.): III 128 � 2. (pron. interr.): III 122 1. el xé tutta – mia: ‘sono in rapporti stretti’ III 128Costrao (lett. ‘castrato’): III 124 �
daa � 1. ‘dare’; imper. 2 pl.: dé III 136; inf.: daa III 167 � 2. ‘picchiare’; ind. pass. pross. 3 s. interr.: ha dao III 165
dabasso ‘in basso’ (riferito al corpo umano): III 132 ghe xé vegnuo, signor carissimo, una man de pettecchie –: ‘gli è venuta, signore carissimo,
una eruzione di petecchie in basso’ III 132de (d’ + voc., prep.) ‘di’; de: III 122, 128, 132; d’: III 124, 167Discipao (lett. ‘sciupato’): III 124 �donne: III 128*dubitaa ‘dubitare’; imper. neg. 2 pl.: no dubité III 167
e (congiunz.): passimel (pron. sogg. 3. s. m.; ĺ anche ’l, l’): III 128 esse ‘essere’; ind. pres. 1 s.: son III 122; so’ III 169; ind. pres. 3 s.: el xé III 128;
l’è III 128, 130; ind. pres. 2 pl. interr.: seu [cascao] III 165; ind. fut. 3 s.: sarà III 167; inf.: esseme [inbattuo] III 167
faa ‘fare’; ind. pres. 3 s.: fa III 122, 128; imper. neg. 2 s.: no far III 169; inf.: faa III 167
fa de besogno: ‘serve’, ‘è necessario’ III 122, 128fallo ‘errore’: III 169 mi tio’ in –: ‘mi prendi per un altro’ III 169fin ‘fino’ (prep.): III 167fraello ‘fratello’: III 169Friul ‘Friuli’: III 124fuora ‘fuori’ (rispetto alla casa o alla località di abitazione): III 128 mentre che nu stemo –: ‘mentre noi siamo fuori’ III 128
ghe (pron. dat. 3 s. e pl., m.) ‘a lui’, ‘a loro’: III 128, 132, 167 quel che – fa de besogno: ‘ciò di cui hanno bisogno’ III 128, – xé vegnuo: ‘gli è venuto’
132, – voleva daa: ‘gli avrei voluto dare’ 167gran (s. f.) ‘grande’: III 124
Bergamasco 453
tel (in –) ‘nel’: III 167*tioo ‘prendere’; ind. pres. 2 s.: tio’ III 169 mi tio’ in fallo: ‘mi prendi per un altro’ III 169torgolo�¶GRFLOH·�>"@��,,,���� lo voleva faa vegnii – morgolo: ‘lo avrei voluto far venire docile docile’ III 167 �tutta: III 128 el xé – cosa mia: ‘siamo in rapporti stretti’ III 128
un (f. una, un’ + voc.); m.: III 130; f. una: III 124, 132; un’: III 167
v’ (v’ + voc., pron. dat. 2 pl.) ‘vi’, ‘a voi’ (ĺ anche ve): III 165ve (pron. dat. 2 pl.) ‘vi’, ‘a voi’ (ĺ anche v’): III 122, 136vegnii ‘venire’; ind. pass. pross. 1 s.: son vegnù III 124; ind. pass. pross. 3 s.: xé
vegnuo III 132; inf.: vegnii III 167 faa vegnii torgolo morgolo: ‘far diventare docile docile’ III 167Venesia ‘Venezia’: III 124*volee ‘volere’; ind. imperf. 1 s.: voleva III 167; condiz. pres. 1 s.: vorrave III 167vostra (agg. poss. s. f.): III 136
zorni ‘giorni’: III 126
BERGAMASCO
a1 (prep.; s. f. alla); a: III 110, 146, 148, 150; alla: III 148 alla fè sì��¶LQ�IHGH�PLD�Vu·�,,,����a2 (pron. sogg. 1 s.; ĺ anche i >"@���,,,������������������������adès ‘adesso’: III 110, 118alla ĺ a1
almanch ‘almeno’: III 148altra (agg.): III 118anch ‘anche’: III 148*aver ‘avere’; ind. pres. 1 s.: a i ho III 112, 118; ind. pres. 3 s.: non l’à [mangiat]
III 116
ben ‘bene’: III 110bif ‘bere’; ind. pass. pross. 1 s.: ho bevuch’ III 148; inf.: bif III 114braghe ‘calzoni’, ‘brache’: III 106 me scompiis in le –!: ‘piscio nelle brache!’ III 106
Repertori lessicali454
ch’ (pron. rel.) ĺ che2
car ‘caro’: III 116, 118cest ‘cesto’: III 104che1 (congiunz.): III 104, 108, 114, 118, 140, 142, 146, 148, 154che2 (ch’ + voc., pron. rel.); che: III 116, 142; ch’: III 148chiluga ‘qui’: III 112 � a i ho pagura da no trovarve –: ‘ho paura di non ritrovarvi qui’ III 112co (congiunz.) ‘che’: III 116cont ‘conto’: III 116 no tegnì – co ’l voster pover Zambù: ‘non tenete conto che il vostro povero Zambon’ III 116*contentarse ‘accontentarsi’, ‘avere piacere’; ind. pres. 2 pl.: ve contenté III 114cornucc’ ‘cornuto’: III 154così (avv.): III 146crosta: III 114
d’ (prep.) ĺ de
da1 (prep.) ‘di’: III 112, 138da2 (prep.) ‘da’: III 114, 150daocch’ ‘daotto’ (moneta di basso argento da otto soldi veneti): III 146dar ‘dare’; inf.: dar III 114, 140; darm III 138de (d’ + voc., prep.; s. m. del) ‘di’ (ĺ anche di); de: III 118; d’: III 140; s. m.:
III 150del (prep. art.) ĺ de
dir ‘dire’; ind. pres. 1 s.: a digh III 146; a ve digh III 108; inf.: dir III 154dre ‘dietro’: III 146*dubitarse ‘dubitare’; imper. neg. 2 pl.: no ’f dubitè III 118durà ‘resistere’, ‘farcela’; inf.: durà III 108
e (congiunz.): passimesser ‘essere’; ind. pres. 3 s.: no l’è III 150; ind. pres. 3 s. f.: l’è III 104; ind. pres.
3 s. interr.: n’è III 114; ind. pres. 2 pl.: se’ III 142, 154; cong. pres. 1 s.: che mi sia III 154; inf.: esser [pagacch’] III 152
’f (pron. rifl. 2 pl.) ‘vi’: III 118 no ’f dubitè: ‘non dubitate’ III 118fadiga (pl. fadighe) ‘fatica’; s. III 142; pl. III 150*far ‘fare’; ind. pass. pross. 1 s.: ho facch’ III 140; cong. pres. 1 s.: che me faga
III 114; condiz. pres. 2 pl.: faressi III 110; fé ‘fede’: III 148 alla fé sì��¶LQ�IHGH�PLD�Vu·�,,,����
Grazianesco 457
sesin ‘monetina’: III 148sì (avv.): III 112, 148strada: III 140
tanta (agg.): III 140tegnir � 1. ‘tenere’; ind. pres. 2 pl. interr. no tegnì III 116 � 2. ‘trattenere’, ‘lesinare’,
‘risparmiare’; ind. fut. 2 pl. tegnerì III 142; inf.: tegnir III 150 1. no tegnì cont: ‘non tenete conto’ III 116trovar ‘trovare’; inf.: trovarve III 112tutt’ (+ voc.) ‘tutto’: III 146 – hoz: ‘oggi’ III 146
un (f. una); m.: III 114, 142, 146, 148, 154; f.: III 114
ve1 (pron. dat. 2 pl.) ‘vi’, ‘a voi’: III 108, 138ve2 (pron. rifl. 2 pl.) ‘vi’: III 114vegnir ‘venire’; ind. pres. 3 s.: vè III 142; inf.: vegnirv III 146vira ‘vero’: III 114 n’è –?��¶QRQ�q�YHUR"·�,,,����voia ‘voglia’: III 118*voler ‘volere’; ind. pres. 1 s.: a voi III 152; voi III 148; no i voi III 146; ind.
pres. 2 pl.: volé III 154voster (agg. poss. s. m.) ‘vostro’: III 116vu (pron. sogg. 2 pl.) ‘voi’: III 142, 154
Zambù ‘Zambon’: III 116zentilom ‘gentiluomo’: III 142, 150zo ‘giù’: III 104
GRAZIANESCO
a1 (ad, prep.; s. m. al, all’ + voc., s. f. alla, all’ + voc., pl. m. ai; pl. f. alle); a: I 47; II 86, 93, 97, 99, 102, 106, 109, 115; III 1, 27, 31, 33; IV 20, 26, 38, 40, 42, 52, 56, 98, 112, 122, 142, 150, 168; V 167, 171; ad: IV 52; s. m. al: I 47; II 86, 97, 102, 109; III 1, 31; IV 18, 40, 50, 96, 166; all’: IV 48; s. f. alla: II 125, 154; III 1, 7, 27, 31; V 201; pl. m.: I 47; V 156; all’: I 47; II 102; III 31; IV 36, 40; V 201; pl. f.: II 102
Repertori lessicali458
a2 (pron. sogg. 1 s.): I 47; II 86, 93, 95, 97, 99, 102, 104, 106, 109, 111, 115, 119, 123, 125, 135, 139, 141; III 3, 5, 7, 13, 19, 25, 27, 29, 31, 33; IV 18, 20, 30, 34, 38, 40, 56, 98, 112, 134, 142, 150, 152, 156, 158, 160, 164, 166, 168; V 156, 158, 171, 173, 175
a3 (pron. sogg. 3 s. m.; ĺ anche al2, l’4): I 47; III 1; IV 54, 96, 150, 168; V 156a4 (pron. sogg. 1 pl.): III 27; IV 164a5 (pron. sogg. 2 pl.): IV 18, 32, 36, 40, 42, 98, 114, 116, 166; V 169abidualmient ‘abitualmente’ (burl. per ‘in stato vedovile’): II 125 domentre che la viv –��¶ILQFKp�YLYH�DELWXDOPHQWH·���¶ILQFKp�YLYH�LQ�VWDWR�YHGRYLOH·�,,�����accettar ‘accettare’; inf.: accettar IV 130*acchiappars ‘afferrarsi’; ind. pres. 3 s.: al s’ acchiappa IV 64*accommodar ‘sistemare’; imper. 2 pl.: accommodai IV 98*aconzars, acconzars ‘acconciarsi’, ‘sistemarsi’; ind. fut. 1 s.: a m’aconzarò II
97; a m’acconzarò II 99acqua (ĺ anche aqua): III 1 l’asprezza dell’– del legn sant: ‘l’asprezza dell’acqua del legno santo’ III 1 �acquason ‘acquazzone’ (burl. per ‘occasione’): IV 50 � chi ha dad l’– son al bottaz da scriver sì bien?: ‘chi ha dato l’acquazzone al bottaccio per
VFULYHUH�FRVu�EHQH·���¶FKL�KD�GDWR�DO�%RFFDFFLR�O·RFFDVLRQH�GL�VFULYHUH�FRVu�EHQH"·�,9����adès ‘adesso’: II 86; IV 98adie ‘addio’: II 111; IV 168ados ‘addosso’: IV 36*affermar affermare; cong. pres. 3 pl.: ch’afferma IV 148aforism ‘aforisma’: I 47*agrizzars ‘vergognarsi’, ‘rabbrividire’; ind. pres. 3 s.: n’ s’agrizza III 33ah (interiez.): II 106; III 31; IV 18, 52aiut ‘aiuto’: II 106; V 201*aiutar ‘aiutare’; imper. 2 pl.: aiutem II 106al1 ĺ a1
al2 (pron. sogg. 3 s. m.; ĺ anche a3, l’4): I 47; II 93, 97, 102, 111, 115, 130, 135, 150; III 1, 7, 11, 27; IV 40, 52, 64, 118, 122, 146, 148; V 156, 171, 201
Albert ‘Alberto’ (– andò a Fiorenza: burl. per ‘Albertano da Brescia’): III 1 �alcun ‘alcuno’: IV 38all’ (prep. art.) ĺ a1
alla (prep. art.) ĺ a1
alle1 (prep. art.) ĺ a1
alle2��VRVW��SO���¶DOL·�>"@ (pugn d’–: burl. per ‘pugnale’): IV 166 ch’a m’ voi armar in t’un sach d’ fer e con un pugn d’–: ‘mi voglio armare in un sacco di
IHUUR�H�FRQ�XQ�SXJQR�GL�DOL·���¶PL�YRJOLR�DUPDUH�GL�XQ�JLDFR�H�GL�XQ�SXJQDOH·�,9������
Grazianesco 459
*alluder ‘alludere’; ger. pres.: alludend I 47alta: IV 40altr (s. f. altra; pl. m. altr; pron. e agg.) ‘altro’, ‘altri’; s. m.: III 1; V 169; s. f.:
II 97, 102; IV 30; pl. m.: II 97; IV 36altrui (agg. sost.): II 150*ammazzar ‘ammazzare’; imper. 2 s.: ammazza V 201amor ‘amore’: I 47; IV 38, 40, 56an ‘anno’: II 115, 130an’ ‘anche’ (dov – mi son: burl. per ‘donazione’): III 27 �anch ‘anche’: II 95ancora (avv.): IV 110andar ‘andare’; ind. pres. 1 s.: a vag II 97; III 33; V 158; a ’l vagh I 47; ind.
pres. 3 s.: al va I 47; V 201; ind. pass. pross. 1 s.: a son ’dà II 141; ind. pass. pross. 3 s.: è andad I 47; ind. pass. rem. 3 s.: andò III 1 (Albert – a Fiorenza: burl. per ‘Albertano da Brescia’) �; imper. 2 pl.: andai IV 40; inf.: andar II 93, 109; III 1
andai al burchiel!��¶DQGDWH�DO�EXUFKLHOOR·���¶DQGDWH�DO�ERUGHOOR·�,9���Andrea (Andrea fachin: burl. per ‘Andrea Fachinei’): III 1 �anel ‘anello’ (osc.): IV 52 chi ha insegnad a montar su ad ongi e lica con l’–: ‘chi ha insegnato a montare ad ungi e
OHFFD�FRQ�O·DQHOOR·���¶FKL�KD�LQVHJQDWR�D�FDYDOFDUH�DG�$QJHOLFD�FRQ��O·DQHOOR·�,9�����antigh (pl. f. antigh; agg.) ‘antico’, ‘antiche’; s. m.: III 33; pl. f. IV 36Antonia: IV 128Antonio (sug –: burl. forse per ‘Svetonio’): III 1 �apetit ‘appetito’: IV 56apiaser ‘piacere’: II 86appress ‘presso’: IV 40apunt ‘appunto’: IV 98aqua ‘acqua’ (– pendient: burl. per ‘Girolamo Fabrici d’Aquapendente’, anato-
mista; ĺ anche acqua): III 1 �arca (Il pret è in l’–; pietra è l’–: burl. per ‘Petrarca’): IV 44, 46, 148 s’ l’– cades��¶VH�O·DUFD�FDGHVVH·���¶VH�RFFRUUHVVH·�,9����arch ‘arco’ (anche piantò l’–: burl. per ‘Plutarco’, storico e moralista greco):
III 1 �; IV 56*arcomandars ‘raccomandarsi’; ind. pres. 1 s. (forma di saluto): m’arcomand
I 47; II 135 argumient ‘argomento’: IV 54*armars ‘armarsi’; inf.: a m’ voi armar IV 166
Repertori lessicali508
zò ‘ciò’: II 97 zorn ‘giorno’: IV 36zornal ‘giornale’, ‘giornaliero’ (burl. per ‘generale’ e ‘giorno’): III 7; IV 40 e fart hered – d’la so difficultad��¶H�IDUWL�HUHGH�JLRUQDOLHUR�GHOOD�VXD�GLIILFROWj·���¶H�IDUWL�HUHGH�
generale della sua facoltà’ III 7; al – quint, la prima manoella: ‘al giornale quinto, la prima PDQRYHOOD·���¶DOOD�TXLQWD�JLRUQDWD��OD�SULPD�QRYHOOD·�,9���
zostrar ‘giostrare’ (osc.); inf.: zostrar IV 38 lu n’ val a – né a cavalcar né a far alcun att da cavalier: ‘non è capace di giostrare né di
cavalcare né di fare alcun atto da cavaliere’ IV 38 �*zovar ‘giovare’, ‘servire’; ind. fut. 3 s.: a n’ gh’ zovarà V 156Zuan ‘Giovanni’ (– beccaz: burl. per ‘Giovanni Boccaccio’): IV 40zucca�>"@� III 1 al fa d’ mestier haveir zacch, – e crivel: ‘è di mestiere avere giaco, zucca e crivello’ III 1Zuda ‘Giuda’: IV 166zudiè ‘giudeo’: III 31 �zudio ‘giudeo’ (burl. per ‘giudice’): II 106zusta ‘giusta’: II 99
PEDANTESCO
*acclamare ‘chiamare’; ind. pass. pross. 1 s.: ho acclamato IV 19 acerbamente ‘duramente’: IV 9acerbo ‘amaro’: IV 15acherontea: I 20aculeo: IV 9*addurre ‘portare’; ind. pass. rem. 2 s.: adduceste I 34adito ‘strada’, ‘accesso’: I 45*advenire ‘provenire’; part. pres.: advenienti I 16alienigini ‘stranieri’: I 16alieno ‘altro’, ‘estraneo’: I 16altera (bissena et –) ‘tredicesima’: IV 67 nella sua bissena et – questione: ‘nella sua tredicesima questione’ IV 67amandare ‘allontanare’, ‘rimuovere’; inf.: amandare II 25amasia ‘amante’: I 34amatrice ‘amante’: II 31ancipite ‘ambivalente’; ‘pericolosa’: IV 1 remota ogni – dubitatione: ‘rimossa ogni ambivalente incertezza’ IV 1 �anullare ‘matrimoniale’: V 142 subarratione –: ‘contratto di matrimonio’ V 142 �
Pedantesco 509
*appellare ‘chiamare’; ind. pres. 3 pl.: s’appellano II 33*aprobare ‘comprovare’, ‘dimostrare’; ind. fut. 1 s.: aprobarò IV 67architriclino ‘cameriere’: IV 91 �arta ‘stretta’: IV 17assaggio: I 145assessori ‘assessori’; ‘assistenti’: I 20aure ‘venticelli’: IV 69Austro: I 60 *avertire � 1. ‘stare attenti’; imper. 2 s.: averti IV 91 � 2. ‘avvertire’; ind. pass.
pross. 1 s.: ho avertito IV 19
bellua ‘bestia’, ‘belva’: I 38 �; IV 71bissena ‘dodicesima’: IV 67 nella sua – et altera questione: ‘nella sua tredicesima questione’ IV 67blanditie ‘lusinghe’: IV 71Borea: I 60
*cavare ‘estrarre’; cong. pres. 2 s.: cavi IV 7cernere ‘vedere bene’, ‘distinguere’; inf.: cernere I 18chiarezza ‘altezza’: I 56cogitatione (pl. cogitationi) ‘preoccupazione’, ‘riflessione’, ‘pensiero’; s. IV
5; pl. I 60; II 25*commemorare ‘ricordare’; ind. fut. 1 s.: commemorarò II 33commutare ‘scambiare’; inf.: commutare IV 13compedi ‘ceppi’: IV 79 in –: ‘in ceppi’ IV 79 �comperto ‘scoperto’: IV 1 conato ‘fatica’, ‘sforzo’: II 33conducibili ‘utili’: II 25congionto ‘congiunto’, ‘subordinato’: I 10, 13; IV 17congiuntione ‘congiunzione’, ‘unione’: II 31; V 141 conspicilli ‘occhiali’: I 18 �constare ‘constatare’; inf.: constare II 29*contemperare ‘temperare’, ‘moderare’, ‘mitigare’; imper. 2 s.: contempera II
27contubernale ‘amico’: IV 11convicio ‘insulto’: IV 71cortice ‘corteccia’: II 31crassa ‘grossolana’: IV 19
Repertori lessicali514
solerte ‘vivace’: IV 72soverchia ‘eccessiva’: IV 67spontaneo ‘volontario’: IV 13*sternere ‘stendere’; imper. 2 s.: sterni IV 91stigia: I 20strati ‘tappeti’: IV 91 exorna il cubiculo, sterni i –: ‘orna la sala, distendi i tappeti’ IV 91subarratione ‘contratto’, ‘promessa ufficiale’: V 142 – anullare: ‘contratto di matrimonio’ V 142 �
tanto�¶FRVu�JUDQGH·��,9����tartarei: I 20testacii (agg.) ‘da tegame’, ‘cotto in tegame’: IV 91 averti di non pervertere i pulmenti –: ‘sta’ attento a non mescolare le pietanze dei tegami’
IV 91 �testimonio ‘prova’: V 142tosco ‘veleno’: IV 7*translare ‘condurre’; inf. passivo: esser translati V 142 traslatitia ‘effimera’: I 34
ulisseo ‘di Ulisse’: IV 11 �unquanco ‘mai’: I 34usato ‘solito’: IV 81, 83
vago � 1. ‘seducente’: II 31 � 2. ‘incerto’: II 33vario ‘contraddittorio’: II 33vatiniano ‘vatiniano’, ‘di Vatinio’, avversario di Cicerone: IV 69 �venerea ‘lasciva’: IV 5vocabulo ‘vocabulo’: I 36vociferationi ‘grida’: I 16volgatrice ‘divulgatrice’: I 60vosco ‘con voi’: I 18vulpecula ‘volpacchiotto’: IV 69 �, 71
TOSCANO
abbarbagliata ‘abbagliata’: V 13*abboccarsi ‘parlare’; inf.: abboccarvi V 148
Toscano 515
abbondevole, abondevol ‘provvisto’; ‘abbondante’; abbondevole: V 111; abon-devol: I 46
abbrucciare ‘bruciare’; cong. pres. 3 s.: s’abbruggi I 146; inf.: abbrucciare II 26accidente (pl. accidenti) �����‘evento’, ‘azione’; s.: Pr. 13; V 107; pl.: Pr. 11 �����
‘caso’, ‘situazione’; s.: V 111; pl.: V 133accommodata ‘composta’, ‘fornita’: V 90acerba ‘amara’: V 69acquearuola ‘vinello’: I 146*acquietarsi ‘calmarsi’, ‘placarsi’; ind. fut. 2 pl.: v’acquietarete V 39; imper. 2
pl.: acquietatevi V 25*adduggiare ‘corrompere’, ‘contaminare’, ‘infettare’, ‘ammorbare’; ind. pres.
3 s.: adduggia IV 68 la morte il tempo adduggia: ‘la morte corrompe il tempo’ IV 68adiettivo ‘aggettivo’: I 146adobbata ‘acconciata’: III 62*adoprare, *adoprarsi ‘adoperare’, ‘usare’; ‘comportarsi’; ind. pres. 1 s.: adopro
V 210; imper. 2 pl.: adopratevi V 89adorno ‘dotato’: V 111adulterato: I 146affanni: V 14, 58, 65affettione ‘benevolenza’: I 4afflittione ‘afflizione’: V 110aggiati ‘comodi’: V 90aita ‘aiuto’: V 8albori: V 68alesso (pl. alessi) ‘lesso’; s.: I 146; pl.: IV 86 allegrezze: Pr. 17; V 144alma: II 34; V 59 almanco ‘almeno’: I 146altitonante ‘colui che tuona dall’alto’, epiteto di Giove: II 30 �altrimente ‘diversamente’: V 14ambrosia: V 142ammollire ‘ammorbidire’; inf.: ammollire V 13aperto ‘dichiarato’: V 110 nemico –: ‘nemico dichiarato’ V 110*appagarsi ‘soddisfarsi’; ind. fut. 1 s.: m’appagherò V 41*appannare; ind. pres. 3 s.: appanna V 58applicati: V 93apportare ‘apportare’, ‘portare’; ind. pres. 3 s.: apporta V 110; cond. pres. 3 s.:
apportarebbe V 2; inf.: apportare V 75; apportarmi I 33
BIBLIOGRAFIA
ACCORSI Dialetto e dialettalitàM. G. ACCORSI, Dialetto e dialettalità in Emilia-Romagna dal Sei al Novecento, Bologna, Boni, 1982.
ACCORSI Letteratura dialettale in Emilia RomagnaM. G. ACCORSI, Per una storia della letteratura dialettale in Emilia Romagna, in La letteratura dialettale preunitaria, a cura di P. MAZZAMUTO, Palermo, Tip. G. Aiello, 1994, pp. 735-770.
ALLACCI DrammaturgiaL. ALLACCI, Drammaturgia, accresciuta e continuata fino all’anno MDCCLV, Venezia, Giambatista Pasquali, 1755.
ALONGE La riscoperta rinascimentale del teatroR. ALONGE, La riscoperta rinascimentale del teatro, in Storia del teatro moderno e contemporaneo, diretta da R. ALONGE e G. DAVICO BONINO, vol. I, La nascita del teatro moderno. Cinque-Seicento, Torino, Einaudi, 2000, pp. 5-118.
ALTIERI BIAGI ComicoM. L. ALTIERI BIAGI, Dal comico del «significato» al comico del «significante», in EAD., La lingua in scena, Bologna, Zanichelli, 1980, pp. 1-57.
ANDREINI Due comedieG. B. ANDREINI, Le due comedie in comedia, in FERRONE Commedie II, pp. 9-105.
ANGELINI CommediaF. ANGELINI, La commedia, in La letteratura italiana. Storia e testi, diretta da C. MUSCETTA, vol. V/2, F. ANGELINI - A. ASOR ROSA - S. S. NIGRO, Il Seicento. La nuova scienza e la crisi del Barocco, Bari, Laterza, 1974, pp. 223-286.
ARETINO Sei giornateP. ARETINO, Sei giornate. Ragionamento della Nanna e della Antonia (1534). Dia-logo nel quale la Nanna insegna a la Pippa (1536), a cura di G. AQUILECCHIA, Ba-ri, Laterza, 1969 (reprint a cura di G. A., ibid. 1975, ibid. 1980).
ARETINO Teatro P. ARETINO, Teatro, a cura di G. PETROCCHI, Milano, Mondadori, 1971.
ARIOSTO Commedie L. ARIOSTO, Commedie, a cura di A. CASELLA, G. RONCHI, E. VARASI, Milano, Mondadori, 1974.
Bibliografia 551
ZAMBONI CaratteristicheA. ZAMBONI, Le caratteristiche essenziali dei dialetti veneti, in Guida ai dialetti veneti, a cura di M. CORTELAZZO, Padova, C.L.E.U.P., 1979, pp. 9-43.
ZAMBONI VenetoA. ZAMBONI, Veneto, Pisa, Pacini, 1974.
ZAMBONI VenezienA. ZAMBONI, Italienisch: Areallinguistik IV. Aree linguistiche IV. a) Venezien. Veneto, in LRL Bd. IV [1988], pp. 517-538.
ZANELLO Dottor GrazianoG. ZANELLO, Intorno al dottor Graziano, «Metodi e ricerche», n.s., XXVII (2008), 2, pp. 101-150.
ZANELLO GattinonG. ZANELLO, Gattinon Marcantonio, in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, vol. II, L’età veneta, a cura di C. SCALON, C. GRIGGIO e U. ROZZO, Udi-ne, Forum, 2009, pp. 1247-1251.
ZANELLO Tra musica e letteraturaG. ZANELLO, Nella storia: tra musica e letteratura friulana, «Metodi e ricerche», n.s., XXII (2003), 2, pp. 115-170.
ZANELLO Versi friulani«E chest mo par amor del nestri Imperador». Versi friulani da Vienna per l’inco-ronazione di Ferdinando III, «Metodi e ricerche», n.s., XXII (2003), 1, pp. 67-95.
ZORZI Il teatro e la cittàL. ZORZI, Il teatro e la città. Saggi sulla scena italiana, Torino, Einaudi, 1977.
INDICE DEI NOMI
L’indice registra i nomi di persona; ne rimangono esclusi il nome di Marc’An-tonio Gattinon, quelli dei tipografi o degli editori che compaiono nei titoli di libri e articoli, nonché quelli dei personaggi letterari nei casi in cui costituiscano il titolo di un’opera. Come di consueto, la lettera n indica i riferimenti che compa-iono nelle note (e soltanto alle note si riferiscono i rinvii delle pp. 85-244, nelle quali è contenuta l’edizione della commedia). Il maiuscoletto indica gli scrittori, gli stampatori antichi e i personaggi storici, mentre il corsivo è adottato per i personaggi di invenzione e letterari (in questi casi il nome precede il cognome). Mentre sono indicizzate le deformazioni dei nomi propri a fini burleschi, non sono comprese nell’indice le traduzioni di tali nomi deformati.
Abbondanza Roberto: 158nAcario: 130nACCOLTI Francesco ĺ ARETINO
Accorsi Maria Grazia: 330n, 331n, 531ACQUAPENDENTE (Girolamo Fabrici detto
l’–): 24, 156n, 159n, 459, 491; aqua pendient: 24, 459, 491
Adamo ĺ DanAdes: 98n Afrone: 41n, 184nAgata: 48Agnelli Giuseppe: 23, 23nAgnolo: 7, 16, 41, 52, 281Alban: 176n, 312, 414; Albano: 176n, 414ALBANO (santo): 176nALBERTANO DA BRESCIA: 155n, 157n, 458,
459; Albert andò a Fiorenza: 458, 459ALBERTO MAGNO: 69, 73, 113nAlbigerio: 46, 48, 49, 324Alceo: 133nAlcmena: 133n, 134nALESSANDRO MAGNO: 128n, 317Alessio Giovanni: 537Aletto: 98n Alfeo: 199nAlgorante: 48, 49
ALIGHIERI ĺ DANTE ALIGHIERI
ALLACCI Lione: 38, 38n, 68, 68n, 531ALLEGRI Alessandro: 29Alletto: 98nALODNARIM Fabrizio ĺ MIRANDOLA Fa-
brizio Alonge Roberto: 50n, 531Altieri Biagi Maria Luisa: 9n, 347, 347n,
348, 348n, 350n, 351n, 354n, 531, 544ALVAROTTI Francesco: 158nALVAROTTI Iacopo: 155n, 158n, 479, 505;
Giacobo Alvarotto: 158n, 505; Varot: 158n, 479, 505
ALVAROTTI Marco Aurelio: 158nAmadigi di Gaula: 155n, 157n, 476, 484;
Amadis de Gaula: 24, 157n, 472, 476, 484; a Madris e’ la garla: 24, 157n, 472, 476, 484; Amadis de Grecia: 157n
Amaltea: 134n, 135nAMASEO Gregorio: 180nAmone: 104nAnassarte di Nichea: 157n; Anaxartes:
157nANDREINI Giovan Battista: 41n, 51, 208n,
531
Indice dei nomi554
Anfitrione: 133n, 134nAngelica: 21, 148n, 195n, 354, 459, 475,
482, 487, 489; Anzilica: 148n; ongi e lica: 21, 195n, 459, 475, 482, 487, 489
Angelini Franca: 54n, 531Antonia (personaggio di P. Aretino): 531Antonia: 208n, 343, 459, 471Apollo: 125n, 199nAPULEIO: 134nAQUILANO Serafino (Serafino de’ Cimi-
nelli): 162nAquilecchia Giovanni: 531Aquilio: 39, 40, 47, 59, 183nArchibio: 54nAres: 189nARETINO (Francesco Accolti detto l’–):
158nARETINO Pietro: 44, 116n, 127n, 149n,
153n, 156n, 162n, 194n, 201n, 238n, 239n, 531
Aretusa: 199nARGIROGLOTTO Iano: 203nArianna: 199nARIOSTO Ludovico: 103n, 104n, 137n,
143n, 156n, 170n, 195n, 208n, 232n, 343, 344, 355n, 423, 426, 427, 446, 460, 478, 483, 506, 531, 532; ms’ier Lodovigh: 105, 343, 483; arrost: 343; l’host: 343, 354, 478, 506
ARISTOTELE: 147n, 202n, 332, 353n, 495, 501; Aristotile: 55; Aristot’l: 343n; Re stotil: 495, 501
Arlecchino: 45n, 105n, 143n, 207nArnaldi Girolamo: 7nArriana: 199nArrunzio: 48Artemide: 125n, 199nAsor Rosa Alberto: 531, 544AUDIFFREDI Giovanni Battista: 68, 68n,
532Aurigemma Marcello: 534
AVICENNA �$Eŗ�¶$OĦ�DO�+XVD\Q�LEQ�¶$EG�$OOăK�LEQ�6ĦQă������Q�����Q�����Q��343n, 460; Avicena: 460; Vannaccena: 104n; Vien a cena: 104n, 343n; vino a cena: 104n
AZZO (giurista, maestro di Iacopo Bal-dovini): 158n
Bacco: 180n, 187n, 197n, 237n, 345, 365, 413, 462; brach: 345, 462
Badini Bruna: 334n, 335n, 336n, 337n, 339, 339n, 478n, 532
Badoccli: 11, 11n, 108n, 273, 361Balanzone: 103n, 330n, 332n, 481, 534;
Balanzon: 329n; Balanzon Bombarda: 105n; Lanzon >"@���������Q�����Q������
Balbiani Laura: 113n, 532BALDOVINI Iacopo: 155n, 158n, 460; Gia-
cobo di Balduino: 158n, 460; Balduin: 158n, 460
Balissarda ĺ ValisardaBalordo: 45nBANCHIERI Adriano: 83, 104n, 153n, 156n,
157n, 168n, 194n, 211n, 331, 331n, 333, 333n, 532; Scaliggeri Camillo: 333n
BANDELLO Matteo: 148nBARBARO Ermolao (il giovane, medico e
umanista): 159nBARGAGLI Girolamo: 223n, 532Barile (seente –): 303, 361, 396, 402Bartolomeo di Badoccli ĺ Meu di Ba-
doccliBARUTTI Marc’Antonio: 50, 109nBascetta Carlo: 130nBattaglia Salvatore: 540Battisti Carlo: 537BELANDO Vincenzo: 31n, 45n, 120n, 139n,
208n, 532BELLACATO Alvise: 159nBELLI Giuseppe Gioachino: 16
Indice dei nomi 555
BELO Francesco: 44, 100n, 201n, 532BEMBO Pietro: 25, 165n, 198n, 355, 532Benandantuz Sadinà: 12Benincà Paola: 256, 256n, 269n, 274n,
289n, 296n, 301n, 532, 533, 538Benzoni Gino: 156nBEOLCO Angelo ĺ RUZANTE
Bernardina ĺ BidineBernardo (personaggio della Veniexia-
na): 45nBernardo Cappuzzi: 48BEROSO: 189nBerta: 147n, 474, 504Bertoldo: 330n, 333n, 342n, 346n, 534BERTOLISIO Zaneto: 33nBetia: 127nBiagia ĺ BlasieBianco Furio: 180n, 533BIANCONE Girolamo: 18BIBBIENA (Bernardo Dovizi detto il –):
45n, 131n, 538BIDIN (– comito): 36Bidine: 115n, 303, 362, 396; Bernardina:
115n, 303, 362, 396Billanovich Eugenio: 542Billanovich Giuseppe: 542Billanovich Myriam: 542BIONDO Flavio: 24, 155n, 156n, 461, 473;
fè la bionda: 24, 156nBlasie: 10, 277, 282, 285, 362; Biagia:
10, 108n, 362BOCCACCIO Giovanni: 104n, 107n, 194n,
195n, 198n, 355, 458, 461, 462, 463, 482, 508, 510, 533; Zuan beccaz: 461, 463, 482, 508; bottaz: 343, 458, 462
Boerio Giuseppe: 15, 83, 109n, 112n, 114n, 116n, 117n, 120n, 121n, 122n, 129n, 130n, 131n, 138n, 139n, 147n, 148n, 149n, 159n, 161n, 164n, 166n, 167n, 174n, 175n, 176n, 177n, 178n,
181n, 191n, 195n, 204n, 207n, 210n, 212n, 215n, 236n, 238n, 243n, 533
Boggione Valter: 28, 29n, 538BOIARDO Matteo Maria: 104n, 137n, 138n,
195n, 211n, 533Bolcetta: 48nBOLDO ĺ UBALDO
Bolelli Tristano: 546Bonora Ettore: 50n, 533Borghello Giampaolo: 533Borsellino Nino: 57n, 91n, 97n, 100n,
107n, 111n, 120n, 122n, 130n, 131n, 133n, 141n, 153n, 170n, 179n, 188n, 190n, 201n, 202n, 203n, 204n, 223n, 228n, 240n, 532, 534, 535, 538, 546
BOTERO Giovanni: 24, 155n, 156n, 462; botter: 24, 156n, 344, 462; Zann But-tier: 156n
Bradamante: 21, 104n, 195n, 462, 483, 485; bro’ di manz: 21, 462, 483, 485
Branca Vittore: 533BRAZACCO Gio Ioseffo: 35BRICCIO Giovanni: 173n, 314n, 347nBrigliadoro: 138nBrocchetta: 48Brugnolo Furio: 538, 541Brunello: 138n, 139nBrunetta: 102n, 103n, 104n, 461, 462BRUNO Giordano: 97n, 107n, 120n, 122n,
130n, 133n, 179n, 188n, 190n, 201n, 202n, 203n, 204n, 228n, 534
BRUNO Vincenzo: 224nBruno: 104nBrustolao: 65, 71, 72, 73, 175n, 176n,
321, 449BUGATO Gasparo: 156nBuiatti Anna: 158nBurattino: 330nBURCHIELLO (Domenico di Giovanni): 548Busnatico Pantalon ĺ Pantalon
Indice dei nomi556
Caffarelli Enzo: 12nCairo Laura: 68, 68n, 534CALEPINO Ambrogio: 97nCallisto: 99nCALMO Andrea: 9, 10, 14, 23, 41n, 42,
42n, 45n, 48n, 49, 50, 56, 56n, 57, 57n, 58, 58n, 93n, 104n, 111n, 114n, 120n, 121n, 130n, 131n, 138n, 143n, 149n, 151n, 159n, 160n, 166n, 173n, 177n, 180n, 181n, 209n, 215n, 229n, 231n, 238n, 239n, 302, 306n, 314n, 320n, 321, 321n, 324n, 325n, 326n, 534, 538, 541, 550
CAMPANA Cesare: 24, 155n, 156n, 463; campana: 24, 156n, 344
Campanelli Alessandro: 330n, 332, 332n, 534
CAMPOLONGO Emilio: 24, 156n, 159n, 463, 483; camp longh: 24, 159n, 463, 483
Camporesi Piero: 104n, 118n, 330n, 333n, 341n, 342n, 346, 346n, 534
CAMUFFO Andrea: 33nCanova Mauro: 50n, 535CAPODIVACCA Girolamo: 24, 156n, 158n,
159n, 503, 505; Caodivacca: 159n; testa d’ vaca: 24, 158n, 503, 505
Cappello Teresa: 104n, 163n, 164n, 207n, 535
CAPRILI Silvio: 34n; Silvio Caprileo: 36; Silvio Kaprileo: 36n
Caprin Giulio: 54n, 535CARABELLO Gasparo: 17, 17nCARAVAGGIO (Michelangelo Merisi detto
il –): 113nCARAVIA Alessandro: 215n, 535CARBO Nastasio: 19, 20; Nastaas Carb:
20n, 131nCARDANO Girolamo: 159nCarletti Ercole: 543CARLO V: 25, 163n, 164n, 463; Carl quint:
25, 463
Casalegno Giovanni: 28, 29n, 538Casali Elide: 105nCasella Angela: 531Cassi Gellio: 13, 34n, 114n, 164n, 535Castore: 133n, 134nCatlina da Budri: 333nCATONE (Marco Porcio –): 192n, 193n,
476; Gat: 476 CATONE (Publio Valerio –): 192n, 193n,
476; Gat: 476CAVALCANTI Guido: 155n, 157n, 460, 464,
476; Giuda cavalcò avant: 157n, 460, 464, 476
Cecchi Emilio: 50n, 533CECCHI Giovan Maria: 131n, 153n, 535CECCHINI Pier Maria: 340, 341, 341nCerasuolo Pertusi Maria Rosaria: 545Cerere: 187nCervello: 333nCesare (personaggio di L. Dolce): 104nCESARE (Caio Giulio –): 24, 155n, 464,
����������JL��GH�Ou�&HVDU�����������469, 476
CESARII DA BUDRIO Giuseppe Maria: 157n, 193n
Cescutti Maria Cristina: 31CHAMBERS Ephraim: 224nChechin Suzzastelle: 12Cherchi Paolo: 540Chiabò Maria: 546CHIESA Girolamo: 332nChiesa Mario: 539Ciacco: 104nCiapponi Lucia A.: 535CICERONE (Marco Tullio –): 99n, 100n,
101n, 130n, 134n, 201n, 350, 514; Chiachiaron: 343n
DE’ CIMINELLI Serafino ĺ AQUILANO Se-rafino
Cimone: 194n, 499; Simon: 499Ciociola Claudio: 46n, 535
Indice dei nomi 557
Circe: 132nCLARIO pre Blasio: 36nClaudia: 27, 232n, 343, 465, 472, 495,
506Cleandro: 143nClimene: 199nClitennestra: 133nClivio Gianrenzo: 532, 542Clori: 188nCoco Francesco: 331n, 535Collina Beatrice: 540Collofonio: 41nDI COLLOREDO Ermes: 12, 18, 50n, 51,
51n, 108n, 109n, 114n, 535COLONNA Francesco: 100n, 133n, 187n,
190n, 201n, 203n, 228n, 342n, 352n, 535
COMASCO Niccolò: 159nComello: 40, 46, 59, 71, 79, 175n, 179n,
180n, 303, 312, 320, 322Contini Gianfranco: 325n, 535Corgnali Giovanni Battista: 140n, 170n,
535, 543Cornelio: 104nCORNIANI DEGLI ALGAROTTI Marco An-
tonio: 69nCoronedi Berti Carolina: 104n, 105n,
150n, 151n, 153n, 156n, 158n, 162n, 163n, 166n, 191n, 194n, 197n, 230n, 232n, 236n, 536
Cortelazzo Manlio: 42n, 50n, 51, 51n, 52n, 57n, 111n, 113n, 118n, 164n, 167n, 210n, 215n, 258n, 267n, 306n, 310n, 311n, 320n, 532, 533, 536, 538, 542, 551
Corti Maria: 45n, 46n, 239n, 324, 324n, 325n, 348n, 536
Corvisieri (casa d’aste): 69nCOSTA Margherita: 204n, 537Costantini Enos: 12, 130n, 537
COSTANTINO (Flavio Valerio Aurelio –): 104n, 482
Costrao: 175n, 176n, 321, 450DE COVARRUBIAS Y LEYVA Diego: 24, 155n,
158n, 467; Covarunia: 24, 158n, 467CROCE Giovanni: 42n, 51, 183n, 208n,
537CROCE Giulio Cesare: 104n, 332n, 333,
333n, 341n, 343n, 537, 540, 541DI CROLLALANZA Giovan Battista: 38n,
61n, 537Crono: 98n, 134n, 135nCupido: 188n, 194n, 353, 462, 475
Dafne: 199nDAL GORGO Giambattista: 187nD’Amico Silvio: 329, 330n, 537Damone: 189n, 190n, 355Dan: 273, 281, 287, 288, 370; Adamo:
117n, 370Danao: 222nDANIEL DI MAURO: 35nDaniele Antonio: 536, 543DANTE ALIGHIERI: 195n, 469; dent davant:
343, 469Davico Bonino Guido: 104n, 143n, 531,
537, 543De Blasi Nicola: 532, 542De Robertis Domenico: 546Debenedetti Santorre: 532DECIO Filippo: 158nDeione: 189nDel Col Andrea: 546DELLA CASA Giovanni: 24, 155n, 156n,
464, 469, 475, 487; monsignor dè fuoch alla casa: 24, 156n, 344, 464, 468, 475, 487
DELLA PORTA Giovanni Battista: 13, 100n, 111n, 112n, 113n, 141n, 170n, 201n, 240n, 532, 538
Indice dei nomi558
DELMINIO Giulio Camillo: 24, 155n, 156n, ����������JL��GH�Ou�&DPLO���������Q��463, 476; Iulo Camillo: 156n
DEL PUPPO Giovanni: 242nDESPRÈS�-RVTXLQ�����QDIANORA Betta: 34nDiarodone: 72, 79, 183n, 224n, 519Didone: 183nDimante: 199nDINO ROSSONI DAL MUGELLO: 155n, 158n,
470, 479; Din: 158n, 470, 479Dioniso: 199nDionisotti Carlo: 532, 537DIONORI Isabeta: 33nDiridon: 183n, 270, 303, 372, 400; Diri-
done: 183n, 372, 400 Discipao: 175n, 321, 450Doglio Federico: 546Doglio Maria Luisa: 547DOLCE Lodovico: 48n, 104n, 132n, 133n,
190n, 201n, 538DOMENICO DI GIOVANNI ĺ BURCHIELLO
DOMENICO eremita (santo): 176nDONATO (Elio –): 192n, 193n, 471DONATO Crimaio: 19nDONATO Giovan Battista: 9, 11, 12, 19,
19n, 20, 21, 31, 53, 54n, 109n, 111n, 120n, 129n, 131n, 159n, 180n, 195n, 230n, 324, 324n, 334, 334n, 543, 545, 549
D’Onghia Luca: 42n, 46n, 58n, 111n, 114n, 120n, 160n, 231n, 239n, 314n, 324n, 325n, 326n, 534, 538, 547
Doralice: 143nDoria Mario: 545Doride: 199nDorotea: 41nDOVIZI Bernardo ĺ BIBBIENA
Dulippo: 143nDurante Ginebri: 41n, 51
Durindana: 138n, 139n, 423; Durlindana: 21, 138n, 195n, 423, 459, 470, 471, 475; dura Diana: 21, 195n, 470, 471, 475
Eaco: 98nEcuba ĺ HecubaEdippo: 355; Edipo: 189nEdoardo Leonido: 48, 49Efigenia: 194n, 503; Tiffagenia: 193n,
194n, 503Egeo: 199nEgina: 98nEgitto: 222nElara: 125nElena: 133nElettrione: 133nElice: 98n, 99n Elios: 132n, 199nElpenore: 132n, 133nElwert Wilhelm Theodor: 50n, 538, 544ENNIO (Quinto –): 99n, 350Enone: 98nEolo: 189nEpidimo: 41nEra: 134n, 189nEracle: 133n, 188n, 199nErcole: 99n, 133nEros: 199nEtra: 199nvon Ettmayer Karl: 194nETTOREO Cristoforo: 114nEuropa: 98nEustrato: 41n Eve: 273, 281, 287, 288, 374; Eva: 117n,
374
FABER Ioannes: 158n, 473, 507; Fabro: ���Q��-HDQ�)DEUH�����Q��-HDQ�/HIHYUH��158n; Zan Favr: 158n, 473, 507,
FABRICI Girolamo ĺ ACQUAPENDENTE
Indice dei nomi 559
FACHINEI Andrea: 155n, 158n, 459, 472; Andrea fachin: 158n, 459, 472
Faetusa: 199nFaggin Giorgio: 11n, 31, 108n, 113n,
115n, 116n, 117n, 118n, 140n, 173n, 194n, 204n, 207n, 539
Falerina: 138n, 139nFALLOPPIA Gabriele: 159nFanfani Pietro: 139n, 164n, 173n, 201n,
208n, 211n, 224n, 539Fant Carlo: 33nFantini Giovanni: 12Faust: 473; Fausto: 145n, 473 Federico Ilenia: 141n, 539Fedra: 199nFEDRO (Gaio Giulio –): 201nFeraguto: 137nFERDINANDO III D’ASBURGO: 50, 551Ferigo Giorgio: 32Ferluga Petronio Fedora: 535Ferrari Claudio Ermanno: 236n, 539Ferrero Ernesto: 104n, 121n, 146n, 153n,
163n, 192n, 210n, 539Ferrone Siro: 50n, 51n, 54n, 55n, 120n,
139n, 148n, 159n, 163n, 173n, 204n, 208n, 236n, 347n, 531, 532, 537, 539, 541, 544
Ferroni Giulio: 50n, 539Fetonte: 199nFiammetta: 195n, 473; favetta: 195n, 473;
femenetta: 339, 473Fibbia Pungentini: 153nFICINO Marsilio: 155n, 157n, 465, 473,
485; Marsili fè il cign: 157n, 465, 473, 485
Fidenzio: 342n, 355, 547Filippa: 65, 163n, 474, 495 Filippe: 114nFilippino: 39, 40, 47, 66Filomela: 107nFiordespina: 137n
Fioretto: 48nFirpo Luigi: 156nFlamminio: 132nFlorida: 41, 42, 46, 47, 59, 71, 76, 173n,
206n, 212n, 230n, 233n, 318, 376; Flodrade: 70, 75, 376; Flore: 376; Florade: 376; Floride: 376; Fluride: 249, 376; Fluriide: 249, 376
Florindo Brancadori: 26, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 60, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 79, 91n, 99n, 107n, 132n, 189n, 191n, 192n, 196n, 200n, 202n, 215n, 216n, 231n, 303, 335, 343, 351, 353, 355, 376, 474; Floriid: 335, 339, 343, 474; Florindu: 376
Florisello di Nichea: 155n, 157n, 475, 486, 498; fu fuor d’ sella Michea: 157n, 475, 486, 498
FLURÎT: 19Folena Gianfranco: 22, 45n, 50n, 56, 56n,
57, 59, 59n, 539, 543, 548FOLENGO Teofilo: 148n, 194n, 539; Merlin
Cocai: 542Forastiere: 40, 55, 91n, 92nForcellini Egidio: 97n, 100n, 203n, 207n,
540Foresti Fabio: 331n, 540Francescato Giuseppe: 22, 22n, 250n,
258n, 260n, 268n, 270n, 278, 278n, 281n, 282n, 283n, 286n, 293n, 540
Francesco (personaggio di Ruzante): 45nFRANGIPANE Giovan Battista: 51Frasnedi Fabrizio: 9n, 544Frau Giovanni: 22, 22n, 258n, 260n,
293n, 540, 543FRIANORO Rafaele: 534Frisano Roberto: 31Fubini Riccardo: 156nFusco Fabiana: 543
GABRIELLI Pietro: 69n
Indice dei nomi560
Galasso Vinicio: 31, 33n, 34n, 48n, 540GALENO: 102n, 103n, 157n, 343n, 476;
Galen: 104n, 157n, 476; Gallina: 104n, 343n
Gamillscheg Ernst: 242n, 540Ganimede: 239nGarbin: 48nGarbuglio: 42nGARDELLINO Carlo: 35nGARZALDIS Odorico: 36GARZONI Tomaso: 24, 43n, 98n, 104n,
120n, 156n, 157n, 158n, 159n, 189n, 193n, 341n, 540
GATTINON Alessandro: 37nGATTINON Andrea sr. (padre di Marc’An-
tonio sr.): 33, 33n, 36GATTINON Andrea jr. (figlio di Marc’An-
tonio sr.): 33, 34n, 37, 37nGATTINON Anna: 34, 34nGATTINON Apollonia: 37nGATTINON Bernardino: 37nGATTINON Desiderio: 37nGATTINON Elena sr.: 37nGATTINON Elena jr.: 37nGATTINON Elisabetta: 33, 33n; Isabetta:
34n; Lisabetta: 34nGATTINON�*LDFLQWR������-DFLQWR����QGATTINON Marc’Antonio jr. (figlio di An-
drea jr.): 37, 37nGATTINON Michela: 34; Michiela: 34nGATTINON Tiberia: 37nGerasto: 100n, 170nGerofilo: 41nGiacchetto: 48nGiacomini Amedeo: 242nGIAMBLICO: 190nGIANCARLI Gigio Artemio: 41n, 42n, 45n,
48n, 49, 50, 57n, 58, 111n, 130n, 159n, 184n, 210n, 231n, 541, 550
Gianda: 42nGianfrè: 48, 49
GIASONE DEL MAINO: 24, 155n, 158n, 478; Iason: 24, 158n, 478
GIOVANNI D’ANDREA: 158nGiove: 99n, 133n, 134n, 135n, 515GIOVENALE (Decimo Giunio –): 228nGIROLDI Giambattista: 187nGIUDA (biblico): 213n, 466, 508; Zuda:
466, 508Giunone: 108n, 134n, 135nGIUSTINIANO (Flavio Pietro Sabbazio –):
158n, 162nGIUSTINO (Marco Giuniano –): 25, 163n,
164n, 480; Iustin: 25, 480GLAREANUS (Heinrich Loriti): 162n Gliozzi Giuliano: 159nGOLDONI Carlo: 69n, 547, 548GORDIN Angelica: 33nGORDINO�*LDFRPR����Q����Q�>"@GORDINO Gio Batta: 35nGORI Antonio: 51nGottofredo: 147nGradassa: 211n, 312Gradasso: 137n, 211nGRANDIS Brandisio: 34nGraziano: 7, 10, 16, 24, 25, 26, 39, 40, 41,
43, 43n, 44, 47, 59, 60, 78, 82, 104n, 148n, 149n, 153n, 156n, 157n, 163n, 166n, 173n, 189n, 193n, 208n, 236n, 237n, 303, 315, 318, 329n, 330, 330n, 331, 331n, 332, 332n, 333, 333n, 334, 340, 341, 341n, 342, 343n, 344, 345, 346, 347, 347n, 348, 349, 350, 351, 354, 355, 355n, 549, 551; Gratian: 26, 27, 153n, 331, 343, 354; Gratiano: 7, 60, 332, 341; Gratianus: 330n; Grazia-no delle Codeghe: 330; Gratiano Par-tesana da Francolin: 25, 157n; Gratia-no Francolinese: 333n; Graziano da Francolino: 332n; Gratiano Scatolone: 104n; Grazian Scatlon: 332n
GREGORIO D’AREZZO: 224n
Indice dei nomi 561
Greule Albrecht: 543Griggio Claudio: 17n, 551Grillo ĺ Mastro GrilloGRIMANI Antonio: 129n GROTTA Lucietta: 34nGROTTO Nadal: 36GROTTO Nicolò: 35nGUARINI Giovan Battista: 50GUARINO VERONESE: 192n, 193n, 477;
Guerin: 193n, 477Guerrini Olindo: 332n, 541Guerrini Paolo: 157nGUICCIARDINI Francesco: 24, 155n, 156n,
472, 507; fu in zardin: 24, 156n, 344, 472, 507
Haubrichs Wolfgang: 543Hauthal Ferdinand: 203n, 352Hecuba: 199n; Ecuba: 199nHeinemann Sabine: 108n, 109n, 242n,
250n, 271n, 283n, 541Helice: 99nHerrmann Hans-Walter: 543+ROWXV�*�QWHU����������
Iacum Tentimbon: 10, 109n, 273, 285, 379, 408; Giacomo Tentimbon: 108n, 379, 445; Giacomo Tientimbuono: 10
Ificle: 133nIpermnestra: 222nIppocrasso (personaggio di S. Oddi):
104n, 143nIPPOCRATE: 103n, 104n, 477, 493; Ippo-
crasso: 104n, 343n, 477, 493; porc gras: 104n, 477, 493; porc grass: 104n; Porc grasso: 343n; Porcograsso: 104n; porco grasso: 104n, 343n
ISEPPI Anzolo: 35nIssione: 189nItona: 98nIuppiter: 70, 77, 134n, 135n, 354
.UDPHU�-RKDQQHV�����
Ladislao Leonido: 48Lampetusa: 199nLANDO (famiglia): 34n, 38nLANDO Antonio: 38nLANDO Francesco: 38, 38n, 52, 61, 62,
62n, 68LANDO Girolamo: 38nLanzon ĺ BalanzoneLaone: 199nLattantio Mescolotti: 105n Laura: 102n, 354, 481Lazzerini Lucia: 31, 50n, 52n, 58n, 104n,
105n, 111n, 121n, 156n, 210n, 252n, 329n, 534, 541
Leda: 133n, 134nLeto: 125nLicasto: 98nLICINIO Giulio: 51Lion: 104n, 482, 497; Leone: 102n, 103n,
482, 497 Lionora: 41n, 215nLissandrina: 333nLOCATELLI Basilio: 330LODOVICO DA BOLOGNA: 332nLOMBARDI Bernardino: 148n, 159n, 163n,
173n, 236n, 347n, 541/RUFN�-HDQ�eWLHQQH�����Q�����Lorenzini Claudio: 31Lorenzoni Giovanni: 30, 243nLORITI Heinrich ĺ GLAREANUS
Lucchetta Maurizio: 51nLUCILIO (Lucilio il giovane): 101nLuis: 27, 205n, 467, 483, 499; Luigi:
205n, 467, 483, 499LUNARDI Gregorio: 34n
Macor: 114nMACROBIO (Ambrosio Teodosio –): 24,
155n, 156n, 464, 484; magna carobb: 24, 156n, 464, 484
Indice dei nomi562
Madalena: 211n, 315, 431; Maddalena: 211n, 431
Magazzini Vitale: 116nMAGGI Biagio: 179n, 215n, 541MAGGI Carlo Maria: 16Magnifico ĺ PantaloneMALACARNE (cognome): 12, 109nMalacarne: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 16n, 19, 22, 23, 26, 29, 39, 40, 41, 42, 42n, 46, 47, 60, 71, 75, 77, 108n, 109n, 112n, 113n, 127n, 130n, 131n, 138n, 146n, 148n, 149n, 152n, 166n, 178n, 180n, 205n, 212n, 213n, 234n, 238n, 241n, 242n, 259, 302, 303, 304, 305, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 348, 386, 517; Malechiarn: 10, 109n, 273, 278, 384
Malato Enrico: 539, 544Manfurio: 97n, 120n, 133n, 190n, 202n,
228nMangini Nicola: 7, 7n, 26, 38, 38n, 50n,
55, 55n, 92n, 542Marcato Carla: 12n, 31, 32, 50n, 306n,
320n, 532, 542MARCO (santo): 177nMarfisa: 21, 195n, 459, 475; al m’ frisa
>"@���������Q�����MARIA (serva di M. A. Gattinon sr.): 34nMARINO Giovan Battista: 548Mariti Luciano: 54n, 173n, 195n, 346,
346n, 347, 347n, 542Marotti Ferruccio: 157n, 340n, 341n, 542Marsili: 70, 78, 157n, 465, 473, 485;
Marsilio: 137nMarte: 196n, 198n, 204nMarti Mario: 157n, 533Martin (personaggio di G. A. Giancarli):
45nMartin: 204n, 431; Martino: 204n, 431 MARTINO (santo): 204nMaschi Roberta: 258n, 268n, 289n, 293n,
296n, 297n, 301n, 542Mastro Grillo: 43nMATEI�>"@�$QWRQLR����Mazzamuto Pietro: 531Medea: 165nMedeot Feliciano: 32DE’ MEDICI Lorenzo: 14MEDICI Sisto, 57nMEDICO Giacomo: 51Megera: 98nMelindo: 41nMelissa: 135nMenato Marco: 32MENATO ĺ ALVAROTTI Marco AurelioMenchin: 45nMENEGA��VHUYD�GL�$QGUHD�*DWWLQRQ"���
33, 33nMERCURIALE Girolamo: 24, 155n, 156n,
159n, 485; Mercurial: 24, 159n, 485Mercurio: 198nMERISI Michelangelo ĺ CARAVAGGIO
MERLIN COCAI ĺ FOLENGO TeofiloMerope: 189nMessedaglia Luigi: 130n, 159n, 542Messner Dieter: 549Metzeltin Michael: 541Meu di Badoccli: 10, 273, 282, 388; Bar-
tolomeo di Badoccli: 108n; Meo di Battacchio: 10
Micasta: 39, 40, 41, 42, 46, 91n, 103n, 137n, 149n, 150n, 151n, 205n, 208n, 232n, 233n, 235n, 237n, 317, 318, 343, 345, 464, 486; Micastra: 103n, 149n, 343, 345, 486; manda il castrà: 343, 345, 464
CA’ MICHIEL (famiglia): 35Migliorini Bruno: 93n, 130n, 157n, 158n,
163n, 194n, 195n, 204n, 211n, 542Milani Marisa: 50n, 344n, 542MILLANTA Gioseffo: 332nMinos: 98n; Minosse: 98n, 199nMinotauro: 199n
Indice dei nomi 563
MIRANDOLA Antonio: 333nMIRANDOLA Fabrizio (Fabrizio Alodna-
rim): 333nMissiersì: 46, 48, 324MOCENIGO (famiglia): 34nMOCENIGO Pietro: 243nMOLIN Antonio: 5500ROLQDUR�-OHQLD����Q�����MONI�>"@�%LGLQ����QMontagnani Cristina: 533Morassi Luciana: 28n, 34n, 543Morlicchio Elda: 112n, 543MORLUPINO Nicolò: 18, 140n, 141n, 168n,
545Muccillo Maria: 159nMuscetta Carlo: 531, 534Mutini Claudio: 156n
Nanna: 239n, 531NANNI DA VITERBO: 189nNarciso: 239nNascimben Laura: 32, 54n, 109n, 111n,
129n, 131n, 159n, 180n, 230n, 334n, 543
DE’ NATALI PIETRO: 176nNEGRI Francesco: 333nNEGRO Antonio: 159nNEGRO Marin: 7, 9, 16, 31, 41n, 42n, 45n,
49, 50, 58, 93n, 104n, 120n, 258n, 267n, 281, 281n, 321, 321n, 543
Nepita: 240nNereo: 188n, 199nNestore: 188n, 512NEVIO (Gneo –): 101nNigro Salvatore Silvano: 531Nunziale Sennen: 543
Occo: 48, 189n, 331, 331n; Occh: 331ODDI Sforza: 104n, 143n, 543ORAZIO (Quinto – Flacco): 201n, 343, 352Origille: 138n
Orioles Vincenzo: 535, 538, 542, 543, 549
Orlando: 137n, 138n, 139n, 211n, 215nORSI Tiberio: 159nOrtica: 104n, 321OTTAVIA (moglie di Andrea Gattinon jr.):
37nOttaviano: 203nOttavin: 141nOUDIN Antoine: 112nOVIDIO (Publio – Nasone): 27, 107n,
199n, 232n
Pacca Vinicio: 546Paccagnella Ivano: 45n, 46n, 50n, 57n,
109n, 325n, 326n, 543, 544Padoan Giorgio: 50, 50n, 56n, 57n, 58,
58n, 59n, 533, 538, 544, 547PAGANELLI Antonio: 35nPALLADIO DEGLI OLIVI Enrico: 157nPALLADIO DEGLI OLIVI Gian Francesco:
157nPalmerino di Oliva: 155n, 157n, 490, 496,
505; Palmirin d’uliva: 157n; Palma rend l’uliva: 157n, 490, 496, 505
Pancrazio Brancadori: 38, 39, 40, 47, 59, 60, 67, 97n, 98n; Pancratio: 62, 67, 69, 73
Pandione: 107nPandolfi Vito: 44n, 45n, 54n, 105n, 153n,
157n, 193n, 208n, 330, 330n, 332n, 340n, 544
Panfila: 41nPantaloncin de Malacarne Bisognosi:
317; Pantaloncino di Malacarne Bi-sognosi: 241n
Pantalone: 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 26, 27, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 59, 79, 91n, 103n, 111n, 121n, 137n, 138n, 139n, 143n, 153n, 155n, 156n, 160n, 204n, 207n, 213n, 230n, 302,
Indice dei nomi564
303, 304, 306, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 329, 329n, 330, 330n, 333n, 340, 343, 346, 347, 347n, 348, 349, 354, 355n, 392, 490, 492, 500, 548; Pantalon: 8, 10, 15, 27, 40, 60, 69, 73, 208n, 490; Pantalone de’ Bi-sognosi: 38, 41, 208n, 209n, 462, 496; Busnatico Pantalon: 41n; Magnifico: 45n, 143n, 329; Magnifico Busnatico detto Pantalone: 139n; Padelon: 208n; Panieron: 208n; Panziron: 208n, 343, 490, 500; Panziron de’ bus rognoos: 462, 496; Petulon: 208n, 340; Pian-talimon: 208n, 340, 343, 492; Pian-talimon di Bus rognos: 208n; Pian-taliron: 208n; Pianzamelon: 208n; Piantam’lon: 26, 208n, 343, 492; Piaton: 208n; Piattolon: 343, 346, 492; Pultrunzon: 208n, 340
Pantasilea (personaggio di M. Negro): 93n
Pantasilea Bisognosi: 38, 39, 40, 41, 46, 47, 69, 71, 73, 92n, 206n, 212n, 230n, 233n, 305, 316, 318, 348, 355
Panurgo: 100n, 111nPanuzio: 49Paolino Laura: 546Papa Menestra: 543Parlangeli Oronzo: 536Pascute: 114nPasifae: 199nPASQUALI Giovanni: 34Pastore Stocchi Manlio: 7nPATERNO Bernardino: 159nPatriarchi Gasparo: 122n, 166n, 207n,
230n, 231n, 544Pedante (personaggio di L. Dolce): 130nPellegrini Giovan Battista: 14n, 111n,
120n, 121n, 149n, 210n, 231n, 238n, 544, 545, 547
Pellegrini Rienzo: 9n, 17n, 30, 30n, 31, 50n, 51n, 52, 52n, 97n, 109n, 120n, 140n, 141n, 151n, 159n, 168n, 179n, 195n, 230n, 239n, 242n, 243n, 269n, 324n, 336n, 535, 545, 546
PELLIZZARI Gio Antonio: 35nPeneo: 199nPENZO Zacaria: 34nPERCOTO Caterina: 218nPeriandro Fedeli: 38, 39, 40, 47, 59, 69,
73, 99nPerottino: 198nPERRUCCI Andrea: 547DI PERS Ciro: 50Perseide: 133nPerusini Gaetano: 17, 535PETRARCA Francesco: 104n, 107n, 195n,
220n, 345, 354, 459, 462, 492, 494, 536, 541, 546; Pier caga: 343, 345, 354, 462, 492; pietra è l’arca: 343, 354, 459, 492; pret è in l’arca: 343, 354, 459, 494
Petrocchi Giorgio: 531Petronio: 333nPhillips Peter: 162nPIASENTIN Mutio: 180nPICCOLOMINI Alessandro: 91n, 131n, 546PICCUZZO Piero: 35nPier: 192n, 480, 491, 492; Piero: 192n,
195n, 480, 491, 492 PIETRO (santo): 138n, 162n, 181n, 425,
437, 492; san Piero: 138n; san Piezo: 138n, 315, 425, 437
PIGNOSINO Daniel: 19; Neel Pignulaat: 19PINI Teseo: 534Pippa: 239n, 531Piritoo: 189nPirona Giulio Andrea: 5433LURQD�-DFRSR����Q�������������Q�����Q��
109n, 111n, 113n, 114n, 115n, 116n, 117n, 118n, 121n, 126n, 129n, 130n,
Indice dei nomi 565
131n, 139n, 140n, 141n, 142n, 166n, 172n, 175n, 194n, 204n, 207n, 210n, 218n, 229n, 235n, 236n, 238n, 242n, 543
Pisandro: 46, 48, 324Pisani Vittore: 536Pisul Stentadizza: 11, 19, 109n, 180nPitia: 190n, 355; Pizia: 189n, 190nPLATONE: 24, 155n, 156n, 157n, 492; Pia-
ton: 104n, 343n; Platon: 24, 492 PLAUTO (Tito Maccio –): 98n, 100nPLUTARCO: 24, 155n, 156n, 459, 492; pian-
tò l’arch: 24, 70, 78, 156n, 459, 492Plutone: 98nPolidamante Prassitelli: 26, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 46, 47, 59, 66, 67, 71, 79, 103n, 171n, 212n, 233n, 303, 318, 355, 360, 398, 493, 494, 498; Polidamant: 493, 498; Pulidamant: 494; Puuda-mantu: 271, 398
Polidoro (figlio di Ecuba): 199nPolidoro Polliciano: 38, 39, 40, 47, 59,
66, 67, 97nPolinesta: 143nPolinestore: 199nPOLLINI Ciro: 161nPolluce: 133n, 134nPomponio: 26, 38, 39, 40, 43, 44, 45,
46, 47, 59, 67, 329n, 348, 350, 353, 354, 355
PORDENONE (Giovanni Antonio de’ Sac-chis detto il –): 51, 52
PORTA Carlo: 16PORZIO Cristoforo: 158n, 465, 493; Cri-
stoforo Porcio: 155n, 158n; Christofol porch: 158n, 465, 493
Povoledo Elena: 50n, 546Pozzi Giovanni: 535Prandoni Marco: 32Prassildo Prassitelli: 149n, 150n; Pras-
sild Prassitel: 493
Prati Angelico: 83, 104n, 111n, 112n, 118n, 121n, 122n, 140n, 158n, 163n, 164n, 166n, 179n, 194n, 201n, 207n, 210n, 211n, 236n, 306n, 546
Preteiani: 120n, 438; Prete Gianni: 120n, 438
Priamo: 199nProgne: 107nPrologo: 40, 55, 60, 91n, 92nPRUDENTIA: 34nPrudenzia: 104nPULCI Luigi: 103n, 104n, 138n, 546Puppa Paolo: 50n, 546, 550
QUADRIO Francesco Saverio: 38, 38n, 546QUARTARO Battista: 33nQUARTARO Franzesco: 34nQUARTARO Gierolamo: 34nQuilici Piccarda: 68, 68n, 534QUINTILIANO (Marco Fabio –): 24, 155n,
156n, 495; Quintilian: 24, 156n, 495
Radamanto: 98nRadao: 175n, 176n, 321, 452RAO Cesare: 24, 157nRavegnani Giuseppe: 23, 23nRAZZI Girolamo: 355Rea: 134n, 135nREGHETTINI Angelo: 9, 61, 62Renzi Lorenzo: 32, 549RICCHIERI Ludovico ĺ RODIGINO CelioRidder Klaus: 543RIGHETTINI (tipografi): 9, 68RIGHETTINI Aurelio: 9, 68nRIGHETTINI Girolamo: 9, 67Rinaldo: 104nRingger Kurt: 544RODIGINO Celio: 24, 155n, 464, 496; Celi
Rodegin: 24, 156n, 464, 496; Ludovi-co Ricchieri: 156n, 464, 496
RODRÍGUEZ DE MONTALVO Garci: 24, 157n
Indice dei nomi566
Rogello di Grecia: 157nRohlfs Gerhard: 111n, 546Romei Giovanna: 157n, 340n, 341n, 542Romolo: 513Ronchi Gabriella: 531Rosato: 42nRosmonda Fedeli: 38, 39, 40, 46, 47, 69,
73, 91n, 355ROSSI Bartolomeo: 332Rossi Vittorio: 534ROSSONI (ROSSANIO) dal Mugello Dino:
158n, 470Rovenio: 41n, 51Rozzo Ugo: 17n, 551Ruggiera: 211n, 312Ruggiero del Falcone (personaggio di M.
A. Gattinon): 48, 49Ruggiero di Risa: 102n, 103n, 104n,
139n, 211n, 482, 497; Ruzier: 104n, 482, 497
RUMTOT ĺ CARABELLO GasparoRUZANTE (Angelo Beolco detto – o Ruz-
zante): 9, 14, 16, 19, 42, 42n, 45n, 50n, 56, 58n, 111n, 112n, 114n, 118n, 121n, 127n, 130n, 138n, 140n, 143n, 149n, 158n, 159n, 164n, 180n, 181n, 194n, 198n, 204n, 209n, 223n, 231n, 232n, 239n, 240n, 305, 305n, 324n, 325n, 326n, 344n, 348n, 542, 543, 544, 547, 550
Sabanello: 41n, 321SABBADINI Tommaso: 108n, 141n, 539Saccani Rossana: 537DE’ SACCHIS Giovanni Antonio ĺ POR-
DENONE
Sacripanta: 211n, 312Sacripante: 211n, 490, 497; sacra panza:
211n, 490, 497Sallach Elke: 120n, 547Saltuzza: 42n
Salvioni Carlo: 274n, 533SANDEO Felino: 158n, 473; Felin: 155n,
158n, 473Sandrin: 45nSanesi Ireneo: 54n, 104n, 133n, 190n,
201n, 329, 329n, 538, 547Sanguino: 130nSantagata Marco: 546Santoro Ciro: 536SANUDO Marin: 139nSapegno Natalino: 50n, 533SARZINA Giacomo: 62Sattin Antonella: 306n, 308n, 309n, 547Saturno: 70, 74, 75, 134n, 135nSBAIZ Bastian: 34nSBAIZ Pietro: 33nSCALA Flaminio: 330SCALIGGERI Camillo ĺ BANCHIERI AdrianoScalon Cesare: 17n, 551Scarpella: 45n, 180nScatolon da Francolin: 334Schittolon da Frittolin: 334Schmidt Paul Gerhard: 101n, 132n, 134n,
146n, 148n, 550Schmitt Christian: 541Schorr Andreas: 543SCROFFA Camillo: 100n, 107n, 132n,
187n, 190n, 198n, 201n, 202n, 203n, 228n, 342n, 352n, 353n, 355, 547
SCUSSIO (GUSEO) Alvise: 21, 334; predi Luiis: 195n, 334, 334n
SECCO�>"@�����QSECONDO Giuseppe Maria: 224nSegre Cesare: 58n, 532, 547SENECA (Lucio Anneo –): 24, 101n, 155n,
156n, 499Senzabezzi: 46, 48, 49, 324SERMINI Gentile: 28Serpentino dal Drago: 48, 49SERVI Gaspare: 69nSERVIO (– Mario Onorato): 100n
Indice dei nomi 567
SFORZA Ascanio: 162nSgubin Eraldo: 545Silvio: 197n, 343, 499Simon ĺ CimoneSimon (personaggio di A. Calmo): 45n Simona: 333nSimone (personaggio di Terenzio): 190nSINI Girolamo: 18Sisiffo: 189nSOCRATE: 101nSosia: 190nSPADA Bernardino: 333nSpadan: 42n, 184nSPELLADI Giuseppe: 51nSpezzani Pietro: 181n, 314, 314n, 315,
316, 316n, 332, 332n, 547, 548Spingarda: 130nSQUARCINA Francesco: 35nStäuble Antonio: 44n, 107n, 189n, 342n,
350n, 352n, 548STEFANELLO Mariano: 159nSTELLA Eusebio: 18, 242n, 545, 548Stella: 130nStempera: 104n, 143nVAN DER STRAET�-DQ����QSTRASSOLDO Giuseppe: 18, 30, 30n, 243n,
545Stussi Alfredo: 57n, 259n, 260n, 306n,
307n, 309n, 310n, 321n, 548Sulpizia: 48, 49SVETONIO (Tranquillo Caio –): 24, 155n,
156n, 459, 502; sug Antonio: 24, 156n, 459, 502
Tabarin: 42n, 45nTACITO (Publio Cornelio –): 24, 155n,
467, 501, 502; Corneli stè tacit: 24, 344, 467, 501, 502
DA CA’ TAJAPIERA Niccolò: 176nTamos Antonella: 34n Tantalo: 125nTARCAGNOTA Giovanni: 24, 155n, 156n,
463, 503; traccagnot: 24, 70, 75, 156n, 344, 463, 503
TASSO Torquato: 333nTelmon Tullio: 32Tentimbon ĺ Iacum TentimbonTERENZIO (Publio – Afro): 190n, 193nTereo: 107nTeseo ĺ TheseoTesi Riccardo: 9n, 544Tesifone: 98nThanatos: 189n Theseo: 199n; Teseo: 199nTIBERIA (moglie di M. A. Gattinon sr.):
33, 33n, 34nTindaro: 133nTiraboschi Antonio: 174n, 548Tissoni Benvenuti Antonia: 533TITO LIVIO: 24, 155n, 156n, 503, 504; tettò
l’uliv: 24, 156n, 503, 504Tizio: 125nTofano: 333nTomao: 143nTomat: 50Tommaseo Niccolò: 201nTOMMASO D’AQUINO: 198nTonin: 45n7RVFDQ�-HDQ�����Q�����Q�����Q�����Q�����Toso Fiorenzo: 50n, 330n, 542, 549Trauzzi Alberto: 549TREBELLIO (Marco – Massimo): 130nTrifone Pietro: 203n, 352n, 547Trincavella Vittore: 159nTristano: 48Trovato Roberto: 330n, 549Truffa: 42nTruvlein: 332n, 333n
DEGLI UBALDI Baldo: 158n, 460; Bald: 460; Baldo il vecchio: 155n, 460
UBALDO (santo): 153n, 308, 425, 437; san Boldo: 308, 315, 425, 437
Ulisse: 132n, 133n, 188n, 199n, 514
Indice dei nomi568
Ungarelli Gaspare: 166n, 211n, 213n, 230n, 232n, 549
Urano: 98n
Vale Giuseppe: 54n, 549VALERIO MASSIMO: 24, 155n, 156n, 502,
505; Valeri: 24, 156n, 502, 505VALESIO Francesco: 61Valisarda: 138n, 139n, 416; Balissarda:
138n, 416Valmaggi Luigi: 99nVanelli Laura: 32, 269n, 271n, 278n,
283n, 289n, 532, 533, 538, 549Varasi Elena: 531Vasoli Cesare: 157nVaticeolo Pedantini: 12VATINIO (Publio –): 201n, 514VENDRAMIN (famiglia): 34nVenere: 61, 108n, 197n, 198n, 204n, 462,
505; Venier: 462, 505; Veniero: 197n, 462, 505
Ventura Viviana: 158nVERALDO Paolo: 333, 357nVERINI Giovanni Battista: 333nVerlato Zeno Lorenzo: 541VERUCCI Virgilio: 59n, 333Vescovo Piermario: 32, 45n, 50, 50n, 57n,
58n, 111n, 130n, 138n, 143n, 215n, 534, 544, 550
VESPA Francesco: 34n, 35nVETTORUZZO Simone: 10, 19, 19n, 53,
54n; Simoon: 19nVicario Federico: 32Vidossi Giuseppe: 42n, 550Violante: 29, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 59,
235n, 243n, 304, 317, 318, 348, 411; Violanta: 29, 411; Viole: 411
Virgili Dino: 19, 19nVIRGILIO (Publio – Marone): 98n, 132n,
133n, 188n, 189n, 193n, 196n, 350
Vitali Daniele: 334n, 550Volcano: 198n; Vulcano: 204nVolpino: 27, 39, 41, 44, 47, 48, 59, 97n,
200n, 201n, 348, 353, 354, 355n
Walther Hans: 100n, 101n, 132n, 134n, 146n, 148n, 164n, 228n, 232n, 550
Zambelli Francesco: 141n, 539Zambon: 40, 45, 60, 65, 71, 72, 74, 174n,
303, 324, 348, 454, 457; Zambù: 326, 327, 454, 457
Zamboni Alberto: 306n, 307n, 309n, 311n, 312n, 313n, 314n, 320n, 321n, 322n, 536, 551
Zambrini Francesco: 224nZanello Gabriele: 8, 9, 10, 11, 11n, 12,
14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 32, 33n, 43n, 50n, 51n, 109n, 329n, 333n, 551
Zannella: 148nZanni: 45, 45n, 143n, 315, 329, 330,
330n, 346; Zan: 45; Zane: 45n; Zanne: 45n, 120n; Zani: 45; Zuan: 45; Zuane: 45; Zuani: 45;
ZARATHUSTRA: 189n; Zoroastro: 189nZeus: 98n, 125n, 133n, 134n, 135n, 189n,
199nZolli Paolo: 533, 536ZOMPINI Gaetano: 8ZOROASTRO ĺ ZARATHUSTRA
Zorutti Pietro: 242nZorzi Ludovico: 50n, 112n, 114n, 121n,
130n, 138n, 143n, 159n, 164n, 181n, 194n, 198n, 204n, 209n, 231n, 242n, 348n, 547, 551
ZUAN DEL PICO: 35nZULIANA Isabetta: 36Zurloto d’i Ugnoli: 41n, 321
Società Filologica FriulanaBiblioteca di studi linguistici e filologici
diretta daFederico Vicario
1. Giorgio De Leidi, I suffissi nel friulano, 1984. 2. Rienzo Pellegrini (a cura di), Un “Canzoniere” friulano del Primo Cinquecento, 1985. 3. Federico Vicario (a cura di), Carte Friulane del Quattrocento dall’Archivio di San
Cristoforo di Udine, 2001. 4. Rosanna Benacchio, I dialetti sloveni del Friuli tra periferia e contatto, 2002. 5. Elwys De Stefani, Cognomi della Carnia, 2003. 6. Daniela Piccini, Lessico latino medievale in Friuli, 2006. 7. Federico Vicario (a cura di), Ladine loqui. IV Colloquium retoromanistich, 2007. 8. Graziadio Isaia Ascoli, Scritti scelti di linguistica italiana e friulana, a cura di Carla
Marcato e Federico Vicario, 2007. 9. Carla Marcato e Maurizio Puntin, Etnici e blasoni popolari nel Friuli storico, 2008.10. Girolamo Asquini, Lingua Friulana o Gallo-Carnica, a cura di Maria Cristina Cescutti,
2008.11. Gabriele Paciani, I versi autografi, a cura di Anna Bogaro, 2009.12. Carla Marcato e Federico Vicario (a cura di), Il pensiero di Graziadio Isaia Ascoli
a cent’anni dalla scomparsa, 2010.13. Carla Marcato, Profilo di antroponimia friulana, 2010.14. Sabine Heinemann e Luca Melchior, Bibliografia ragionata di linguistica friulana,
2011.15. Maria Teresa Vigolo e Paola Barbierato, Glossario del cadorino antico, 2012.16. Giovanni Frau, Linguistica foroiuliensis et alia, a cura di Federico Vicario, 2013.17. Marc’Antonio Gattinon, I travagli d’amore, a cura di Gabriele Zanello, 2015.