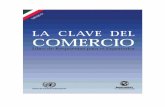Lo stemma, il rango e la memoria del «cavaliere don Filippo Juvara, architetto», in La forma del...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
Transcript of Lo stemma, il rango e la memoria del «cavaliere don Filippo Juvara, architetto», in La forma del...
non solo volle ricordare che il padre Pietro era figlio diun «soldato spagnolo della Biscaglia», ma ci tenne adaggiungere che «ciò si nota [va] per far risaltare essere[...] don Filippo di sangue spagnolo». Un secondo ele-mento è che il cognome Juvarra poteva esser ritenutofacilmente una derivazione di Guevara, con la G dive-nuta J: si ricordi, inoltre, che Juvarra era pronunciato«Giuvara», il che rendeva ancora più forte la somiglian-za con Guevara. In ultimo, va considerato che nellepratiche che regolavano l’assunzione di uno stemma,fra le più comuni era quella di sceglierne uno d’unafamiglia nobile, che avesse lo stesso cognome: in talmodo si dava l’impressione di esser parte dell’agnazio-ne della stessa. Se si fosse avuto successo sarebbe statala stessa famiglia più importante a favorire questo pro-cesso: l’esempio del rapporto che si era instaurato fra iDella Rovere di Savona – di umili origini, ma giunti alpapato con Sisto IV e Giulio II – e quelli di Torino –più antichi e nobili, ma decisamente meno rilevantisulla scena italiana – era un caso da manuale, ben pre-sente ad ogni trattatista di temi nobiliari. Il giovane Juvarra scelse, quindi, d’adottare lo stemmadei Guevara. Una prima testimonianza del suo interesse verso di essasi trova nel Libro di più pensieri d’architettura, buonaparte eseguiti in Napoli... 3, in cui disegnò uno stemmaderivato chiaramente da quello dei Guevara. A diffe-renza di questo, però, esso era «partito» (diviso in dueverticalmente) e non «inquartato» (fig. ) 4.Le modifiche esprimono probabilmente la volontà dicreare una variante dello stemma dei Guevara chepotesse figurare come l’arma dei Juvarra, pur mante-nendo il rapporto con la ben più titolata famiglia. Lacorona posta sul tutto, con il suo implicito rimando aduna dignità nobiliare, dimostra comunque che il giova-ne architetto non aveva ancora le idee ben chiare. Se,infatti, l’uso d’uno stemma non era affatto privilegionobiliare, lo era, invece, quello delle corone, che espri-mevano un titolo concesso o riconosciuto da un sovra-no. Mi pare, quindi, che il disegno del codice ex-Tournon vada considerato come una prima espressionedel percorso che portò Filippo Juvarra a decorarsi
Di fronte alle Memorie Sepolcrali le prime domande chesorgono spontanee sono sul significato stesso dell’ope-ra: perché Juvarra la realizzò? cosa intendeva racconta-re? qual era il pubblico cui si rivolgeva? Per cercare didarvi risposta, ho scelto di ricostruire alcuni aspettisolo apparentemente minori della biografia e della per-sonalità juvarriana. Come si vedrà, infatti, essi aiuteran-no a comprendere la chiara consapevolezza del proprioruolo e rango che Juvarra ebbe sino alla fine della suavita e, contemporaneamente, ad avvicinarci al codiceinterpretativo sotteso all’opera.
Lo stemma
Gli stemmi nacquero al fine di identificare la personache li usava; solo in seguito passarono a simboleggiareuna famiglia. Anche dopo questa evoluzione, comun-que, lo stemma continuò ad esser un forte strumento diautorappresentazione personale, diffuso presso tutti iceti e niente affatto esclusivo del secondo stato. Neipercorsi di ascesa sociale l’adozione di uno stemma eraun passaggio obbligato. Juvarra pensò di dotarsi d’unostemma intorno al , in quel primo soggiorno roma-no che lo vide vincitore al Concorso Clementino e l’an-no seguente accademico di merito dell’Accademia diSan Luca.Per ricostruire questa vicenda – come spesso accade –bisogna, però, partire dalla fine. In questo caso, dallostemma presente sul sigillo posto da Juvarra in una sualettera del giugno , ritrovata un ventennio fa daAugusta Lange 1 (fig. ). Si tratta d’uno stemma nontroppo difficile da identificare, soprattutto per quei«cinque cuori [...] bene ordinati» presenti nel secondoe nel terzo quarto. Come mi ha suggerito Luisa Gentilein una conversazione avuta mentre lavoravo a questosaggio, essi rimandavano allo stemma dei Guevara,un’importante famiglia spagnola con diramazioni nelRegno di Napoli ed in quello di Sicilia (fig. ) 2.Perché Juvarra scelse di adottare per sé lo stemma deiGuevara? Un primo elemento da considerare è che iJuvarra tenevano molto ad affermare la loro originespagnola. Francesco Juvarra nella biografia del fratello
Lo stemma, il rango e la memoria del«cavaliere don Filippo Juvara, architetto»Andrea Merlotti
d’una sua propria arma. Questo percorso si compì conlo stemma presente nell’album conservato al Metro-politan (fig. ).Si tratta di un disegno di grande interesse, che esprimeassai bene la coscienza di sé e del proprio valore comearchitetto raggiunta da Juvarra dopo la vittoria nelConcorso Clementino del 5.Innanzitutto lo stemma. L’arma è un’ulteriore variazio-ne di quello dei Guevara 6, di cui viene anche ripreso ilmotto: «Potius mori quam foedari» («piuttosto morireche perder l’onore»): un po’ altisonante, forse, per ungiovane architetto, figlio d’un orafo, ma nel complessoadatto al nipote d’un soldato spagnolo, che vogliarivendicare la sua agnazione ad una famiglia nobile,celebre sul terreno delle armi.
Ma a colpire di più sono il sostegno dell’arma e la coro-na. Lo stemma, infatti, appare come poggiato su undisegno d’architettura, che ricorda assai da vicino ilcartiglio presente nella Pianta generale del Regio Palaz-zo in villa per tre personaggi illustri che gli era valso lavittoria al Concorso Clementino (fig. ). Il cartiglio –su cui con pochi tratti Juvarra dà l’idea della presenzad’un disegno – poggia su una squadra ed una rigaincrociate (quasi come due spade). Dall’impugnaturadella squadra spunta una cornucopia, da cui esce unamedaglia che rimanda alla vittoria nel concorso.Dall’angolo in alto a destra dello scudo (a sinistra perchi guarda) pende, quasi fosse una nappa, un filo apiombo. Ma l’elemento più affascinante è certo la coro-na. A differenza di quanto accade nel disegno del codi-ce ex-Tournon, Juvarra non pone qui una corona nobi-liare, espressione di un titolo che non ha, ma se neattribuisce una costituita da una successione di com-passi. Troppo chiara è la simbologia sottesa a questascelta perché sia necessario che mi ci soffermi. Vale lapena notare che in quegli stessi anni vi sono altre provedi riflessioni di Juvarra intorno allo stemma Guevara: isoli cinque cuori, per esempio, compaiono in una tavo-la realizzata fra e per l’insegnamento all’Acca-demia di San Luca (fig. ).Inizialmente, quindi, Juvarra pensò d’usare come stem-ma una variazione di quello dei Guevara. Il sigillousato nel mostra che ad un certo punto, però deci-se di adottarlo nella sua forma esatta. Ciò accadde pro-babilmente dopo il , quando divenne cavalieredell’Ordine di Cristo. Vi è poi un’altra evoluzione fondamentale che va consi-derata. I disegni sin qui citati erano un fatto privato,quasi un gioco, forse comprensibile al solo Juvarra e,possiamo immaginarlo, ad una ristretta cerchia di amicifidati. Negli anni successivi, invece, egli cominciò adusare pubblicamente lo stemma. Un esempio di ciò èofferto dal progetto della sua casa torinese, disegnatonel e realizzato nel , quando vi si trasferì dallestanze che abitava nel convento di san Filippo 7. È inte-ressante notare che nel progetto per la facciata dellacasa in un primo momento facesse bella mostra di sé
. Sigillo di Filippo Juvarra apposto sullalettera indirizzata ad Antonio Pelleri, giugno . AST
. Stemma del cavalier Juan de Guevara dalportale di palazzo Guevara, Lorca ()
all’Ordine del Cristo da parte del suo gran maestro, reGiovanni V nel 8. La concessione del titolo di cava-liere si svolse, racconta Francesco, «con una solennissi-ma funzione, alla quale prese parte tutta la nobiltà e colconferimento d’una croce adorna di sette diamanti delvalore di quattro mila scudi». Anche Scipione Maffei,autore di un’altra breve biografia dell’architetto, nericordava l’ingresso nell’Ordine cavalleresco portoghe-se come prova del successo da lui riportato nel viaggiolusitano del -. Per il quarantenne Juvarra, ineffetti, si trattava d’un riconoscimento importante: nonsolo da questo momento egli poteva fregiarsi del titolodi cavaliere, ma si trattava dello stesso Ordine dei cava-lieri di Cristo di cui era stato insignito cinquant’anniprima il suo maestro Carlo Fontana. Da questo
un grande stemma (fig. ). Anche se non se ne legge ildisegno, è ormai chiaro quale fosse. In un secondomomento, però, Juvarra modificò il progetto ed inserìdei balconcini, uno dei quali sembrerebbe cancellare lostemma. Non si sa quale variante egli abbia realizzato.Certo, la sola idea di porre sul suo palazzo uno stem-ma, secondo un tipico costume nobiliare, era un chiaroindice della coscienza che Juvarra aveva di sé e del pro-prio rango.
Il cavaliere di Cristo e l’abate di Selve
Nella biografia di Filippo Juvarra scritta quasi sicura-mente dal fratello Francesco era ricordata con manife-sto compiacimento l’ascrizione dell’architetto messinese
. Filippo Juvarra, Stemma Guevara. Codiceex-Tournon, ca, fol.
. Filippo Juvarra, Stemma Guevara/Juvarra,- ca. New York, MetropolitanMuseum of Art, MM.
. Filippo Juvarra, Particolare del cartigliodella Pianta generale del Regio Palazzo invilla per il diporto di tre personaggiillustri..., . AASL, Disegni diarchitettura
. Filippo Juvarra, Variazione sullo stemmaGuevara/Juvarra. Particolare dallo Studiodi presentazione dell’Ordine composto perl’esercizio degli allievi, -. BNT, Ris.., fol. , n.
degli autori aveva riconosciuto sia che un pittore o unarchitetto potesse esser nobile sia che la pratica di que-ste arti non derogasse la nobiltà se ad esercitarla era unesponente del secondo stato. «Si formerebbe un buon volume se si imprendesse arapportare tutti gli scultori, architetti e pittori, medici,poeti e tutti gli altri artigiani che hanno meritato il glo-rioso titolo di cavalieri per essersi segnalati nelle bellearti o per essersi renduti pregevoli col loro sapere ecolle loro grandi azioni», scriveva nel Honoré deSainte Marie nelle sue Dissertations historiques sur lachevalerie 11. A riprova della difficoltà di porre gli artistinel secondo stato restando all’interno della tradizionaletripartizione «oratores, bellatores, laboratores», devonotare, comunque, che padre de Sainte Marie ponevagli artisti cavalieri in una gerarchia degli onori che livedeva dopo i cavalieri «di lettere», quelli «di toga»,quelli «d’onore» e quelli «civili o sia cittadini», e primasolo delle «persone escite dalla feccia del popolo», fatticavalieri per le loro «azioni cotanto risplendenti».
momento, Juvarra iniziò a firmarsi «cavaliere donFilippo Juvara, architetto» e questa forma, comemostrerò più avanti, restò sostanzialmente immutataanche dopo esser stato nominato abate di Selve, nel.Nel corso del Seicento, l’ascrizione di architetti, pittorie scultori agli ordini cavallereschi era stata un fattotutt’altro che raro. Ciò soprattutto nello Stato Pontifi-cio, dove i papi che si erano susseguiti lungo tutto ilsecolo avevano premiato i maestri loro più cari coop-tandoli nelle fila dell’Ordine dello Speron d’Oro e inquel del più prestigioso Ordine di Cristo. Si tratta diuna storia che è stata ricostruita da Sebastian Schütze9
e che va collocata sullo sfondo della lunga riflessionesulla nobiltà delle professioni e delle arti che percorsetutta la storia dell’Italia moderna 10. La nobiltà degliartisti, peraltro, era stato un tema assai dibattuto nellatrattatistica italiana del Cinquecento, epoca di chiusuradei ceti e di delimitazione di chiari confini sociali.Nonostante vi fossero state voci contrarie, la più parte
. Filippo Juvarra, Prospetto per CasaJuvarra a Torino, . MCT, vol. , fol. ,n
Per quanto riguarda gli architetti, nel Seicento essi ave-vano avuto nell’Ordine di Cristo alcuni dei loro mag-giori maestri, a partire da Bernini e Borromini, fatticavalieri rispettivamente nel e nel . Rispetto aloro, ma anche a Carlo Fontana ed a suo figlio France-sco 12, tuttavia, vi è un’importante differenza: Juvarraottenne il titolo dal re di Portogallo e non dal papa. Percomprendere i termini della questione, è necessarioconoscere alcuni punti della storia dell’Ordine di cui ilquasi quaranntenne architetto era divenuto cavaliere.L’Ordine dei cavalieri di Cristo era nato nel perraccogliere l’eredità – spirituale e temporale – deimembri portoghesi dell’Ordine templare 13. I cavalierierano stati posti sotto il controllo dei re di Portogallo(che dal XVI secolo ne assunsero il Gran magistero), mail papa, forse quale retaggio del rapporto privilegiatoche aveva avuto coi Templari, s’era riservato il diritto dicreare anch’egli cavalieri dell’Ordine. Dai Templari icavalieri di Cristo ereditavano manto bianco e crocerossa, «caricata», però, d’una croce bianca più piccola.Grazie alla proiezione in Oltremare del Portogallo,l’Ordine di Cristo era stato nel Cinquecento uno deipiù ricchi e potenti d’Europa 14. La conquista spagnoladel Portogallo (-) ed altre ragioni, che quisarebbe fuori luogo approfondire, avevano fatto sì chenel Seicento esistessero di fatto due ordini di Cristo:uno lusitano ed uno pontificio. Mentre i re di Porto-gallo ritenevano che i cavalieri creati dal papa dovesse-ro esser loro sottoposti, in quanto gran maestri, a Romasi sosteneva, invece, che si trattava di due ordini diffe-renti, pur con origine comune. Tale tesi fu sostenuta afine Seicento dal veneziano Bernardo Giustiniani nelleHistorie cronologiche della vera origine di tutti gl’ordiniequestri e religioni cavalleresche, un classico della storiacavalleresca 15, e fu ripresa poi nel dal gesuita roma-no Filippo Bonanni (-) nel suo Catalogo degliordini equestri 16. I cavalieri di Cristo creati dal papa,spiegava Bonanni, non rispondevano al re del Porto-gallo, ed avevano decorazioni differenti dai cavaliericreati da quest’ultimo. Inoltre, proseguiva, il gesuita,coloro che aspiravano a far parte dell’Ordine di Cristopontificio non dovevano esser nobili per divenire cava-
lieri 17.La questione era tutt’altro che di poco conto e nellaprima metà del Settecento, dell’Ordine di Cristo creòdiverse tensioni fra Roma e Lisbona. A farne le spesefu, nel , l’architetto fiorentino Niccolà Sperandoni,che aveva da poco ottenuto grande successo in Franciacon la facciata della chiesa di St. Sulpice. Nel
Servandoni aveva ottenuto da Benedetto XIV l’Ordinedi Cristo, che gli era stato conferito in una cerimoniapubblica da monsignor Languet 18. Due anni dopo, Ser-vandoni era stato chiamato in Portogallo da Giovanni V(lo stesso re che aveva creato cavaliere Juvarra), perchés’occupasse del palazzo-convento di Necessidades. Ilsoggiorno di Servandoni si concluse, però, bruscamentequando egli usò pubblicamente il titolo di cavaliere diCristo conferitogli dal papa. Giovanni V, infatti, lo fece
. Agostino Masucci, Ritratto del cavalierFilippo Juvarra, ca Madrid, RealeAccademia di San Fernando
all’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Ciò era in stridente contrasto non solo con quantoaccadeva a Roma, ma anche a Parigi, dove Luigi XIV
aveva creato cavalieri tutti i principali architetti attivinei cantieri della corona, a Parigi come a Versailles. Il«Re Sole», anzi, riformò l’Ordine di San Michele – ilpiù antico di Francia – per destinarlo ad artisti e lette-rati (pendant civile dell’Ordine di San Luigi, istituitonel per i militari). Jules Hardouin-Mansard, Andrèle Notre e Robert de Cotte ne furono fatti cavalieri e lacroce di San Michele fa bella mostra di sé, per esempio,nei ritratti che Rigaud fece ad Hardouin-Mansard nel ed a De Cotte nel 21.Quando Juvarra giungeva a Torino nel egli realiz-zava il suo sogno di divenire architetto di corte22, ma,nello stesso tempo, arrivava in una realtà in cui il ruolosociale dell’architetto non aveva ancora ottenuto il rico-noscimento che aveva altrove. Nonostante la sua nomi-na alla carica – per lui appositamente istituita – di«primo architetto civile del re», egli, infatti, non fu maiascritto all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, néebbe alcuna concessione nobiliare da parte di VittorioAmedeo II o del figlio di questi Carlo Emanuele III.L’ascrizione all’Ordine dei cavalieri di Cristo era, quin-di, particolarmente preziosa per Juvarra, almeno perdue ordini di ragioni.In primo luogo gli riconosceva una nobiltà personaleche quello pontificio gli avrebbe solo conferito. I criteridi selezione dei cavalieri dell’Ordine di Cristo porto-ghese erano più rigidi di quelli dei cavalieri dell’Ordinedi Cristo romano: per esser ascritti in quest’ultimo,come aveva scritto Bonanni, infatti, non era necessarioesser nobili; per esserlo in quello lusitano, sì. Juvarra,in realtà, non era nobile, ma Giovanni V ricorse proba-bilmente ad un provvedimento di grazia. Un fatto che,però, restava al chiuso degli archivi dell’Ordine. In secondo luogo, con buona pace della società pie-montese che non vedeva in architetti ed ingegneri sog-getti degni del cavalierato, egli non solo era riuscito adaverlo, ma in un ordine più prestigioso di quello deiSanti Maurizio e Lazzaro. Si trattava di un’implicitadimostrazione del suo rango di artista europeo, onorato
arrestare e lo espulse dal Portogallo, ribadendo che eglisolo poteva creare cavalieri dell’Ordine 19.Alla luce di tutto ciò, la nomina di Juvarra a cavalieredi Cristo portoghese e non romano si pone sotto unaluce nuova. Prima, però, di fare alcuna considerazionein merito, credo si debba affrontare il problema delcavalierato di Juvarra ancora sotto un’altra angolazione,più sabauda.Nel Seicento i Savoia avevano ascritto all’Ordine deiSanti Maurizio e Lazzaro non solo letterati e storici, maanche i principali pittori attivi a corte 20. Non avevano,però, fatto altrettanto con gli architetti: né AscanioVitozzi, né Carlo ed Amedeo di Castellamonte – purappartenenti ad una delle più antiche famiglie dellanobiltà piemontese –, né Guarino Guarini, né Miche-langelo Garove, né Antonio Bertola furono ascritti
. Martin van Meytens (attribuito), Ritrattodel cavalier Filippo Juvarra, ca.Torino, Galleria Sabauda
a Roma come a Lisbona.Non a caso, dal egli si indicò sempre come il«cavaliere don Filippo Juvara», mentre i suoi interlocu-tori piemontesi continueranno a chiamarlo, con pocheeccezioni, «don Filippo» o «il prete signor don Filippodi Messina», come indicato in un verbale del Consigliodegli edili del 23. Ancora nel il viaggiatore tede-sco Johann George Keysler registrava come spesso ci siriferisse a lui semplicemente come a «Filippo the archi-tect» 24.Al contrario, Juvarra teneva moltissimo al suo titolo dicavaliere. Ciò non risulta solo dalle firme e dai titolidati alle sue opere – tornerò oltre su questo argomento– ma anche dall’iconografia juvarriana. È impossibilenon notare che tutti i suoi ritratti a noi conosciutiriportano la croce dell’Ordine di Cristo con grande evi-denza. Non si trattava, poi, semplicemente d’una crocedell’Ordine, ma di quella «adorna di sette diamanti»donatagli da Giovanni V 25. Ciò è vero sia nel ritrattoche gli fece Agostino Masucci, conservato oggi all’Ac-cademia di San Fernando a Madrid (fig. ) (una copiaè all’Accademia di San Luca, a Roma), sia in quello diMeytens, conservato alla Galleria Sabauda di Torino(fig. ). È parrebbe vero anche per quello, oggi disper-so, dell’Università di Torino (fig. ): ma lo stato del-l’unica fotografia esistente mi induce alla prudenza26.Solo in un’opera ciò non accade. Si tratta della Vedutadel castello di Rivoli da Levante di Pannini: evidente-mente il pittore non ebbe l’architetto a disposizionecome modello e dipinse una croce come l’avrebbeavuta un qualsiasi cavaliere dell’Ordine di Cristo ponti-ficio. Ma si tratta, appunto, della classica eccezione checonferma la regola.Eppure, a differenza di Roma dove già un secolo primaGiuseppe Cesari appena ascritto da Clemente VIII
all’Ordine di Cristo era divenuto per tutti il cavalierd’Arpino, e dove Bernini, in virtù dello stesso cavaliera-to, era conosciuto da tutti come il cavalier Bernini,Juvarra a Torino non riuscì mai a divenire il cavalierJuvarra. Nonostante fama e successo, la sua considera-zione sociale non era – almeno a Torino – quella cheavrebbe desiderato: mentre a Roma otteneva il titolo di
«architetto della fabbrica di san Pietro», a Torino nonriusciva a farsi chiamare cavaliere: tutto quello cheottenne – e sono convinto che non ne fosse affatto sod-disfatto – fu di diventare l’abate Juvarra.Nel Juvarra ottenne finalmente, infatti, un titoloda Vittorio Amedeo II: il dicembre – quasi un regalodi Natale – Juvarra fu nominato abate di Selve, nelVercellese, e prestò giuramento a Vittorio Amedeo II il marzo 27. L’abbazia di Selve – per quanto non frale più illustri dello Stato Sabaudo – aveva alle spalleuna storia di tutto rispetto e, cosa che ha più importan-za in questa sede, dal punto di vista sociale era statapatrimonio di esponenti di famiglie appartenenti allanobiltà più antica e più vicina alla corte 28. Ciò nono-stante, Juvarra non mostrò mai grande interesse per
. Anonimo piemontese, Ritratto delcavalier Filippo Juvarra, ca, giàTorino, Università degli Studi
Torino, ma a quello del doveva risultare poco piùche una seccatura, in cui il rapporto costi-benefici pen-colava pericolosamente verso i primi. Non a caso,Juvarra nominò subito un suo factotum e se ne occupòil meno possibile. Il convergere e l’insistere di tantiindizi in quest’unica direzione mi pare costituisca unaprova abbastanza convincente. D’altronde, egli nonpoteva certo rifiutare una carica datagli dal re.Innanzitutto, egli continuò ad usare la firma «cavalieredon Filippo Juvarra, architetto», ricorrendo a quella di«abate Filippo Juvarra, architetto» solo quando nonpoteva far altrimenti. In secondo luogo, evitò accurata-mente di definirsi abate nell’intitolazione delle sueopere. Il codice di capricci inviato a lord Burlington(fig. ) nel (e realizzato nel biennio precedente) 32
ed il codice di Dresda per Augusto il Forte del 33
sono firmati «cavaliere don Filippo Juvarra», dell’abatenessun cenno. E così anche il Libro di disegni... per gliornati di candelabri e vasi fatti in Torino l’anno e,mi pare quasi superfluo ricordarlo, anche le MemorieSepolcrali che qui si pubblicano. Abate Juvarra egli erachiamato quasi solo da coloro che non volevano chia-marlo cavalier Juvarra ed è un po’ un gioco del destinoche sia stato proprio un suo amico quale Scipione Maf-fei ad introdurre post mortem la prassi di chiamarloabate Juvarra, scrivendo, nel , un Elogio dell’abatedon Filippo Juvarra messinese, dove sopprimeva quel«cavaliere e architetto» che Juvarra aveva sempre volu-to accanto al suo nome. Più vicino a quest’uso fu inve-ce, e certo non è un caso, il fratello Francesco Juvarrache intitolò la biografia del fratello Vita del cavagliereFilippo Juvarra, abbate di Selve e primo architetto di SuaMaestà di Sardegna.Ma l’indizio che trovo più interessante dello scarsointeresse per un titolo che, evidentemente, non sentivasuo è il ritratto che gli fece Martin van Meytens (fig. ).Il pittore svedese fu a Torino fra il ed il . Nel-l’anno circa trascorso nella capitale sabauda fu impe-gnato soprattutto a corte, dove, stando a quanto eglistesso racconta nelle sue memorie, dipinse più volte ilsovrano, altri membri della famiglia reale e diversiesponenti della corte 34. Il ritratto che Meytens eseguì a
questo titolo e non si indicò mai, se non in atti ufficialio in quelli relativi all’abbazia, come abate Juvarra. Mipare, quindi, opportuno soffermarmi su quest’ultimotitolo del cursus honorum sociale dell’architetto messi-nese. Un primo – importate – punto da tener presente è chela nomina di Juvarra non fu un fatto isolato, ma s’inserìin una cospicua serie di nomine con le quali VittorioAmedeo II sistemò cariche per molto tempo rimastescoperte. Nel , infatti, grazie all’abile politica delmarchese d’Ormea, lo Stato sabaudo aveva finalmentestipulato un concordato con Benedetto XIII, ponendofine (ma solo momentaneamente) ad un durissimoscontro tra Roma e Torino che per vent’anni avevabloccato le nomine di vescovi, abati e numerose altrecariche minori 29.È interessante notare, allora, che anche altri personaggilegati al mondo delle professioni culturali furono alloragratificati con la nomina ad un’abbazia: è il caso deiprofessori Francesco Domenico Bencini e GiuseppePasini, docenti rispettivamente di teologia scolastico-dogmatica e di Sacra Scrittura con lingua ebraica30. Dalpunto di vista culturale, Bencini e Pasini erano proba-bilmente i personaggi più in vista cui fossero state affi-date delle abbazie. Gli altri erano perlopiù esponenti difamiglie nobili che avevano già altre e più alte carichenella Chiesa – come il cardinal Carlo Vincenzo Ferrero– nella corte o nello Stato. Nella ventina di abati alloranominati, l’architetto Juvarra era un caso del tuttoparticolare. Anche dal punto di vista finanziario, come ha mostratola Lange, l’abbazia di Selve non era una fonte di reddi-to particolarmente rilevante: più o meno lire diPiemonte 31. Certo erano più delle lire che frutta-vano le abbazie concesse a Bencini e Pasini, ma si eraben lontani delle quasi lire di reddito dell’abba-zia di Staffarda, che il re aveva assegnato al cardinalAlbani, quale ringraziamento per la sua politica romanaa favore dei Savoia.Socialmente non molto prestigioso, economicamentepoco redditizio, il titolo d’abate sarebbe forse apparsopiù interessante al Juvarra del , appena giunto a
Juvarra risale, quindi, ai mesi immediatamente successi-vi la nomina dell’architetto siciliano ad abate di Selve35.Ciò nonostante, nel ritratto non vi è alcun segno dellanuova carica: la stessa scelta di raffigurare la manodestra infilata nella giacca impedisce di scorgere l’anel-lo che gli abati portavano – come i vescovi – all’anularedella mano destra, e che avrebbe comunicato, senzaesser troppo appariscente, la carica del personaggio raf-figurato, anche a chi ne avesse ignorato l’identità36.I ritratti – soprattutto quelli ufficiali, come questo chia-ramente è – non erano fatti per nascondere le cariche,ma per mostrarle: tanto più in una corte, dove si deveapparire ciò che si è e non nasconderlo. L’unica spiega-
zione è che fosse stato Juvarra a chiedere al pittore difare così. Sul ritratto spicca – unico punto di luce – lacroce dell’Ordine di Cristo, vanto dell’architetto Juvar-ra e vero suo modo di distinguersi nella rigida e diffici-le società torinese.Va notato, però, che Juvarra sembra aver avuto il rico-noscimento che desiderava nel mondo a lui più vicino,quello degli studi e delle professioni. Ne è indizio l’ora-zione De usu mathéseos in civili et militari architecturatenuta nel novembre dal matematico Ercole Coraz-zi in apertura dell’anno accademico dell’ateneo torine-se. In essa Corazzi chiamava Juvarra «eques», elogian-done la chiesa di Santa Cristina, che avrebbe certo pro-
. Filippo Juvarra, Frontespizio dell’albumdedicato a Lord Burlington, .Chatsworth
Juvarra non ebbe mai (e, come lui, neppure Vittone) e,in aggiunta, chiamato anche fra i decurioni delConsiglio di Torino. Tornando a Juvarra, per comprendere le sue difficoltàcon una parte almeno della società di corte torinesebasta analizzare i documenti intercorsi con l’Ordinemauriziano a partire da quel in cui iniziò i lavoriper Stupinigi 41. Nelle Istruzioni e memorie per la fabbri-ca... di Stupinigi il Consiglio della sacra religione deiSanti Maurizio e Lazzaro si riferiva all’architetto sem-pre come «l’abbate Juvara», evitando con ogni atten-zione il titolo di cavaliere. Juvarra, da parte sua, il aprile inviava al Consiglio la sua Istruzione per la palaz-zina di caccia... di Stupiniggi firmandola «cavaliere donFilippo Juvarra, architetto». Venti giorni dopo, il
aprile, il Consiglio riceveva il «signor abate don FilippoJuvarra» (sempre nessuna menzione del titolo di cava-liere) e, per metter subito in chiaro ranghi e ruoli reci-proci, lo faceva accomodare «su una sedia senza brac-cia» (quelle che si usavano nelle anticamere per faraspettare i postulanti), per di più «alquanto discostadalla tavola del Consiglio, e circa il fine di essa»42. Unaspiegazione del significato sociale della «sedia senzabraccia» si ha se si pone mente ad un fatto accadutoquarantacinque anni prima, nel , quando essa erastata riservata agli ingegneri Michelangelo Garove eGiovan Francesco Baroncelli in quanto «vili meccani-ci» 43. Tornando a Juvarra, da allora e sino alla partenzadell’architetto per Madrid, nel , il Consiglio del-l’Ordine continuerà a rivolgersi all’«abate Juvarra» equesti a rispondere firmandosi «cavaliere Juvarra» 44:testimonianza forse burocratica, ma non per questomeno vera, di un freddo gioco di ruoli, che fu certomotivo d’amarezza per l’architetto siciliano e che è datener ben presente nell’affrontare la lettura delleMemorie Sepolcrali.
Le «Memorie Sepolcrali»: una scrittura autobiograficain forma architettonica
Juvarra lavorò alle Memorie Sepolcrali fra e .Sebbene non potesse certo immaginare quanto poco gli
curato l’immortalità al «magnus architectus» 37.Proprio l’Università, tuttavia, era un altro settore in cuiJuvarra aveva una posizione ambigua. Durante lediscussioni per la riforma dell’Ateneo si era più volteventilata la possibilità di creare una cattedra di architet-tura, aprendo così la strada ad una laurea ad hoc. Erastata questa anche l’opinione di Scipione Maffei chepoi sarebbe divenuto uno dei grandi estimatori diJuvarra: «non deve però farsi mancare nel nostroStudio chi tratti[...] l’architettura, che fa tutto l’orna-mento delle città e il commodo della vita, e che permancanza di studio e per la licenza e stranissime fanta-sie di uomini idioti va in molte parti ritornando allesciochezze de’ secoli barbari» 38. La proposta, tuttavia,era stata rigettata. Si era deciso, invece, di trasferirel’Accademia torinese di San Luca nel palazzodell’Ateneo (cosa che avvenne intorno al ) e che isuoi allievi dovessero seguire alcuni corsi universitari,ma al termine del loro iter di studi non avrebberosostenuto un esame per il dottorato, ma solo per lalibertà d’esercizio della professione 39. Fra i laureati e gliarchitetti si veniva così a creare una netta differenzasociale: i primi, infatti, conseguendo il dottorato otte-nevano anche la nobiltà, i secondi no 40. Non a caso,diversi architetti si laurearono anche in leggi, in mododa garantirsi uno status loro altrimenti precluso.Juvarra insegnò per anni nel Palazzo dell’Università,dove ebbe anche il suo studio ed il gabinetto deimodelli (forse a questa sua attività di docente rimandail quadro oggi perduto cui ho già accennato), ma eraun docente, per così dire, in tono minore rispetto aquelli incardinati nel sistema dei gradi accademici. Unadebolezza che ricadeva, anche sui suoi allievi. Certodiversi di loro divennero le colonne portanti della pra-tica architettonica in Piemonte per diversi decenni ealcuni si fecero molto onore, basti pensare alla vittoriadi Vittone e Massazza nelle due classi del ConcorsoClementino nel , ma poco potevano in una societàregolata dal sistema dei privilegi. Lo si vide bene quan-do Juvarra morì. A sostituirlo non fu chiamato il suoallievo Vittone, ma il nobile Benedetto Alfieri, avvoca-to, subito gratificato di quel cavalierato mauriziano che
restasse da vivere, egli s’avvicinava ormai ai sessant’an-ni: un’età in cui era legittimo fare un bilancio della pro-pria vita. Nel trentennio trascorso dalla vittoria delClementino e grazie ai capolavori realizzati nella capita-le sabauda, s’era affermato come «uno de’ miglioriarchitetti» della sua epoca, «anzi il migliore senza com-parazione», come scriveva Pier Leone Ghezzi, in calcealla celebre caricatura del suo Mondo novo. Ma, soprat-tutto dopo il , sulle luci incominciarono a prevalerele ombre. Era un momento particolare della sua vita, segnato dal-l’amarezza per l’esito negativo del suo viaggio a Romadella prima metà del : non solo non era riuscito afar aprire il cantiere della Sacrestia di San Pietro, maanche i progetti per il palazzo del Conclave e la facciatadi San Giovanni in Laterano erano rimasti sulla carta 45.Il suo rientro a Torino era stato quello d’un uomoalmeno in parte sconfitto, consapevole che una fasedella sua vita s’era chiusa per sempre.I due anni e mezzo compresi fra il settembre –quando tornò a Torino– ed il febbraio – quandopartì per Madrid – furono, in effetti, un periodo diripiegamento. Persa ogni speranza di aprire nuovi can-tieri a Roma, Juvarra vedeva procedere un po’ stanca-mente quelli torinesi, senza che si prospettasse per luinessun grande progetto che non fosse già stato definitoe deciso negli anni di Vittorio Amedeo II. È il casoanche di tutti i lavori per la cosiddetta «zona di coman-do», definiti nel loro insieme non più tardi della prima-vera del e, quindi, ancora durante il regno delprimo sovrano sabaudo, la cui abdicazione avvenne il settembre 46. Era evidente che Carlo Emanuele III nonaveva la stessa volontà del padre di terminare i cantieriiniziati (anche al di là del caso particolare di Rivoli) e,in fondo, anche i permessi sempre più frequenti che gliconcedeva per allontanarsi da Torino potevano esserletti come una prova di disinteresse. Per Juvarra sitrattò di anni dedicati soprattutto alla decorazione d’in-terni a Palazzo Reale ed in altre residenze sabaude, inprimis Villa della Regina 47. Non è difficile capire cheper chi aveva sperato sin a poco prima di costruire laSacrestia di San Pietro – un’opera che se realizzata
avrebbe rivaleggiato col colonnato del Bernini – trovar-si a disegnare «gabinetti alla china» e decorare antica-mere non doveva esser motivo d’entusiasmo. E ciòsenza, comunque, voler sminuire l’importanza di un’at-tività che era pure di indubbio rilievo 48.Prigioniero d’una quotidianità dominata dall’ordinariaamministrazione, privo dello slancio violento, ma crea-tivo imposto da una personalità demiurgica qual’eraquella di Vittorio Amedeo II, sospeso tra l’epilogo del-l’esperienza romana e l’inizio di quella spagnola,Juvarra si dedicò – e tempo e l’impegno loro destinatoacquistano così un senso più logico e comprensibile –alla redazione degli oltre disegni dei Geroglificisopra l’iconologia del cavalier Ripa, terminata nel ,del Libro di disegni ... per ornati di candelabri e vasi edelle Memorie Sepolcrali, interrotti (più che conclusi)nel . Ma mentre i libri dei geroglifici e dei candela-bri appaiono in qualche modo legati all’attività d’arre-datore d’interni, per così dire, allora svolta da Juvarra,le Memorie Sepolcrali sono qualcosa di diverso.A mio avviso, infatti, si tratta di un’opera forse unicanel suo genere: una scrittura autobiografica in formaarchitettonica 49.Sia chiaro: non voglio dire che Juvarra non intendesserealizzare in quest’opera anche una sorta di campiona-rio teorico per architetture funebri, che avrebbe anchepotuto un giorno pubblicare (e in questo caso ben face-va a disegnare memorie solo di uomini morti, o che cre-deva tali). Non vi sono prove per sostenerlo, ma nem-meno per negarlo. Ma nel farlo finiva inevitabilmenteper raccontare anche la sua stessa vita. Nel frontespizioJuvarra spiegava di voler presentare, attraverso le loromemorie, gli «huomini più insigni di questo secolo» cheaveva conosciuto, «per memoria del loro grandenome». È evidente anche al lettore meno smaliziato cheil nome che Juvarra intendeva ricordare e preservareera il suo. In un certo senso, le Memorie Sepolcralirispondevano allo stesso fine della memorialistica stori-ca tipica della cultura del Seicento, un «genere lettera-rio aristocratico [...] che tenta di ridurre la persona aisuoi atti pubblici» 50. Juvarra, dopo tutto, era contem-poraneo di Saint Simon (-). Solo che in questo
marchese di Valparaiso (fol. ) o del generale La Tour(fol. ) i primi non sembrano certo di un altro milieusociale, anzi. Juvarra, certo, non è sempre preciso, masi tratta di dettagli, nemmeno troppo importanti 51.La grande presenza di militari – di tutti gli schieramen-ti coinvolti nella guerra di successione polacca – per-mette a Juvarra di far sfoggio di tutta la sua abilità diartista, ma, insieme, di raccontare quanto egli fosseinserito nella società dei principi. Nel frontespizio,infatti, egli aveva precisato che i personaggi di cuiaveva disegnato le memorie erano stati da lui «cono-sciuti». Non si trattava per lui di nomi sulle gazzette,ma di protagonisti del gran teatro del mondo con cuiaveva avuto rapporti diretti. Troppo scarse sono lenostre conoscenze della biografia di Juvarra per poterricostruire di ciascuno i rapporti avuti con Juvarra. Ciòrisulta particolarmente ostico nei confronti dei militari.Ma alcuni squarci sulla vita juvarriana aiutano a farluce. Mi limito ad un esempio, che ritegno particolar-mente interessante perché relativo ad uno dei quesiti dipiù difficile soluzione: quello relativo ai rapporti fraJuvarra e le decine di militari presenti nelle Memorie.Il gennaio , in una Milano da poco conquistatadalle truppe gallo-sarde, Carlo Emanuele III volle che«si desse un ballo alle dame e a cavalieri milanesi e agliufficiali delle due corone che colà trovavansi» e, per farcapire chi comandava ora in città, volle che si tenesse«nella gran sala del palazzo ducale, detta delle ringhie-re, dall’architetto regio Filippo Juvarra maestrevolmen-te addobbata». Stando a quanto racconta l’abate Pasi-ni, il ballo fu un successo: «riuscì con tale ricchezza,generosità ed isquisitezza d’ogni genere di cose cheattirossi l’ammirazione di tutte e tre le nazioni» 52.Juvarra si fermò necessariamente a Milano diversi gior-ni e ebbe allora occasione di conoscere o di rincontraretutti i principali ufficiali dell’armata gallo-sarda, fra cuianche quelli che di lì a qualche mese sarebbero mortisui campi di Parma e Guastalla. Mi pare, tuttavia, che più che le presenze – cui, peral-tro, sono dedicati altri saggi in questo stesso volume,oltre all’apparato di schede relative alle singole memo-rie – sia opportuno cogliere qui le assenze. Non può
caso, ciò di cui Juvarra voleva informare il lettore nonerano le sue opere – cui, anzi, non faceva alcun riferi-mento –, ma la sua vita: il suo itinerarium nella societàdei principi. Non avendo né indici né progetti dell’opera non sap-piamo quale ne fosse il programma. Certo, essa èincompiuta: pur non sapendo se Juvarra intendessedisegnare altre memorie, lo dimostrano i cartigli vuotidi diverse di queste. Eppure, questa quasi paradossaleassenza di architettura del testo non rende le MemorieSepolcrali un’opera disorganica. È difficile, infatti, noncogliere in essa l’esistenza – pur frammentaria – d’unordine, di un’armonia che è innanzitutto espressionedella coscienza juvarriana del valore di sé e della pro-pria arte. Le Memorie Sepolcrali esprimono in ognipagina la consapevolezza di vivere in un’epoca in cuigli artisti hanno ormai conseguito uno status socialeche riconosce il valore del loro pensiero e della loroopera. L’accostamento di pittori ed architetti a diplo-matici e militari è reso armonioso proprio dalla presen-za dei titoli cavallereschi e nobiliari conferiti tanto aiprimi quanto ai secondi. Juvarra dipinge, così, un’unitàsociale tutta interna al secondo stato ed insieme legitti-ma un ordine culturale che nei decenni successivi, inve-ce, sarebbe stato pesantemente – e definitivamente –messo in discussione. Un’unità cui il cavalier Juvarra ri-vendicava con orgoglio l’appartenenza. Nelle MemorieSepolcrali Juvarra, infatti era, molto attento a mostrarel’appartenenza di architetti, pittori, scultori e letteratiad ordini cavallereschi, così come al loro uso di armiaraldiche. Nella prima delle memorie, per esempio,dedicata al suo maestro Carlo Fontana (fol. ) la coronacomitale, lo stemma e la croce che lo circondano indi-cano l’ascrizione dell’architetto all’Ordine portoghesedi Cristo nel , il suo uso di un’arma parlante ed iltitolo di conte, ottenuto da Augusto II di Sassonia nel. Il compasso e la squadra presenti nella memoriadi Carlo Fontana così come i riferimenti espliciti adalcune opere nella memoria del figlio di questi Fran-cesco (fol. ) non solo non inficiano la nobiltà dei due,ma le esplicitano le origini e le ragioni. Se si confronta-no le memorie dei Fontana padre e figlio con quelle del
non colpire, per esempio, che nelle Memorie Sepolcralinon compaiano i sovrani che Juvarra aveva conosciutoe per cui aveva lavorato. Sono assenti Vittorio AmedeoII ed Anna d’Orléans, scomparsi rispettivamente nel e nel ; così come i papi Clemente XI (-),Innocenzo XIII (-) e Benedetto XIII (-); nonvi appare nemmeno Augusto II il Forte, re di Polonia,duca di Sassonia, cui nel aveva inviato un preziosocodice di disegni, e che era morto nel gennaio del .Ma l’assenza più rilevante è, certo, un’altra: i piemonte-si. Su un centinaio di memorie solo sette erano in qual-che modo legate allo Stato sabaudo: due dedicate all’in-gegnere Antonio Bertola; tre a stranieri che come Ju-varra erano passati al servizio sabaudo, il colonnellotedesco d’Embser (due memorie) ed il musicista Stefa-no Andrea Fioré; una al marchese Gabriele d’Este diBorgomanero, che però quando Juvarra era giunto inPiemonte aveva già abbandonato il servizio sabaudoper passare a quello asburgico; l’ultima – la più curiosa,tanto da costituire un unicum nelle Memorie –agli «ofi-ciali del re di Sardegna morti nella battaglia di Parma». Del tutto assenti erano la corte (tranne la citata memo-ria su Fioré), la diplomazia, il mondo dei ministeri,l’Università 53. Stride, poi, con la fitta presenza dimemorie dedicate a militari francesi ed imperiali, l’as-senza di analoghe memorie dedicate agli ufficiali sabau-di. Eppure gli elenchi dei caduti nelle battaglie dellaguerra di successione polacca annoveravano ufficiali dialcune delle più belle famiglie della nobiltà sabauda.Esemplare il caso dei Benso: Carlo Giuseppe Benso diCavour (), ufficiale nel reggimento Saluzzo, fu ucci-so alla battaglia di Guastalla, dove anche il fratellomaggiore Michele Antonio (-) fu gravementeferito, rimanendo invalido; alla battaglia di Parma morìinvece Vittorio Amedeo Benso di Santena, capitano nelreggimento Torino. Cacherano di Bricherasio, d’Hallotdes Hayes, Grimaldi di Bellino, Piossasco d’Airasca,sono solo alcune delle grandi famiglie piemontesi cheebbero caduti nelle prime battaglie del conflitto. Il casoche fece forse più scalpore fu quello del giovane capita-no Domenico Cortina di Malgrà, ucciso alla battaglia diGuastalla, mentre faceva scudo a Carlo Emanuele III,
che stava per esser colpito da una fucilata. Sul frontetedesco morì, invece, Eugenio Giovanni Francesco diSavoia-Soissons, duca di Troppau (-), nipote ederede del principe Eugenio, che era restato fedeleall’Impero, divenendo generale e cavaliere del Tosond’Oro. Il giovane principe aveva studiato a Torino,avendo a precettore padre Joseph Roma, ed era certa-mente stato conosciuto da Juvarra 54. Nell’esercito diCarlo VI egli rivestiva un ruolo maggiore di diversi deipersonaggi ricordati nelle Memorie Sepolcrali.Insomma, Juvarra non avrebbe avuto problemi a trova-re sudditi sabaudi da ricordare: evidentemente nonaveva voglia di farlo. La memoria sugli «offiziali» morti a Parma mi pareesemplare. Una serie d’urne anonime, senza decorazio-ni che le distinguano l’una dall’altra e permettano diidentificarne le ceneri, poste sotto un alato stemmasabaudo: l’unico caso in cui lo stemma non è quello deldefunto, ma del sovrano al servizio del quale il defuntoera morto. La grande lapide bianca sottostante sembraattendere che vi venga incisa una serie di nomi, destina-ti ad esser presto dimenticati. Forse nessuno meglio diJuvarra in questo disegno aveva espresso la capacitàdisciplinatrice dell’esercito dei Savoia. Non a caso glieroi delle guerre sabaude non erano mai militari: unminatore – Pietro Micca –, una popolana – MariaBricca – ed un religioso – il beato Valfrè – in quella disuccessione spagnola; un tedesco luterano – vonLeutrum, il baron Litròn – in quella di successioneaustriaca. Quella polacca, come Juvarra aveva forseintuito, era destinata a restare una guerra senza eroi,nonostante le vittorie riportate.Del tutto particolare, d’altronde, era il profilo dei dueufficiali sabaudi che Juvarra aveva voluto ricordare,Giovan Battista d’Embser ed Antonio Bertola, che ave-vano lavorato a stretto contatto nel reggimento d’arti-glieria, diventandone entrambi colonnelli nel . Ilprimo era un capitano dell’artiglieria imperiale cheaveva combattuto a lungo accanto al principe Eugenioed era poi passato al servizio sabaudo alla fine dellaguerra di successione spagnola. Vittorio Amedeo II neaveva molta stima e nel lo aveva incaricato di redi-
più tardi, «dispiacque molto al re per l’esperienza checol servizio di molti anni acquistata avea nella sua pro-fessione» 56. Il colonnello d’Embser era un esponente,quindi, di quei militaires savantes che erano un caratte-ristica tipica, ma non esclusiva di un’arma dotta comel’artiglieria e che a Torino negli anni di Vittorio Ame-deo II erano stati rappresentati anche da un altro perso-naggio che Juvarra volle inserire nelle sue MemorieSepolcrali. Mi riferisco ad Alvaro Navìa y Ossorio, mar-chese de Santa-Cruz de Marcenado (-), che fuambasciatore spagnolo a Torino dal al e chenella capitale sabauda scrisse e pubblicò la prima edi-zione delle sue Reflexiones militares, forse il più impor-tante trattato militare del XVIII secolo 57. Fu semprenella capitale sabauda che il marchese scrisse la Rapso-dia económico-política monárquica, sua principale operaeconomica in cui era ben presente la conoscenza delleriforme operate da Vittorio Amedeo II 58. La presenza diSanta Cruz nelle Memorie di Juvarra suggerisce cheforse anche l’architetto messinese possa aver partecipa-to alla conversazione che il marchese teneva nel suopalazzo di Torino e che gli ambasciatori stranieri segna-lavano come uno dei principali centri intellettuali dellacapitale. In questo mondo di militaires savantes si trovava a suoagio anche il biellese Antonio Bertola (-), cuiJuvarra dedicava due memorie fra le più interessantidell’opera, almeno dal punto di vista storico. Figliod’un minusiere, Bertola era riuscito a studiare ed a lau-rearsi in legge; aveva preso parte alle guerre di CarloEmanuele II e di Vittorio Amedeo II, percorrendoun’ottima carriera militare, che aveva portato nel algrado di colonnello 59. Nel era stato chiamato daMaria Giovanna Battista nel corpo docente dell’alloraistituita Accademia Reale come maestro di matematica.Nel aveva assunto le funzioni di regio blasonatore,carica che rimase alla sua famiglia per oltre un secolo.L’elemento forte delle memorie di Bertola era la citta-della di Torino – riprodotta in pianta nella prima e rap-presentata attraverso un particolare architettonico nellaseconda –, di cui nel Bertola era stato uno dei piùstrenui ed abili difensori durante l’assedio francese.
gere un’opera che servisse per l’insegnamento dell’arti-glieria. Erano nati così il Dizzionario istruttivo di tuttele robbe appartenenti all’artiglieria (fig. ) e le oltre tavole dei Dissegni e piante e profili di ogni voce delpredetto, che d’Embser aveva consegnato nel aCarlo Emanuele III, nel frattempo subentrato alpadre 55. Pasini nelle sue Memorie istoriche ricordavache la sua morte all’assedio di Pizzighettone, un anno
. Frontespizio del Dizzionario istruttivo diEmbser. Torino, Biblioteca della scuolad’applicazione
Eppure il dettaglio più interessante è, a mio avviso, unaltro. Le umili origini di Bertola, unite al mestiere diingegnere, non gli avevano consentito di ottenere untitolo o d’entrar a far parte dell’ordine mauriziano.Juvarra, che di Bertola era divenuto amico sin dai suoiprimi anni torinesi, non poteva non saperlo. Eppure, inuna delle due memorie che gli dedicò volle porre unacorona sullo stemma che Bertola aveva regolarmenteregistrato nel 60. Un dettaglio, certo, ma che sfrut-tando le possibilità offerte dall’uso dello stemma e dallanobiltà che spettava ai laureati consentiva a Juvarra direndere l’amico, almeno sulla carta, simile ai suoi colle-ghi romani, coi loro cavalierati e – a volte – titoli nobi-liari. Le memorie di Bertola e, più in generale, la presenzacosì limitata di piemontesi nell’opera di Juvarra mi paresiano un indizio abbastanza chiaro del suo progressivodistacco dal Piemonte. D’altronde Juvarra non era statocerto il solo a vivere quest’esperienza. Furono in diver-si, anzi, ad avvertire con disagio il passaggio dal dina-mismo creativo di Vittorio Amedeo II allo «Stato benamministrato» di Carlo Emanuele III. Juvarra, poi,aveva ragioni sue particolari per voltar pagina e mi pared’aver dimostrato che almeno alcune di esse sono rin-tracciabili nelle pieghe delle Memorie Sepolcrali.
Quando Juvarra era morto da oltre trent’anni, CarloEmanuele III incaricò Daniele Minutoli (-) –un ex ufficiale ginevrino, convertitosi al cattolicesimo edivenuto abate – di scrivere una storia delle campagnemilitari sabaude nelle guerre di successione polacca edaustriaca 61. L’ambasciatore veneto Berlendis al princi-pio del racconta che «nelle sere» in cui il re nonera «occupato da altri affari», Minutoli si recava da luicon la sua opera «di mano in mano» che la scriveva 62. Idue anziani si chiudevano, allora, nelle sale dell’«archi-vio particolare». Qui, mentre il re sedeva, afflitto dall’i-dropisia che gli rese assai dolorosi gli ultimi anni,Minutoli leggeva ad alta voce l’opera che li riportavaagli anni eroici della giovinezza. Nel frattempo, l’inge-gnere topografo Sottis († ), l’unico che conoscesse isegreti dell’archivio che un decennio prima aveva avuto
l’incarico di organizzare, apriva le scansie e ne traevacarte e mappe dei luoghi dove si erano svolte le batta-glie, alcune delle quali fatte preparare appositamenteper l’opera di Minutoli. In una di quelle scansie eranoanche le Memorie Sepolcrali, che qualche anno prima lostesso Sottis aveva inventariato 63. Mi piace pensare chein una di quelle serate, l’opera di Juvarra fosse anch’es-sa tratta dalle «guardarobbe» dell’archivio, trovandofinalmente il suo pubblico 64. Carlo Emanuele III avràpensato con rimpianto al grande architetto che avevaperso troppo presto e che forse non aveva saputo utiliz-zare come avrebbe meritato? Non mi riesce proprio dinon pensare a quanto avrebbe scritto un altro sudditosabaudo in fuga, che nel - correva già perl’Europa, mosso dalla «smania dell’andare»: «bisognaveramente che l’uomo muoia, perché altri possa appu-rare, ed ei stesso, il di lui giusto valore» 65.
NOTE
1 Per ragioni che ignoro, la Lange non pubblicò la foto del sigillo,affidandone le trasmissione alla descrizione di Luisa Gentile:«inquartato, al primo ed al quarto di ... a tre bande di ...; al secondoed al terzo di ... a cinque cuori di ..., bene ordinati» (la cera, è chia-ro, non consentiva di distinguere i colori). Lo stemma era sormonta-to dal cappello di abate, titolo che Juvarra aveva ottenuto nel 1728,e circondato da un nastro con la croce dell’Ordine di Cristo, confe-ritogli nel 1719. Cfr. LANGE 1992, pp. 69 sg. con anche il testoGentile. La lettera si trova in AST, corte, Materie politiche in rap-porto all’estero, Materie politiche in rapporto all’estero in generale,mz. 32 (1733); è diretta ad Antonio Pelleri, agente sabaudo aVenezia e tratta del trasporto a Torino di un quadro di GiovanBattista Pittoni. Il sigillo è su cera nera perché la corte era in luttoper la morte di Vittorio Amedeo II, avvenuta il 31 ottobre 1732.2 Alla metà dei Seicento fiorivano a Napoli i Guevara duchi diBovino. Ai Velez de Guevara apparteneva, invece, il conte IñigoVélez de Guevara y Oñate (1597-1658) che Filippo IV volle vicerèdi Napoli nel 1648 per pacificare la città dopo la rivolta diMasaniello. Erano, poi, un ramo cadetto dei conti di Oñate, queiVelez de Guevara y de la Pegna, stabilitisi in Sicilia. Il nome e lostemma dei Guevara compariva, quindi, in palazzi, chiese, fontanedi tutto il Meridione. Juvarra, per esempio, fermandosi a Napolivide certamente la Fontana della Sellaria, costruita nel 1649 e sor-montata dallo stemma del viceré, dove sul cuore delle armi deiGuevara era l’arma dei Taxis tedeschi, con cui i conti d’Oñate s’era-no imparentati. Lo stesso stemma era usato anche dai rami spagnoli,pur se ognuno vi apportava piccole differenze che servivano a diffe-renziare le varie linee.3 Dopo l’occupazione francese del 1798-99 e 1800-14, il Libro di più
20 Carlo Emanuele I creò cavalieri personaggi del calibro di GiovanBattista Marino (1609), Cesare Ripa, Fulvio Testi (1619) e GabrieleChiabrera. I suoi successori concessero la croce ai principali storiciattivi per la corte: Francesco Caprè e Samuel Guichenon nel 1658,Luca Assarino nel 1662, Pietro Gioffredo nel 1679. Per quantoriguarda i pittori, Carlo Emanuele I fece cavaliere Pier FrancescoMazzucchelli, il Morazzone; Vittorio Amedeo I nel 1634 creò cava-lieri Isidoro Bianchi e Francesco Cairo (che divenne poi conte nel1646); Carlo Emanuele II ascrisse all’ordine Jan Miel e CharlesDauphin; Vittorio Amedeo II fece altrettanto con Daniel Seyter(1695). Sull’ordine cavalleresco sabaudo si vedano MERLOTTI 2002;MERLOTTI 2006.21 In essi, entrambi al Louvre, i due architetti sono avvolti da unampio manto nero: un riferimento al colore dell’Ordine di SanMichele. Lo stesso manto avvolge anche Andrè le Notre nel ritrattoche gli fece Carlo Maratta. Nel Settecento il cordon noiredell’Ordine di San Michele divenne il segno distintivo dei principaliarchitetti (ed artisti) attivi alla corte di Versailles, così come il cordonrouge dell’Ordine di San Luigi lo era dei militari ed il cordon bleudel ben più importante ed elitario Ordine del Santo Spirito lo eradei più grandi nobili di Francia.22 Si veda a questo proposito il saggio di Tommaso Manfredi in que-sto stesso volume.23 LANGE 1992, p. 18.24 Nativo di Tournau e laureatosi ad Halle, Keysler (1689-1743)visitò l’Italia come precettore dei nipoti del barone Bernstorf, mini-stro di Giorgio d’Hannover (Giorgio I d’Inghilterra) come elettoredi Brunswick Lüneburg. Visitando la reggia di Venaria nel 1729 edescrivendo con toni di vivo apprezzamento la Grande galleria, scri-veva: «the designer of this edifice which is extremely admirated wasFilippo the architect». Solo giorni dopo, visitando Superga, gli erastato rivelato il nome completo dell’architetto: «The whole[Superga] was built from a plan and under the direction of donFilippo Juvarra, a native of Messina». Cfr. KEYSLER, I, pp. 236, 238.Traggo i dati su Keysler da NOBLE/GRANGER 1806 III, pp. 505 sg. Edalla London Encyclopaedia 1829, XII, p. 339.25 Diversi mesi dopo la morte di Juvarra, la croce fu inviata a suo fra-tello Francesco. Dopo la morte di questi, nel 1759, passò alla sorellaBenedetta che la fece smontare ed utilizzò i diamanti per un calicevotivo, suo dono alla cappella di San Vincenzo Ferreri in SantaMaria sopra Minerva. Cfr. MANFREDI 1995, in part. p. 293, note 36 e38.26 Sul ritratto di Masucci cfr. GRISERI 1958/1959 (la cit. da p. 154) ela scheda di B. Blasco Esquivias in Juvarra architetto delle capitali1995, p. 319. Il quadro non poté esser dipinto dopo la morte – comesostenuto in Mostra di ritratti 1970 – poiché la croce del Cristo èquella donata a Juvarra dal re di Portogallo, e quindi il pittoredovette vederla di persona. Non si può pensare che Masucci, mortoJuvarra, aspettasse che la croce fosse restituita a Francesco Juvarra(cfr. supra n. 25) per poi recarsi da lui a dipingerla. Mi pare più logi-co pensare che Masucci abbia dipinto Juvarra durante uno dei suoifrequenti soggiorni a Roma nei mesi invernali, magari intorno al1724, anno cui sembra rimandare la forte somiglianza – notata dallaGriseri e dalla Blasco Esquivias – con i ritratti dell’architetto dipintida Pannini nella Veduta del castello di Rivoli verso Levante e nellaVeduta del castello di Rivoli verso Mezzogiorno. Sul ritratto diMeytens cfr. GRISERI 1995a in part. pp. 17 sg. ed ora DARDANELLO
pensieri d’architettura, lasciò gli archivi sabaudi iniziando un percor-so che lo condusse infine nella collezione Tournon. Per una descri-zione del codice e della sua storia rimando a GRISERI 1998.4 Rispetto allo stemma dei Guevara, v’era anche un’altra importantedifferenza. Mentre i cinque cuori – in realtà «panelas», una figuratipica dell’araldica spagnola, che ha una forma oscillante fra il cuoree la foglia di pioppo – erano rappresentati fedelmente, le tre bandeerano rovesciate, così da diventare sbarre (in araldica la banda èquella che va dall’angolo superiore destro a quello inferiore sinistro;la sbarra, al contrario, va dall’angolo superiore sinistro a quello infe-riore destro; destro e sinistro, naturalmente, per chi, in teoria, tienelo scudo, non per chi lo guarda).5 Il disegno è stato pubblicato da Millon nel 1984, otto anni primache l’uscita del saggio della Lange gli permettesse di stabilire unlegame fra lo stemma e Juvarra. Millon ha, comunque, notato il rap-porto fra questo stemma e quello del codice ex-Tournon. Cfr.MILLON 1984a, pp. 41, 109, 199, e 241.6 La semplificazione da inquartato a partito è ribadita, ma le bandenon sono più rovesciate in sbarre.7 Cfr. LANGE 1992, p. 23; BINAGHI 2001, in part. p. 178, nota 120;DARDANELLO 2008.8 Pubblicata da Adamo de’ Rossi nel 1874 (Giornale di erudizioneartistica) è stata più volte ristampata. La si veda, per esempio, inJuvarra architetto delle capitali 1995, pp. 431-434. Francesco Juvarra(1673-1759), fratello maggiore di Filippo, fu noto e celebrato orefi-ce. 9 SCHÜTZE 1992.10 Per un inquadramento del problema non posso che rimandareall’ormai classico DONATI 1998.11 SAINTE MARIE 1718. Cito qui dalla traduzione italiana approntatacinquant’anni dopo: SAINTE MARIE 1761, p. 177. Sul carmelitanoHonoré de Sainte Marie (1651-1729), al secolo Blaise Vauzelle, siveda la voce dedicatagli in LADVOCAT 1755, I, pp. 723 sg.12 Cfr. SCHÜTZE 1992 p. 349 nota 100.13 L’Ordine dei Cavalieri dei Tempio fu sospeso nel 1312. Cfr. FRALE2007, p. 169. 14 Sull’Ordine di Cristo fra Cinque e Settecento sono fondamentaliDUTRA 2006 e OLIVAL 2001.15 GIUSTINIANI 1672.16 BONANNI 1711. L’opera ebbe tre edizioni nel volgere di poco piùd’un decennio. 17 Nelle tavole dell’opera di Bonanni era raffigurato un cavaliere diCristo pontificio con un abito nero, e non col manto biancodell’Ordine portoghese. Si tratta dello stesso manto nero che avvolgel’anziano Bernini nell’incisione di Arnold van Westerhout (BerniniRegista del Barocco 1999, pp. 59 e 304 sg.) e Borromini nel ritrattod’apertura dell’Opus architectonicum, uscito poco dopo il trattato diBonanni. 18 DEZALLIER D’ARGENVILLE 1788, I, p. 458. Nel 1732 Servandoniera stato ascritto anche all’Ordine dello Speron d’Oro. Cfr. Mercurede France, giugno 1733, pp. 1192-1195.19 Si tratta di un episodio che i biografi settecenteschi di Servandoni,da Milizia a d’Argenville, o non conobbero o non vollero raccontareper evitare imbarazzi. La notizia è riportata, comunque, in POLIANO1943, pp. 68 sg. ed in CORTE-REALE 1983, p. 18.
2008, pp. 75 sg. Sul ritratto già all’Università di Torino si vedanoGRITELLA 1992, I, p. 64 e BINAGHI 2000, in part. p. 270.27 Il testo del giuramento è in AST, Mat. eccl., Abbazie, Selve, mz. 3non inv., f. 29. Ad esso era presente come testimone «Saverio, prin-cipe di Valguarnera». Questi era il maggiore dei tre fratelliValguarnera, che ebbero tutti cariche assai rilevanti alla corte sabau-da. Il principe don Francesco Saverio Valguarnera (1689-1739) – ilmaggiore – fu comandante delle Guardie del corpo del re e cavalieredell’Annunziata dal 1737; Pietro (1694-1779), cavaliere di Malta, fucomandante del Reggimento di Sicilia durante la guerra di successio-ne polacca e fu poi gentiluomo di camera del re; il principe donEmanuele (1693-1770), fu comandante le Guardie del corpo del redopo il fratello Saverio; creato maresciallo di campo e cavalieredell’Annunziata nel 1739, fu poi ambasciatore sabaudo in Spagnadal 1739 al 1743, vicerè di Sardegna dal 1748 al 1751 e gran ciam-bellano dal 1751 alla morte. I Valguarnera furono i tra i principalinobili siciliani a restare al servizio sabaudo anche dopo il 1720. Illoro rapporto con Juvarra – attestato anche dalla scelta del principeSaverio come testimone – mi pare sia tutto da ricostruire. Su di lorosi veda LO FASO DI SERRADIFALCO 2001. 28 Nel Seicento l’abbazia di San Pietro era stata prima del gesuitaCarlo Antonio Tesauro († 1643), fratello maggiore di Emanuele, ilgrande scrittore barocco, per poi passare a Filiberto AlessandroScaglia († 1641), ambasciatore sabaudo in Francia immortalato in uncelebre ritratto di Van Dick, e al nipote di questi Filiberto († 1658),anch’egli ambasciatore per il duca di Savoia. L’ultimo abate prima diJuvarra era stato mons. Giovan Domenico Tomatis († 1711), fratellodel vescovo di Asti e a sua volta vescovo, seppur in partibus infide-lium. Cfr. OSBORNE 2002, pp. 66 sg.; SILVESTRINI 1997, p. 298, nota20.29 Sullo scontro fra Roma e Torino esiste un’ampia bibliografia percui rimando a RICUPERATI 2001, pp. 15-88; RICUPERATI 2003. Sullenomine si veda SILVESTRINI 1997, pp. 293-375.30 A Bencini (1664-1744), teologo maltese, ma formatosi a Roma, ilre conferì l’abbazia di San Ponzio (la nomina ad abate precedette dipoco quella a prefetto della biblioteca universitaria). Al padovanoPasini (1687-1770) Vittorio Amedeo II assegnò, invece, il prioratodel Moncenisio, che conferiva titolo abbaziale. Su Bencini si vedanola voce dedicatagli da QUAZZA 1966b e DELPIANO 1997, pp. 152-155, 160-163. Su Pasini si vedano RICUPERATI 2001, pp. 136-144 eDELPIANO 1997, pp. 141 sg., 163-168.31 Cfr. LANGE 1992, pp. 47-82. Si tratta delle pagine migliori sull’ab-bazia di Selve negli anni di Juvarra e sul ruolo d’abate di questi.32 Su quest’album resta fondamentale WITTKOVER 1949.33 Disegni di prospettiva ideale del cav[alier] d[on] Filippo Yuvaraarchitetto e dal medesimo dedicati alla Sagra Real maesta del reAugusto di Polonia (aprile 1732). 34 Sull’attività di Meytens (1695-1770) alla corte sabauda si vedano leschede di Stefania de Blasi sul ritratto di maestà di Vittorio AmedeoII (1728, Regione Piemonte / Reggia di Venaria) e del marescialloBernard Otto von Rehbinder (1728/29, Fondazione Cavour /Castello di Santena,), in La Reggia di Venaria 2007, II, pp. 24 e211 sg. Sull’attività di ritrattista degli Asburgo si veda BARTA 2001,pp. 91-99. 35 L’opera, documentata in una collezione privata piemontese almenodal 1966, è stata acquistata dalla Galleria Sabauda nel 1992. Per unalettura dell’opera si veda GRISERI 1995a, pp. 16 sg. e nota 5.
36 Si veda la voce Anello degli abati regolari in MORONI 1840-1879, II(1840), pp. 71 sg. 37 Traggo la citazione da BINAGHI 2001, pp. 181 sg. L’orazione diCorazzi è conservata alla Biblioteca Nazionale di Torino, Miscella-nea G-IV-7. Al saggio della Binaghi rinvio per l’analisi del ruolo diJuvarra – e dell’Accademia torinese di San Luca – nell’Ateneo tori-nese.38 Cfr. Sentimento di Scipione Maffei intorno al metodo che potrebbedarsi ad uno Studio pubblico, in AST, Corte, Mat. econ., Istruzionepubblica, Università di Torino, mz. 1 d’addizione. Sul rapporto traMaffei e il Piemonte cfr. ROMAGNANI 1986; LEVI-MOMIGLIANO1989; LEVI-MOMIGLIANO 1998.39 Cfr. PELISSETTI 2001, in part. p. 266. Su Juvarra docente si vedanocitati saggi di BINAGHI 2000 e BINAGHI 2001. 40 Cfr. MERLOTTI 2000a.41 Cfr. MONCALVO 1981-1983, in part. p. 90 e LANGE 1992, pp. 18 sg.42 Il documento, datato 23 aprile 1729, è stato poi pubblicato inGRITELLA 1987, pp. 286 sg.43 Cfr. SIGNORELLI 1994, in part. p. 139.44 Tutti i documenti sono editi in GRITELLA 1987. I principali interlo-cutori di Juvarra erano il conte Giuseppe Provana di Pralungo,grand’ospitaliere dell’Ordine, ed il marchese San Martino diRivarolo, gran conservatore. Su quest’ultimo, poi divenuto celebrecome vicerè di Sardegna, mi permetto di rinviare ad MERLOTTI2005.45 Sui soggiorni romani di Juvarra dopo la sua nomina torinese sivedano VIALE 1969 (Palazzo del Conclave), HAGER 1970 (Sacrestiadi San Pietro), KIEVEN 1991 (facciata di San Giovanni in Laterano) eMANFREDI 2001. 46 Fra 1730 e 1735 Juvarra lavorò sostanzialmente a chiudere i can-tieri aperti negli ultimi anni di Vittorio Amedeo II. Oltre a quello diStupinigi si trattava, soprattutto, di quelli relativi alla «zona dicomando»: dal palazzo dell’Accademia Reale, dove fra 1730 e 1731realizzò «ingenti lavori di ristrutturazione», a quello dei Regi Archividi Corte, che costruì fra 1731 e 1734. Si vedano a tal proposito isaggi raccolti in Architettura, governo e burocrazia 2000. Il disegnoche costituisce il progetto di tutti questi lavori è stato recentementeretrodatato a non oltre la primavera del 1730 (quindi ancora duranteil regno di Vittorio Amedeo II). Cfr. MIGHETTO 2000. Fra 1732 e1735 Juvarra lavorò allora anche alla sistemazione della GalleriaRegina (poi Galleria del Beaumont) a Palazzo Reale e degli interni diVilla della Regina. Su di ciò si VEDANO GRISERI 1995b, DARDANELLO2001 (in part. pp. 149-151) e i saggi raccolti in Villa della Regina2005 e Juvarra a Villa della Regina 2008. Fra 1731 e 1733 sembròche Juvarra dovesse realizzare il monumento funebre a BenedettoXIII (atto politico, in quanto papa amico dei Savoia rispetto al suc-cessore Clemente XIII), ma Carlo Emanuele III, dopo due anni diprogetti e discussioni, bloccò l’operazione, giudicando il progettotroppo costoso. Cfr. MANFREDI 2001, pp. 190 sg. 47 DARDANELLO 2007a; DARDANELLO 2007b. 48 Forse non è un caso che in quegli stessi anni egli riprendesse alavorare in area lombarda e veneta, ove aveva avuto sin ad allorasolo incarichi sporadici: nascono allora i progetti della cupola delduomo di Como (1731), del campanile della cattedrale di Belluno(1732), della cupola della chiesa di Sant’Andrea a Mantova (1733),della cupola del Santuario di Caravaggio (1733/34). Nuovi stimoli in
Nicolò Pensabene (1660-1730), un siciliano che era stato fra i princi-pali collaboratori di Vittorio Amedeo II nella battaglia giurisdiziona-lista, divenendo capo del Magistrato della riforma (sorta diMinistero della Pubblica Istruzione) e conservatore dell’Universitàdi Torino dal 1720 al 1728. Per quanto riguarda, poi, le cariche dicorte, ricordo solo che tra coloro che Juvarra aveva conosciuto ederano morti prima del 1734 vi erano due gran ciambellani – il mar-chese Guy Balthesar Pobel de la Pierre († 1731) ed il suo successoreFilippo Guglielmo Pallavicino di Saint Remy († 1732) –, un granmaestro – il marchese Guido Francesco Biandrate Aldobrandino diSan Giorgio (1635 ca-1724), in carica dal 1694 –, e due gran scudieri– il marchese Francesco Maria Adalberto Pallavicino delle Frabose(1645-1719), che aveva ricoperto tale carica dal 1697 alla morte, edil suo successore conte Giovan Michele Piossasco De Rossi di None(1654-1732) –. Diversi di costoro avevano ricoperto tali cariche altermine anche di lunghe carriere militari, che li avevano visti ai gradipiù alti dell’esercito, spesso impegnati nelle battaglie delle guerre diVittorio Amedeo II contro Luigi XIV.54 Su di lui si vedano SFORZA 1909; MERLOTTI, ”Savoia, Asburgo edImpero” (in corso di stampa).55 I manoscritti delle due opere sono ancor oggi conservati allaBiblioteca della scuola d’applicazione di Torino. Cfr. AMORETTI1971; AMORETTI 1981. Recentemente dei due volumi è stata realizza-ta una nuova ristampa anastatica: D’EMBSER 2007.56 PASINI, Memorie istoriche del regno di Carlo Emanuele III, cit.,Memorie dell’anno 1733, cc. 46r-46v.57 Edito a Torino da Mairesse nel 1724-1727 in 10 volumi. Dopo lamorte del marchese l’opera fu tradotta in francese dal marchese diVergy (Reflexions militaires et politiques, traduites de l’espagnol ...par Mr. De Vergy, Paris, Guerin, 1738, 11 voll.; 2a ed. La Haye,1739-1740, 12 voll), affermandosi come un classico della trattatisticamilitare. Ancora cinquant’anni dopo Federico II di Prussia racconta-va di considerarle uno dei suoi libri ispiratori.58 Madrid, Marín, 1732. Su di essa si vedano Cfr. GALMÉS DEFUENTES 2001 e GUASTI 2000, studi cui rimando per la bibliografia.59 Su di lui oltre la voce dedicatagli da CARBONERI 1967 si vedaSIGNORELLI 1995.60 Antonio Bertola registrò nel 1687 come stemma «un scudo d’oroad un orlo d’azzurro carico di sei stelle del primo et un’aquila digueules nel centro». Negli stessi registri egli è qualificato come«signore». Cfr. GENTA/MOLA DI NOMAGLIO/REBUFFO/SCORDO 2000,ad vocem. La corona non può esser letta come un riferimento al tito-lo di conte d’Exilles concesso al figlio adottivo Giuseppe IgnazioBertola-Roveda (1676-1755), poiché questi lo ebbe nel 1742, setteanni dopo la morte di Juvarra.61 Si tratta della Relation des campagnes faites par S.M. et par songénéraux avec des Corps Séparés si conservano oggi solo i volumirelativi alle campagne del 1742-47, mentre sono irreperibili quelledelle campagne del 1733-35. Nel 1740 Minutoli aveva già avuto l’in-carico di redarre un Ragionamento nel quale si espongono li drittidella Casa di Savoia sopra lo Stato di Milano. Cfr. MERLOTTI 2003,p. 148.62 L’episodio è raccontato in una lettera dell’inviato veneto a TorinoGiovanni Berlendis al Senato di Venezia del 4 febbraio 1769. La siveda in Archivo di Stato di Venezia, Senato, Dispacci degli amba-sciatori, Savoia, mz. 18.
nuovi territori. Le idee per la facciata del Duomo di Milano risalgo-no, invece, con tutta probabilità al soggiorno che egli fece nel capo-luogo lombardo fra la fine del 1733 e l’inizio del 1734, chiamatovida Carlo Emanuele III per organizzare le feste da lui date per lanobiltà lombarda in occasione del carnevale.49 Lo stesso titolo può esser letto, in fondo, come un gioco baroccosulla polisemia della parola memoria. D’altra parte, sebbene fosseentrato in Arcadia sin dal 1712 (col nome di Bramanzio Feesseo)basta scorrere una sua lettera, per comprendere come Juvarra fossealieno al mestiere della scrittura. Per parlare agli altri – ed a sé stesso– egli doveva usare gli strumenti in cui era maestro: l’architettura edil disegno.50 GOULEMOT 1987 (la cit. da p. 305). All’epoca di Juvarra era anco-ra lontana quell’affermazione dell’individuo che sarà invece prodot-to dell’Illuminismo. La bibliografia su questi temi è semplicementesterminata. Rimando qui solo ai saggi raccolti in Metamorfosi deiLumi 2000, da cui il lettore potrà partire per le necessari ricognizio-ni in merito. Chissà se Juvarra conobbe o anche solo sfiorò JeanJacques Rousseau in quel 1728 in cui il giovane ginevrino fu a servi-zio dal conte di Govone (un servizio di cui, come è noto, ha lasciatouna mirabile descrizione nelle Confessioni). Juvarra conosceva beneil conte Ottavio Solaro di Govone, personaggio fra i più importantidella corte sabauda. Fu con lui che fece il viaggio dalla Sicilia aTorino e forse collaborò ai lavori per il suo castello, che certo visitò.Cfr. BROVIA 1997, p. 32.51 Nella memoria dell’architetto Giovan Battista Contini, che pureindica giustamente come cavaliere, non disegna la croce dell’Ordinedi Cristo, forse perché non era sicuro dell’ordine cui questi apparte-neva. In alcuni casi ignora del tutto i titoli dei protagonisti delle suememorie: non sapeva, per esempio, che Dorigny era cavaliere (ma,d’altra parte, ignorava anche che fosse ancora vivo nel momento incui ne disegnava la tomba). Non sapeva, ma non avrebbe potutosaperlo, che Giovan Battista Gaulli era anch’egli cavaliere di Cristo,poiché il pittore genovese aveva voluto tenere nascosta la sua ascri-zione all’Ordine (Cfr. SOPRANI/RATTI 1768-1769, II (1769), pp.81 sg. e 85: Ratti racconta che Gaulli aveva nascosto la nomina acavaliere ai suoi stessi famigliari, che l’avevano scoperta solo dopo lamorte, trovando il diploma fra le carte del pittore). In alcuni casi,poi, non conoscendo o non ricordando quale fosse lo stemma deisuoi personaggi se lo inventò di sana pianta: è il caso di quello diCarlo Maratta, come emerge dal confronto con quello che egli stessosi fece scolpire sulla tomba.52 Cfr. Giuseppe Pasini, Memorie istoriche del regno di CarloEmanuele III duca di Savoia e primo di questo nome re di Sardegnadall’anno 1730 in AST, Corte, Storia della Real Casa, cat. III, Storieparticolari, mz. 3 d’addizione, Carlo Emanuele III, f. 3, Memoriedell’anno 1734, cc. 52r-52v. Al ballo, giudicato magnifico per l’appa-rato juvarriano, partecipò anche il re che volle danzare con variedame dell’aristocrazia milanese, presentandosi senza baldacchino esenza verun distintivo reale. Proprio il tono «sciolto e cordiale» delre fu malvisto dai milanesi, abituati al sussiego ed al «rigido formali-smo asburgico». Cfr. ANNONI 1953, p. 173. Sui lavori eseguiti daJuvarra per Carlo Emanuele III durante la guerra si veda PATETTA1914.53 Fra i ministri erano scomparsi nel 1730 il conte Pierre Mellarédede Bettonet (1659-1730), diplomatico noto in tutta Europa, membrodella Royal Society di Londra, protagonista della pace di Utrecht, esegretario di Stato agli interni dal 1717 alla morte, ed il marchese
63 L’inventario realizzato da Giovan Battista Sottis nel 1764 è statopubblicato a cura di G. Giacobello Bernard in Juvarra architettodelle capitali 1995, pp. 437-442. Le Memorie Sepolcrali sono al n. 62(p. 440). 64 Carte e mappe erano nelle «guardarobbe» C, D ed E. I disegni diarchitettura nella vicina «guardarobba» F. Le scansie dell’archiviopersonale del re furono in seguito smantellate per ordine di CarloAlberto e ricomposte alla palazzina di Stupinigi. Cfr. CORNAGLIA1998.65 ALFIERI 1981, p. 138.
Referenze fotografiche-, : Autore; : GRISERI , p. ; : MILLON a, p. ; : VonBernini bis Piranesi , p. ; : Guarini, Juvarra e Antonelli ,p. ; : Guarini, Juvarra e Antonelli , p. ; : Juvarra architettodelle capitali , p. ; : Guarini, Juvarra e Antonelli , p. ;: Juvarra architetto delle capitali , p. ; : WITTKOVER , p.