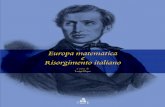Lo sfruttamento della risorsa animale in Puglia tra il X e lʼXI secolo: il contributo della ricerca...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Lo sfruttamento della risorsa animale in Puglia tra il X e lʼXI secolo: il contributo della ricerca...
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
279
Introduzione
In un’ottica di approccio globale allo studio deipaesaggi antichi inteso come adozione integrata difonti e strumenti di indagine diversi, applicato ormaida alcuni anni all’analisi dell’Apulia tardoantica e al-tomedievale 1, le ricerche archeozoologiche rappre-sentano un filone di indagine autonomo e allo stessotempo in costante dialogo con le scienze naturali e sto-rico-archeologiche. Risultato delle attività economi-che, sociali e culturali di un determinato gruppoumano, le ossa animali rinvenute in siti archeologici equindi inserite in un preciso contesto territoriale, sto-rico e archeologico, acquistano un peso rilevante nellamisura in cui contribuiscono a definire alcuni aspettidella ricostruzione storica legati alle attività economi-che d’allevamento, al regime alimentare e all’am-biente. Produzione e consumo possono essere definitigli estremi di una vicenda economica condizionata daagenti direzionali di natura sociale ed ambientale, traloro dipendenti e frequentemente in conflitto: poterecentrale ed articolazioni periferiche, insediamento ru-rale e nucleo urbano, commercio e autoconsumo, agri-coltura ed allevamento.
Se fino agli anni Settanta del secolo scorso le ri-cerche archeozoologiche hanno privilegiato i siti di etàpreistorica 2, i risultati raggiunti in contesti storici e so-prattutto medievali sono abbastanza recenti, grazie al-l’impulso di studiosi come G. Barker o J. Cartledge 3.Il bilancio presentato da P. Baker e G. Clark nel 1993 4,sui metodi e sui risultati raggiunti fino ad allora dal-
l’archeozoologia, sottolineava la rarità di indaginisvolte nel Mezzogiorno 5 rispetto al più dinamico statodegli studi in Italia settentrionale 6 e, in generale, inEuropa. In Italia meridionale le indagini archeozoolo-giche sono state raramente inserite in organici progettidi ricerca storico-archeologica: poche eccezioni, perquanto riguarda l’età tardoantica e altomedievale, sonorappresentate dai dati registrati per la villa di San Gio-vanni di Ruoti 7 e per i siti urbani di Carminiello aiMannesi (Napoli) 8, Herdonia (Ordona) 9 e Otranto 10.
Il dibattito storiografico sull’allevamento in Pugliatra età bizantina ed occupazione normanna ha cono-sciuto uno sviluppo limitato rispetto agli studi condottisulle modalità di utilizzo della risorsa animale nel pe-riodo svevo, angioino e primo aragonese, in conse-guenza del riconoscimento di un ruolo economicocentrale affidato dalla Corona a strutture massarialispecializzate ed alla transumanza ovina 11. Tra la finedegli anni Ottanta ed i primi anni Novanta del secoloscorso, accanto alla necessità di incrementare il datoarcheologico e di fronte ad una documentazione d’ar-chivio in cui la sola grande proprietà monastica ed ildemanio emergevano quali maggiori gestori del patri-monio zootecnico della regione, si individuavano al-cuni caratteri specifici dell’attività di mantenimentodel bestiame tra X ed XI secolo 12. Gli animali di pic-cola taglia, pecore e maiali, risultavano più frequentidei bovini e degli equini; gli ovini garantivano la pro-duzione di lana e latte, con l’abbattimento di agnelli edi adulti sterili non più adatti alla riproduzione; i suinicostituivano la principale risorsa carnea. J. M. Martin
1 Si veda Volpe 2005b, 299.2 Tagliacozzo 1993.3 Barker 1981, Cartledge 1981.4 Baker, Clark 1993.5 Si ricordino le indagini condotte a Santa Maria in Cività,
in Molise (Barker 1980), Santa Maria d’Anglona in Basilicata(Whitehouse 1969, 72-74) e nel villaggio normanno-svevo diBrucato (Bossard-Beck 1984, Bossard-Beck, Maccari-Poisson1984). In Puglia, Otranto rappresenta l’unico caso, fino aglianni Novanta, di contesto urbano oggetto di un progetto ar-cheozoologico (Cartledge, Clark, Higgins 1992).
6 Si vedano il recente bilancio di Salvadori 2003 per l’Italiacentro-settentrionale e, in generale, gli Atti dei Convegni Na-zionali di Archeozoologia dal 1993 al 2010.
7 MacKinnon 2002.8 King 1994.9 Leguilloux 2000; Simone 2000; Buglione, De Venuto
2008.10 Cartledge, Clark, Higgins 1992.11 Cfr. Licinio 1983; Id. 1998.12 Cfr. Martin, Noyé 1989, 580-582.
Lo sfruttamento della risorsa animale in Puglia tra il X e lʼXI secolo:
il contributo della ricerca archeozoologica
di Antonietta Buglione, Giovanni De Venuto*
* Dipartimento di Scienze Umane - Università degli Studi di Foggia; [email protected]; [email protected].
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
280
constatava, contrariamente all’Italia Settentrionale,una più diffusa presenza della pecora/capra rispetto almaiale. Il bue era utilizzato soprattutto come forza la-voro, mentre rare erano le notizie sui cavalli, i volatilie la selvaggina. Una specializzazione maggiore del-l’allevamento si sarebbe verificata dal XII secolo 13. P.Toubert individuava, con l’avvento normanno nelMezzogiorno, un’accentuata contrapposizione tra areed’incolto e porzioni di terra coltivate, osservando unaprevalenza delle prime sulle seconde, contestualmentead una intensificazione del fenomeno dell’incastella-mento ed all’istituzionalizzazione di un’entità fiscaleed insieme ambientale quale la foresta 14. A tale feno-meno sarebbe corrisposto un incremento quantitativodelle risorse proprie dell’allevamento 15.
L’indagine archeozoologica proposta in questasede sulla base dell’analisi dei campioni faunistici pro-venienti dai siti pugliesi di Vaccarizza (FG), Ordona(FG), Canosa-San Pietro (BT) ed Apigliano (LE) (fig.1) 16, ridimensionando un approccio fortemente deter-ministico, su base ambientale, e di continuità culturalenello studio del rapporto economico intercorso trauomo ed animale, riconosce come variabili discrimi-nanti degli orientamenti di produzione e consumo di
un gruppo umano la condizione sociale delle popola-zioni e la finalità dell’insediamento all’interno del pro-prio territorio.
A.B. - G.D.V.
Vaccarizza
I datiIl campione faunistico risulta composto da 12.721
frammenti ossei, dei quali 5.032 (39,6%) determinabili,7.689 (60,4%) non attribuibili, per estrema frammenta-rietà, ad alcun taxon animale. I reperti sono distribuititra i due principali periodi storici riconosciuti archeolo-gicamente: 6.742 (il 53% del totale) sono databili ad etàbizantina (X-prima metà XI secolo), 5.979 (il 47%) adetà normanna (seconda metà XI-prima metà XIII se-colo). Per l’età bizantina (tab. 1) gli animali domesticisono i più attestati con il 54,06% del N.R. ed il 56,3%del N.M.I.: in particolare si riscontrano elevate percen-tuali di suini, seguite da quelle degli ovicaprini e dei bo-vini. Bassa è la frequenza dei frammenti ossei deiselvatici: risulta interessante osservare come particolareattenzione fu rivolta dagli abitanti del sito allo sfrutta-
13 Martin 1993, 377-384.14 Toubert 1997, 302 e 319-324.15 Porsia 1987, 247.16 Per il dato storico-archeologico cfr. Cirelli, Noyé 2003 con
bibliografia precedente; Mertens 1995, Volpe 2000; Volpe et
alii 2003 e 2007; Arthur (ed.) 1999; Arthur, Bruno (eds.) 2009.È necessario però precisare, che in alcuni casi (ad es. per Or-dona e Canosa), non è stato possibile distinguere specificata-mente i campioni di X-XI sec. da una più ampia fase relativa alVII-X sec. e ad un periodo genericamente ascrivibile a ‘dopo ilX sec.’.
1. - Localizzazione dei siti da cui provengono i campioni archeofaunistici (elaborazione di N. M. Mangialardi).
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
281
mento della lepre. Secondo gruppo faunistico maggior-mente attestato all’interno del campione archeozoolo-gico è quello dell’avifauna: il pollo rappresentò,verosimilmente, una delle principali risorse alimentaridell’insediamento umano, accanto ad altri volatili do-mestici e selvatici. Non secondario risulta anche l’ap-provvigionamento di pesci e molluschi: in età bizantina,sembrerebbe esserci stata una domanda di mercato spe-cifica per spigole, cefali e seppie 17. Tra seconda metàdell’XI e prima metà del XIII secolo (tab. 2) le speciedomestiche restano quelle maggiormente attestate al-
l’interno del campione faunistico: in crescita appaionole percentuali di bovini ed ovicaprini, mentre i suini ri-sultano la specie rappresentata dal più alto numero diframmenti ed individui. Un sostanziale incremento con-nota le percentuali di tartaruga terrestre e delle speciedi animali selvatici. Una netta diminuzione conosconole specie avicole. Pesci e malacofauna incidono, rispet-tivamente, solo per lo 0,7% e lo 0,6%.
Per i bovini è possibile che si sia proceduto ad unaselezione nella pratica di allevamento del bestiame,per destinare al consumo alimentare gli esemplari nonancora in piena età adulta (prima dei 36 mesi) e di-sporre di carni più tenere e di più elevata qualità 18.
Il dato relativo alla fusione epifisiaria negli ovica-prini mostra una sostanziale differenza tra periodo bi-
17 Lo studio dei resti ittici è affidato a M. Battafarano e J.De Grossi Mazzorin (Università del Salento).
18 In base a Silver 1969.
Taxa
N.R. % N.M.I. %
Animali domestici
Cavallo - Equus caballus L. 22 0,8 9 1,9
Asino - Equus asinus L. 5 0,2 2 0,5
Equini - Equus sp. 1 0,03 1 0,2
Bue - Bos taurus L. 99 3,4 37 7,8
Pecora o Capra - Ovis vel Capra 366 84
Pecora - Ovis aries L. 36 14
Capra - Capra hircus L. 6
14,2
4
21,6
Maiale - Sus domesticus Erx. 1020 35,4 114 24,1
Cane - Canis familiaris L. 1 0,03 1 0,2
Animali selvatici
Cervo - Cervus elaphus L. 6 0,2 4 0,8
Capriolo - Capreolus capreolus L. 6 0,2 3 0,6
Cinghiale - Sus scrofa ferus L. 2 0,06 1 0,2
Lepre - Lepus sp. 66 2,3 18 3,8
Microfauna
Microfauna ind. 2 0,06 - -
Avifauna
Pollo - Gallus gallus L. 659 22,9 120 25,4
Cigno - Cygnus olor L. 1 0,03 1 0,2
Gru - Grus grus L. 1 0,03 1 0,2
Oca - Anser sp. 30 1 10 2,1
Branta - Branta sp. 2 0,06 2 0,5
Anatra - Anas sp. 48 1,7 17 3,6
Alzavola - Anas crecca L. 2 0,06 1 0,2
Colombiforme - Columba sp. 35 1,2 22 4,6
Pavoncella - Vanellus vanellus L. 8 0,3 4 0,8
Fagiano - Phasianus colchicus L. 2 0,06 1 0,2
Uccelli ind. - Aves 233 8,1 - -
Rettili
Testuggine - Testudo hermanni Gml. 5 0,2 2 0,5
Pesci
Pesci - Pisces 109 3,8 - -
Decapoda
Granchi ind. - Decapoda 4 0,1 - -
Molluschi
Molluschi ind. - Mollusca 2 0,06 - -
Seppia - Sepia sp. 101 3,5 - -
Mussolo - Arca noae L. 1 0,03 - -
Totale identificati 2881 100 473 100
Coste 829 21,5 - -
Vertebre 511 13,2 - -
Coste avifauna 7 0,2 - -
Vertebre avifauna 83 2,1 - -
Frammenti indeterminabili 2431 63 - -
Totale indeterminabili 3861 100 - -
Tabella 1. Vaccarizza (X-prima metà XI secolo): elencodelle specie identificate e relativi numero di resti(N.R.) e numero minimo di individui (N.M.I.).
Taxa
N.R. % N.M.I. %
Animali domestici
Cavallo - Equus caballus L. 35 1,6 10 2,4
Asino - Equus asinus L. 9 0,4 9 2,1
Equini - Equus sp. 2 0,09 1 0,2
Bue - Bos taurus L. 203 9,51 50 11,9
Pecora o Capra - Ovis vel Capra 482 93
Pecora - Ovis aries L. 35 9
Capra - Capra hircus L. 3
24,31
3
25
Maiale - Sus domesticus Erx. 974 45,41 134 31,8
Cane - Canis familiaris L. 7 0,3 6 1,4
Gatto - Felis catus L. 2 0,09 2 0,5
Animali selvatici
Cervo - Cervus elaphus L. 28 1,3 12 2,8
Capriolo - Capreolus capreolus L. 9 0,4 4 0,9
Cinghiale - Sus scrofa ferus L. 8 0,3 1 0,2
Volpe - Vulpes vulpes L. 16 0,8 1 0,2
Lepre - Lepus sp. 15 0,7 9 2,1
Talpa - Talpa sp 2 0,09 2 0,5
Microfauna
Microfauna ind. 5 0,2 - -
Avifauna
Uccelli ind. - Aves 22 1 - -
Pollo - Gallus gallus L. 164 7,71 44 10,4
Oca - Anser sp. 6 0,2 5 1,2
Anatra - Anas sp. 9 0,4 4 0,9
Columbiforme - Columba sp. 4 0,1 2 0,5
Rettili
Testuggine - Testudo hermanni Gml. 79 3,7 21 5
Pesci
Pesci - Pisces 15 0,7 - -
Decapoda
Granchi ind. - Decapoda 2 0,09 - -
Molluschi
Molluschi ind. - Mollusca 1 0,05 - -
Seppia - Sepia sp. 6 0,2 - -
Unio - Unio sp. 7 0,3 - -
Conide del Mediterraneo - Conus mediterraneus L. 1 0,05
Totale identificati 2151 100 422 100
Coste 893 23,2 - -
Vertebre 337 8,8 - -
Vertebre avifauna 8 0,2 - -
Frammenti indeterminabili 2590 67,6 - -
Totale indeterminabili 3828 100 - -
Tabella 2. Vaccarizza (seconda metà XI-XIII secolo): elenco delle spe-cie identificate e relativi numero di resti (N.R.) e numero minimo di in-dividui (N.M.I.).
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
282
Antonietta Buglione, Giovanni De Venuto
zantino e normanno: ad un quasi dimezzamento diossa con epifisi non fuse, tra XI e XIII secolo, ilquantitativo di elementi epifisiari fusi cresce di trevolte rispetto al X-XI secolo. In particolare più alta èper il periodo bizantino la quantità di animali abbat-tuti prima dei 3-4 anni di vita e soprattutto prima diun anno. Queste osservazioni sembrerebbero essereconfortate anche dalla lettura delle curve di soprav-vivenza e dagli istogrammi di mortalità costruiti sullabase dell’analisi delle usure dentarie (figg. 2-5). Dalconfronto tra i grafici, pur considerando la minorepresenza di mandibole e denti sciolti 19, emerge comein età bizantina più accentuata fosse l’attenzione ri-volta all’uccisione dei giovani individui ancora in etàda latte. Durante l’occupazione normanna dell’inse-diamento il modello di uccisione dei caprovini sem-brerebbe privilegiare il bestiame compreso tra i dueed i quattro anni.
Il confronto quantitativo tra elementi osteologici dimaiale con epifisi fuse e non fuse non sembrerebbe faremergere particolari distinzioni nella modalità di uc-cisione degli animali tra età bizantina ed età nor-manna: la strategia di uccisioni più diffusa per l’interafase di frequentazione medievale del sito appare quellache privilegia gli animali non superiori al secondoanno di vita. Il dato derivato, però, dall’analisi del-l’usura e rimpiazzamento dei denti, individua una so-stanziale differenza percentuale per i resti di suini al disotto dei 7 mesi e tra 7 e 11 mesi: esse risultano quasiinvertite tra età bizantina ed età normanna, periodo incui sembrerebbe emergere, dunque, un maggiore sfrut-tamento carneo di esemplari giovanili.
Discussione
L’allevamento dei domestici era ampiamente pra-ticato sul territorio; in particolare, nella seconda fasestorica, è evidente un incremento percentuale di bue epecora/capra ed una diminuzione dei maiali che re-stano, però, il bestiame privilegiato nella domanda dimercato del gruppo umano (tab. 3).
Il bue risulta essere stato consumato più raramentein età bizantina: per l’intera sequenza insediativa essofu macellato prevalentemente in età subadulta (tra idue ed i tre anni) fornendo carni di buona qualità. Una
19 Per il periodo bizantino si dispone complessivamente di 11elementi dentari; per quello normanno di 23.
2. - Vaccarizza (età bizantina): curva di mortalità degli ovi-caprini (in base a Payne 1973) (tot.:11 elementi).
3. - Vaccarizza (età normanna): curva di mortalità degli ovi-caprini (in base a Payne 1973) (tot.: 23 elementi).
4. - Vaccarizza (età bizantina): istogramma relativo alle per-centuali di uccisioni per classi dʼetà degli ovicaprini (tot: 11elementi).
5. - Vaccarizza (età normanna): istogramma relativo alle per-centuali di uccisioni per classi dʼetà degli ovicaprini (tot.: 23elementi).
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
283
maggiore attenzione all’approvvigionamento proteicoprimario per l’età normanna deriva anche dal modellodi abbattimento delineato per i caprovini: fortementeridotti appaiono in questo periodo, rispetto al X-XI se-colo, la produzione ed il consumo di latte. La scarsa at-tenzione alla lana 20, inoltre, potrebbe essere inter-pretata come ulteriore dimostrazione di attività arti-gianali legate alla trasformazione del prodotto di ori-gine animale, esterne all’insediamento. Per i suini piùfrequente è l’uccisione di esemplari maschili compresitra i 19 ed i 24 mesi, ad indicare un allevamento at-tento ad ottenere la massima resa con il minore im-piego di risorse per il sostentamento del bestiame: lapiù alta percentuale di giovanili inferiori al primo annodi età nella fase normanna potrebbe indicare una ri-chiesta di carni pregiate maggiore rispetto al X-XI se-colo. I consumi di età bizantina furono verosimilmenteintegrati, in maniera cospicua, dalla circolazione deiprodotti avicoli ed ittici. Le percentuali di pollo e dialtri uccelli domestici e selvatici si riducono drastica-mente con il passaggio alla seconda metà dell’XI-XIIIsecolo. Precedentemente è possibile ipotizzare un al-levamento intensivo di pollame testimoniato anchedall’attestazione di alcune patologie a livello dei tar-sometatarsi, la cui diffusione poteva essere favoritadalle stesse modalità di mantenimento degli animali. Iresti di pesce testimonierebbero possibili attività spe-cializzate di pesca sulla costa o pertinenze di tipo itti-colo direttamente dipendenti dalla civitas bizantina.Scarso fu per l’intero periodo medievale, ad eccezionedi alcune forme di piccola caccia quali la lepre o l’uc-cellagione (X e XI secolo), il contributo all’economiae all’alimentazione fornito dai mammiferi selvatici. Inetà normanna sembrerebbe accentuarsi una tendenzaall’attività venatoria dei grandi mammiferi, in parti-colare del cervo.
G.D.V.
Ordona
I dati: VII-X secoloIl campione faunistico attribuibile al VII-X secolo
d.C. è formato da 2.923 frammenti, di cui è stato pos-sibile determinarne 1.845, pari al 63,2%; 1.078 (36,8%)sono costituiti da coste e vertebre e da resti non deter-minabili (tab. 4) 21. Ovicaprini e bovini risultano le ca-tegorie domestiche maggiormente rappresentate(rispettivamente 45% e 40% del N.R.; 34% e 28% delN.M.I.), seguite dai suini. Il pollo ricopriva, nella dietaumana, un ruolo minore (fig. 6), anche se si registra,rispetto ai secoli precedenti, un incremento dei resti edelle percentuali relativamente all’intero campione eai principali animali domestici (bovini, ovicaprini,suini) 22; risulta attestata anche l’oca domestica. Mode-sta appare la presenza di equini (3,4% dell’intero cam-pione), anche in confronto alla fase tardoantica (fineV-VII sec.). Poche, inoltre, risultano le ossa attribuibiliad animali selvatici (1,23% di cervidi e lepre). I mol-luschi non rappresentavano una sostanziale fonte ali-mentare, ancor meno che nei periodi precedenti,costituendo poco più dell’1% del totale dei resti.
20 Basse sono le percentuali d’individui sopravvissuti oltre iquattro anni.
21 I dati sono ricavati dallo studio dei resti raccolti nelle cam-pagne di scavo dal 1997 al 2000 e rappresentano, quindi, unampliamento della ricerca avviata su un campione faunisticoristretto al settore termale, per cui si veda Buglione, De Venuto2008. Ringraziamo il prof. Giuliano Volpe per aver incorag-giato e per continuare a sostenere tali studi archeozoologici.
22 Per questo e altri dati relativi alle fasi tardoantiche, si vedaBuglione 2006, 521 e Ead. 2009a.
Età bizantina Età normanna Specie
N.R. % N.M.I. % N.R. % N.M.I. %
bovini 98 6,4 37 14,6 203 12 50 17,3
ovicaprini 408 26,8 102 40,3 520 30,6 105 36,3
suini 1020 66,8 114 45,1 974 57,4 134 46,4
Totale 1526 100 253 100 1697 100 289 100
Tabella 3. Vaccarizza: percentuali dei principali animali do-mestici utilizzati nellʼalimentazione.
Taxa N.R. % N.M.I. %
Animali domestici
Cavallo-Equus caballus L. 31 1,68 9 3,75
Asino-Equus asinus L. 29 1,57 3 1,25
Equino Equus sp. 3 0,16 1 0,41
Bue- Bos taurus L. 590 31,9 56 23,33
Pecora o Capra- Ovis vel
Capra 615 50
Pecora- Ovis aries L. 30 10
Capra- Capra hircus L. 21
36,09
8
28,32
Maiale-Sus domesticus Erx. 238 12,9 53 22,08
Cane-Canis familiaris L. 63 3,41 14 5,83
Gatto- Felis catus L. 7 0,37 2 0,83
Animali selvatici
Cervo- Cervus elaphus L. 10 0,54 4 1,66
Capriolo- Capreolus
capreolus L. 11 0,59 2 0,83
Lepre- Lepus europaeus
Pall. 2 0,1 2 0,83
Avifauna
Uccelli ind.- Aves 1 0,05 1 0,41
Pollo- Gallus gallus L. 157 8,5 23 9,58
Oca domestica- Anser
domestica 12 0,65 2 0,83
Molluschi - -
Ostrica- Ostrea edulis L. 19 1,02 - -
Lutraria- Lutraria lutraria
L. 2 0,1 - -
Tellina- Donax trunculus L. 1 0,05 - -
Unio- Unio elongatulus P. 4 0,21 - -
Totale identificati 1845 100 240 100
Coste animali grossa taglia 204 18,9 - -
Coste animali piccola taglia 94 8,71 - -
Vertebre animali grossa
taglia 165 15,3 - -
Vertebre animali piccola
taglia 56 5,19 - -
Frammenti indeterminabili 559 51,85 - -
Totale indeterminabili 1078 100 - -
Tabella 4. Ordona (VII-X secolo): elenco delle specie identi-ficate e relativi numero di resti (N.R.) e numero minimo diindividui (N.M.I.).
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
284
Antonietta Buglione, Giovanni De Venuto
Pecore e capre erano probabilmente allevate perfornire lana e carne, a giudicare dalla curva di soprav-vivenza e dall’istogramma di mortalità ricavati dal-l’usura dentaria (29 fra mandibole e denti sciolti) (figg.7-8). L’analisi della fusione delle ossa lunghe confer-merebbe questo dato, evidenziando anche un piùampio interesse per la produzione di latte, oltre che pertagli di carne pregiata (quasi il 30% fra 68 individuidi cui è stato possibile stabilire l’età di morte fu ab-battuto prima di 12 mesi) 23. L’allevamento dei bovinidovette essere abbastanza diversificato: la maggiorparte dei capi fu abbattuta entro i tre anni di età per ri-cavarne carne di qualità, una buona percentuale vennetenuta in vita fino ad età avanzata per essere impiegata
come forza-lavoro 24. I suini rappre-sentavano un’importante fonte pro-teica: in base all’osservazione dellafusione epifisaria, dell’eruzione edell’usura dentaria 25, risulta che il41% di 49 individui fu ucciso fradue-tre anni, il 37% al di sotto delprimo anno di vita (tra cui alcuni apochi mesi), fornendo evidentementecarne gustosa e di più immediato re-perimento (tab. 5).
A.B.
I dati: XI-XIII secolo
Per i secoli XI-XIII, il campionedelle tre principali specie domesticherisulta composto da 271 resti di bue(29 individui), 411 di pecora/capra(53 individui), 279 di maiale (50 in-dividui).
In età normanno-sveva gli ovica-prini appaiono funzionali alla dispo-nibilità di carne, allo stesso modo delmaiale, abbattuto prevalentementetra il primo ed il secondo anno divita. I bovini erano probabilmente in-trodotti nella dieta alimentare degliabitanti di Ordona, alla fine dellapropria attività di supporto dellaforza lavoro umana in agricoltura.
G.D.V.
23 In base a Bullock, Rackham 1982.
24 In base a Barone 1974, Silver 1969.25 In base a Bull, Payne 1982.
6. - Ordona (VII-X secolo): percentuali delle principali speciedomestiche utilizzate nellʼalimentazione, distinte per nu-mero di resti (N.R.) e numero minimo di individui (N.M.I.).
7. - Ordona (VII-X secolo): curva di mortalità degli ovicaprini (in base a Payne1973) (tot.: 29 elementi).
8. - Ordona (VII-X secolo): istogramma relativo alle percentuali di uccisioni perclassi dʼetà degli ovicaprini (tot.: 29 elementi).
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
285
Lo sfruttamento della risorsa animale in Puglia tra il X e l’XI secolo: il contributo della ricerca archeozoologica
Discussione
Il campione faunistico considerato suggerisce chel’allevamento degli animali domestici fu l’attivitàmaggiormente sviluppata nell’abitato altomedievale diHerdonia, le cui tracce archeologiche, dopo il VII se-colo, sono ancora evanescenti 26. Il dato archeozoolo-gico contribuirebbe quindi a ridimensionare l’ipotesidi un abbandono della città dopo il processo di rura-lizzazione che si verificò a partire dalla fine del V se-colo 27, esortando a credere a forme di occupazionedell’area piuttosto organizzate, seppure sporadiche oprecarie. L’attestazione degli ovicaprini come princi-pale gruppo domestico, rappresentato sia da individuigiovanili che adulti, indicherebbe, anche per il periodoaltomedievale, una diffusa pratica dell’allevamento dipecore e capre, probabilmente di tipo transumante:evidentemente l’abitato formatosi all’indomani delleinvasioni longobarde continuava a svolgere in talsenso una funzione centrale, sebbene in forme e di-mensioni mutate 28. La lana costituiva uno dei prodottimaggiormente ricavati : essa rappresentava, ancora perquesti secoli, una risorsa economica di rilievo, desti-nata a soddisfare domande di mercato anche esterne 29.I bovini, secondo gruppo rappresentato, erano sfruttatia scopi alimentari e agricoli: la presenza equilibrata ditutte le porzioni scheletriche e di individui giovanili,adulti e di sesso femminile 30 potrebbe indicare un al-levamento e un consumo interno al villaggio. La per-centuale di suini abbattuta entro i tre anni suggerisceuna gestione della risorsa volta ad ottenere la massimaresa di carne e grasso; la carne dei maialini, gustosa,
era comunque richiesta. Per le principali specie do-mestiche non si può inoltre escludere che esistesseroforme di scambio di carni e prodotti derivati su breveo più ampio raggio.
La non trascurabile attestazione di resti di gallo do-mestico, congiuntamente ai pochi frammenti ossei at-tribuibili all’oca, rinvierebbe a diffuse pratiche diallevamento da cortile, con cui potrebbe spiegarsi, pro-babilmente, la patologia riscontrata su un omero di unindividuo di pollo affetto da una lesione traumaticacon formazione di callosità 31.
Il foro osservato su alcune valve di ostrica (speciemaggiormente attestata tra i molluschi) potrebbe esserericonducibile a modalità di trasporto della risorsa versoil sito, similmente a quanto osservato a San Giovannidi Ruoti e, in Puglia, ad Otranto ed Egnazia32 (fig. 9). Lapresenza, inoltre, di resti di unio documenterebbe il con-
26 Volpe 2000, 538-541; Id. 2005a, 239-240.27 Sulla fase di ‘villaggizzazione’ e ruralizzazione di Her-
donia dalla fine del V secolo, cfr. Volpe 2000, 533-537, Id.2006a.
28 Herdonia e il vicino sito rurale di San Giusto svolgevano,tra V e VI secolo, varie funzioni all’interno del territorio circo-stante, tra cui quella di supporto logistico all’allevamento tran-sumante (Volpe 2000, 535). Per i caratteri generali e gli sviluppidella pratica fra Tardoantico e Altomedioevo cfr. la raccolta difonti storiche e diplomatiche in Volpe 1996, 289-297; Id. 2005a;Id. 2005b, Id. 2006a; Id. 2006b e ora in Volpe 2010. Per un ap-
proccio archeozoologico alla tematica, si veda inoltre Vie deglianimali, vie degli uomini, e in particolare, relativamente all’etàtardoantica e medievale, i contributi di A. Buglione e G. De Ve-nuto (2010).
29 A tal proposito cfr. Buglione 2010.30 Buglione 2005-2006, Ead. 2006.31 Si veda anche Buglione, De Venuto 2008, 260, fig. 25.
Tale frattura potrebbe essere stata causata dalla pratica di te-nere legati i volatili: cfr. una simile patologia osservata a Veronada Riedel, Rizzi 2000, 346.
32 Cfr. Cretella 1994; Reese 1992, 349; Id. 2002, 189-190.
Classi di età
Ordona < 7 m 7-11 m 12-18 m 19-23 m
31-35 m >36 m
Totale
individui
VII-X secolo 6 12 10 6 14 1 49
Tabella 5. Ordona (VII-X secolo):mortalità dei suini per N.M.I. e inbase alla fusione epifisiaria, al-lʼeruzione, rimpiazzamento e usuradei denti (Bull, Payne 1982).
9. - Valve di ostrica forate da Ordona (VII-X sec.).
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
286
Antonietta Buglione, Giovanni De Venuto
sumo di molluschi di acqua dolce, provenienti proba-bilmente dal vicino torrente Carapelle.
La caccia al cervo, al capriolo e, in misura minore,alla lepre era poco diffusa; i cervi erano probabil-mente sfruttati soprattutto per finalità artigianali, agiudicare dal tipo di resti, perlopiù costituiti da palchied estremità 33.
In età medievale, pur considerando una riduzionequantitativa del campione faunistico, è possibile osser-vare un’accentuazione dell’allevamento caprovino, a di-scapito dei bovini e contemporaneamente ad unacrescita dei resti di maiale. Persiste lo scarso contributodelle attività di caccia e pesca all’economia del sito.
A.B.
Canosa, loc. San Pietro
I dati
Il campione considerato è costituito da 10.537frammenti, di cui 3.908 (37%) sono stati determinati,6.629 (63%) risultano non determinabili (tab. 6). Il ma-teriale proviene dalle stratigrafie riconducibili alle ul-time fasi dell’abitato altomedievale individuato, sullacollina di San Pietro, nell’area precedentemente occu-pata da un complesso paleocristiano 34. È stato possi-bile distinguere i reperti secondo i due periodi storiciriconosciuti archeologicamente: al IX-X secolo sonoattribuibili 5.405 ossa (51,3% del totale), ad un periodosuccessivo al X sec. (non precisabile ulteriormente)5.132 ossa (48,7% del totale) 35. In entrambi i periodigli ovicaprini sono gli animali domestici più rappre-sentati, seguiti dai suini e dai bovini. Il pollo, soprat-tutto fra il IX-X secolo, è presente con percentualisignificative, di gran lunga maggiori anche di quelledel bue (figg. 10-11); si registra, inoltre, un considere-vole aumento di interesse verso il volatile soprattutto ri-spetto alle fasi precedenti 36. Particolarmente scarsiappaiono i resti di equini nel primo periodo (1,26%),privi di tracce di macellazione. Per quanto riguarda glianimali selvatici, fra il IX-X sec., è probabile che
cervo, lepre e riccio fossero oggetto occasionale di at-tività venatoria (0,51% dei resti); compaiono anchel’oca selvatica e frammenti di altri volatili. Dopo il Xsecolo le percentuali relative ai mammiferi selvatici(1,72% dei resti) registrano, invece, una crescita di in-teresse verso la cattura della lepre, oltre che per la cac-cia al cervo, alla volpe e, in misura minora, al cinghiale.
L’ostrica appare il mollusco più rappresentato; iresti di ittiofauna sono riconducibili, fra il IX e il Xsecolo, a cernia, spigola, ombrina e rombo chiodato 37.Pesci e malacofauna ebbero un ruolo maggiore nella
33 Si veda Buglione, De Venuto 2010.34 Volpe et alii 2003;Volpe et alii 2007.35 I dati sono tratti dall’analisi del campione faunistico rac-
colto durante le campagne di scavo dal 2001 al 2005. I risultatipreliminari presentati in altre sedi sono stati quindi ampliati erivisti in seguito alle analisi di campioni maggiormente rap-presentativi.
36 Buglione 2006, 523; Ead. 2009a. Nel campione databilealla fine del VII-VIII sec. i resti di pollo sono attestati in per-centuali superiori anche rispetto al bue (10% del totale e 11%dei resti di bue, pecora, maiale e pollo).
37 Segnalazione di M. Battafarano e J. De Grossi Mazzorin(Università del Salento).
10. - Canosa, loc. San Pietro (IX-X secolo): percentuali deiprincipali animali domestici utilizzati nellʼalimentazione, di-stinti per numero di resti (N.R.) e numero minimo di indivi-dui (N.M.I.).
11. - Canosa, loc. San Pietro (dopo il X secolo): percentualidei principali animali domestici utilizzati nellʼalimentazione,distinte per numero di resti (N.R.) e numero minimo di indi-vidui (N.M.I.).
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
287
IX-X secolo Dopo il X secolo
Taxa N.R. % N.M.I. % N.R. % N.M.I. %
Animali domestici
Cavallo- Equus caballus L. 9 0,42 6 1,9 18 1 12 3,72
Asino- Equus asinus L. 3 0,14 2 0,63 32 1,79 9 2,79
Equino- Equus sp. 15 0,7 6 1,9 19 1,06 12 3,72
Bue- Bos taurus L. 183 8,61 26 8,25 209 11,7 45 13,97
Pecora o Capra- Ovis vel
Capra 1023 113 795 104
Pecora- Ovis aries L. 3 2 6 2
Capra- Capra hircus L. 5
48,54
2
37,14
6
45,16
2
33,54
Maiale- Sus domesticus Erx. 409 19,25 61 19,36 382 21,41 72 22,36
Cane- Canis familiaris L. 1 0,04 1 0,31 3 0,16 1 0,31
Gatto- Felis catus L. 5 0,23 3 0,95 15 0,84 4 1,24
Coniglio-Oryctolagus
cuniculus L. - - - - 2 0,11 1 0,31
Animali selvatici
Cervo- Cervus elaphus L. 4 0,18 2 0,63 7 0,39 4 1,24
Cinghiale- Sus scrofa ferus
L. - - - - 1 0,05 2 0,62
Riccio- Erinaceus
europaeus L. 2 0,09 2 0,63 - - - -
Lepre- Lepus europaeus
Pall. 5 0,23 4 1,27 17 0,95 6 1,86
Volpe- Vulpes vulpes L. - - - - 6 0,33 5 1,55
Avifauna
Pollo- Gallus gallus L. 359 17 73 23,17 198 11,1 37 11,49
Oca selvatica- Anser anser
L. 6 0,28 5 1,58 1 0,05 1 0,31
Uccelli ind. - Aves 10 0,47 7 2,22 17 0,95 1 0,31
Rettili
Testuggine- Testudo
hermanni Gml. - - - - 7 0,39 2 0,62
Molluschi
Molluschi ind.- Mollusca 3 0,14 - - 9 0,7 - -
Ostrica- Ostrea edulis L. 27 1,27 - - 12 0,67 - -
Cerastoderma-
Cerastoderma edule gl. P. 6 0,28 - - 1 0,05 - -
Lutraria- Lutraria lutraria
L. 5 0,23 - - 4 0,22 - -
Tellina- Donax trunculus L. 22 1,03 - - 5 0,28 - -
Murice- Murex trunculus L. 5 0,23 - - 3 0,16 - -
Glicimere- Glycimeris
glycimeris L. 1 0,04 - - 1 0,05 - -
Pecten- Pecten sp. 1 0,04 - - - - - -
Spondilo- Spondylus
gaederopus L. - - - - 1 0,05 - -
Seppia- Sepia sp. 1 0,04 - - 1 0,05 - -
Ittiofauna
Pesci- Pisces 11 0,51 - - 6 0,33 - -
Totale identificati 2124 100 315 100 1784 100 322 100
Coste animali grossa taglia 355 10,81 - - 145 4,33 - -
Coste animali piccola taglia
401 12,22 - - 210
6,27 - -
Vertebre animali grossa
taglia 42 1,28 - - 30
0,89 - -
Vertebre animali piccola
taglia 77 2,34 - - 219
6,54 - -
Frammenti
indeterminabili 2406 73,33 - - 2744
81,95 - -
Totale indeterminabili 3281 100 - - 3348 100 - -
Tabella 6. Canosa, loc. San Pietro: elenco delle specie identificate e relativi numero di resti (N.R.)e numero minimo di individui (N.M.I.)
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
288
Antonietta Buglione, Giovanni De Venuto
dieta nel primo periodo (3,8% del to-tale) rispetto al secondo (2,5%) 38.
Osservando l’usura dentaria (119fra mandibole e denti sciolti, figg. 12-13) è ipotizzabile che fra il IX e il Xsecolo gli ovicaprini fornissero so-prattutto lana e carne. Minore sem-brerebbe, anche per la fase succes-siva, l’attenzione per la produzione dilatte e derivati, a giudicare dalla bassapercentuale di capi abbattuti a pochimesi. Un più ampio interesse per ilconsumo di individui relativamentegiovani (12-24 mesi) emergerebbe apartire dalla fine del X secolo (figg.14-15). Il gruppo umano residente aSan Pietro probabilmente apprez-zava, fra il IX-X secolo, la carne for-nita da giovani maiali (24% di 58 in-dividui), oltre a quella ottenuta a costipiù vantaggiosi rispetto alle spese disostentamento dai capi abbattuti tra idue-tre anni di età (52%) (tab. 7).Dopo il X secolo il modello di abbat-timento sembra privilegiare maiali dioltre tre anni. La macellazione diparte dei bovini ad un’età inferiore atre anni lascia ipotizzare, tra IX-Xsec., una propensione per la produ-zione di carne di qualità oltre che unutilizzo nei lavori dei campi che di-venterà prioritario dopo il X secolo.Diffusa dovette essere, nei pressidell’insediamento, la pratica di alle-vamento del pollo, considerando, ol-tre al dato quantitativo, anche la presenza di indivi-dui giovanili, adulti e di sesso femminile el’equilibrata distribuzione dei resti in entrambi i pe-riodi considerati 39.
Discussione
Il nucleo insediativo di carattere rurale riconosci-bile sulla collina di San Pietro già dalla fine del VIIsecolo 40 fondava le sue attività economiche sull’alle-vamento degli animali domestici, in primo luogo ovi-caprini: la propensione verso l’allevamento ovinodell’abitato emerge soprattutto tra IX-X sec., regi-strandosi la più alta percentuale di resti di pecora/capra
38 La stima dei resti di ittiofauna risente, in ogni caso, delmancato uso del setaccio nella raccolta dei resti.
39 Buglione 2005-2006.40 Volpe et alii 2003;Volpe et alii 2007, 1136-1139.
12. - Canosa, loc. San Pietro (IX-X secolo): curva di mortalità degli ovicaprini (inbase a Payne 1973) (tot.: 119 elementi).
13. - Canosa, loc. San Pietro (IX-X secolo): istogramma relativo alle percentualidi uccisioni per classi dʼetà degli ovicaprini (tot.: 119 elementi).
Classi di età
Canosa
7-11
m
31-35 m >36 m
Totale
individui
IX-X secolo 14 30 14 58
Tabella 7. Canosa, loc. San Pietro (IX-X secolo): mortalità deisuini per N.M.I. e in base alla fusione epifisiaria, allʼeruzione,rimpiazzamento e usura dei denti (Bull, Payne 1982).
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
289
Lo sfruttamento della risorsa animale in Puglia tra il X e l’XI secolo: il contributo della ricerca archeozoologica
(quasi il 48,5% del campione di questa fase e il 63,5%delle tre principali specie domestiche) 41. L’attestazionedi tutte le porzioni scheletriche e di individui abbattutiin età giovanile e adulta indicherebbe, soprattutto per ilperiodo successivo al X sec., un allevamento praticatoin loco. Tra il IX e il X secolo pecore e capre erano evi-
dentemente impiegate anche per laproduzione della lana: potrebbe es-sere utile ricordare che la città di Ca-nosa, sede di un gineceo imperialeinsieme a Venosa, ebbe un ruolo cen-trale per le attività legate al settoredell’artigianato tessile e dell’alleva-mento transumante in età tardoan-tica 42. Il dato relativo ad unamaggiore attestazione di resti dicapra rispetto a quelli di pecora, re-gistrato a partire dalla fine del VIIsec., potrebbe inoltre suggerire ulte-riori attività produttive 43 praticate nelterritorio ofantino. Una diffusa pra-tica dell’allevamento ovino finaliz-zato, tra il VI e il IX secolo, allaproduzione laniera, sembra emergereanche dal campione, seppur esiguo,raccolto nell’area del Battistero diSan Giovanni a Canosa e costituitoper più della metà da resti di pe-cora/capra abbattuta in età adulta 44.È interessante sottolineare, soprat-tutto per il IX-X sec., l’esigua atte-stazione di resti di bue, il cuisfruttamento era indirizzato, dopo ilX secolo, a produrre forza-lavoro.Tra gli animali destinati alla dieta, ilpollo rivestiva un ruolo certamentenon marginale; allevato probabil-mente in situ, assicurava carne euova 45. Cavalli e asini, invece, nonsembrano aver avuto, come ad Or-dona, un ruolo all’interno del re-
gime alimentare. La scarsità dei resti di specieselvatiche, anche rispetto ai secoli precedenti, indi-cherebbe una poco diffusa copertura forestale o unapratica limitata della caccia da parte degli abitanti delvillaggio 46; minimo fu comunque il contributo dellaselvaggina alla dieta 47. La presenza di molluschi e
41 Buglione 2010. Nel periodo successivo al X sec., la per-centuale diminuisce di poco: i resti di pecora/capra rappresen-tano il 45% del campione e il 57,8% dei resti di ovicaprini,suini, bovini.
42 Volpe 1996, 276-285; Id. 2006a, 562; Id. 2010.43 Buglione 2010.44 Corrente, Giuliani, Leone 2007; Buglione 2006, 504.45 Molti resti di pollo provengono da alcune strutture ipo-
geiche utilizzate come fosse di scarico, indagate in relazionealle unità abitative altomedievali che si installarono sulla col-lina: si veda Volpe et alii 2003, 152-156 e, per il dato archeo-zoologico, Buglione 2006, 505, 529; Ead. 2007.
46 Buglione 2006; Ead. 2009a; Ead. 2009b, 711. 47 Anche relativamente alle fasi precedenti di VII-VIII sec.,
i dati mostrano come i palchi rappresentino una buona percen-tuale dei resti di cervo, in molti casi congiuntamente alle estre-
14. - Canosa, loc. San Pietro (dopo il X secolo): curva di mortalità degli ovicaprini(in base a Payne 1973) (tot.: 70 elementi).
15. - Canosa, San Pietro (dopo il X secolo): istogramma relativo alle percentuali diuccisioni per classi dʼetà degli ovicaprini (tot.: 70 elementi).
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
290
Antonietta Buglione, Giovanni De Venuto
pesci indicherebbe un rifornimento proveniente dallacosta o dal porto fluviale di Canne la cui attività è do-cumentata anche dopo il X secolo 48. Scambi per sod-disfare richieste di mercato potrebbero essere suggeritianche dalle basse percentuali di ossa dell’arto poste-riore osservate per le tre principali specie domestiche,in particolare per i suini, fra il IX e il X secolo 49.
I dati faunistici, dunque, sembrerebbero ben co-niugarsi con quelli archeologici che descrivono ilgruppo umano residente a San Pietro dedito ad attivitàdiversificate (di tipo agricolo, artigianale e di alleva-mento) e un comprensorio ofantino caratterizzato, apartire dalla fine del VII sec., dalla ripresa delle attivitàproduttive e da articolate forme rurali di popolamento,dopo un periodo compreso tra il VI e il VII sec. di evi-dente rottura rispetto alla Tardoantichità. La rinnovatafase durò probabilmente fino agli inizi del IX sec. d.C.,prima che la città fosse colpita dalle scorrerie dei Sa-raceni. Se labili sono le tracce archeologiche che con-sentano di ipotizzare una continuità insediativa nellazona di San Pietro oltre il X secolo e scarse appaionole informazioni anche per il territorio canosino nellafase compresa tra la fine del IX e gli inizi dell’XI se-colo 50, le indagini archeozoologiche indicherebbero lapersistenza di pratiche di allevamento e produttive,
contestualmente alla riconquista bizantina e, poi, al-l’intervento normanno: elevato, in particolare, rimasel’interesse per i prodotti ricavati dagli ovicaprini e, insecondo luogo, dai maiali e dai bovini. L’età di abbat-timento di questi ultimi, superiore ai tre-quattro anni dietà, potrebbe indicare una maggiore attenzione daparte dell’insediamento per le pratiche agricole ri-spetto al IX-X secolo.
A.B.
Apigliano
I dati
Sono stati complessivamente esaminati 2.899frammenti ossei, dei quali 768 risultano attribuibiliad un determinato taxon animale, mentre 2.131 nonsono riconducibili ad alcuna specie per lo stato diestrema frammentarietà. Il campione comprende re-perti sia di età bizantina (VIII-X secolo) sia di X-XIIsecolo (tab. 8) 51.
In età bizantina il sito sembrerebbe connotarsi peruna predisposizione all’allevamento ovicaprino: sia,infatti, sulla base del N.R. che del N.M.I, è possibileaffermare che questi animali furono tra i domesticimaggiormente utilizzati dalla popolazione del vil-laggio medievale. Un ruolo trascurabile nell’econo-mia generale del sito sembrerebbero aver avuto isuini, i bovini e il pollame; assente appare l’attivitàvenatoria.
Tra X e XII secolo il N.R. ed il N.M.I. sembrereb-bero mostrare un ridimensionamento del ruolo svoltodalla risorsa ovicaprina nell’economia del sito, a van-taggio degli altri domestici; accresciuta appare la pre-senza di pollame. Interessanti sono i dati riguardantile specie selvatiche: in questo periodo si registra la piùalta percentuale di ossa appartenenti a mammiferi nondomestici, di grande e piccola taglia (cinghiale, cervo,capriolo, volpe, lepre, riccio). Elementi anatomici dispecie selvatiche recanti tracce di macellazione sonoassenti, ad eccezione di una mandibola di riccio contagli netti forse riconducibili alla disarticolazione diquest’osso dal cranio, precedentemente ad un’opera-
mità, ad indicare che nell’insediamento erano introdotte so-prattutto le parti utili a fini artigianali: cfr. Buglione, De Venuto2010.
48 CDB VIII, 9, 1030.49 Buglione 2005-2006.
50 Favia in Volpe et alii 2007. Si veda, per queste fasi,anche Goffredo, Volpe 2005, 233-237 e Goffredo, Volpe2007.
51 Un’analisi preliminare del campione è in De Grossi Maz-zorin, De Venuto c.s.
VIII-inizi X sec. X-XII sec. Taxa
N.R. % N.R. %
Animali domestici
Asino - Equus asinus L. - - 1 0,3
Cavallo - Equus caballus L. - - 2 0,6
Equino - Equus sp. 2 1,1 - -
Bue - Bos taurus L. 24 12,8 84 24,4
Pecora o Capra - Ovis vel Capra 111 59,1 91 26,4
Pecora - Ovis aries L. 17 9 8 2,3
Capra - Capra hircus L. 2 1,1 1 0,3
Maiale - Sus domesticus Erx. 25 13,3 87 25,3
Gatto - Felis catus L. - - 1 0,3
Pollo - Gallus gallus L. 4 2,1 52 15
Oca - Anser sp. 1 0,5 - -
Animali selvatici
Cervo - Cervus elaphus L. - - 2 0,6
Capriolo - Capreolus capreolus L. - - 1 0,3
Cinghiale - Sus scrofa ferus L. - - 1 0,3
Volpe - Vulpes vulpes L. - - 1 0,3
Lepre - Lepus sp. - - 1 0,3
Riccio - Erinaceus europaeus L. - - 2 0,6
Micromammiferi indeterminati 1 0,5 2 0,6
Uccelli indeterminati - - 2 0,6
Testuggine - Testudo hermanni Gml. 1 0,5 1 0,3
Pesci indeterminati - - 4 1,2
Totale identificati 188 100 344 100
Coste 26 5,5 161 12,8
Vertebre 19 4,1 103 8,2
Frammenti indeterminabili 425 90,4 997 79
Totale indeterminati 470 100 1261 100
Tabella 8. Apigliano: elenco delle specie identificate e rela-tivo numero resti (N.R.) (da De Grossi Mazzorin, De Venutoc.s.).
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
291
Lo sfruttamento della risorsa animale in Puglia tra il X e l’XI secolo: il contributo della ricerca archeozoologica
zione di scuoiamento (fig. 16). La presenza, semprein percentuali minime, di questo mammifero in altricontesti dell’Italia meridionale in età medievale 52, nonè mai stata messa in relazione con usi alimentari.
Pur essendo attestata la presenza di pesce, il con-sumo non dovette essere determinante ai fini della sus-sistenza degli abitanti del sito.
Per l’età bizantina i bovini dovettero essere abbat-tuti prevalentemente in età adulta. Le stime cambianoper quanto riguarda il X-XII secolo, con un aumentodi ossa con una o entrambe le epifisi non fuse.
In riferimento agli ovicaprini, la costruzione dellacurva di sopravvivenza e dell’istogramma di mortalità(figg. 17-18), sulla base di 14 elementi dentari data-bili tra l’VIII e la prima metà dell’XI secolo, mostracome ampio fosse, in questa fase di frequentazione delchoríon salentino, l’interesse dimostrato dalla popola-zione nei confronti dei capi di bestiame di età adulta(tra i 48 ed i 96 mesi di vita) e di circa 24 mesi.
Raramente i suini erano abbattuti in un’età supe-riore ai tre anni di vita: questo modello di mortalità ap-pare maggiormente verificabile soprattutto tra X e XIIsecolo, quando la maggior parte degli individui fu uc-cisa entro il primo anno di vita.
Discussione
Furono soprattutto gli ovicaprini a rivestire il prin-cipale ruolo economico nell’attività di allevamento del
sito di Apigliano, durante l’intera facies di occupa-zione medievale (tab. 9). Questa pratica sembrerebbeessere stata più intensa durante le prime fasi di vitadell’insediamento umano, subendo un evidente calo incoincidenza dei secoli centrali della frequentazionedell’area. Gli animali furono verosimilmente allevatiin situ e dovettero rappresentare, almeno per il villag-gio bizantino, un’importante risorsa carnea; come ap-pare dalla lettura della curva di mortalità particolarerilievo sembrerebbe aver rivestito la produzione la-niera. Il rapporto tra resti ossei di pecore e capre ri-sulta a favore dei primi, con una particolare evidenzatra VIII e X secolo.
L’aumento percentuale dei bovini tra X e XII se-colo potrebbe far supporre una maggiore attenzione,
52 Segesta - TP (Di Martino 1997, 262): 2 fr.ti; Brucato (Bos-sard-Beck 1984, 631): 1 fr.to; Fiumedinisi - ME (Villari 1988,
620): 2 fr.ti; Quattro Macine - LE (Albarella 1996, 223): 1 fr;Ordona - FG (De Venuto 2007): 1 fr.
16. - Apigliano (XI secolo): mandibola di riccio con evidentitracce di macellazione-disarticolazione in corrispondenzadel ramo mandibolare.
17. - Apigliano (VIII-XI secolo): curva di mortalità degli ovi-caprini (in base a Payne 1973) (tot.: 14 elementi dentari).
18. - Apigliano (VIII-XI secolo): istogramma relativo alle per-centuali di uccisioni per classi dʼetà degli ovicaprini (in basea Payne 1973) (tot.: 14 elementi).
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
292
Antonietta Buglione, Giovanni De Venuto
da parte della popolazione locale, a pratiche di disso-damento del suolo.
I maiali restano per tutta l’età medievale, ad Api-gliano, la seconda risorsa d’allevamento. L’abbatti-mento degli animali doveva avvenire soprattutto tra i7 e gli 11 mesi di vita: si tratta di un’età in cui non èstato ancora raggiunto il più vantaggioso rapporto, dalpunto di vista economico, tra resa in carne e spese ne-cessarie per il sostentamento dei singoli esemplari. Ildato potrebbe suggerire la necessità, da parte del mer-cato interno, di reperire abbondante quantità di carne,in un tempo breve: questa strategia sembrerebbe es-sere stata accentuata tra X e XII secolo.
La caccia non aveva alcuna influenza sull’econo-mia e sul sostentamento della popolazione del vil-laggio; solo tra X e XII secolo si riscontra una piùalta percentuale e varietà di resti di selvaggina. Gliscarsi resti di grandi mammiferi, come il cervo o ilcinghiale, indicano un paesaggio non caratterizzatoda diffuse coperture forestali e soprattutto una scarsapropensione o limitato accesso della popolazione ru-rale all’approvvigionamento di risorse faunisticheselvatiche.
G.D.V.
Conclusioni
I dati fin qui presentati consentono di definire al-cune differenze nelle modalità di sfruttamento del be-stiame riconoscibili su di un piano cronologico erispetto alla funzione svolta dai singoli insediamentiumani sul proprio territorio.
In età bizantina (VII-X secolo) è possibile osser-vare un allevamento diretto prevalentemente nei con-fronti della risorsa ovina, con particolare interesse perla produzione laniera e carnea. Tale tipo di tendenzasembrerebbe suggerire un paesaggio agrario caratte-
rizzato da ampie aree pascolative verosimilmente al-ternate a zone di coltivo, come desumibile dalla pre-senza, all’interno dei campioni, soprattutto per ilcomprensorio della Puglia settentrionale, di non tra-scurabili percentuali di resti di bovini adulti. Questianimali potevano rappresentare, inoltre, un’importanterisorsa proteica come si può evincere dall’abbatti-mento, da parte dei singoli gruppi umani, di esemplarisubadulti. Un’ulteriore considerazione riguarda il cen-tro di Vaccarizza, presso il quale il modello sinora de-lineato e valido per i siti originariamente a vocazioneagricola (Apigliano) o sottoposti ad un fenomeno diruralizzazione (Ordona, Canosa), è solo parzialmenteriscontrabile: principale oggetto d’interesse, per scopidi tipo alimentare, furono i suini seguiti dagli ovica-prini per il reperimento di latte e derivati, e dai boviniutilizzati prevalentemente per ricavarne carne. In que-sto periodo, inoltre, diffuso e intensivo fu verosimil-mente l’allevamento da cortile indirizzato verso ilpollame.
Di particolare interesse risulta la scarsa attenzionerivolta all’attività di caccia che potrebbe spiegarsi conuna limitata estensione, nella regione, delle aree bo-schive o con un accesso ad esse ristretto ed elitario.Maggiormente praticata dovette essere la pesca in areecostiere o lagunari di pertinenza, soprattutto, di centriprivilegiati come Vaccarizza.
Per il periodo compreso tra XI e XIII secolo ilruolo svolto da pecore e capre apparirebbe maggior-mente decisivo, con una più accentuata destinazionecarnea del loro allevamento. In crescita risultano, in-vece, le percentuali di bovini in alcuni insediamentirurali come quello di Apigliano, da ricondurre proba-bilmente all’intensificarsi di pratiche di dissodamentodei terreni. Persiste la funzione di approvvigionamentoproteico svolta dai maiali. Il pollo resta risorsa impor-tante a Canosa, forse ad indicare un’economia a ca-rattere domestico; notevole la sua drastica diminuzio-ne a Vaccarizza. Pur considerando una limitata pre-senza di ossa di selvatici, è possibile registrare una piùdiffusa propensione alla caccia 53; assolutamente tra-scurabili appaiono invece i resti di pesce.
A.B. - G.D.V.
(VIII-inizi X sec.) (X-XII sec.) Specie
N.R. % N.R. %
bovini 24 13,4 84 31
ovicaprini 130 72,6 100 37
suini 25 14,0 87 32
Totale 179 100 271 100
Tabella 9. Apigliano: percentuali dei principali animali do-mestici utilizzati nellʼalimentazione (da De Grossi Mazzorin,De Venuto c.s.).
53 Cfr. supra, anche nota 14.
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
293
Lo sfruttamento della risorsa animale in Puglia tra il X e l’XI secolo: il contributo della ricerca archeozoologica
Bibliografia
Ageing and sexing, Wilson B., Grigson C., Payne S.(eds.) 1982, Ageing and sexing animal bones from ar-chaeological sites, B.A.R. British Series, 109, Ox-ford.
Albarella U. 1996, The faunal remains, in Arthur P., Al-barella U., Bruno B., King S., “Masseria QuattroMacine” a deserted medieval village and its territoryin Southern Puglia: an interim report on field survey,excavation and document analysis, BSR, LXIV, 181-237, 222-224.
Arthur P. (ed.) 1999, Da Apigliano a Martano. Tre annidi archeologia medievale (1997-1999), Galatina.
Arthur P., Bruno B. (eds.) 2009, Apigliano. Un villaggiobizantino e medievale in Terra d’Otranto. L’am-biente, il villaggio, la popolazione, Galatina.
Baker P., Clark G. 1993, Archaeozoological evidence forMedieval Italy: a critical review of the present stateof research, AMediev, XX, 45-77.
Barker G. 1980, Stock keeping at D85, in Hodges R.,Barker G., Wade K., Excavations at D85 (SantaMaria in Cività). An Early Medieval hilltop settle-ment in Molise, BSR, XLVIII, 97-102.
Barker G. 1981, Studi sulla fauna e l’economia medie-vale in Italia, AMediev, VIII, 59-71.
Barone R. 1974, Anatomia comparata dei mammiferi do-mestici, I, Bologna.
Bossard-Beck C. 1984, Le mobilier ostéologique et bo-tanique, in Pesez J.-M. (ed.), Brucato. Histoire et ar-chéologie d’un habitat médiéval en Sicile, Roma,615-671.
Bossard-Beck C., Maccari-Poisson B. 1984, L’alimenta-tion, in Pesez J. M. (ed.), Brucato. Histoire et ar-chéologie d’un habitat médiéval en Sicilie, II, Roma,749-773.
Buglione A. 2005-2006, Attività economiche, sistemialimentari e paesaggi in Apulia et Calabria fra Tar-doantico e Altomedioevo: il contributo dell’archeo-zoologia, Tesi di dottorato, Università di Foggia.
Buglione A. 2006, Ricerche archeozoologiche in Pugliacentro-settentrionale: primi dati sullo sfruttamentodella risorsa animale fra Tardoantico e Altome-dioevo, in Gravina A. (ed.), 26o Convegno sulla Prei-storia, Protostoria e Storia della Daunia (San Severo2005), San Severo, 495-532.
Buglione A. 2007, People and animals in Northern Apu-lia from Late Antiquity to Early Middle Age: someconsiderations, in Pluskowski A. (ed.), Breaking andShaping Beastly Bodies. Animals as Material Culturein the Middle Age, Papers of One Day Conference atMcDonald Institute, University of Cambridge (19th
March 2005), Oxford, 189-216.Buglione A. 2009a, Paesaggi e risorsa animale in Pu-
glia fra Tardoantico e Altomedioevo, in Melis M.G.(ed.), Uomo e territorio, dinamiche di frequentazionee di sfruttamento delle risorse naturali nell’antichità,
Atti del Convegno Nazionale dei Giovani Archeologi(Sassari, 27-30 settembre 2006), Muros, 515-520.
Buglione A. 2009b, Ricerche archeozoologiche pressol’abitato altomedievale di Faragola (Ascoli Satriano,Fg), in Volpe G., Favia P. (eds.), Atti del V CongressoNazionale di Archeologia Medievale (Foggia, 30 set-tembre 2009-Manfredonia, 1-3 ottobre 2009), Fi-renze, 708-711.
Buglione A. 2010, L’allevamento transumante ovino inPuglia fra Tardoantico e Altomedioevo: un approc-cio archeozoologico, in Vie degli animali, vie degliuomini (vedi), 51-68.
Buglione A., De Venuto G. 2008, Indagini archeologi-che nell’area delle terme di Herdonia. I reperti fau-nistici di età tardoantica e medievale, in Volpe G.,Leone D. (eds), Ordona XI, Bari, 245-343.
Buglione A., De Venuto G. 2010, L’uso artigianale delpalco di cervo in Puglia fra Tardoantico e Medioevo,in Tagliacozzo A., Fiore I., Manconi S., Tecchiati U.(eds.), Atti del 5° Convegno Nazionale di Archeo-zoologia (Rovereto, 10-13 novembre 2006), Rove-reto, 349-352.
Bull G., Payne S. 1982, Tooth eruption and epiphysialfusion in pigs and wild boar, in Ageing and sexing(vedi), 55-81.
Bullock D., Rackham J. 1982, Epiphysial fusion andtooth eruption of feral goats from Moffatdale, Dum-fries and Galloway, Scotland, in Ageing and sexing(vedi), 73-80.
Cartledge J. 1981, Faunal studies and urban archaeo-logy, in Barker G., Hodges R. (eds.), Archaeology andurban society. Prehistoric, roman and medieval stu-dies, Papers in Italian Archaeology, II, B.A.R. Inter-national Series, 102, Oxford, 91-97.
Cartledge J., Clark G., Higgins V. 1992, The animalbones: a preliminary assessment of the stock eco-nomy, in Otranto II (vedi), 317-336.
CDB VIII=Codice Diplomatico Barese, VIII. Nitti F.(ed.), Le pergamene di Barletta. Archivio Capitolare(897-1285), Bari 1914.
Cirelli E., Noyé Gh. 2003, La cittadella bizantina e lamotta castrale di Vaccarizza (scavi 1999-2002), inFiorillo R., Peduto P. (eds.), Atti del III CongressoNazionale di Archeologia Medievale (Castello di Sa-lerno, Complesso di S. Sofia, Salerno 2-5 ottobre2003), Firenze, 481-486.
Corrente M., Giuliani R., Leone D. 2007, Edilizia paleo-cristiana nell’area di piano a San Giovanni a Canosadi Puglia, in Bonacarra R.M., Vitale M. (eds.), La cri-stianizzazione in Italia fra Tardoantico e Altome-dieovo, Atti del IX Congresso Nazionale diArcheologia Cristiana (Agrigento 20-25 novembre2004), II, Palermo, 1167-1200.
Cretella M. 1994, Molluschi, in Arthur P. (ed.), Il com-plesso archeologico di Carminiello ai Mannesi, Na-poli (scavi 1983-1984), Galatina, 423-428.
De Grossi Mazzorin J., De Venuto G. c.s., L’economiaproduttiva animale: risultati delle analisi archeozoo-
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
294
logiche nel villaggio medievale di Apigliano (Mar-tano, Le).
De Venuto G. 2007, Animals and Economic Patterns ofMedieval Apulia, in Pluskowski A. (ed.), Breakingand Shaping Beastly Bodies. Animals as MaterialCulture in the Middle Age, Papers of One Day Con-ference at McDonald Institute, University of Cam-bridge (19th March 2005), Oxford, 217-234.
De Venuto G. 2010, Contributo alla ricostruzione dei ca-ratteri dell’allevamento transumante ovino traAbruzzo e Tavoliere di Puglia in età medievale, in Viedegli animali, vie degli uomini (vedi), 69-82.
Di Martino S. 1997, Le analisi archeozoologiche, in Mo-linari A. (ed.), Segesta II. Il castello e la moschea(scavi 1989-1995), Palermo, 259-271.
Goffredo R., Volpe G. 2005, Il ‘Progetto Valle del-l’Ofanto’: primi dati sulla Tarda Antichità e l’Alto-medioevo, in Volpe G., Turchiano M. (eds.), Paesaggie insediamenti rurali in Italia meridionale fra Tardo-antico e Altomedioevo (Foggia, 12-14 febbraio 2004),Atti del I Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevoin Italia meridionale, Bari, 223-240.
Goffredo R., Volpe G. 2007, La bassa valle dell’Ofantotra la fine del VI e il XIII secolo, AMediev, XXXIV,43-65.
King A. C. 1994, Mammiferi, in Arthur P. (ed.), Il com-plesso archeologico di Carminiello ai Mannesi, Na-poli (scavi 1983-1984), Galatina, 367-406.
Leguilloux M. 2000, Le matériel ostéologique d’Ordona.Campagnes de fouilles 1994-1995: premières con-clusions, in Ordona X (vedi), 477-496.
Licinio R. 1983, Uomini e terre nella Puglia medievale,Bari.
Licinio R. 1998, Masserie medievali. Masserie, massarie carestie da Federico II alla Dogana delle pecore,Bari.
MacKinnon M. R. 2002 (ed.), The excavations of SanGiovanni di Ruoti. Volume III. The Faunal and PlantRemains, Toronto, Buffalo, London.
Martin J. M. 1993, La Pouille du VIe au XIIe siècle,Roma.
Martin J. M., Noyé Gh. 1989, Les campagnes de l’Italieméridionale byzantine (Xe-XIe siècles), MEFRM, 101,2, 559-596.
Mertens J. 1995, Dal tardo antico all’altomedioevo, inMertens J. (ed.), Herdonia. Scoperta di una città,Bari, 339-352.
Ordona X, G. Volpe (ed.), Ordona X. Ricerche archeolo-giche a Herdonia (1993-1998), Bari 2000.
Otranto II, D’Andria F., Whitehouse D. (eds.), Excava-tions at Otranto. Volume II: the finds, Galatina 1992.
Paesaggi e insediamenti rurali, Volpe G., Turchiano M.(eds.), Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meri-dionale fra Tardoantico e Altomedioevo (Foggia, 12-14 febbraio 2004), Atti del I Seminario sulTardoantico e l’Altomedioevo in Italia meridionale,Bari 2005.
Payne S. 1973, Kill-off patterns in sheep and goats: themandibles from Aşvan Kale, AnatSt, XXIII, 281-303.
Porsia F. 1987, L’allevamento, in Musca G. (ed.), Terrae uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo, Atti dellesettime giornate normanno-sveve (Bari, 15-17 otto-bre 1985), Bari, 235-260.
Reese D. S. 1992, The marine and fresh- water shells, inOtranto II (vedi), 349-452.
Reese D. S. 2002, Marine and freshwater shells, in Mac-Kinnon M. R. (ed.), The excavations of San Giovannidi Ruoti. Volume III. The faunal and Plant Remains,Toronto, Buffalo, London, 189-193.
Riedel A., Rizzi J. 2000, Studio preliminare sui resti osseidi avifauna di Verona medioevale (scavi di piazzaMercato Vecchio e del Tribunale), in Atti del 2° Con-vegno Nazionale di Archeozoologia (Asti, 1997),Forlì, 341-348.
Salvadori F. 2003, Archeozoologia e medioevo: lo statodegli studi, in Fiorillo R., Peduto P. (eds.), Atti del IIICongresso Nazionale di Archeologia Medievale (Ca-stello di Salerno, Complesso di Santa Sofia, Salerno,2-5 ottobre 2003), Firenze, 176-181.
Silver A. 1969, The ageing of domestic animals, in Bro-thwell D., Higgs E. (eds.), Science in Archaeology. Asurvey of progress and research, London, 283-302.
Simone O. 2000, Resti faunistici dal riempimento dellacisterna della domus B, in Ordona X (vedi), 497-504.
Tagliacozzo A. 1993, L’Archeozoologia: problemi e me-todologie relativi all’interpretazione dei dati, Origini,XVII, 7-88.
Toubert P. 1997, Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agri-coltura e poteri nell’Italia medievale, Torino.
Vie degli animali, vie degli uomini, Volpe G., BuglioneA., De Venuto G. (eds.) 2010, Vie degli animali, viedegli uomini. Transumanza e altri spostamenti di ani-mali nell’Europa Tardoantica e Medievale, Atti delSecondo Seminario Internazionale di Studi ‘Gli ani-mali come cultura materiale nel Medioevo’ (Foggia,7 ottobre 2006), Bari.
Villari P. 1988, Resti faunistici da uno scarico medioe-vale del castello di Fiumedinisi (Messina), AMediev,XV, 609-642.
Volpe G. 1996, Contadini, pastori e mercanti nell’Apu-lia tardoantica, Bari.
Volpe G. 2000, Herdonia romana, tardoantica e medie-vale alla luce dei recenti scavi, in Ordona X (vedi),507-554.
Volpe G. 2005a, Villaggi e insediamento sparso in Italiameridionale fra Tardoantico e Altomedioevo: alcunenote, in Brogiolo G. B., Chavarria Arnau A., ValentiM. (eds.), Dopo la fine delle ville: le campagne dal VIal IX secolo, Atti dell’11° Seminario sul Tardoanticoe l’Altomedioevo (Gavi, 8-10 maggio 2004), Man-tova, 221-249.
Volpe G. 2005b, Paesaggi e insediamenti rurali del-
Antonietta Buglione, Giovanni De Venuto
LA CAPITANATA E Lʼ ITALIA MERIDIONALE NEL SECOLO XI DA BISANZIO AI NORMANNI · © 2011 - Edipuglia s.r.l . - www.edipuglia.it
295
Lo sfruttamento della risorsa animale in Puglia tra il X e l’XI secolo: il contributo della ricerca archeozoologica
l’Apulia tardoantica e altomedievale, in Paesaggi einsediamenti rurali (vedi), 299-314.
Volpe G. 2006a, Città apule fra destrutturazione e tra-sformazione: i casi di Canusium ed Herdonia, inAugenti A. (ed.), Le città italiane tra la tarda an-tichità e l’alto medioevo, Atti del Convegno diStudi (Ravenna, 26-28 febbraio 2004), Firenze,559-587.
Volpe G. 2006b, La transhumance entre Antiquité tardiveet haut Moyen Âge dans le Tavoliere des Puilles (Ita-lie), dans Aux origines de la transhumance. Les Alpeet la vie pastorale d’hier à aujourd’ hui, sous la di-rection de C. Jourdain-Annequin et J.-C. Duclos,Actes du Séminaire (Grenoble, 28-3-2003), Paris,297-308.
Volpe G. 2010, Introduzione. Alcuni cenni sulla transu-manza fra Tardoantico e Medioevo: archeologia, ar-
cheozoologia e storia, in Vie degli animali, vie degliuomini (vedi), 11-18.
Volpe G., Annese C., Corrente M., De Felice G., De San-tis P., Favia P., Giuliani R., Leone D., Nuzzo D.,Rocco A., Turchiano M. 2003, Il complesso paleo-cristiano di San Pietro a Canosa. Seconda relazionepreliminare (campagna di scavi 2002), AMediev,XXX, 107-164.
Volpe G., Favia P., Giuliani R., Nuzzo D. 2007, Il com-plesso sabiniano di S. Pietro a Canosa, in Bonacarra R.M., Vitale M. (eds.), La cristianizzazione in Italia fraTardoantico e Altomedieovo, Atti del IX CongressoNazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento 20-25novembre 2004), I, Palermo, 1113-1165.
Whitehouse D. 1969, Animal bones, in Whitehouse D.,Whitehouse R. (eds.), Excavations at Anglona, BSR,XXXVII, 72-74.