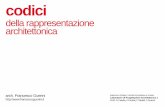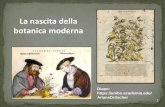Lezione 1 - Cos'è la semiotica
Transcript of Lezione 1 - Cos'è la semiotica
Semiotica 0: prima settimana• prima lezione: Cos’è la semiotica: campo o disciplina? - Semiotica
Strutturale e Interpretativa - L’oggetto della semiotica: dal segno al senso - Segno, significazione e comunicazione - La relazione di significazione - La nozione di relazione e di differenza
• seconda lezione: Saussure e lo strutturalismo in linguistica - Langue e Parole - Nozione di segno in Saussure - Differenza e Valore - Hjelmslev e la glossematica - La funzione segnica: Espressione e Contenuto - Gli strati del linguaggio: Forma/Sostanza e Materia - Sistema e Processo
• terza lezione: Greimas e l’École de Paris - analisi lessematica - narratività - Percorso generativo - Strutture attanziali - Schema Narrativo Canonico - Isotopia e quadrato - (Modalità) - Enunciazione - Cenni su strutture discorsive
Campo o disciplina?• Secondo Umberto Eco la semiotica non può essere intesa come disciplina allo
stesso modo di, ad esempio, la filosofia teoretica, o la fisica nucleare. È più simile ad un campo, così come si dice della medicina generale, dove ci sono specializzazioni anche molto diverse fra loro, dalla neurochirurgia all’agopuntura. Eco distingue tra una semiotica generale (di stampo più filosofico, anzi: per Eco la semiotica è l’unica forma di filosofia oggi praticabile) e le semiotiche specifiche (applicate a diversi linguaggi, mezzi espressivi, problemi, ad es. la semiotica del cinema, la semiotica della letteratura, della cognizione/percezione ecc.)
• Secondo l’approccio struttural-generativo, la semiotica aspira ad essere una disciplina “a vocazione scientifica” in grado di “tagliare all’interno del campo aperto di questioni semiotiche una serie coerente di concetti e categorie, cercando di interdefinirli fra loro e di orientarli verso un’unica pertinenza: quella del senso umano e sociale e della sua articolazione in quanto significazione” (Paolo Fabbri). La semiotica generativa mira a trovare un unico metodo per descrivere qualunque sistema o processo semiotico attraverso un insieme di concetti interdefiniti fra loro e a proporsi come organon (non canone) disciplinare.
Alcune definizioni di semiotica• Ferdinand de Saussure: “la lingua è un sistema di segni esprimenti delle idee e, pertanto, è
confrontabile con l’alfabeto dei sordomuti, i riti simbolici, le forme di cortesia, i segnali militari, ecc. ecc. Essa è semplicemente il più importante di tali sistemi. Si può dunque concepire una scienza che studia la vita dei segni nel quadro della vita sociale; essa potrebbe formare parte della psicologia sociale e, di conseguenza, della psicologia generale; noi la chiameremo semiologia (dal greco semeion, segno). Essa potrebbe dirci in cosa consistono i segni, quali leggi li regolano. Poiché essa ancora non esiste non possiamo dire che cosa sarà; essa tuttavia ha diritto ad esistere e il suo posto è determinato in partenza” (1916, Cours de linguistique générale)
• Charles S. Peirce: “Io sono, per quel che ne so, un pioniere, o piuttosto un esploratore, nell’attività di chiarire e iniziare ciò che io chiamo semiotica, vale a dire la dottrina della natura essenziale e delle varietà fondamentali di ogni possibile semiosi” (1931, CP 5.488) […] Per semiosi intendo un’azione, un’influenza che sia, o coinvolga, una cooperazione di tre soggetti, come per esempio un segno, il suo oggetto e il suo interpretante, tale influenza tri-relativa non essendo in nessun caso risolubile in un’azione tra coppie” (CP 5.484)
• Paolo Fabbri: “L’impegno, o la scommessa, della semiotica è dire qualcosa di sensato sul senso” (La svolta semiotica)
• Umberto Eco: “La semiotica, in principio, è la disciplina che studia tutto ciò che può essere usato per mentire” (Trattato)
• La semiotica studia i sistemi e i processi di significazione
I padri della semiotica
vs.
Due genealogie teoriche incompatibili oppure conciliabili?
Ferdinand de Saussure, linguistaGinevra, 26 novembre 1857 –
Vufflens-le-Château, 22 febbraio 1913
Charles Sanders PeirceCambridge, MA (USA) 10 settembre 1839 –
Milford, PA (USA) 19 aprile 1914)
Ferdinand de Saussure (linguistica strutturale)
Louis Hjelmslev (glossematica)
Roland Barthes (semiologia, translinguistica)
Algirdas J. Greimas (semiotica generativa)
Umberto Eco (semiotica interpretativa)
Charles S. Peirce (pragmatismo)
Charles W. Morris (semiotica: sintassi -
semantica - pragmatica)
pragmatismofilosofico
linguistica strutturale
semiotica interpretativa semiotica strutturale
Il precedente albero genealogico non ricostruisce tutte le teorie semiotiche ma mira semplicemente a rendere conto della sua “doppia matrice” (linguistico-strutturale e pragmatico filosofica). Riporto di seguito solo alcune delle ramificazioni e parentele teoriche della semiotica (lista molto parziale e puramente indicativa della complessità e non linearità dello sviluppo della semiotica)
• linguistica strutturale: Scuola di Praga (Jakobson, Trubeckoj) e altri linguisti (Martinez, Tesniere, Halle, ecc)
• narratologia, ermeneutica, antropologia (Dumezil, Propp, Emile Benveniste, Todorov, Levi-Strauss, Geertz, Ricœur, ecc.)
• altri pensatori post-strutturalisti: (Foucault, Deleuze, Guattari, Lacan, Lyotard, Kristeva…)
• inoltre, nella storia del pensiero filosofico numerosissimi sono, ovviamente, quelli che si sono occupati di problemi legati al segno e al significato (stoici, epicurei, presocratici, Platone, Aristotele, Porfirio, Agostino, modisti, Tommaso d’Aquino, Guglielmo da Occam, John Locke, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel, sino a (per citarne alcuni) Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty ecc. ecc. Chi fosse interessato ad approfondire ci sono testi di Eco, Manetti, Calabrese, Marmo e altre ricerche di storia della semiotica
• filosofia del linguaggio: Frege, Carnap, Wittgenestein, Quine, Ogden & Richards, Austin, Chomsky…
Inoltre, oltre alle correnti (se è lecito considerarle tali) generativa e interpretativa, si può parlare anche di semiotica della cultura, approccio sviluppato presso la scuola di Tartu specialmente da Jurij Lotman e Boris Uspenskj
• ulteriori nuovi recenti sviluppi: sociosemiotica (Landowski), semiotica tensiva (Fontanille, Zilberberg), ecc
Due nozioni (inconciliabili?) di segnoSegno binario vs. segno triadico
Interpretante
OggettoRepresentamen
Peircesignificato
significante
Saussure
Hjelmslev
da cosa si riconosce la semiotica?
I. il “simbolico” (come lo intende Deleuze) - relazione di significazione, autonomia del semiotico
II. la relazione - non studiamo i segni ma determinate configurazioni e organizzazioni di senso che stanno al di sotto o al di sopra dei segni (testi)
III. la differenza - il senso è generato da scarti differenziali, primato della relazione sui termini
(cfr. il saggio di Deleuze, “Da che cosa si riconosce lo strutturalismo?”)
alcuni punti• relazione di significazione: punto fermo di un approccio genuinamente semiotico. Tale relazione implica che non ci sono
da una parte i fatti e dall'altra concetti che “nominano” i fatti, non ci sono le cose e le parole che rappresentano le cose. Rifiuto di un approccio referenzialista: la semiotica rifiuta ogni idea di linguaggio come mera rappresentazione ma anche come semplice mediazione tra mondo e pensiero. La relazione di significazione è tutta interna al processo semiotico, è relazione tra piani semiotici.
• si tratta di un’ipotesi di tipo costruttivista (ma non idealista, né decostruzionista in senso derridiano): i significati non pre-esistono né sono dati una volta per tutte, essi sono costruiti e costituiti dalla relazione segnica
• il segno è unione inscindibile (se non artificialmente dall’analisi) di significante e significato (di Espressione e Contenuto, come le chiamerà dopo Hjelmslev). Queste due facce del segno stanno in rapporto di presupposizione reciproca, e di “correlazione” (ciò che succede su un piano provoca effetti sull’altro)
• Approccio strutturalista: la semiotica si occupa del senso, fornendo modelli descrittivi che rendono conto dell’articolazione della significazione attraverso l’individuazione di relazioni tra elementi dello stesso piano e tra i due piani (Espressione e Contenuto), alla ricerca di “configurazioni” (dai segni ai testi, da un modello della comunicazione legato alle intenzionalità di chi emette il segno ad uno della significazione, ad un modello della significazione (antropologico nel senso che riguarda il modo in cui l’uomo sociale interpreta attribuisce valori e “organizza” la sua esperienza del mondo).
• In un approccio di questo tipo tutti gli elementi sono collegati, per cui non sarà importante il valore del singolo elemento, ma la relazione (tra elementi che determina un valore). Il valore di ogni elemento risiede nel rapporto con tutti gli altri (il saussuriano “nella lingua non vi sono che differenze”). In questo senso diciamo che è la differenza ad innescare la significazione.
• Floch: “Per la semiotica il senso deriva dalla relazione dei due piani che ogni linguaggio possiede: il piano dell’espressione e il piano del contenuto. Il piano dell’espressione è quello in cui le qualità sensibili che un linguaggio sfrutta per manifestarsi sono selezionate ed articolate fra di loro per mezzo di scarti differenziali. Il piano del contenuto è invece quello in cui la significazione nasce dagli scarti differenziali grazie ai quali ogni cultura, per pensare il mondo, ordina e incatena idee e racconti”
Consigli bibliografici• Due antologie:
• Bettetini, Calabrese, Lorusso, Violi, Volli (a cura di) (2005) Semiotica, Milano: Raffaello Cortina Editore.
• Fabbri, Marrone (a cura di) (2000, 2001) Semiotica in nuce, voll. I & II, Roma: Meltemi.
• Manuali:
• Marmo, C. (2014) Segni, linguaggi e testi. Semiotica per la comunicazione, Bologna: Bononia University Press
• Traini, S. (2013) Le basi della semiotica, Milano: Bompiani.
• Pozzato, M.P. (2013) Capire la semiotica, Milano: Carocci. Oppure, dello stesso autore, (2001) Semiotica del testo, Milano: Carocci
• Due classici da leggere:
• Eco, U. (1975) Trattato di semiotica generale, Milano: Bompiani.
• Fabbri, P. (1998) La svolta semiotica, Bari-Roma: Laterza.
















![lezione IVA 10-7.ppt [modalit\340 compatibilit\340] - My LIUC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633614a362e2e08d490356f1/lezione-iva-10-7ppt-modalit340-compatibilit340-my-liuc.jpg)