Avventure di un'avventuriera. Le note di viaggio (in Sicilia) di Marija Puare
Le nozioni fisiche di kinesis, energheia e poiesis: Giamblico alleato strumentale di Simplicio ...
Transcript of Le nozioni fisiche di kinesis, energheia e poiesis: Giamblico alleato strumentale di Simplicio ...
45LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
« Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale » XXII (2011)
GIOVANNA R. GIARDINA
Le nozioni fisiche di kinesis, energheia e poiesis␣ :Giamblico alleato strumentale di Simplicio
contro Plotino in difesa di Aristotele
1. Premessa — In questo studio intendo prendere in esame una porzione delCommentario di Simplicio alle Categorie, precisamente le lin. 295.1-308.101, in cuiil Commentatore, prendendo le mosse dalle categorie dell’agire e del patire,contesta la posizione teorica di Plotino (e in un caso è implicato anche Porfirio)in merito al rapporto intercorrente, nella filosofia di Aristotele, fra le nozioni diagire, to; poiei'n, movimento, kivnhsi~, e ‘attività’ o ‘atto’, ejnevrgeia. Plotino ritieneinfatti che, anziché l’agire, Aristotele avrebbe dovuto assumere come categoria ilmovimento, kivnhsi~, in cui rientrerebbero sia l’agire che il patire, ed anzi, inquanto il movimento è detto da Aristotele ejnevrgeia ajtelhv~, attività imperfetta oincompiuta, lo Stagirita avrebbe dovuto assumere come categoria proprio l’ejnevrgeia.
Per contestare Plotino, Simplicio si avvale sostanzialmente di Giamblico.Le suddette pagine del commentario di Simplicio, di cui mi occuperò in questostudio, comprendono, infatti, ben sette frammenti del perduto commentarioalle Categorie di Giamblico, e precisamente i frr. 82-88 della raccolta diLarsen2 . Non mi soffermerò, tuttavia, sui frr. 82-83, perché nel fr. 82 (= SIMPL.,In Cat., 297.23-298.26) Giamblico si occupa delle categorie del dove, delquando e dell’avere, che non interessano l’argomento oggetto del presentestudio, mentre nel fr. 83 (= SIMPL., In Cat., 299.28-34) fornisce una valutazionedi ordine generale che ha, però, carattere accessorio3. I rimanenti frammenti
1 L’edizione di riferimento è : Simplicii in Aristotelis Categorias Commentarium, ed. K. KALBFLEISCH,Berlin 1907 (CAG, 8). La porzione di testo della quale mi occuperò in queste pagine è stata tradottada R. GASKIN, Simplicius On Aristotle’s Categories 9-15, Duckworth, Ithaca-New York 2000.
2 Fragmenta exegetica : Jamblique de Chalcis. Exégète et philosophe. Appendice␣ : testimonia etfragmenta exegetica, ed. B. D. LARSEN, Universitetsforlaget, Aarhus 1972. Nel suo commentarioalle Categorie Simplicio dedica alle categorie dell’agire e del patire complessivamente le pp.295.1 - 334.5. A partire dalla lin. 314.10 si trovano altri dieci frammenti di Giamblico (i frr. 89-98 Larsen), che tuttavia esaminano aspetti differenti e conseguenti rispetto ai problemi teoricidi cui intendo occuparmi in questo studio, in quanto riguardano delle riflessioni di Giamblicosu posizioni di Archita, sul rapporto tra i quattro tipi di movimento secondo Aristotele e l’azione,sugli aspetti peculiari del patire e dell’affezione, eccetera.
3 E cioè la seguente (traduco partendo da qualche linea avanti affinché si comprenda laquestione), SIMPL., In Cat., 299.28-34 : « Ma si potrebbe dire [afferma Simplicio] che <Aristotele>,da un lato ha parlato degli aspetti generali dell’agire e del patire, e dall’altro lato non ne ha
46 GIOVANNA R. GIARDINA
di Giamblico sono così collocati in Simplicio : fr. 84 = 302.5-17 ; fr. 85 = 302.18-303.31 ; fr. 86 = 303.32-306.12 ; fr. 87 = 307.6-274 ; fr. 88 = 308.1-35 . Inoltre, perquanto riguarda il passaggio che in Simplicio segue immediatamente il fr. 86di Giamblico, cioè le lin. 306.13-307.1, occorre notare che se da un lato non visono certezze sul fatto che esso possa derivare direttamente da Giamblico — edi fatto Larsen lo omette —, dall’altro lato, però, sembra ragionevolmenterientrare nella lunga testimonianza di Simplicio su Giamblico, perché appareprecisamente come una continuazione del discorso di quest’ultimo.
Quello di stabilire i termini del rapporto intercorrente fra le nozioni diagire, movimento, e ‘attività’ o ‘atto’ — e precisamente le loro affinità edifferenze —, non è un compito facile. Il discorso che Simplicio fa, sostanzial-mente sulla base di Giamblico, in queste pagine del suo commentario alleCategorie, è piuttosto denso e presenta diverse argomentazioni fra loroconcatenate. Mi è sembrato perciò utile suddividere la mia analisi in più punti,sulla base delle diverse argomentazioni che questi contengono, pur se vasubito precisato che l’intero discorso di Simplicio-Giamblico è caratterizzatoda una indubbia unità tematica e si prefigge il duplice scopo di mostrare glierrori in cui è incorso Plotino interpretando Aristotele e di difendere quest’ul-timo. Ritengo pertanto indispensabile, vista la complessa articolazione deldiscorso, sintetizzare in questa premessa le linee essenziali del ragionamentodi Simplicio-Giamblico così come l’ho suddiviso nei diversi punti tematici.
Nel primo punto affronto l’analisi delle lin. 295.1-301.33, in cui Simplicioin un primo tempo pone questioni di ordine generale, ad esempio se l’agiredebba essere trattato dopo le categorie della sostanza, della quantità, dellaqualità e della relazione, e se ci sia contrarietà di natura qualitativa tra l’agiree il patire e, infine, se alcuni rapporti agente-paziente siano termini intermedidi contrarietà, e in un secondo tempo comincia a porre questioni teoriche piùpregnanti, in cui stabilisce che agire e patire sono categorie separate e, quindi,non necessariamente in relazione reciproca tra loro. In questo primo puntodella mia analisi emerge che secondo Simplicio la nozione di agire, to; poiei'n,è analoga alla nozione di ejnevrgeia, anche se si tratta di nozioni differenti fraloro, differenza di cui lo stesso Commentatore fornisce termini e ragioni.
dimostrato gli aspetti peculiari. A questo proposito Giamblico dice : “Tra gli stessi aspettiritenuti generali sono stati indicati <implicitamente da Aristotele> anche gli aspetti peculiari<delle categorie dell’agire e del patire>, perché egli non assume semplicemente ‘contrari’ e ‘piùe meno’, ma assume alcune cose che sono interne al compiere un’azione, e altre cose che sonointerne al subire un’azione”. È facile (soggiunge Simplicio) replicare a questo proposito che<Aristotele> anche nel caso delle altre categorie non assumeva a caso i contrari e il più e il meno,ma assumeva le cose appropriate <a ciascuna categoria>, e nondimeno credeva che si dovesseroaggiungere agli aspetti generali quelli peculiari ».
4 In LARSEN, 307.1-27.5 In LARSEN, 307.30-308.3.
47LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
Nel secondo punto, che è il più esteso e contiene argomenti di crucialepregnanza teorica, affronto l’analisi delle lin. 301.33-307.1, in cui sonocontenuti i frr. 84, 85 e 86 di Giamblico. Qui Simplicio si pone il problema,una volta stabilito che l’agire e il patire sono generi, cioè categorie, se si debbaporre come genere l’agire, l’azione o l’agente e mostra come giustamenteAristotele abbia posto come categoria l’agire anziché l’agente o l’azione.L’affinità fra l’agire e l’ejnevrgeia che Simplicio ha mostrato precedentementelo induce a chiedersi se non si debba porre come categoria, anziché l’agire,l’ejnevrgeia oppure, dal momento che la nozione di ejnevrgeia parrebbe indicarel’agire nel suo aspetto dinamico dello svolgere un’attività (poiei'n cioè comeejnergei'n), se non si debba porre come categoria il movimento, kivnhsi~. Unasimile posizione teorica è, in effetti, quella di Plotino, che Simplicio chiamasubito in causa : Plotino si pone, infatti, in Enn., VI 1 [42], 15.5 ss., ladomanda se si debba considerare categoria l’agire oppure l’azione e rispondeche, essendo l’agire termine equivalente a ‘trovarsi in una certa azione’ (to;poiei'n ejn poihvsei ei\naiv tini), ne consegue che l’azione (poivhsi~) è nozione piùadatta di quella dell’agire (to; poiei'n) ad essere assunta come categoria. Mapoivhsi~, sempre secondo Plotino, significa ejnevrgeia, per cui si dovrà porrepiuttosto quest’ultima nozione come categoria. E tuttavia, ancora, ejnevrgeiasignifica in effetti kivnhsi~, per cui dovrebbe essere assunta come categoria lanozione di movimento piuttosto che quella di azione (poivhsi~) o quella diattività (ejnevrgeia). Simplicio, sulla scia di Giamblico, combatte questa posi-zione di Plotino, mostrando che movimento e agire sono nozioni differenti,perché, se così non fosse, agire e patire si unirebbero nell’unica categoria delmovimento e non sarebbero più categorie né categorie fra loro separate.
Anche Porfirio si esprime a favore della separazione tra agire e patire,epperò lo fa con argomentazioni che non sono congrue con il pensiero diAristotele, come Simplicio apprende dalla lezione di Giamblico. Il movimen-to, in realtà, lungi dall’essere qualcosa che unisce l’agire e il patire, è separatosia dall’agente sia dal paziente ed è intermedio fra questi due, che sonodistinti fra loro. Ma anche se, partendo dall’agire, in virtù della differenza chesi è stabilita fra l’agire e il movimento, non è corretto affermare che Aristoteleavrebbe dovuto porre come categoria il movimento come ciò che comprendesia l’agire che il patire, rimane pur sempre il problema, posto da Plotino, senon si debba assumere come categoria l’ejnevrgeia. Se infatti il movimento èun’ejnevrgeia ajtelhv~6 , pensa Plotino in Enn., VI 1 [42], 16.1-3, potrebbe esserein ragione di questa imperfezione che Aristotele non ha assunto come catego-
6 Cf. ARISTOT., Phys., III, 2, 201b31-32 ; Meta., IX, 6, 1048b28-29 e XI, 9, 1066a20-21 ; De An.,II, 5, 417a16 e III, 7, 431a6-7.
48 GIOVANNA R. GIARDINA
ria il movimento, e tuttavia avrebbe dovuto assumere come categoria l’ejnevrgeia.È di qui che Simplicio muove per risolvere i problemi da lui posti all’inizio,senza nulla aggiungere, o quasi, alle argomentazioni di Giamblico. Quest’ul-timo, infatti, partendo dall’esigenza di comprendere in che senso il movimen-to è detto da Aristotele ejnevrgeia ajtelhv~, arriva a distinguere nettamentekivnhsi~ ed ejnevrgeia, perché ritiene che, mentre il movimento è un processoche tende verso la realizzazione di qualcosa, ma non è mai esso stesso che sirealizza, perché al contrario è la cosa coinvolta nel movimento che si realizzae quando c’è compiutezza e determinazione non c’è più il movimento, invecel’ejnevrgeia significa proprio la compiuta determinazione formale, perché è ciòche ha in sé la sua forma perfetta (In Cat., 304.7-8). Perciò Giamblico ritienenecessario mettere in luce tutta una serie di differenze (In Cat., 304.10-27)che esistono fra le due nozioni, quella di kivnhsi~ e quella di ejnevrgeia :quest’ultima, infatti, concepita aristotelicamente come determinazione for-male compiuta e immobile dell’ente, appare qui coincidente con la nozione di‘atto’. Plotino, però, non ha inteso la nozione di ejnevrgeia allo stesso modo diGiamblico — sostiene quest’ultimo —, perché considera ejnevrgeia piuttostocome ‘attività’, alla stregua del movimento (kata; to; kinei'stai, 304.30) e delcompiere un’attività (ejnergei'n), e per questo ha identificato attività e movi-mento, mentre si tratta di due nozioni che, a parere di Giamblico, devonoessere tenute ben distinte, né l’una può essere genere dell’altra. Chi pensa chel’ejnevrgeia implichi il movimento ignora, secondo Giamblico, il rapporto cheintercorre fra ciò che è attivo o ‘in atto’, to; ejnergeiva/, e l’attività come tale,ejnevrgeia. Ciò che è attivo o ‘in atto’ è tale non in virtù di un suo rapporto conla potenza, con la quale non c’è rapporto se non di opposizione (come ciò cheè perfetto si oppone all’imperfetto), bensì in virtù del suo rapporto conl’ejnevrgeia, che è un rapporto implicante la perfezione formale che lo rende asua volta perfetto, cioè compiuto. Vero è, però, che ci sono due modi diintendere l’ejnevrgeia, sui quali Giamblico discute subito dopo. C’è infatti, daun lato un genere puro dell’ejnevrgeia, che è quello di cui Giamblico ha fin quiparlato e che corrisponde a una forma separata dal movimento, e dall’altrolato un genere di ejnevrgeia che deriva dal primo e che si riferisce ad attivitànon prive di movimento ed anzi perfettive del movimento stesso, nel sensoche sono forme che precedono e inducono il movimento, in quanto si realiz-zano nella materia grazie al movimento. L’ejnevrgeia è sempre, secondoGiamblico, una determinazione formale, che però ha due aspetti differenti :in quanto si realizza nei processi è connotativa dell’agire ed è perfettiva delmovimento, nel senso che specifica l’agire e guida il movimento verso larealizzazione di sé come forma compiuta ; in quanto forma immobile (quandoappunto è considerata nel suo genere puro), invece, è del tutto separata dalmovimento. Plotino, che non ha compreso, secondo Giamblico, né questi due
49LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
sensi dell’ejnevrgeia né la differenza fra ejnevrgeia e kivnhsi~, si è posto ilproblema di considerare l’ejnevrgeia come categoria unitaria al posto dell’agiree del patire aristotelici, non comprendendo che non ogni azione è attività néogni attività è azione. In realtà, le forme che fungono da motori primi eimmobili sono agenti, la cui azione non si mescola ad alcuna affezione, eperaltro l’agire di questi agenti primi non è un’azione7 . Mettere insiemepoiei'n e pavscein, kivnhsi~ ed ejnevrgeia, significa non riconoscere che c’è unprincipio immobile del movimento. Plotino si è lasciato ingannare dagliStoici, i cui errori su questi problemi Giamblico mostra dettagliatamente.
Nel terzo punto della mia suddivisione analitica del tema in questione misoffermo sull’analisi delle lin. 307.1-19, che fanno parte del fr. 87 di Giamblico,perché, al fine di discutere il modo in cui gli Stoici hanno interpretatol’affermazione di Aristotele secondo cui il movimento sarebbe una ejnevrgeiaajtelhv~, Giamblico utilizza la nozione di ejntelevceia. Imperfetta, dice infattiGiamblico, non è l’ejnevrgeia, bensì l’ejntelevceia, dal momento che, in partico-lare, occorre identificare il movimento con l’entelechia imperfetta e non conquella perfetta. La nozione di entelechia imperfetta, infatti, individua alcontempo la processualità in cui è coinvolto un ente e la forma che taleprocesso tende ad attuare. Giamblico utilizza, comunque, anche la nozione dientelechia perfetta, facendola coincidere con lo stato compiuto della formache si è realizzata tramite il movimento.
Nel quarto ed ultimo punto, infine, affronto l’analisi delle lin. 307.20-308.10, corrispondenti alla fine del fr. 87 e al fr. 88 di Giamblico, dove ilproblema della differenza tra ciò che è attivo o ‘in atto’, to; ejnergeiva/, e l’attivitào atto, ejnevrgeia, viene riproposto alla luce della differenza che Giamblico hastabilito fra ejnevrgeia ed ejntelevceia. Ciò che è attivo o ‘in atto’, infatti,corrisponde all’entelechia nella misura in cui per entrambe queste nozioni siparla di rapporto con l’aspetto potenziale, al contrario di ciò che accade nelcaso dell’ejnevrgeia che non è in rapporto al potenziale ma esiste per se stessa(kaq’ eJauthvn). Tuttavia, precisa Simplicio a rincalzo di questo discorso diGiamblico, ciò che è attivo o ‘in atto’ non indica affatto un movimento — comepotrebbe far pensare l’ammissione di un suo rapporto con la potenza — mapiuttosto la perfezione di ciò che prima era imperfetto. Si prepara così ladefinitiva confutazione, da parte di Simplicio, della posizione teorica diPlotino tramite la citazione del fr. 88 di Giamblico e la conseguente difesa diAristotele. Plotino in definitiva ha commesso, secondo Giamblico (e, quindi,anche secondo Simplicio), tre ordini di errori, dovuti tutti all’identificazione
7 Ad esempio l’arte medica quale forma della salute è per Aristotele un motore o agenteprimo che agisce immobilmente senza che il suo agire sia un’azione e senza subire azione daparte di ciò su cui agisce.
50 GIOVANNA R. GIARDINA
del movimento con l’ejnevrgeia : a) non ha assunto in quanto mobile l’operazio-ne del movimento (oujc h| / kinhtovn, fhsivn [scil. Giamblico], lambavnei~ to; e[rgonth'~ kinhvsew~) ; b) non ha collegato tale operazione alla potenza (oujde; pro;~ th;nduvnamin aujto; sunavptei~) ; c) non ha assunto l’entelechia come appartenente aun mobile (oujde; th;n ejntelevceian ou\n wJ~ kinhtou' lambavnei~).
2. Il rapporto fra poiein ed energheia␣ : SIMPL., In Cat., 295.1-301.33 — Apartire dalla p. 295.1 del suo Commentario alle Categorie Simplicio si occupadelle categorie dell’agire e del patire (to; poiei'n kai; to; pavscein)8. Dapprima ilCommentatore procede con argomenti di ordine generale, affermando adesempio che Aristotele si è occupato dell’agire e del patire principalmente nelDe generatione et corruptione (In Cat., 295.11-12) e che, in quanto tali catego-rie hanno rapporto sia con la sostanza che con la quantità, con la qualità e conla relazione così come l’attività e l’affezione hanno rapporto con la realtà (wJ~pro;~ u{parxin ejnevrgeia kai; pavqo~ — 295.23), è giusto che le categorie dell’agiredel patire siano trattate dopo le quattro categorie sopracitate (295.17-24)9 .Simplicio si dilunga poi sul rapporto di contrarietà che lega l’agire e il patirecon riferimento a quanto Aristotele dice in Cat., 9, 11b1-8 10, e fa lo stessoesempio di Aristotele del rapporto che esiste fra il riscaldare e il raffreddaree l’essere riscaldato e l’essere raffreddato, che sono contrari fra loro eaccolgono il più e il meno (in quanto è appunto possibile riscaldare oraffreddare e l’essere riscaldato o l’essere raffreddato di più o di meno)11 . Alcontempo, però, pur prendendo spunto da Cat., 9, 11b1-8, Simplicio riflettesul fatto che c’è contrarietà fra due processi non solo sotto il profilo qualitativo,
8 Al titolo Peri; tou' poiei'n kai; pavscein Simplicio fa seguire l’indicazione del passaggio delleCategorie di Aristotele di cui si occuperà, e precisamente Cat., 9, 11b1-2, il cui testo è il seguente :’Epidevcetai de; kai; to; poiei'n kai; pavscein [to; pavscein SIMPL.] ejnantiovthta kai; to; ma'llon kai; to; h|tton.Simplicio tiene conto anche delle successive lin. b2-16, in cui Aristotele propone come esempidi categorie che implicano ‘contrarietà’ e ‘più e meno’ quelle del riscaldare e raffreddare e delrallegrarsi e rattristarsi. Aristotele conclude che per quanto concerne le rimanenti categorie, ecioè quelle dello stare, del tempo, del luogo e dell’avere, basta rinviare a quanto egli stesso hagià detto. L’ultima parte di questo testo (lin. 10-16) è da espungersi secondo Minio-Paluello,l’autore dell’edizione oxoniense.
9 Diversa è l’opinione di AMM., In Cat., 92.10-11, secondo il quale l’agire e il patire sarebberodue categorie derivanti dalla mescolanza della categoria della sostanza con la categoria dellaqualità (ejk th'~ mivxew~ th'~ oujsiva~ kai; tou' poiou' gi vnontai e{terai duvo to; poiei'n kai; to; pavscein).
10 ARISTOT., Cat., 9, 11b1-8 : « Anche l’agire e il patire accolgono contrarietà e il più e il meno,perché il riscaldare è contrario al raffreddare e l’essere riscaldato all’essere raffreddato e ilprovare piacere al provare dolore ; sicché accolgono contrarietà. <Ma accolgono> anche il piùe il meno, perché è possibile riscaldare di più e di meno, ed essere riscaldato di più e di meno,e provare dolore di più e di meno ; dunque l’agire e il patire accolgono il più e il meno ».
11 Cf. anche più avanti SIMPL., In Cat., 297.1 ss.
51LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
nel caso in cui, cioè, tali processi siano qualitativamente contrari (come nelcaso del riscaldare e del raffreddare, che rientrano entrambi nell’agire, odell’essere riscaldati e dell’essere raffreddati, che rientrano entrambi nelpatire), ma anche sotto il profilo dell’agire e del patire come contrari tra loro(per cui ci sarà contrarietà fra il riscaldare e l’essere riscaldato o fra ilraffreddare e l’essere raffreddato). In effetti, come sottolinea Simplicio, icontrari agiscono sui contrari (ta; de; ejnantiva ejnantivwn ejsti;n poihtikav —296.17-18), per cui ci sarà contrarietà anche nell’agire (ei[h a]n kai; ejn tw' / poiei'nejnantivwsi~), quando la contrarietà è assunta come attività dei generi cheaccolgono contrarietà (o {tan w J~ e jne vrgeia lamba vnhtai tw 'n e jnantio vthtaejpidecomevnwn genw'n — 296.18-19) : in altri termini, quando c’è un genere cheaccoglie la contrarietà, come avviene nel caso della qualità (si pensi allacontrarietà del riscaldare e del raffreddare), l’attività (ejnevrgeia) che producecontrarietà è l’agire stesso e ci sarà contrarietà tanto nell’agire che nel patire,per il fatto che « ciò che produce l’agente, è <precisamente> ciò che patisce ilpaziente (o} ga;r to; poiou'n poiei', tou'to pavscei to; pavscon — 296.20) ». In breve,se l’agente è il freddo la sua attività, che coincide con il suo agire, è quella diraffreddare e il paziente, quindi, viene raffreddato, mentre se l’agente è ilfuoco, ovverosia il caldo, la sua attività, che ancora una volta coincide con ilsuo agire, è quella di riscaldare e il paziente viene riscaldato.
E ancora, fra le contrarietà — fa notare Simplicio —, alcune hanno terminiintermedi, e sono quelle in cui le qualità che costituiscono la contrarietàhanno termini intermedi, mentre altre non hanno termini intermedi, e sonoquelle in cui le qualità che costituiscono la contrarietà non hanno terminiintermedi. Questo discorso però viene opportunamente esteso da Simplicio alproblema dell’agire e del patire. Se infatti prendiamo in considerazione unaqualità che ha termini intermedi, allora li avrà anche la contrarietà corri-spondente considerata sotto il profilo dell’agire e del patire (ad esempiol’intiepidire, in quanto il tiepido è intermedio fra il caldo e il freddo, oppurel’arrossire, in quanto il rosso come il grigio è un intermedio fra il bianco e ilnero) ; se al contrario prendiamo in considerazione una qualità che non hatermini intermedi, allora anche la contrarietà corrispondente, consideratasotto il profilo dell’agire e del patire, non avrà termini intermedi (ad esempionon ci sono termini intermedi fra il guarire e l’ammalarsi) e non ci sarannoagenti produttivi di una qualità intermedia di questo tipo né enti che lasubiscano (ou[te ta; ejnerghtika; touvtwn ou[te ta; paqhtikav — 296.25-26), appuntoperché non c’è la qualità intermedia12 .
12 Tutto questo discorso si legge in SIMPL., In Cat., 296.19-26.
52 GIOVANNA R. GIARDINA
A questo punto Simplicio si sofferma su Cat., 9, 11b10 ss. In questa partedelle Categorie Aristotele accenna brevissimamente alla categoria dello ‘sta-re’, dicendo che ne ha discusso a proposito della relazione, e trascura del tuttole rimanenti tre categorie, cioè il ‘dove’, il ‘quando’ e l’‘avere’, dicendo che èsufficiente a loro riguardo quanto ne ha detto prima. Simplicio, per supplirea questa scarsa attenzione che Aristotele ha riservato a tali categorie, ripren-de, come egli stesso afferma, gli studi approfonditi di Porfirio e di Giamblicosu questi argomenti13 . A partire da 299.1 Simplicio ritorna però al problemadell’agire e del patire, in ordine al fatto che alcuni contestano ad Aristoteleche non si tratta di categorie separate l’una dall’altra, bensì di categorierelative l’una all’altra. Costoro, pensa Simplicio, sbagliano, perché l’agire e ilpatire non esistono per reciproca relazione —, come ad esempio accade nelcaso di destra e sinistra, che sono tali solo in virtù della relazione dell’uno conl’altro —, in quanto da un lato l’agente esiste a prescindere dal paziente edall’altro lato il paziente esiste a prescindere dall’agente (299.3-6). « Ingenerale — afferma Simplicio — l’agire si dice di ogni cosa che compieun’azione, ma non ogni attività ha relazione con una cosa che patisce (o{lw~de; kata; panto;~ me;n ejnergou'nto~ to; poiei'n levgetai, ouj pa'sa de; ejnevrgeia pro;~pavscon — 299.9-10) ». Che la relazione fra agire e patire sia non necessaria èconfermato peraltro dal seguente discorso : se l’agire e il patire, si domandaSimplicio, sono entrambi generi, come mai, per il fatto che l’avere (to; e[cein)è genere, non è un genere anche l’essere posseduto (to; e[cesqai), dato chel’avere si distingue (ajntidiairei'tai) dall’essere posseduto così come il patire sidistingue dall’agire ? Forse perché (h] o{ti) nell’avere è compreso anche l’essereposseduto ? In verità, precisa Simplicio, ciò che è posseduto è congiuntoall’avere, per cui quando si assume quest’ultimo si assume di conseguenzaanche il primo, mentre la stessa cosa non accade nel caso dell’agire e delpatire, poiché c’è agire a cui non è congiunto alcun patire (299.36-300.5).
A partire dalla lin. 301.20 Simplicio ricapitola brevemente il discorso fattofino a questo punto e anzitutto sottolinea che al suo discorso consegue chel’agire e il patire sono generi e che, come si era posta come genere dopo lasostanza la quantità, e poi si era posta alla stessa maniera come genere laqualità, « allo stesso modo anche l’attività, cioè l’agire, viene dopo la sostanzaed è necessario, perciò, che dopo la realtà14 si pongano come genere l’attivitàe l’affezione congenere a questa, ovvero il patire (ou{tw~ kai; hJ ejnevrgeia kai; to;poiei'n meta; th;n oujsivan, kai; crh; kai; kata; tau'ta gevno~ tivqesqai meta; th;n u{parxinth;n ejnevrgeian kai; to; tauvth~ suggene;~ pavqo~ h] to; pavscein — 301.24-26) ». Se però
13 SIMPL., In Cat., 297.12-298.27 ; cf. GIAMBLICO fr. 82 Larsen.14 Ovverosia dopo la concreta sostanza.
53LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
è chiaro che bisogna porre come generi l’agire e il patire, non è ancora chiaro,secondo Simplicio, se si debba porre come genere l’agire (to; poiei'n) o l’agente(to; poiou'n) o l’azione (hJ poivhsi~), domanda che nasce dal fatto che Aristoteleavrebbe posto come genere la qualità (hJ poiovth~) e il quale (poiovn)15 . « Oppureanche in questo caso — aggiunge Simplicio — azione, agire e agente sonocongiunti tra loro (h] suvzuga me;n uJpavrcei kai; ejntau'qa poivhsi~ poiei'n poiou'n)16 ,ma mentre l’agente include il soggetto e introduce un’idea composta da ciòche svolge un’attività e dall’attività (ajlla; to; me;n poiou'n sumperilambavnei kai; to;uJpokeivmenon kai; suvnqeton uJpovnoian e[k te tou' ejnergou'nto~ kai; th'~ ejnergeiva~ejmpoiei'), l’azione e l’agire, invece, sono <concetti> più semplici e non possie-dono alcuna composizione, sicché essi sono <concetti> più adatti di quello diagente per una definizione di genere (hJ de; poivhsi~ kai; to; poiei'n aJplouvstera kai;oujde;n sunqevsew~ ejfaptovmena, w{ste oijkeiovtera tau'ta tou' poiou'nto~ eij~ gevnou~ajforismovn — 301.28-33) ».
Ora, occorre notare che in tutto il discorso di Simplicio qui riassunto, siè fatto uso continuamente della nozione di attività (ejnevrgeia) al fine dispiegare l’agire (to; poiei'n) e con esso l’azione (hJ poivhsi~) e l’agente (to; poiou'n).Quando ad esempio Simplicio afferma (295.17-24) che occorre trattare dellacategoria dell’agire dopo le categorie della sostanza, della quantità, dellaqualità e della relazione, egli specifica che l’agire e il patire hanno rapportocon queste categorie così come l’attività e l’affezione hanno rapporto con larealtà (wJ~ pro;~ u{parxin ejnevrgeia kai; pavqo~ — 295.23). In quest’ultima espres-sione si percepisce l’intenzione di Simplicio di considerare, prima ancora diarticolare il suo discorso sull’agire e sul patire, la nozione di ejnevrgeia comeequivalente a quella di poiei'n e la nozione di pavqo~ come equivalente a quelladi pavscein ; del resto, poco più avanti, precisamente alla lin. 296.9, Simplicioafferma esplicitamente che ‘agire’ significa ‘attività’ e ‘patire’ significa ‘affe-zione’ (shmaivnei de; to; me;n poiei'n ejnevrgeian, to; de; pavscein pavqo~) e specifica chequest’ultima nozione, quella cioè di affezione, non deve essere intesa nelsenso in cui la intenderemmo se parlassimo della categoria della qualità,come quando ad esempio si parla di una caratteristica dell’animo, ma deveessere intesa sotto il profilo del movimento che c’è nell’affezione (kata; th;n ejntw' / pavqei kivnhsin — 296.11). In altri termini, se prendiamo come esempio ilcaldo, e intendiamo il suo pavqo~ nel senso del movimento che lo riguarda,otteniamo l’essere riscaldato, e in questo consisterà il patire (to; pavscein) ilcaldo da parte di un ente. Poco più avanti, l’attività (ejnevrgeia) che produce
15 SIMPL., In Cat., 301.27-28 : ajll’ a\ra to; poiei'n h\n ti vqesqai gevno~ h] to; poiou'n h] th;n poivhsin,w{sper kai; hJ poiovth~ h\n gevno~ kai; to; ajp’ aujth'~ poiovn…
16 Cf. PLOT., Enn., VI 1 [42], 15.5-8 : ‘Ar’ ou\n to; poiei'n h] hJ poivhsi~, ajf’ h|~ to; poiei'n, w{sper kai;poiovth~, ajf’ h|~ to; poiovn… ‘H ejntau'qa poivhsi~, poiei'n, poiw'n, h] poiei'n kai; poivhsi~ eij~ e}n lhpteva…
54 GIOVANNA R. GIARDINA
contrarietà appare, nel discorso di Simplicio, come l’agire stesso (to; poiei'n),ma poiché, come si è visto, « ciò che produce l’agente, è <precisamente> ciò chepatisce il paziente (296.20) », allora l’ejnevrgeia non è altro che l’agire (to; poiei'n)stesso dell’agente. D’altronde, alle lin. 301.24-26, quando, per ricapitolarebrevemente il discorso fatto in precedenza, Simplicio ribadisce che la categoriadell’agire viene dopo quella della sostanza, hJ ejnevrgeia kai; to; poiei'n costituisco-no un’endiadi con cui si vuol significare che appunto la categoria dell’agire sicolloca logicamente meta; th;n oujsivan, dopo la sostanza, concetto ribadito conl’espressione secondo cui bisogna porre l’attività e l’affezione congenere aquesta, ovvero il patire (th;n ejnevrgeian kai; to; tauvth~ suggene;~ pavqo~ h] to; pavscein),dopo la realtà (meta; th;n u{parxin). Anche qui appare evidente che, secondoSimplicio, la nozione di ejnevrgeia è di fatto equivalente alla nozione di ‘agire’(poiei'n), così come quella di pavqo~ è equivalente a quella di ‘patire’ (pavscein).
Più avanti Simplicio, come si è detto, riflette sul fatto che si trovacontrarietà se si prendono in esame non solo le qualità contrarie, ma anchequei processi in cui sussiste relazione fra ciò che agisce e ciò che patisce. Adesempio, un processo visto sotto il profilo di una stessa e medesima qualità,ad esempio un processo di riscaldamento, postula come contrari fra lorol’agente che riscalda e il paziente che subisce questo riscaldamento. Ma, perspiegare questo concetto, Simplicio afferma che ci sarà contrarietà anchenell’agire quando la contrarietà è assunta come attività (wJ~ ejnevrgeia) deigeneri che accolgono contrarietà (296.18-19), nel senso che, come ho giàdetto, se assumiamo ad esempio una qualità che accoglie la contrarietà,l’attività (ejnevrgeia) che produce contrarietà è l’agire stesso, poiché taleattività consiste nel compiere un’azione che mette in relazione ciò che compiel’azione o agente e ciò che la subisce o paziente. Ad esempio, l’attività delriscaldare si compie attraverso un agente riscaldante e un paziente riscaldatoe il compiere una tale azione (ejnergei'n) è di fatto un agire (poiei'n) a cuicorrisponde un patire (pavscein) ad esso contrario.
Alle lin. 296.25-26, dopo aver detto che la relazione di contrarietà cheesiste fra l’agire e il patire non ha termine intermedio se si assume una qualità— come ad esempio la salute o la malattia — che non ha termini intermedi,Simplicio, per dire che appunto non c’è un agire o un agente di una qualitàintermedia che non sussiste, esprime questo pensiero dicendo che non ci sonoagenti produttivi (ta; ejnerghtikav) così come, per dire che non c’è un patire oun paziente di una qualità intermedia che non sussiste, dice che non ci sonoenti capaci di subirla (ta; paqhtikav). Ancora una volta, quindi, Simplicio usala nozione di ejnergei'n come equivalente a quella di poiei'n. E ancora, alle lin.299.9-10, per affermare che la relazione fra l’agente e il paziente non ènecessaria, cioè non si realizza sempre in tutti i processi, Simplicio affermache l’agire (to; poiei'n) si dice sempre di qualcosa che compie un’azione
55LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
(ejnergou'nto~) e che però non ogni attività (ejnevrgeia) è relativa a un paziente(pavscon), mostrando così che è possibile scambiare senza problemi poiou'nto~,l’agente, con ejnergou'nto~, e quindi poivhsi~ con ejnevrgeia. Questa relazionenecessaria fra ejnevrgeia e poiei'n, così com’è sostenuta da Simplicio, è confer-mata da altri passaggi : alle lin. 301.29-31 l’agente (to; poiou'n) comprende nelsuo significato sia ciò che svolge un’attività (tou' ejnergou'nto~) sia l’attivitàstessa (th'~ ejnergeiva~), mentre alle lin. 301.33-35, l’azione (poivhsi~), affermaSimplicio, si dice in due sensi, perché significa sia attività, ejnevrgeia, sial’esito dell’attività, to; ajpotevlesma th'~ ejnergeiva~.
In breve. Da quanto Simplicio ha fin qui detto della categoria dell’agire e delpatire emerge che egli, come ho detto, considera la nozione di ejnevrgeia, maanche gli altri termini che gravitano nell’area semantica del verbo ejnergei'n,come equivalenti a quelli che gravitano nell’area semantica del verbo poiei'n. Aquest’ultimo viene assimilato talvolta ejnergei'n e talvolta ejnevrgeia, termine chealtre volte risulta equivalente a poivhsi~ (più avanti, leggendo le lin. 302.2-3, sicomprenderà che ejnevrgeia è equivalente a poiei'n piuttosto che a poivhsi~, inquanto l’agire significa l’attività ancora in svolgimento — to; ga;r poiei'n th;n e[tiginomevnhn ejnevrgeian shmaivnei —, mentre l’azione significa piuttosto il momentoin cui <l’azione> si arresta perché l’agente ha realizzato il suo scopo). A partiredalle lin. 301.33, tuttavia, si vedrà come Simplicio ritenga che Aristotele hagiustamente dato la sua preferenza a poiei'n rispetto a to; poiou'n e a poivhsi~, dalmomento che solo poiei'n indica propriamente lo svolgimento di un’azioneovvero un processo, laddove gli altri termini appartenenti alla sua stessa areasemantica, to; poiou'n e poivhsi~, recano con sé significati aggiuntivi che non lirendono adatti a fungere da genere o categoria. Solo poiei'n può essere consi-derato equivalente a ejnergei'n, anche secondo una lezione che si trova già nelCommentario alle Categorie di Ammonio, dove, alla lin. 92.17, si legge appuntoche « agire è dunque compiere un’azione su qualcosa — e[stin ou\n poiei'n me;n to;ei[~ ti ejnergei'n », nel duplice senso, sempre secondo Ammonio, che si può agiresu se stessi (come nel caso dell’anima che conosce se stessa) o su qualcosa didiverso (come nel caso del riscaldare). Io colgo però un ulteriore aspettodell’affinità che Simplicio stabilisce fra poiei'n ed ejnevrgeia, aspetto che a mioavviso merita una particolare attenzione anche al fine di comprendere inmaniera appropriata la questione che, tramite le citazioni di Giamblico che sisusseguono l’una all’altra, Simplicio si appresta a trattare sotto forma didiscussione confutatoria della posizione teorica di Plotino. Da un lato, infatti,si è visto chiaramente come Simplicio utilizzi come equivalenti fra loro terminiquali poiei'n, ejnergei'n, ejnevrgeia, e ancora come per lui to; poiou'n sia equivalentea to; ejnergou'n, così come poivhsi~ è equivalente a ejnevrgeia. Dall’altro lato, però,occorre notare che questa equivalenza non significa identità concettuale,perché, al contrario, mentre to; poiei'n appare come un verbo che ha significato
56 GIOVANNA R. GIARDINA
generico, e infatti lo traduciamo con ‘agire’ senza possibilità di determinazio-ne aggiuntiva — ed è grazie a questa genericità, peraltro, che to; poiei'n apparea giusto titolo come una categoria —, la nozione di ejnevrgeia, invece, sembrapiuttosto significare quella precisa determinazione in virtù della quale l’‘agire’assume la connotazione di un particolare agire, ad esempio del riscaldare odel raffreddare eccetera. Si incontra qualche difficoltà, in effetti, a compren-dere questa nozione di ejnevrgeia alla quale Simplicio assimila, per così dire,l’agire, e non sarà certo sfuggito a chi legge che parlando dell’ejnevrgeia io hoscritto, in precedenza, nel tentativo di darne una traduzione, ora ‘attività’ —nozione con la quale non abbiamo eccessiva difficoltà ad assimilare l’agire,stante la medesima radice verbale almeno nelle principali lingue moderne —ora ‘atto’ — nozione certamente più familiare, almeno agli studiosi di Aristotele,ma in ogni caso più difficile ad essere assimilata all’agire. Proviamo, allora,a rivedere sotto questo particolare profilo alcuni dei passaggi già letti.
Alla lin. 295.23 si è già visto il passaggio nel quale, per dire che la categoriadell’agire deve essere trattata dopo quelle di sostanza, quantità, qualità erelazione, Simplicio afferma che l’agire e il patire hanno rapporto con questequattro categorie così come l’attività e l’affezione hanno rapporto con la realtà(wJ~ pro;~ u{parxin ejnevrgeia kai; pavqo~ — 295.23, cf. anche 301.24-26). Che quiejnevrgeia serva a Simplicio per indicare l’agire così come pavqo~ gli serve perindicare il patire, lo si è già dimostrato. Ma questo rapporto con la realtà17
tanto dell’ejnevrgeia quanto del pavqo~ indica abbastanza chiaramente, a miomodo di vedere, il fatto che agire e patire vanno visti alla luce di unadeterminazione sì formale, ma che è quella stessa che poi si realizza nellasostanza delle cose. A proposito di pavqo~ che significa il patire, to; pavscein,Simplicio poco più avanti (296.9 ss.) precisa con chiarezza che questa nozionedi affezione deve essere intesa sotto il profilo del movimento, nel senso che,come si è visto, fa capo a una determinazione formale in rapporto alla qualerisulta essere un particolare movimento passivo. Di qui si può intuire comel’ejnevrgeia, che in questa coppia di termini indica l’agire, sia anch’essa pro;~u{parxin, nel senso che rappresenta un agire che fa capo a una determinazioneformale in rapporto alla quale risulta essere un movimento attivo.
Altri passaggi mi confermano in questa mia interpretazione. Alle lin.296.17 ss., ad esempio, Simplicio dice che « se le contrarietà sono in funzionedelle qualità (e infatti il caldo è contrario al freddo), e i contrari sono produttivi
17 L’espressione pro;~ u{parxin ha più o meno lo stesso significato dell’espressione pro;~oujsivan, con la differenza che, mentre quest’ultima indica un rapporto che è di natura formalee immateriale, la prima invece indica un rapporto che è sì di natura formale ma anche materiale,in quanto concerne concretamente la realtà delle cose. È questa la ragione per la quale iopreferisco tradurre il termine u{parxi~ con ‘realtà’, che sta a indicare la sostanza che si è giàrealizzata secondo la sua propria forma o essenza.
57LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
dei contrari, allora ci sarà contrarietà anche nell’agire, qualora sia assuntacome attività quella dei generi che ammettono contrarietà » (296.16-19) : inaltri termini Simplicio sostiene che, affinché vi sia contrarietà nell’agireoccorre che questo sia concepito come suscettibile di contrarietà, cioè implichiil suo contrario, ovverosia il patire : ci sarà in tal modo nell’attività, ejnevrgeia,una contrarietà tra l’agire e il patire, per il fatto che, come chiarisce lo stessoSimplicio, « ciò che produce l’agente è <precisamente> ciò che patisce ilpaziente », cioè è una medesima proprietà formale quella sulla base della qualesi determina un movimento attivo e l’altro passivo. In questo modo l’attivitàdell’agente risulta determinata e coincide con l’agire ; determinata risultaanche l’affezione del paziente sulla base della medesima determinazione for-male. Avremo così, come ho già detto, ad esempio un agente che riscalda e unpaziente che viene riscaldato in virtù della proprietà formale che è il caldo e cheva a connotare come un ‘riscaldare’ il generico agire. E ancora, quandoSimplicio, come si è già visto sopra, si domanda se si debba porre come generel’agire (to; poiei'n), o l’agente (to; poiou'n) o l’azione (poivhsi~), l’agente, to; poiou'n,appare come una nozione composta, perché significa sia l’ente che compieun’attività, to; ejnergou'n, sia l’attività, ejnevrgeia : anche qui è chiaro che, perindividuare un agente specifico, occorre che ci sia una determinazione forma-le, ejnevrgeia, in virtù della quale può essere detto agente, mediante il participiodi ejnergevw, la cosa o la persona che agisce. Ora, questo impianto del discorsodi Simplicio porta con sé problemi che impegnano a tutt’oggi gli studiosi deitesti aristotelici. Ci si domanda, infatti, se l’ejnevrgeia sia, nel senso della suadeterminazione formale, un’attività o un atto che implichi o no movimento. Hogià accennato sopra e si vedrà più dettagliatamente in seguito che ejnevrgeia haun doppio significato, almeno secondo l’opinione di Giamblico seguita daSimplicio : o come forma perfettiva del movimento (per cui quest’ultimo vienedefinito aristotelicamente come entelechia equivalente a una ejnevrgeia ajtelhv~),oppure come forma compiuta e immobile. La difficoltà di dirimere questaquestione si presenta già a proposito di alcuni passaggi di Aristotele il quale,in Meta., Q, 6, 1048b8-9, ad esempio, fornisce due significati di ejnevrgeia : qualeoujsiva in rapporto alla materia e quale movimento in rapporto alla potenza18 .
18 È questo significato di ejnevrgeia che ha molto interessato non solo i commentatori antichidi Aristotele, ma anche gli studiosi moderni, che si sono concentrati prevalentemente su quantolo Stagirita dice alle lin. 1048b18-35. Lo studio di riferimento a questo proposito è quello di J.L. ACKRILL, Aristotle’s Distinction between Energeia and Kinesis, in R. BAMBROUGH ed., New Essayson Plato and Aristotle, Routledge & Kegan Paul, London 1965, pp. 138-140, con il quale, tuttavia,non tutti gli studiosi concordano, cf. ad esempio L. A. KOSMAN, Substance, Being, and Energeia,« Oxford Studies in Ancient Philosophy », 2, 1984, pp. 121-149 ; R. BRAGUE, Aristote et la questiondu monde. Essai sur le contexte cosmologique et anthropologique de l’ontologie, PUF, Paris 1988,pp. 468 ss. Contro le tesi qui esposte da Brague cf. B. BESNIER, Acte et puissance selon Aristote,« Les cahiers de Philosophie », 13, 1991, pp. 143-177, p. 153 ss.
58 GIOVANNA R. GIARDINA
Ma l’ejnevrgeia nei passaggi qui esaminati di Simplicio sembra significare, indefinitiva, una sorta di connotatore di tipo formale, e perciò di naturaontologica, di processi di divenire, per cui ejnergei'n non è in sostanza una cosadiversa da poiei'n, ma è un agire determinato. Stando così le cose, in cherapporto stanno fra loro l’agire, di cui si può parlare nei termini in cui ne haparlato fin qui Simplicio, l’ejnevrgeia e il movimento ?
Questa domanda si pone in vista sia dell’argomentazione che Simplicio siappresta a svolgere sulla base delle critiche mosse da Giamblico a Plotino —critiche intese a dimostrare che ejnevrgeia e kivnhsi~ sono due nozioni cosìdifferenti dalla categoria dell’agire che né l’una né l’altra può essere assuntaal posto di quest’ultima —, sia del fatto che l’affinità fra poiei'n ed ejnergei'n cheSimplicio ha fin qui stabilito non è in effetti una lezione che egli ha assuntodal De generatione et corruptione di Aristotele, che lo stesso Simplicio hadichiaratamente e correttamente considerato quale scritto di riferimento perla trattazione aristotelica dell’agire e del patire (295.11-12). In GC, infatti, lanozione di ejnevrgeia è utilizzata soltanto sei volte e mai nei capitoli 7-9 in cuilo Stagirita si occupa appunto dell’agire e del patire. Ciò che Simpliciosembra avere ben presente è invece il discorso di Phys., III, 1-3, in cuiAristotele, nell’affrontare il problema della kivnhsi~ e in particolare del rap-porto motore-mosso, mette insieme le nozioni di kinei'n, poiei'n ed ejnevrgeia,rendendo possibile non solo l’accostamento fra poiei'n ed ejnergei'n postulatoqui da Simplicio, ma anche la successiva discussione di quest’ultimo sullaposizione di Plotino, il quale ritiene che anziché l’agire Aristotele avrebbedovuto assumere come categoria il movimento, in cui l’agire rientrerebbe.Plotino sostiene anzi, che, poiché il movimento è definito da Aristoteleejnevrgeia imperfetta, egli avrebbe dovuto assumere come categoria propriol’ejnevrgeia. Alla fine di Phys., III, 2, Aristotele, per mostrare come il movimen-to nasca da una relazione fra un motore e un mosso, scrive : « è mosso poi,come si è detto, anche ciò che muove (kinei'tai de; kai; to; kinou'n), cioè il motore,poiché è mobile tutto ciò che è in potenza (pa'n to; dunavmei o]n kinhtovn) e la cuiassenza di movimento è quiete (hjremiva), perché è quiete l’assenza di movi-mento di ciò a cui appartiene il movimento19. Infatti il compiere un’azione inrelazione a questo (scil. in relazione al mobile), è in quanto tale il muoverestesso (to; ga;r pro;~ tou'to ejnergei'n, h| / toiou'ton, aujto; to; kinei'n ejsti) ; questo poi(scil. il motore) agisce per contatto, sicché contemporaneamente anchepatisce (tou'to de; poiei' qivxei, w{ste a{ma kai; pavscei), perciò il movimento è
19 Questo passaggio, cioè Phys., III, 2, 202a3-5, presenta qualche difficoltà testuale, di cuiho discusso in G. R. GIARDINA, La “causa motrice” in Aristotele, Phys. III 1-3, in R. L. CARDULLO,G. R. GIARDINA edd., La Fisica di Aristotele oggi. Problemi e prospettive, CUECM, Catania 2005, p.130 nota 36.
59LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
entelechia del mobile, in quanto mobile, e questo avviene per contatto di ciòche è capace di muovere, sicché contemporaneamente anche patisce (dio; hJkivnhsi~ ejntelevceia tou' kinhtou', h| / kinhtovn, sumbaivnei de; tou'to qivxei tou' kinhtikou',w{sq’ a{ma kai; pavscei) »20. Per riassumere quanto Aristotele dice in questopassaggio della Fisica, potremmo dire che, nel caso del motore, compiereun’attività, ejnergei'n, o muovere, kinei'n, sono la stessa cosa, e questo compiereun’attività da parte del motore avviene per contatto, per cui c’è anche unacompresenza di agire e patire. Questa compresenza o reciprocità di agire epatire è quella stessa che si trova nell’esempio del caldo e del freddo, cheAristotele fa poco prima in Phys., III, 1, 201a19 ss.21 , compresenza di potenzaed entelechia nello stesso ente che Aristotele enuncia nel primo assioma (III,1, 200b26-28). Stando all’esempio, se un ente è caldo in potenza e freddo inentelechia, allora è un ente che sta divenendo più o meno caldo o freddo (aseconda che la sua realtà si sposti verso il non essere della potenza o versol’essere dell’entelechia). Ciò implica una reciprocità di azione e passione,perché in quell’ente il caldo agisce sul freddo che subisce il caldo o viceversa,di modo che nell’ente si va realizzando una delle due proprietà contrarie. Inquesto esempio il freddo non è compiutamente in atto, ma è un freddo che,pur essendo tale, lascia spazio alla realtà del caldo ; ed è appunto questa lacondizione del l ’agire e del patire contemporaneamente (a {ma) . Lacontemporaneità di potenza ed entelechia riflette, infatti, in Phys., III, 1-2, lareciprocità dell’agire e del patire. Proprio questa impostazione della relazio-ne tra agire e patire introduce, sempre nella Fisica, al rapporto motore-mobile, perché anche il motore risulterà mosso, eccetto, aggiunge Aristotele,che nel caso del motore immobile. Ma lasciando da parte quest’ultimo caso,a partire da Phys., III, 2, 202a3 ss., la funzione che rende il motore un agenteè appunto quella di muovere, e poiché tale funzione viene esercitata percontatto, allora ciò che agisce, cioè il motore, contemporaneamente anchepatisce22 . Riassumendo ancora, quindi, per quanto concerne il motore, movi-mento significa muovere, ossia compiere un’azione, e ciò comporta che ilmotore agisce e patisce al contempo (kivnhsi~ = ejnergei'n = kinei'n = poiei'n/pavscein). Per quanto concerne il mobile, invece, movimento significa perAristotele entelechia, e questa significa al tempo stesso essere mosso, cioèpatire (kivnhsi~ = ejntelevceia = kinei'sqai = pavscein). Vero è, tuttavia, che nel De
20 ARISTOT., Phys., III, 2, 202a3-9.21 Lo stesso esempio si legge in GC, I, 10, su cui si vd. G. R. GIARDINA, La chimica fisica di
Aristotele. Teoria degli elementi e delle loro proprietà. Analisi critica del De generatione etcorruptione, Aracne, Roma 2008, pp. 170-171.
22 Di questi problemi mi sono occupata ancora una volta in GIARDINA, La “causa motrice” inAristotele, Phys. III 1-3 cit., pp. 111-150.
60 GIOVANNA R. GIARDINA
generatione et corruptione Aristotele, dopo avere asserito che « ciò che muoveagisce e ciò che agisce muove (GC, I, 6, 323a15-16) », precisa anche che agiree muovere sono nozioni diverse e che occorre tenerle distinte. Il muovere,infatti, è per Aristotele qualcosa di più dell’agire, e ciò che patisce ha semprerapporto con il movimento, mentre non ogni motore è agente, per cui ancheagente e paziente devono essere tenuti distinti (GC, I, 6, 323a16-22).
Da queste argomentazioni di Aristotele, che Simplicio tiene chiaramente inconto, scaturisce quindi una migliore comprensione del rapporto che intercorrefra l’agire — almeno nei termini in cui ne ha parlato fin qui Simplicio in questelin. 295.1-301.32 del suo Commentario alle Categorie — l’ejnevrgeia e il movimento.
3. Il rapporto fra energhein e kinein e le sue conseguenze su poiein comecategoria␣ : Giamblico frr. 84-86 e Simpl., In Cat., 301.33-307.1 — Riprendiamoil discorso dall’ultimo problema posto da Simplicio alle lin. 301.27-28, e cioèse bisogna porre come genere l’agire (to; poiei'n), l’agente (to; poiou'n) oppurel’azione (hJ poivhsi~)23 . Quello di agente, come si è visto, non è un concettosemplice, perché nel suo significato è composto sia dal soggetto che svolgeun’attività (ejk tou' ejnergou'nto~), e quindi agisce, sia dall’attività stessa (kai; th'~ejnergeiva~) ; di conseguenza non può essere assunto come genere o categoria.I concetti di azione e di agire, invece — precisa Simplicio —, sono più adattidell’agente ai fini della determinazione del genere, perché non sono composti.Di questi due termini, azione e agire, tuttavia, ‘azione’ — afferma Simplicio— si dice in due sensi, perché indica sia l’attività (hJ ejnevrgeia) sia l’esitodell’attività (to; ajpotevlesma th'~ ejnergeiva~ — 301.34-35) ; epperò ciò che noicerchiamo non è l’esito di un’attività, bensì l’attività (l’ejnevrgeia) che producetale esito e senza la quale esso non ci sarebbe. Ora, il ‘compiere un’azione’ (to;ejnergei'n) — continua Simplicio — in effetti significa unicamente (shmaivneimonoeidw'~) questa attività, cioè l’ejnevrgeia. In conseguenza di ciò Simplicioritiene che Aristotele abbia posto giustamente come genere, ovverosia comecategoria, l’agire, « perché l’agire significa l’attività che è ancora in corso disvolgimento (to; ga;r poiei'n th;n e[ti ginomevnhn ejnevrgeian shmaivnei — 302.2-3),così come l’azione significa piuttosto il momento in cui <l’azione> si arrestaperché l’agente ha realizzato il suo scopo, come si diceva sopra » 24 . Appare
23 Cf. supra nota 15.24 Il pensiero di Simplicio coincide con quello di FILOP., In Cat., 166.27-9 (a proposito di
ARISTOT., Cat., 9, 11b1-2, dove si dice che l’agire e il patire ammettono la contrarietà e il più e ilmeno) : « Perché dunque Aristotele non ha intitolato <il suo discorso> “sull’azione e sullapassione” (invece che “sull’agire e sul patire”) ? Noi rispondiamo : perché l’azione ha due sensi :si dice infatti azione sia il percorso come tale, ad esempio l’operazione <costruttiva> dell’archi-tetto, che il risultato come tale della sua operazione, cioè la casa (Dia; ti v ou\n mh; ejpevgraye æperi;poihvsew~ kai; paqhvsew~… levgomen o{ti hJ poivhsi~ ditthv e jsti: kai; ga;r aujth; hJ o Jdo;~ poivhsi~ levgetai, oi|onhJ tou' oi jkodovmou ejnevrgeia, kai; to; tevlo~ de; aujto; th'~ ejnergeiva~, oi|on hJ oi jki va) ».
61LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
evidente da questo discorso che i termini utilizzati, poivhsi~, poiei'n, ejnevrgeia,ejnergei'n, pur avendo significati molto simili fra loro, presentano sottili diffe-renze che fanno sì che occorra distinguere le rispettive nozioni. Poivhsi~, infatti,significa sia ejnevrgeia — che indica l’agire nel suo aspetto dinamico, tant’è chealla lin. 302.7 Simplicio afferma che ejnevrgeia è un concetto più appropriatorispetto a poivhsi~ in quanto « mostra ciò che è in movimento (to; kata; kivnhsinejmfaivnei) » — sia to; ajpotevlesma th'~ ejnergeiva~ (che alle lin. 302.7-8 è indicatocome « ciò che è successivo al movimento (to; meta; th;n kivnhsin) »), cioè ilprodotto immobile, perché ultimo, di una certa attività. Ma ejnevrgeia, cometermine distinto da ajpotevlesma, significa ejnergei'n. Quest’ultima nozione, quin-di, cioè il ‘compiere un’azione’ (ejnergei'n), così come quella di ejnevrgeia, qualorasi tenga distinta l’attività dal suo prodotto, indica una precisa processualità,cioè un processo determinato ancora in svolgimento e che non è giunto al suoesito finale. Processo in corso è anche il significato di poiei'n, che risulta quindiancora una volta affine a ejnergei'n ovvero a una ejnevrgeia ancora in divenire.
In conseguenza di questa equivalenza fra poiei'n ed ejnergei'n, nonché delfatto che ejnergei'n indica processualità e, quindi, movimento, Simplicio ponedelle interessanti questioni. La prima è questa : se poiei'n equivale ad ejnergei'n,perché mai non si è posta l’ejnevrgeia come categoria al posto di poiei'n (dia; tivto; gevno~ oujk ejnevrgeian ma'llon tivqemen, ajlla; to; poiei'n… — 302.5-6) ? La secondaquestione è quest’altra : se ejnevrgeia è termine più appropriato di poivhsi~, inquanto indica l’agire nel suo aspetto dinamico, allora Aristotele avrebbe forsedovuto porre il movimento come una delle categorie. Al pari delle altrecategorie, infatti — precisa Simplicio —, anche il movimento riguarda lasostanza e contiene in sé sia l’agire che il patire (ejn h| / kai; to; poiei'n kai; to;pavscein ejstivn — 302.9-10). È precisamente su queste due questioni comple-mentari tra loro che Simplicio articola il suo discorso nel corso del quale, alfine di discutere la posizione di Plotino e di Porfirio sulla scelta da parte diAristotele di porre come categorie l’agire e il patire (to; poiei'n kai; to; pavscein)scartando l’attività (ejnevrgeia) e il movimento (kivnhsi~), egli ricorre più volte,soprattutto in ordine al rapporto che esiste fra ejnergei'n e kinei'n, a Giamblico,con la cui interpretazione Simplicio si trova sostanzialmente d’accordo.
La prima cosa che Simplicio fa è quella di chiamare in causa Plotino (302.11ss.), perché questi, in effetti in Enn., VI 1 [42], 15.5 ss., si pone la stessaquestione che si pone Simplicio, se cioè si debba considerare categoria l’agireoppure l’azione, dalla quale deriverebbe l’agire in analogia con la categoriadella qualità, dalla quale deriverebbe il qualificato — e si chiede se, nel casodell’agire, debbano essere considerati alla stregua di una nozione unitarial’azione, l’agire e l’agente oppure soltanto l’agire e l’azione. Secondo Plotino,sono l’agire e l’agente a rivelare una certa unità fra loro, mentre l’azione (hJpoivhsi~) sembra conservare una certa autonomia rispetto a questi, tant’è che
62 GIOVANNA R. GIARDINA
« l’agire equivale a trovarsi in una certa azione, cioè in attività (to; poiei'n ejnpoihvsei ei\naiv tini, tou'to de; ejnergeiva/). Sicché — continua Plotino — è piuttostol’attività la categoria che si dice sia attinente alla sostanza, come nell’altrocaso era la qualità (’Wste ejnevrgeian ma'llon ei\nai th;n kathgorivan, h} peri; th;noujsivan levgetai qewrei'sqai, wJ~ ejkei' poiovth~). E se <l’attività> riguarda lasostanza, <essa attiene alla sostanza> come movimento (kai; aujth; peri; th;noujsivan w{sper kivnhsi~:) : <quindi> il movimento degli enti è anche un genereunico (kai; e }n gevno~ hJ ki vnhsi~ tw'n o[ntwn) »25 . In questo passaggio Plotinoesprime chiaramente la posizione attribuitagli di fatto da Simplicio con lasola differenza che Plotino sembra avere una certa preferenza per poivhsi~rispetto a poiei'n : se poivhsi~ significa ejnevrgeia, pensa Plotino, allora si dovràporre piuttosto quest’ultima come categoria, ma se ejnevrgeia significa kivnhsi~,allora dovrebbe essere assunta come categoria kivnhsi~ piuttosto che ejnevrgeia.
Ebbene, Simplicio contesta a Plotino e a tutti coloro che hanno la suastessa posizione il fatto che essi ragionano in questo modo perché non fannouso dei presupposti teorici di Aristotele, il quale afferma che il primo motoreo agente è immobile (ejkei'no~ ga;r to; prwvtw~ kinou'n kai; poiou'n ajkivnhton ei\naivfhsin — 302.12). Ciò a cui si sta riferendo qui Simplicio è un’importantelezione di GC, I, 6 e 7, capitoli in cui Aristotele si occupa rispettivamente delcontatto e dell’agire e del patire. Che si tratti di un riferimento a questo testodi Aristotele è evidente, innanzitutto, per il fatto che Simplicio assumeinsieme il motore e l’agente. In effetti, in questi due capitoli di GC Aristoteleassume insieme queste due nozioni, affermando in modo abbastanza esplici-to che « ciò che muove agisce e ciò che agisce muove (kai; ga;r to; kinou'n poiei'ntiv fasi kai; to; poiou'n kinei'n — GC, I, 6, 323a15-16) »26 , anche se avverte subitodopo che il muovere è un concetto più ampio dell’agire, nella misura in cui ilmovimento è anche una proprietà di ciò che patisce e ciò che patisce è contutta evidenza il contrario dell’agente27 . In secondo luogo è chiaro cheSimplicio ha ben presente la lezione di Aristotele per il fatto che afferma cheè immobile il primo motore o agente : secondo Aristotele, infatti, così comenel caso del motore c’è un motore primo che non subisce movimento, e questomotore primo è la forma, ei\do~, e c’è un motore prossimo che muovendo è essostesso mosso, allo stesso modo nel caso dell’agente c’è un agente primo che èla forma e che non subisce azione, come ad esempio nel caso in cui l’artemedica produca guarigione, e c’è l’agente ultimo o prossimo che agendo
25 PLOT., Enn., VI 1 [42], 15.9-13 ; cf. PLAT., Sph., 254d4 ss.26 Vd. ARISTOTELE, Sulla generazione e la corruzione, Introduzione, traduzione e note di G. R.
GIARDINA, Aracne, Roma 2008.27 Cf. GIARDINA, La chimica fisica di Aristotele cit., pp. 130-132.
63LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
subisce azione, come ad esempio nel caso del medicamento che subisceazione (subisce infatti alterazione) esso stesso nel corpo del malato su cuiopera la guarigione. Ciò che secondo Aristotele distingue il primo agentedall’ultimo agente è la materia, che il primo agente in quanto forma nonpossiede (gli incorporei non possono subire azione), al contrario dell’agenteultimo o prossimo che la possiede, e che quindi agendo subisce azione(possono subire azione, secondo Aristotele, solo gli enti corporei, quelli cioèche hanno la loro forma nella materia)28 . Ora, è chiaro anche che, mentre nelcaso dell’agente primo, così come lo pone Aristotele, non si ha movimento, inquanto tale agente è immobile, nel caso di ciò che patisce, invece, si ha sempremovimento, perché ciò che subisce un’azione è sempre mosso, ed è appuntoper questo che — sottolinea giustamente Simplicio — Aristotele ha distintol’agire dal patire e non li ha considerati come un’unica categoria. Secondoquesto stesso ragionamento — conclude Simplicio — Boeto e Giamblicohanno rigettato l’opinione di coloro (Plotino, nel caso di Giamblico) cheritengono opportuno che si ponga come genere, prima dell’agire e del patire,il movimento (302.15-17).
Simplicio — sulla scia di Boeto e di Giamblico29 , come egli stesso dice —ha dimostrato in questa porzione di testo di conoscere bene e di interpretarecorrettamente la parte del De generatione et corruptione in cui Aristotele sioccupa dell’agire e del patire, nonché di conoscere bene l’interpretazione diGiamblico di questi stessi problemi che egli assume contro la posizione diPlotino e di quanti la pensano come lui. Anche nel seguito del suo discorso,come si vedrà, Simplicio predilige la posizione di Giamblico ponendola acorrezione della posizione di altri filosofi neoplatonici, soprattutto di Plotino.Ma fin qui, cioè fino al punto in cui lo abbiamo seguito, egli ha stabilito, daun lato, che la nozione di kivnhsi~ riguarda quella di poiei'n senza coinciderecon essa, in quanto il movimento riguarda sì l’agire ma riguarda anche ilpatire, che è una categoria diversa e contraria rispetto all’agire, e, dall’altrolato, che talvolta si può verificare che l’agire di un agente non sia unmovimento dell’agente, poiché esistono dei particolari agenti, nella fattispeciele forme (ei[dh), che sono motori immobili.
Sulla possibile unitarietà dell’agire e del patire in virtù del loro comuneconcetto di movimento ha riflettuto anche Porfirio, che perciò è citato daSimplicio nei termini seguenti : « Porfirio da parte sua dice : “In alcuni casisembra che il movimento sia unico e continuo rispetto sia all’agire che al
28 Cf. GIARDINA, La chimica fisica di Aristotele cit., pp. 138-141.29 Il discorso fin qui fatto da Simplicio, infatti, occupa le lin. 301.33-302.18 dell’In Cat., di
cui le lin. 302.5-17 corrispondono a Giamblico fr. 84 Larsen.
64 GIOVANNA R. GIARDINA
patire (e[n tisi dokei' th;n kivnhsin ejpiv te tou' poiei'n kai; tou' pavscein mivan kai; sunech'ei\nai), come nel caso dei movimenti per impatto (kata; plhghvn)30 , ad esempionel caso del lancio o della spinta (oi|on rJi vyew~ kai; w[sew~), perché, ad esempio,il movimento di chi scaglia un pezzo di legno è tal quale il movimento dellegno scagliato, e la spinta di chi spinge è tal quale il movimento dell’oggettospinto, e perciò l’uno e l’altro movimento saranno un unico e continuomovimento (dio; kai; miva kai; sunech;~ eJkatevra) ; ma non accade la stessa cosanel caso di ciò che colpisce e della cosa colpita, perché, al contrario, <ilmovimento> della cosa colpita è un’affezione, mentre <il movimento> di ciòche colpisce è un’azione, e così l’agire e il patire non appartengono affatto adun unico genere di movimento, ma hanno una loro differenza” (to; de; ei\nai oujto; aujto; e[cei pro;~ to; plh'tton kai; to; plhttovmenon, ajlla; tou' me;n plhttomevnou pavqo~givnetai, tou' de; plhvttonto~ poivhsi~. kai; ou{tw~ to; poiei'n kai; pavscein oujk e[stinaJplw'~ eJno;~ gevnou~ th'~ kinhvsew~, ajll’ e[cei diaforavn — 302.18-25) ». In effetti,ragionando in termini aristotelici l’agente che scaglia un pezzo di legno nonfa altro che imprimere al legno il movimento (cioè la forza) con il quale essosi muove, così come la spinta che riceve un mobile è tal quale il movimentoche viene impresso dall’agente o motore. In questo modo il movimento appareunico e continuo in quanto è movimento del motore nel mosso31 . Ma applicataal problema dell’agire e del patire questa unitarietà del movimento compor-terebbe l’identità delle due categorie. Tuttavia, fa notare Porfirio, le cose nonstanno allo stesso modo quando si osserva un movimento che comporta unimpatto, poiché in tal caso il movimento del paziente è un pavqo~, un’affezione,mentre il movimento dell’agente è una poivhsi~, un’azione. Questo mostrereb-be, secondo Porfirio, che agire e patire non sono un’unica categoria. Simplicio,a questo punto, fa ricorso ancora una volta al pensiero di Giamblico (= fr. 85Larsen) per discutere questa posizione di Porfirio : « Giamblico rimprovera atale soluzione dell’aporia di essere condotta da lontano e di non procedere dapremesse del tutto ovvie né da ciò che pensava Aristotele (mh; ajpo; pavnu
30 Qui Porfirio ha sicuramente presente la lezione di PLOTINO, Enn., VI 1 [42], 5.8-11, il qualeafferma : « Si potrebbe, dunque, più ragionevolmente porre come azione questo movimento perimpatto, e come passione il movimento opposto <di ciò che subisce l’impatto>, oppure porreciascun movimento come azione dell’uno e passione dell’altro, oppure come azione ‘sul’soggetto, e passione ‘nel’ soggetto (Th;n dh; kivnhsin tauvthn kata; th;n plhgh;n poivhsin ma'llon a]neujlovgw~ ti~ qei'to, th;n de; ajntikeimevnw~ pavqo~, h] e Jkavsthn a[llou me;n poivhsin, a[llou de; pavqo~, h] poivhsineij~ to; uJpokeivmenon, pavqhma d’ ejn tw' / u Jpokeimevnw/) ».
31 ARISTOT., Phys., III, 3,18-20 afferma che per il motore ed il mosso le cose stanno come nelcaso dell’intervallo da 1 a 2 e da 2 a 1, che è uno solo, sebbene non sia unica la definizionedell’uno e dell’altro, o come la strada in salita e in discesa, che è unica sebbene non sia unica ladefinizione ; cf. anche Meta., XI, 9, 1066a31-33. In questo modo il movimento appare, come hanotato Porfirio, unico e continuo.
65LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
gnwrivmwn proi>ou'san mhvte ajpo; tw'n dokouvntwn ’Aristotevlei — 302.25-27) » : nontutte le azioni, infatti, si trovano nella condizione di quelle che comportanoun impatto e che implicano due movimenti differenti, né si può concordarecon gli Stoici, continua Giamblico, i quali ritengono che l’agente agisce sulpaziente sempre per contatto32 . In realtà — precisa Giamblico in Simplicio —non tutti i processi di azione e passione avvengono per contatto (e anzi alcuniavvengono senza bisogno che si entri in contatto, perché è possibile che ci siaun agire a distanza, mentre altri processi, anche in condizione di contatto,non avvengono affatto)33 . Non bisogna quindi ricorrere al contatto perspiegare l’agire e il patire, ma è meglio dire (bevltion ga;r levgein) che l’azioneavviene in virtù dell’attitudine dell’agente verso il paziente (kata; th ;nejpithdeiovthta tou' poiou'nto~ pro;~ to; pavscon givnetai hJ poivhsi~ — 302.32-33). Tale‘a t t i tudine ’ 34 è considerata più avanti da Simplicio quale affinità ocongenericità della potenza (hJ th'~ dunavmew~ suggevneia — 303.8-9) dell’agenterispetto al paziente35 . In effetti, in Phys., III, 1, 200b28-32, proprio all’iniziodella sua trattazione sul movimento e sulla causa motrice, Aristotele stabili-sce, nel cosiddetto secondo assioma, che il movimento è possibile soltantotramite una relazione, che è subito stabilita come relazione fra ‘ciò che ècapace di agire’ (poihtikovn) e ‘ciò che è capace di patire’ (paqhtikovn), e, ingenerale, come relazione fra ‘ciò che è capace di muovere’ (kinhtikovn) e ‘ciòche è mobile’ (kinhtovn) (200b28-32). In questo secondo assioma, in altritermini, Aristotele stabilisce che, affinché vi sia movimento o agire e patire,occorre considerare l’agente e il paziente nella relazione che intercorre fra leloro rispettive condizioni potenziali. E ancora, affinché vi sia agire e patireoccorre che ‘ciò che è capace di agire’ (poihtikovn) e ‘ciò che è capace di patire’(paqhtikovn) siano congeneri, poiché, come Aristotele spiega in GC, I, 7, non èpossibile che ciò che agisce sia assolutamente simile a ciò che patisce —perché in questo caso non si comprenderebbe quale dei due dovrebbe fungereda agente e quale da paziente e inoltre ciascuna cosa potrebbe muovere sestessa, con la conseguenza che non ci sarebbe più nulla di immobile o diincorruttibile — né che sia assolutamente diverso — perché non è concepibile,
32 A questa posizione si potrebbe essere indotti leggendo ARISTOT., Phys., III, 2, 202a5-9,citato e discusso più avanti in questo stesso studio.
33 Ad esempio, dice Giamblico, la nafta viene infiammata anche da una fiamma che si trovaa distanza. D’altra parte molte cose non agiscono anche se sono in contatto, come l’impiastro oqualche altro rimedio medicinale qualora siano applicati ad una pietra.
34 Questo concetto viene ripreso in un’altra citazione di Giamblico da parte di Simplicio,sempre nell’ambito dei problemi che il filosofo sta affrontando in queste pagine del suocommentario alle Categorie, e precisamente alla lin. 304.9, di cui discuto qui di seguito.
35 Anche alla lin. 301.26 Simplicio aveva detto che dell’ejnevrgeia c’è un’affezione congenere,suggene;~ pavqo~, che è il patire, to; pavscein.
66 GIOVANNA R. GIARDINA
ad esempio, che la bianchezza subisca azione da una linea o una linea dallabianchezza. Affinché vi siano agire e patire, secondo Aristotele, occorre che« l’agente e il paziente siano di genere simile, o meglio identico, e di speciedissimile, o meglio contraria »36 , poiché agiscono e patiscono reciprocamentele cose che sono fra loro contrarie e i contrari si trovano tutti nello stessogenere37 . L’essere congeneri e avere rapporto di contrarietà è ciò che congrande capacità ermeneutica Giamblico, citato e seguito qui da Simplicio,intende dire — a mio avviso — quando afferma che agente e paziente devonoavere affinità o congenericità di potenza. Come dire, ad esempio, che ciò cheè ‘capace di costruire’ ha rapporto con ‘ciò che può essere costruito’, cosìcome ‘chi è capace di insegnare’ ha rapporto con ‘chi è capace di apprendere’,e così via. Quando si innesca un movimento fra enti che hanno rapporto direciprocità, è possibile che si passi dalla potenza all’atto e che ‘ciò che ècapace di agire’ agisca su ‘ciò che è capace di patire’, cioè di subire azione daparte dell’agente. Giamblico però si affretta a precisare che occorre starebene attenti a non intendere questa affinità o congenericità, di cui egli parla,nel senso dell’identità di essenza tra agente e paziente, perché la conseguenzadi una simile interpretazione sarebbe che motore e mosso costituiscono untutt’uno (e quindi anche agente e paziente) e così sarebbero annullate tuttequante le asserzioni che concernono il movimento, e cioè che il movimentoprocede da qualcosa e concerne qualcosa, che una cosa è il principio delmovimento e altra cosa è il movimento come tale in quanto prodotto dal<suo> principio (303.9-14).
Tornando adesso al problema dell’unitarietà dell’agire e del patire in virtùdella unitarietà del movimento, vediamo che Giamblico riflette su quantoafferma Porfirio a proposito del fatto che, nel caso del lancio o della spinta,sembra che il movimento riunisca in sé sia l’agire che il patire —, perché,come si è visto, il movimento di chi scaglia un pezzo di legno è tal quale ilmovimento del legno scagliato, e la spinta di chi spinge è tal quale ilmovimento dell’oggetto spinto, e perciò l’uno e l’altro movimento sono unmovimento unico e continuo —, e osserva che se il movimento deve essereconcepito come una mescolanza dell’attività dell’agente e del processo affet-tivo del paziente, allora esso non è qualcosa di semplice e non può essere,quindi, assunto come categoria, come vorrebbe Plotino. In realtà, il movi-mento non è affatto una comunanza di agire e patire, afferma Giamblico, enon può essere concepito come qualcosa che include in sé l’azione e lapassione legate in un’unica continuità, ma, al contrario, « è <qualcosa di>separato dall’agente e dal paziente in quanto è intermedio tra i due e da un
36 ARISTOT., GC, I, 7, 323b31-33.37 ARISTOT., GC, I, 7, 324a1-3.
67LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
lato procede dall’agente, dall’altro lato provoca l’affezione al paziente. Cosìcome, dunque, il motore e il mosso sono due cose, allo stesso modo anchel’agente e il paziente sono due cose distinte tra loro »38 . Di qui si evince cheGiamblico, seguito fedelmente da Simplicio, ha compreso molto bene lanatura del movimento così come l’aveva concepita Aristotele, perché sembraaver colto l’aspetto della processualità quale natura specifica del movimento,che, nella realtà, si svolge fra un termine iniziale e un termine finale e, dalpunto di vista della causa motrice, fra un agente e un paziente. Il movimento,kivnhsi~, è concepito da Aristotele come passaggio da un prima a un poi (e nona caso il tempo è uno degli elementi essenziali perché il movimento sirealizzi), ed è quindi una nozione che implica dinamismo, processualità, adifferenza, ad esempio, del mutamento, metabolhv, che è sì anch’essa unanozione dinamica, ma solo in ragione della kivnhsi~, nel senso che è la kivnhsi~che attua la metabolhv. Aristotele, nei libri III e V della Fisica, stabilisce iconfini di questo processo, nel senso che lo colloca tra un punto di partenza,ejx ou|, e un punto di arrivo, eij~ o{, ed è in questo senso che la kivnhsi~ è appuntoconsiderata da Aristotele ejntelevceia, nel senso cioè che da uno stato dipotenza, (dunavmei, ejx ou|), si passa a uno stato di atto (ejnergeiva/, eij~ o{)39 . Ancheil mutamento (metabolhv), secondo Aristotele, procede ‘da qualcosa versoqualcosa’ : i termini necessari affinché esso avvenga, ovvero i confini entro iquali esso avviene, sono sempre l’ejx ou| e l’eij~ o{, e tuttavia il mutamento nonè, come il movimento, semplicemente il processo che conduce dall’unoall’altro di questi termini, perché esso si può osservare, da un lato nell’ejx ou|e nell’eij~ o{, in quanto non può esserci mutamento se non c’è prima una cosache è diversa da come sarà dopo che è mutata, ma dall’altro lato più nell’eij~o{ che nell’ejx ou|, dal momento che è facile comprendere come ci si accorga cheuna cosa è mutata dopo che essa è realmente mutata e non prima, quindi ilmutamento è più visibile nel momento finale che nel momento iniziale delprocesso, il quale ultimo, in sostanza, altro non è se non movimento. In altreparole, il termine di partenza del mutamento, l’ejx ou|, è la cosa nel suo statopotenziale (dunavmei), mentre il termine finale, l’eij~ o{, è la cosa nel suo stato‘attuale’ (ejnergeiva/) : il processo che conduce dall’uno all’altro termine del
38 Qui termina la citazione di Giamblico utilizzata da Simplicio (In Cat., 302.28-303.30 = fr. 85Larsen) per confutare la posizione di Porfirio, tant’è che Simplicio conclude dicendo : « Ma tantobasti come risposta a Porfirio o <meglio> alle opinioni da lui presentate (In Cat., 303.30-31) ».
39 Qui l’espressione eij~ o{ va intesa non nel senso della ‘tendenza verso’, come la preposizioneeij~ farebbe immediatamente pensare, ma nel senso del punto di arrivo del processo e, quindi,nel senso dell’attuazione compiuta dell’ente, che coincide con il momento in cui l’ente stesso èappunto in atto, ejnergeiva/. Sulla differenza fra ejnevrgeia ed ejntelevceia cf. GIARDINA, La “causamotrice” in Aristotele, Phys. III 1-3 cit., pp. 117-129.
68 GIOVANNA R. GIARDINA
processo stesso e che, quindi, realizza il mutamento, è per Aristotele ilmovimento (kivnhsi~) ovvero l’ejntelevceia 40 . Giustamente, quindi, Giamblicodirà in SIMPL., In Cat., 304.18-19, che il movimento è un continuo trascorrereda un contrario all’altro contrario, senza essere però nessuno dei due contrariconsiderati come termini estremi del movimento stesso. Analogamente ilmovimento va dall’agente al paziente rimanendo intermedio fra i due cherimangono fra loro distinti : da una parte l’agente e dall’altra il paziente.
Una volta discussa in chiave confutatoria la posizione teorica di Porfiriograzie alla citazione di Giamblico, Simplicio ritorna a Plotino, e, in partico-lare, ad un approfondimento ulteriore del problema posto da quest’ultimo,cioè quello relativo all’opportunità di porre come categoria, anziché l’agire eil patire, il movimento. Alle lin. 302.11 ss., Simplicio aveva chiamato in causail passaggio di Enn., VI 1 [42], 15.9-13 in cui Plotino afferma che è piuttostol’attività (ejnevrgeia) che, in quanto attinente alla sostanza, dovrebbe essereassunta come categoria, anzi che è piuttosto il movimento come tale, inquanto l’attività attiene alla sostanza come movimento, che dovrebbe essereassunto come categoria. Adesso, a partire dalla lin. 303.32, Simplicio passa aconsiderare Enn., VI 1 [42], 16.1-3, dove Plotino, assumendo l’asserzione diAristotele secondo la quale il movimento è attività imperfetta ovvero attoincompiuto (ejnevrgeia ajtelhv~)41 , da una parte mostra che è in questa imperfe-zione la ragione per cui Aristotele non avrebbe assunto come categoria ilmovimento e, dall’altra parte, suggerisce che per la stessa ragione occorrereb-be assumere come categoria l’attività (ejnevrgeia). Simplicio replica controquesto ragionamento di Plotino facendo ricorso, ancora una volta, a Giamblico(consapevole in partenza che Giamblico contraddice Plotino — ajntilevgwn,scrive Simplicio)42 , il quale discute del movimento (kivnhsi~) e dell’attività(ejnevrgeia) in termini che non lasciano dubbi sulla differenza che intercorrefra queste due nozioni. Ecco il ragionamento di Giamblico in Simplicio.
Domandandosi per quale ragione Aristotele afferma che il movimento è‘attività imperfetta’ o ‘atto incompiuto’ (ejnevrgeia ajtelhv~), Giamblico ipotizzache l’espressione possa significare che si tratta o di un movimento attenuatonella sua stessa natura di movimento (ejn th' / aujth' / fuvsei uJfeimevnh) oppure di unmovimento che si sposta verso una natura inferiore (wJ~ ejxistamevnh eij~ pavnth/katadeestevran fuvsin). Nel primo caso, cioè nel caso in cui il movimento siadetto ‘attività imperfetta’ nel senso che è attenuato nella sua stessa natura,
40 Per una discussione approfondita di questi problemi rimando al mio volume I fondamentidella Fisica. Analisi critica di Aristotele, Phys. I, CUECM, Catania 2002, pp. 119-144.
41 ARISTOT., Phys., III, 2, 201b31-32.42 SIMPL., In Cat., 303.32-306.12 (= fr. 86 Larsen). Il passaggio immediatamente successivo,
cioè In Cat., 306.13-307.1, è quello che, come ho già detto, appare come una continuazione deldiscorso di Giamblico.
69LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
kivnhsi~ sarebbe nozione secondaria rispetto a ejnevrgeia e allora si dovrebbeassumere quest’ultima come categoria, perché essa sarebbe il genere di cui ilmovimento risulterebbe una specie. Nel secondo caso, invece, cioè nel caso cheil movimento sia detto ‘attività imperfetta’ nel senso che esso si sposta versouna natura inferiore, contrariamente a quanto accade nel primo caso, l’attivitànon potrà essere genere del movimento, perché — osserva Giamblico —, « sequindi da un lato il movimento si affretta verso il suo fine ultimo, in quantoesiste in vista di esso senza tuttavia mai possederlo dentro di sé, e dall’altro latol’attività si mantiene stabile in virtù del suo fine ultimo, perché è piena di sestessa e della sua propria perfezione, allora ciò che è assolutamente perfetto<in se stesso> non avrà niente in comune con l’affrettarsi verso la perfezione (eijou\n hJ me;n kivnhsi~ ejpi; to; tevlo~ speuvdei wJ~ e{neka aujtou' ginomevnh kai; mhdevpw aujto; ejneJauth' / e[cousa, hJ de; ejnevrgeia kata; to; tevlo~ e{sthken, plhvrh~ ou\sa eJauth'~ kai; th'~oijkeiva~ teleiovthto~, oujk a]n to; teleiwvtaton pro;~ to; ejpeigovmenon eij~ teleivwsin e[coitina; koinwnivan fuvsew~ — 304.3-7) ». Qui Giamblico coglie perfettamente l’aspet-to dinamico, processuale del movimento, che pur avendo — in termini aristotelici— un punto di partenza, ejx ou|, e un punto di arrivo, eij~ o{, tuttavia si colloca inposizione intermedia tra questi. Il movimento ha rispetto all’attività un aspettodi incompiutezza, perché, quando un ente che si trova coinvolto in un processodi qualsiasi natura raggiunge la sua compiutezza, cioè la sua realizzazioneformale, non è più coinvolto nel movimento, in quanto « il movimento (comegiustamente sottolinea Giamblico in Simplicio) procede verso la forma, perchéla possiede soltanto in potenza e in virtù di un’attitudine materiale e nonformale (hJ de; kivnhsi~ oJdeuvei pro;~ to; ei\do~ dunavmei movnon e[cousa aujto; kai; kata;uJlikh;n kai; ajneivdeon ejpithdeiovthta — 304.8-9) ». A questo punto, come si vede,torna il concetto di cui Giamblico si è servito nel fr. 85, citato anch’esso daSimplicio e che ho già discusso, quello cioè di ‘idoneità’ o ‘attitudine’, che quiè detta acutamente ‘materiale e non formale’. Questa proprietà dell’attitudine,infatti, consiste nel fatto che il movimento è processualità verso una certaforma nella misura in cui non la possiede. Ma se il movimento non possiedecompiutamente una forma, vuol dire che è presente in esso un aspetto poten-ziale che funge da condizione perché si realizzi il movimento stesso. Se unprocesso è definitivamente compiuto, infatti, è evidente che una forma si èpienamente realizzata e che quindi non c’è più bisogno di movimento. Alcontrario, come ha ben compreso Giamblico, l’ejnevrgeia è la nozione cheesprime proprio la compiuta determinazione formale e quindi la totale man-canza di tensione verso un fine, cioè verso una forma da realizzare, di undeterminato ente, perché « l’attività — come afferma Giamblico — possiede inse stessa la <sua> forma perfetta (hJ me;n ejnevrgeia to; ei\do~ ejn eJauth' / tevleion e[cei— 304.7-8) ». Posta la questione in questi termini — conclude Giamblico —, lanozione di kivnhsi~ non può avere nulla in comune con quella di ejnevrgeia.
70 GIOVANNA R. GIARDINA
Ma ci sono molte altre differenze fra movimento e attività che Giamblico, equindi Simplicio che lo cita, mette in evidenza contro la posizione di Plotino(Enn., VI 1 [42], 16.14 ss.) qui non esplicitamente citata. Il movimento, adesempio, si vede nel suo svolgersi e nella sua continuità (ejn diexovdw/ qewrei'tai kai;suneceiva/ — 304.10-11), essendo divisibile all’infinito in ciò che è sempre conti-nuo, mentre l’attività si mantiene stabile in un solo limite (hJ de; ejnevrgeia kaq’ e}npevra~ i{statai — 304.11-12), perché possiede il suo essere da se stessa e alcontempo racchiude in se stessa l’unità del tutto. Ancora una volta Giamblico,ponendo questa differenza, fa notare come il movimento sia processualità ecome sia appunto questo senso di processualità la ragione per cui il movimentoè uno svolgersi continuo, mentre al contrario l’ejnevrgeia rappresenta lacompiutezza della forma ed in questo senso essa sta tutta in un unico limite,quello appunto della forma compiuta. E ancora, il movimento è divisibile einfinito e indeterminato, mentre l’attività è indivisibile ed è un limite e gode dellasua identità (eij hJ me;n kivnhsi~ meristh; kai; a[peiro~ kai; ajovristo~, hJ de; ejnevrgeiaajmevristo~ kai; pevra~ kai; taujtovthti caivrousa — 304.14-15) : se è continuo eviden-temente il movimento è divisibile e se esso non contiene in sé la forma realizzata,in quanto al contrario è realizzazione di una forma, allora è anche infinito eindeterminato ; al contrario, invece, l’ejnevrgeia in quanto forma compiuta èidentica a se stessa e in quanto consiste in un unico limite e non si estende comeil movimento in continuità, essa è indivisibile. Il movimento — prosegue Giamblico— è un continuo trascorrere da un contrario all’altro contrario, senza essere peròné l’uno né l’altro dei due contrari, ma mescolanza di ambedue (hJ ga;r ajpo; tou'eJtevrou eij~ e{teron kivnhsi~ oujdevterovn ejsti tw'n a[krwn, summevmiktai de; ejx ajmfoi'n —304.18-19), mentre l’attività, essendo assolutamente priva di mescolanza, stafissa in uno solo dei contrari non essendo per niente contaminata dalla naturacontraria (hJ de; ejnevrgeia a[mikto~ ou\sa pantelw'~ kai; kaq’ e}n tw'n ejnantivwn i{stataioujde;n ajnapimplamevnh th'~ ejnantiva~ fuvsew~ — 304.19-21) : la kivnhsi~, dunque, inquanto processo di realizzazione di una forma specifica, consiste nel passaggioda una privazione della forma alla forma realizzata o viceversa, mentre l’ejnevrgeia,coincidendo con la forma realizzata, non può avere nulla della natura dellaprivazione ; si potrebbe dire che il movimento si estende parallelamente altempo, come se avesse una dimensione, mentre l’attività che è priva di dimensio-ne si estende parallelamente all’eternità ed è presente tutta intera nell’istante(oJmou' o{lhn ejn tw'/ nu'n parou'san — 304.24) : il movimento, in quanto processo incontinuità, si associa alla nozione di tempo e si presenta quindi, in virtù di questacontinuità e temporalità del suo svolgimento43 , come se avesse una dimensione,
43 Al contrario, PLOT., Enn., VI 1 [42], 16,14-17, ritiene che così come l’attività anche ilmovimento sia atemporale. Nelle lin. successive Plotino si mostra contrario anche agli altri
71LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
mentre l’ejnevrgeia è tutta nell’istante e in quanto tale non ha dimensione e nonha temporalità, ma gode di una eternità atemporale. Tutte queste differenzerendono impossibile la supposizione che l’attività possa essere genere delmovimento o che queste due nozioni possano avere natura omogenea tra loro,« […] e <questo discorso vale> ancor più — aggiunge Giamblico —, sel’attività preesiste come immobile, in quanto contenente insieme l’inizio e lafine del movimento in un unico momento di riposo, mentre il movimento èdiviso in un processo evolutivo di ordine numerico (kai; tw'n ejn crovnw/ oJmogenh;~fuvsi~, e[ti ma'llon eij hJ me;n ejnevrgeia ajkivnhto~ prou>pavrcei, th;n ajrch;n kai; to; tevlo~oJmou' th'~ kinhvsew~ ejn mia' / hjremiva/ sunevcousa, hJ de; kivnhsi~ ejn diexovdw/ th' / kat’ajriqmo;n proi>ouvsh/ diakriqeivh — 304.25-27) ». In quest’ultimo passaggio lakivnhsi~, come si è peraltro già visto sopra, appare ancora più chiaramentecome una processualità e uno svolgimento in continuità, e per questa ragioneha realtà temporale e numerica. L’ejnevrgeia invece, in quanto forma realizza-ta, anzitutto è una sostanza immobile che preesiste nel modo della preesistenzadell’atto rispetto alla potenza, ovvero in virtù della preesistenza dell’essererispetto al non essere44 . La potenza, per Aristotele, è infatti tale, cioè nonessere, in virtù del suo rimando all’essere, che quindi preesiste, per cui leforme, seppure si realizzano compiutamente in seguito a un processo dimovimento o di mutamento, tuttavia preesistono come immobili e costitui-scono il fine dei processi. In questo modo, l’ejnevrgeia costituisce il principiodel movimento, perché è la forma di cui un ente è privo e che l’ente ha lapotenza di acquisire, e costituisce altresì il fine del movimento, perché è laforma che l’ente in potenza assume compiutamente dopo il processo dimovimento : tutto questo, però, in un unico momento di riposo, perchél’ejnevrgeia sta nell’istante e nell’assenza del movimento.
Ora, il fatto che Simplicio non commenti per nulla queste argomentazionidi Giamblico in merito al rapporto fra ejnevrgeia e kivnhsi~ e in merito all’oppor-tunità di assumere come categoria il poiei'n e non l’ejnevrgeia o la kivnhsi~, maal contrario le prenda di peso per confutare le posizioni di Plotino e diPorfirio, lascia ritenere altamente probabile il fatto che egli assuma comecorretta la posizione di Giamblico, la quale, evidentemente, gli si presentatanto chiara ed esaustiva da non avere bisogno di ulteriore sostegno, dato chein effetti nulla Simplicio aggiunge al discorso di Giamblico. « Plotino —aggiunge Giamblico, sempre in Simplicio — non è d’accordo con le più
aspetti che Giamblico attribuisce al movimento e in base ai quali distingue il movimentodall’attività, cioè la dimensione, l’infinità, eccetera.
44 Cf. Meta., VII, 7, 1032b11-13. Sulla sostanza immobile come essenza o sostanza prima cf.A. JAULIN, Eidos et Ousia. De l’unité théorique de la Métaphysique d’Aristote, Klincksieck, Paris1999, pp. 94-106.
72 GIOVANNA R. GIARDINA
corrette opinioni intorno all’attività45 ed è fuorviato verso quella nozione diattività in base alla quale alcuni definiscono46 il compiere un’azione (to;ejnergei'n) in virtù dell’essere-mosso (kata; to; kinei'sqai) e suppongono chemovimento, nel senso di essere-mosso, e attività (kivnhsin th;n kata; to; kinei'sqaikai; ejnevrgeian) coincidano (taujtovn) ; il che è ben lontano dall’essere vero »(304.28-31). Se quanto ha detto Giamblico precedentemente costituisce un’in-terpretazione corretta di Aristotele, Plotino sbaglia, perché di fatto concepi-sce l’attività, ejnevrgeia, alla stregua del movimento come processualità (quil’espressione kivnhsin th;n kata; to; kinei'sqai intende infatti una concezione dikivnhsi~ nel senso del verbo che ha lo stesso significato del nome), mentre alcontrario, come si è visto, la nozione di ejnevrgeia indica piuttosto la formaspecifica perfettamente realizzata ed immobile. La nozione di movimento èseparata da quella di attività, ribadisce Giamblico in Simplicio, chiamando incausa anche l’opinione di Teofrasto : quest’ultimo, infatti, stando a questatestimonianza di Giamblico, riteneva che « il movimento è sì attività, inquanto sarebbe contenuto in questa, ma certamente l’attività non è anchemovimento ; infatti l’essenza o forma specifica di ciascuna cosa costituiscel’attività di ciascuna cosa, sebbene questa non sia movimento (ei\nai de; th;n me;nkivnhsin kai; ejnevrgeian wJ~ a]n ejn aujth' / periecomevnhn, oujkevti mevntoi kai; th;n ejnevrgeiankivnhsin: th;n ga;r eJkavstou oujsivan kai; to; oijkei'on ei\do~ ejnevrgeian ei\nai eJkavstou,mh; ou\san tauvthn kivnhsin — 304.33-305.1) »47 . Tale testimonianza, che non hariscontro in quello che ci è pervenuto degli scritti di Teofrasto, va perfetta-mente nella direzione della posizione teorica di Giamblico fin qui descritta :se infatti l’attività è una forma che rappresenta il principio e la fine di unmovimento (in quanto rappresenta il fine ultimo, quando la forma è ancoraassente o in potenza, e al tempo stesso la sua realizzazione, quando la formaè compiuta e quindi in atto), allora si può affermare che il movimento èattività nel senso che è contenuto in questa come intermedio fra principio efine di essa, e tuttavia l’attività non è movimento, nel senso che essa si puòscorgere solo nel compimento e nella perfezione, cioè quando la formaspecifica è già realizzata e non c’è più movimento. L’ejnevrgeia, proprio in
45 Per ovvie ragioni di cronologia, Giamblico non può qui riferirsi alla sua propria opinionesulla nozione di ejnevrgeia, che gli appare certamente come l’opinione più corretta fra tutte, maalle opinioni di coloro che prima di lui avevano ragionato in maniera corretta sull’ejnevrgeia,primo fra tutti, ovviamente, lo stesso Aristotele.
46 Qui appare del tutto verisimile che Giamblico stia contestando una posizione teorica cheappartiene non solo a Plotino, ma anche ad altri pensatori non meglio identificati.
47 In ciò che ci è pervenuto di Teofrasto — ivi compresi i frammenti riportati da Simplicio,In Phys. — non si legge mai una posizione teorica secondo cui il movimento è attività mal’attività non è movimento. Può essere tuttavia utile leggere i frr. di Teofrasto 19 e 20 Wimmer.
73LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
quanto forma compiuta, è la perfezione (hJ teleiovth~) che esiste sì negliintelligibili e negli enti immobili, ma esiste anche nei sensibili ; ad esempioè ejnevrgeia come teleiovth~ quella della statua secondo la figura, perché èappunto compiutezza formale della statua. L’ejnevrgeia, concepita in questitermini — pensa Giamblico —, trascende il movimento, come si è già dimo-strato sopra, quando si è visto che la kivnhsi~ è attività imperfetta al contrariodell’ejnevrgeia che è fornita di perfezione, ed è questa la ragione per la qualenon è possibile considerare una delle due nozioni come genere dell’altra.
Da quanto Giamblico aggiunge subito dopo, inoltre, sembrerebbe evincersiche chi pensa come Plotino confonde il concetto di ejnevrgeia, attività, conquello di to; ejnergeiva/, cioè ciò che è attivo o ‘in atto’ : « E se qualcuno —osserva Giamblico — dice che l’attività (ejnevrgeia) proietta (scil. mette davantiagli occhi) l’essere-mosso in virtù del suo essere coordinata con quest’ultimo(to; kinei'sqaiv fhsi probavllein kata; to; suntetavcqai pro;~ aujtov), mentre l’essere-attivo (to; ejnergeiva/), che in virtù della figura della statua e dell’entelechia diciascuna cosa sta in relazione all’essere-potenziale, si dice che trascendequest’ultimo48 , ma non già nel senso che l’attività trascenda il movimento,allora costui ignora da un lato che l’essere-attivo è in antitesi rispettoall’essere-potenziale (ajntitivqetai pro;~ to; dunavmei) ed è la perfezione di ciò cheè imperfetto e acquista relazione col suo contrario49 , e tuttavia, dall’altro lato,ignora che l’attività in sé e per sé è assoluta, non è detta in relazione ad alcuncontrario, ed è quella che fornisce la perfezione all’essere-attivo (hJ mevntoiejnevrgeia aujth; kaq’ eJauthvn ejstin ajpovluto~, pro;~ oujde;n ejnantivon legomevnh, h{ti~kai; tw' / ejnergeiva/ o[nti parevcei th;n teleiovthta) » (305.5-13). Qui Giamblicochiarisce la natura di ciò che è attivo o ‘in atto’, to; ejnergeiva/ : esso è tale in virtùdell’ejnevrgeia, cioè è attivo in virtù dell’attività, ovvero è ‘in atto’ in virtùdell’atto, e in quanto tale non ha con la potenza se non un rapporto dicontrarietà. Questa affermazione non è in contraddizione con quantoGiamblico dirà nel corso del fr. 87 Larsen e precisamente in SIMPL., In Cat.,307.25-27, in cui afferma che « ciò che è attivo differisce dall’attività nellamisura in cui ciò che è attivo sussiste in rapporto al potenziale, mentre
48 Sembra abbastanza evidente che ambedue i participi iJstavmenon ed ejxhremevnon concordinocon il soggetto della proposizione, to; de; ejnergeiva/. Il senso del discorso sembra essere questo :l’essere-attivo, che in virtù della forma si pone in relazione con l’essere-potenziale, è dettotrascendere quest’ultimo. In altri termini, ciò che è in atto trascende ciò che è in potenza in virtùdel fatto che il primo è in diretto rapporto con la forma, nella fattispecie con la figura della statua.Tale interpretazione, del resto, sembra confermata dal fatto che subito dopo si dice che l’essere-attivo si contrappone all’essere-potenziale (quella relazione indica, dunque, contrarietà).
49 Scil. è una condizione di compiutezza formale che si acquista quando se ne è privi e perciòè perfezione che sta in relazione con il suo contrario, cioè l’imperfetto.
74 GIOVANNA R. GIARDINA
l’attività esiste per se stessa (diafevrei de; to; ejnergeiva/ th'~ ejnergeiva~, kaq’ o{sonto; me;n ejnergeiva/ pro;~ to; dunavmei uJfivstatai, hJ de; ejnevrgeia kaq’ eJauthvn ejstin) ».Che ciò che è attivo sussista in rapporto al potenziale, come qui dice Giamblico,potrebbe sembrare in contraddizione con quanto aveva detto alle lin. 305.5-13, quando cioè aveva negato una tale possibilità, dicendo al contrario che ciòche è attivo ha un rapporto di antitesi rispetto al potenziale. Fra le dueaffermazioni di Giamblico non c’è in verità contraddizione alcuna, perché ilrapporto con il potenziale di ciò che è attivo si deve intendere nel senso checiò che è attivo è il perfetto, in virtù della perfezione che gli è conferitadall’ejnevrgeia, ed in quanto perfetto rimanda all’imperfetto (in questo caso lacondizione di potenzialità) come suo contrario, con il quale però non esisteconcretamente una relazione, se ciò che è attivo è in quanto tale perfetto. Ciòche è attivo o ‘in atto’, to; ejnergeiva/, è inteso qui da Giamblico come l’entelechiadi cui parla Aristotele, se si intende qui l’entelechia come la condizioneformale che in quanto tale è compiuta ma che, tuttavia, al contempo, nella suacompiutezza, conserva un rapporto di opposizione con una condizione dipotenzialità. Io penso, come cercherò di dimostrare in seguito, che ciò che èattivo è detto qui da Giamblico come l’entelechia di ciascuna cosa nel sensodell’entelechia come tale e non anche nel senso dell’entelechia imperfetta. Daciò che Giamblico dirà più avanti, quando distinguerà un’entelechia perfettada un’entelechia imperfetta, sostenendo che quest’ultima si identifica con ilmovimento, si vedrà che è perfetta l’entelechia che è concepita qualecompiutezza formale e che si oppone ‘totalmente’ al potenziale (come è ilcaso, per riprendere un esempio che Aristotele fa in Phys., III, 2, di una casagià costruita), mentre è imperfetta l’entelechia che è concepita qualecompiutezza formale che si oppone ‘relativamente’ al potenziale (come è ilcaso di una casa che si sta costruendo).
Ciò che è attivo o ‘in atto’, to; ejnergeiva/, è dunque un concetto diverso,secondo Giamblico (e, conseguentemente — è possibile arguire —, secondoSimplicio che assume questo passaggio di Giamblico), da quello di attività,ejnevrgeia, anche se è in rapporto diretto con questo, perché se è vero che dire‘ciò che è attivo’ è cosa diversa dal dire ‘attività’, tuttavia è l’‘attività’ che rende‘attivo’ qualcosa e quindi da un lato ciò che è attivo o ‘in atto’, to; ejnergeiva/, nonprende la sua realtà da una relazione con la potenza e, dall’altro lato, l’attivitào atto, ejnevrgeia, è la perfezione che rende perfetto ciò che è ‘attivo’. Non si puòquindi dire, aggiunge Giamblico, che la forma della statua sia ‘in atto’,ejnergeiva/, senza che le appartenga l’atto, ejnevrgeia.
A questo punto, però, Giamblico, proseguendo il suo discorso, afferma che cisono diversi modi di intendere l’ejnevrgeia, uno dei quali è quello proposto dacoloro che pensano che l’attività implichi la processualità del movimento e chel’essere-attivo, to; ejnergeiva/, sia coordinato all’essere-potenziale, to; dunavmei, per
75LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
cui confondono le due diverse nozioni, cioè quella di ejnevrgeia e quella di to;ejnergeiva/ 50 : costoro « non conoscono il genere puro dell’attività (to; kaqaro;n gevno~oujk i[sasi th'~ ejnergeiva~ — 305.14-15) », non sanno cioè che esiste una nozione diattività che è separata dal movimento e che precede, quindi, ciò che è attivo o ‘inatto’, ejnergeiva/. Allora, è di questo genere puro di attività che Giamblico ha fin quiparlato, identificandolo con una forma specifica immobile. Costoro — aggiungeGiamblico, al fine di far comprendere che cosa sia questo genere puro di attività—, non capiscono « in che senso noi chiamiamo attività gli atti di pensiero,quando presentiamo l’indivisibilità e contemporaneità della conoscenza di essie il fatto che sono istantanei e si compiono tutti d’un colpo, e cose simili : ciò chenel tempo è l’istante, infatti, la stessa cosa occorre pensare che sia nel movimentol’attività (o{per ga;r ejn tw'/ crovnw/ to; nu'n ejstin, tou'to noei'sqai th;n ejnevrgeian ejn th'/kinhvsei) (305.16-19) ». Questo genere puro di attività, con cui si identificanoanche gli atti di pensiero quali atti esenti da movimento51 , è il genere di attivitàche è separata dal movimento (th;n me;n kaqara;n ejnevrgeian kinhvsew~ ejkto;~ ei\nai —305.19-20), e tuttavia ci sono altri generi di ejnevrgeia che procedono da questaejnevrgeia pura e che al contrario di essa non sono esenti da movimento (ajp’ aujth'~de; a[lla~ ejnergeiva~ proi>evnai, ai{tine~ oujk a[neu kinhvsew~ qewrou'ntai — 305.20-21),quali, ad esempio, l’immaginazione (fantasiva) e la sensazione (ai[sqhsi~), chesono movimenti secondo l’affezione (kata; me;n to; pavqo~ kinhvsei~ — 305.22),mentre il tipo puro di attività è secondo la forma (kata; de; to; ei\do~ — 305.22). Cisono — precisa Giamblico — attività che non sono separate dai movimenti (ta;~me;n ajcwrivstou~ tw'n kinhvsewn) e attività che sono separate dai movimenti (ta;~ de;cwristav~), e non sono separate quelle che sono perfettive dei movimenti(teleiwtikai; tw'n kinhvsewn), e sono queste che li precedono e li inducono all’atti-vità (proavgousai aujta;~ eij~ ejnevrgeian), mentre sono separate quelle che sonouniformi e, come si è visto, compiutamente immobili (monoeidei'~ h\san kai;pantelw'~ ajkivnhtoi)52 . La distinzione che qui Giamblico opera in seno alla nozio-ne di ejnevrgeia è, a mio avviso, alquanto sottile, se non sofisticata, perchéesprime una differenziazione di funzione causale delle realtà formali.L’ejnevrgeia nel suo genere puro è una forma, ei\do~ (Aristotele direbbe un’es-senza, to; tiv h\n ei\nai), unitaria e immobile che coincide con quella causamotrice immobile che Aristotele teorizza in diversi luoghi delle sue opere e dicui ho già detto sopra con riferimento a GC, I, 6 ; è una forma esterna al tempo
50 Mi sembra che si debba intendere così l’espressione generica oiJ tou'to levgonte~ della lin.305.14.
51 SIMPL., In Cat., 308.20, per mostrare come non ogni attività sia movimento, dirà che, adesempio, l’attività dell’intelletto è immobile, cioè esente da movimento : hJ tou' nou' ejnevrgeiaajkivnhto~ ou\sa.
52 SIMPL., In Cat., 305.23-27.
76 GIOVANNA R. GIARDINA
e al movimento, che però, quando la si consideri esistente nel mondo stessodella natura, significa la permanenza nel tempo e nel movimento, significacioè l’essere in seno al divenire. Ci sono poi ejnevrgeiai che, in quanto tali, sonosempre realtà di natura formale53 , e sono precisamente quelle che sonocoinvolte nei processi del divenire degli enti naturali, perché questi si realiz-zano, appunto, attraverso un movimento che conduce alla compiuta attuazio-ne di quelle forme sostanziali che, alla fine del processo, risulterannocompiutamente immobili, ma che tuttavia, in quanto si realizzano in modoprocessuale, hanno rapporto con il tempo e con il movimento. Mentre l’ejnevrgeianel suo genere puro sarebbe, quindi, piuttosto una forma immobile, cherimane, cioè, al di fuori di ogni movimento o processualità, l’ejnevrgeia che èperfettiva dei movimenti, invece, è quella che da un lato li precede in virtùdella sua perfezione, e dall’altro lato segue questi movimenti, in quanto liconduce fino alla completa realizzazione e immobilità di se stessa in quantoforma nell’ente. In questo modo l’ejnevrgeia appare sempre una determinazio-ne formale, che però ha due aspetti ben distinti : in quanto si realizza neiprocessi, cioè a seguito di movimento, è connotativa dell’agire ed è perfettivadel movimento medesimo, ma va comunque distinta dal movimento e dall’agi-re ; in quanto forma immobile (quale è appunto considerata da Giamblico nelsuo genere puro), è esterna al movimento, e quindi ad ogni processo in cui sirealizza, risultando così nozione totalmente diversa sia dal movimento chedall’agire, ai quali non è per nulla riconducibile. Subito dopo, infatti, Giamblicoaggiunge che, se in qualche modo si può tollerare il fatto che la nozione diattività venga così abbassata — per il fatto che esistono forme immanenti allamateria (ei[dh tina; h\n e[nula — 305.27) e di conseguenza attività immanentialla materia (aiJ e[nuloi ejnevrgeiai — 305.28), il che comporta l’ammettereattività sia separate che non separate — tuttavia non sono tollerabili in alcunmodo le opinioni di coloro che abbassano le attività al punto da collocarle aldi sotto dei movimenti. In sostanza, quindi, le forme perfettive dei movimentisono quelle, come si è visto, che si realizzano nella materia, ma poichél’ejnevrgeia è di fatto sempre un ei\do~, se è vero che ci sono forme immanentialla materia, e[nula ei[dh, ne consegue che ci devono essere anche attivitàimmanenti alla materia, e[nuloi ejnevrgeiai, che sono appunto le attività delsecondo tipo di cui parla Giamblico, cioè le ejnevrgeiai perfettive dei movimen-ti. In ogni caso, comunque, la concessione a che si abbassi la realtà formale,l’ejnevrgeia, a un livello immanente alla materia, non significa in alcun modo,per Giamblico, che si possa collocare l’ejnevrgeia al di sotto del movimento,non foss’altro perché il movimento è destinato a concludersi e a spegnersi,
53 Se infatti questi tipi secondari di ejnevrgeia sono kata; pavqo~, non si deve tuttavia dimen-ticare che pavqo~ è pro;~ u{parxin, cf. 295.23.
77LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
laddove l’attività formale, cioè l’ejnevrgeia, è destinata a permanere comesostanza dell’ente in cui si è realizzata.
Ora, tutto il discorso che Giamblico ha fin qui sviluppato, prendendospunto da una posizione teorica di Plotino, lo ha condotto a una dettagliataanalisi della differenza che sussiste fra attività e movimento, analisi checomprende anche un esame delle differenze che, sempre secondo Giamblico,sussistono in seno al concetto di ejnevrgeia e che intercorrono fra ejnevrgeia e to;ejnergeiva/. Dopo aver trattato dettagliatamente tutti gli aspetti della differenzafra queste nozioni, Giamblico si avvia alla conclusione del suo discorso,riprendendo le nozioni di agire e patire, che sono quelle di cui si sta occupan-do Simplicio in queste pagine del suo Commentario alle Categorie e per le qualiegli ha fatto ricorso a Giamblico riferendo estesi frammenti del suo omonimoCommentario perduto. Il discorso sulle differenze fra attività e movimento,infatti, partiva dall’osservazione critica di Plotino ad Aristotele, secondo laquale occorrerebbe sostituire alle categorie dell’agire e del patire quella delmovimento, kivnhsi~, o, semmai, dato che il movimento è detto da Aristoteleattività imperfetta, la categoria dell’attività, ejnevrgeia. È chiaro, dice Giamblicoa completamento del suo discorso, che considerare il movimento come generecomune dell’azione e della passione significa assumere una posizione contra-ria alla dottrina che Aristotele ha esposto in più luoghi, perché, come si è giàdetto, l’agire e il patire non sarebbero più due categorie distinte e contrariecosì come le pone Aristotele, ma costituirebbero una categoria unitaria, cioèil movimento, che comprenderebbe entrambe le nozioni, fra loro contrarie,dell’agire e del patire. Peraltro — avverte Giamblico in conseguenza dell’ar-gomentazione fin qui condotta — « si estendono comunemente all’esseremosso le cose che si considerano interne sia al patire che all’agire in virtù diun movimento (pro;~ de; to; kinei'sqai koinw'~ diateivnousin tav te ejn tw' / pavscein kai;ta; ejn tw' / poiei'n qewrouvmena kata; kivnhsin), perché costituiscono mescolanza diun’affezione e di un’attività (mikta; ga;r tau'tav ejstin ejk pavqou~ kai; ejnergeiva~),non dell’attività in senso proprio, bensì di quell’attività che è mescolataall’affezione (ouj th'~ kurivw~, ajlla; th'~ tw' / pavqei summemigmevnh~) »54 . In effetti,dalla precedente argomentazione di Giamblico si evinceva che ciò che patisceè coinvolto nel movimento, e che ciò che agisce, se inteso come agenteprossimo o ultimo di un processo, patisce anch’esso perché è coinvolto in unmovimento. L’azione dell’agente prossimo, quindi, è una mescolanza diun’affezione (dovuta al fatto che l’agente patisce) e di un’attività (dovuta alfatto che l’agente agisce). Ma Giamblico aveva anche spiegato la differenzache sussiste fra quello che ha chiamato ‘genere puro dell’attività’ e l’altro
54 SIMPL., In Cat., 306.5-9.
78 GIOVANNA R. GIARDINA
genere di attività che da essa discende. Di conseguenza, l’azione dell’agenteprossimo è mescolanza di un’affezione e di un’attività solo a condizione chenon si intenda quest’ultima come ejnevrgeia nel suo genere puro, cioè comeatto, ma la si intenda nel senso di quella ejnevrgeia che, come si è già visto, ènon-separata dal movimento. D’altra parte — aggiunge giustamente Giamblicoa questo punto — parlare di attività a proposito delle sole azioni (to; th;nejnevrgeian ejpi; movnwn levgein tw'n poihvsewn) — ed è appunto questo il presuppo-sto teorico di Plotino, che ha individuato nella poivhsi~ una nozione non soloautonoma rispetto all’agire e all’agente, che considera uniti fra loro, maanche equivalente a ejnevrgeia — significa parlare senza avere condotto uncorretto esame del concetto di attività, cioè senza avere individuato le realidifferenze che esistono in seno alla nozione di ejnevrgeia, perché né ogniattività è azione (ou[te ga;r pa'sa ejnevrgeia poivhsi~) — infatti non lo è certamentel’atto di pensiero —, né ogni azione è attività (ou[te pa'sa poivhsi~ ejnevrgeia),perché ci sono delle azioni che sono anche passive.
Qui si conclude il lungo estratto dei frr. 84-86 Larsen di Giamblicoriportato da Simplicio. Partito da una situazione di confusione di ben trenozioni, precisamente poiei'n, kivnhsi~, ed ejnevrgeia, grazie alla citazione dellaposizione teorica di Giamblico su queste nozioni, Simplicio riesce a raggiun-gere al contempo due risultati : a) chiarire la differenza che intercorre fraqueste tre nozioni ; b) confutare, tramite la teoria di Giamblico, la posizioneteorica di Plotino e di quanti la pensano alla maniera di Plotino. Di fattopotremmo riassumere schematicamente la posizione teorica di Giamblico, equindi di Simplicio — anche a costo di sacrificare nella schematicità alcunitratti importanti di questa teoria — nel seguente modo.
Si è dimostrato sopra che secondo la teoria di Giamblico, seguita daSimplicio, l’ejnevrgeia è una determinazione formale che presenta due aspettidifferenti : a) in quanto si realizza nei processi è connotativa dell’agire ed èperfettiva del movimento ; b) in quanto forma immobile (quando appunto èconsiderata nel suo genere puro) è, invece, del tutto separata dal movimento.Ora, ciò che agisce, grazie a tale distinzione di significati del concetto diejnevrgeia, e grazie anche alla distinzione stabilita da Giamblico fra ejnevrgeiae kivnhsi~, dev’essere considerato sotto due diversi profili. Da un lato c’èl’agente immobile (quello che per Aristotele sarebbe il motore o l’agenteprimo) che è principio del movimento senza essere coinvolto nel movimentostesso, perché non si mescola ad alcuna affezione. Si tratta di una formaseparata dal movimento, che corrisponde a quello che Giamblico indica comeil genere puro dell’ejnevrgeia. Dall’altro lato c’è l’agente (quello che per Aristotelesarebbe il motore o l’agente prossimo o ultimo) che, nell’agire, subisce essostesso il movimento, perché è una mescolanza di affezione (in quanto subi-sce) e di attività (in quanto compie un’azione) e corrisponde, quindi, all’ente
79LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
che agisce sulla base di un genere di ejnevrgeia non puro, in quanto nonseparato dal movimento. Oltre a ciò che agisce c’è poi anche ciò che patisce— precisa Giamblico —, che coincide con ciò che è mosso e che è semprecoinvolto nel movimento. Una tale dottrina dell’ejnevrgeia risulta, secondoGiamblico, estranea a tanti filosofi che spinti dalla loro ignoranza hannocriticato Aristotele per avere posto come categorie l’agire e il patire.
« Da tutto questo — scrive Simplicio — bisogna trarre la conclusione chePlotino e gli altri filosofi che trasferiscono <erroneamente> dalla consuetu-dine stoica alla dottrina di Aristotele l’idea secondo cui il movimento è ilgenere comune (scil. la categoria) dell’agire e del patire, confondono inun’unica nozione movimento e attività (ou|toi sugcevousin eij~ taujto; kivnhsivn tekai; ejnevrgeian), e non prestano attenzione all’azione pura che è separatadall’affezione (kai; th;n poivhsin ouj throu'sin kaqara;n ajphllagmevnhn tou' pavqou~),se è vero che essi la intendono come unita al movimento, e inoltre nonprestano certamente attenzione al principio del movimento che è immobile(ei[per meta; kinhvsew~ aujth;n oJrw'sin, kai; e[ti mevntoi th;n ajrch;n th'~ kinhvsew~ oujthrou'sin ajkivnhton), come pensa Aristotele » (306.13-18). In questo passaggio,Simplicio (o forse Giamblico)55 , attribuendo a Plotino e ai filosofi che inquesto lo seguono l’errore di avere assunto la posizione teorica degli Stoici,e di avere confuso le nozioni di attività e di movimento, suggerendo così l’ideache si debba porre come categoria il movimento quale genere comune siadell’agire che del patire, Simplicio, dicevo, parla di azione pura (th;n poivhsinkaqaravn), che equivarrebbe, verosimilmente, all’ejnevrgeia di genere puro dicui ha parlato Giamblico, ovviamente soltanto nel caso in cui l’ejnevrgeia siaconsiderata un’azione (dal momento che, come si è visto, non sempre l’ejnevrgeiaè anche un’azione così come non sempre l’azione è un’ejnevrgeia). InoltrePlotino e coloro che la pensano come lui commetterebbero un ulterioreerrore, quello cioè di non considerare effettivamente immobile il principiodel movimento, perché confonderebbero, stando a quello che ha spiegatoprima Giamblico sul doppio significato dell’ejnevrgeia, il principio formale cheagisce rimanendo totalmente immobile e che corrisponde all’ejnevrgeia digenere puro con il principio formale che invece perfeziona il movimento e chenon può essere, quindi, separato dal movimento.
Gli Stoici, peraltro — aggiunge Simplicio — hanno commesso anche unaltro errore, contrario al precedente, perché se da un lato, nel porre il
55 Si ricorderà che ho già detto che le lin. 306.13-307.1 di SIMPL., In Cat., anche se nonrisultano essere chiaramente di Giamblico — e di fatto Larsen non le prende in considerazionenella sua raccolta di frammenti giamblichei —, sembrano una continuazione del discorso diGiamblico, anche perché proprio Giamblico, nel fr. 85 Larsen visto sopra, in cui confutaPorfirio, chiama in causa gli Stoici.
80 GIOVANNA R. GIARDINA
movimento come genere unico dell’agire e del patire, avevano ridotto a unaunità generica, quella di movimento appunto, tre nozioni diverse, quelle cioèdi movimento, di agire e di patire, dall’altro lato hanno considerato comegeneri una molteplicità di nozioni — quali l’essere mosso da se stesso (to; ejxeJautou' kinei'sqai — 306.19), il compiere movimento per mezzo di se stesso (to;de; di’ eJautou' ejnergei'n th;n kivnhsin — 306.21-22), l’agire da se stesso (to; ajf’eJautou' poiei'n — 306.25) — che altro non sono se non differenze interne a unostesso genere56 . Nelle dottrine degli Stoici — continua Simplicio — il termineejnevrgeia ha un significato confuso, perché essi lo spiegano per mezzo dellostesso termine ejnevrgeia57 . « E quando gli Stoici rendono l’agire e il patire <ununico> genere, dicono questo in maniera corretta (kai; o{tan de; to; poiei'n kai;pavscein gevno~ poiw'sin, tou'to me;n kalw'~ levgousin — 306.32-33) ; quando invecedispongono che l’essere mosso include il muovere, allora entrano in conflittocon se stessi (o{tan de; to; kinei'sqai perievcein to; kinei'n diatavttwntai, mavcontaipro;~ eJautouv~ — 306.33-34), e rendono l’essere mosso genere del muovere,perché lo contiene, e non lo rendono <al contempo> genere, perché è incontrapposizione con esso, se è vero che l’uno (scil. il muovere) è agire el’altro (scil. l’essere mosso) è patire (kai; gevno~ to; kinei'sqai tou' kinei'n poiou'nte~,diovti perievcei aujtov, kai; ouj gevno~, diovti pro ;~ aujto; ajntidiairei'tai, ei[per to; me;npoiei'n ejsti, to; de; pavscein — 306.34-307.1) ». Gli Stoici, in altri termini,parlerebbero bene quando fanno dell’agire e del patire un unico genere inquanto nel pensare questo sono coerenti con le loro premesse teoriche, chevedono il principio formale sempre coinvolto nel movimento e il movimentocome genere unico dell’agire e del patire, e tuttavia poi essi risultano incoe-renti con se stessi, perché da un lato pongono il movimento come genereunico, ma dall’altro lato affermano che il muovere è interno all’essere mosso,con la conseguenza che sarà quest’ultimo, cioè l’essere mosso, il generecomune del muovere e dell’agire e del patire, senza riflettere sul fatto che ilmuovere e l’essere mosso sono contrari fra loro, perché il muovere corrispon-de all’agire, l’essere mosso corrisponde al patire, per cui non può avvenire,sotto questo profilo, che l’essere mosso possa essere genere unico dell’agire einsieme del patire. In questo modo gli Stoici cadrebbero in evidente contrad-dizione, in quanto forniscono una teoria incoerente nelle sue articolazioni.
56 Su questa questione cf. anche ORIGENE, De principiis, 3,1.2-3, vd. A. A. LONG, D. SEDLEY eds.,The Hellenistic Philosophers, 2 vols., Cambridge University Press, Cambridge 1987,vol. II, p. 310.
57 In altri termini gli Stoici spiegherebbero una nozione con se stessa, commettendo unerrore di petitio principii. A proposito di questo passaggio, occorre tuttavia notare che potrebbeavere ragione GASKIN, trad. cit., p. 194, nota 102, che suggerisce di correggere il secondoejnergeiva~ con kinhvsew~, per cui il testo tradotto sarebbe « perché essi spiegano l’attività permezzo del movimento ».
81LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
4. Sulla nozione di entelecheia e il suo rapporto con quella di energheia␣ :Giamblico fr. 87 Larsen e SIMPL., In Cat., 307.1-19 — A questo punto, Simplicioritorna esplicitamente alla posizione di Giamblico (307.1 ss.) per discutere ilmodo in cui gli Stoici hanno interpretato un’importante e nota affermazionedi Aristotele, quella cioè di Phys., III, 2, 201b31-32, in cui lo Stagirita affermaprecisamente che il movimento sembra essere sì una certa attività, maun’attività imperfetta (h{ te kivnhsi~ ejnevrgeia me;n ei\naiv ti~ dokei', ajtelh;~ dev).Giamblico afferma — scrive Simplicio, che però in verità cita qui58 unpassaggio plotiniano, e precisamente Enn., VI 1 [42], 16.4-8 — che gli Stoicinon afferrano correttamente il movimento quando dicono che ‘l’imperfezio-ne’, nel caso del movimento (to; ajtele;~ ejpi; th'~ kinhvsew~), viene detta non nelsenso che il movimento non sia attività (ejnevrgeia), — perché, come diconoessi stessi sulla base di Aristotele, esso è in ogni caso un’attività (e[stin ga;rpavntw~, fasivn, ejnevrgeia) —, ma nel senso che ha la capacità di ricominciare piùvolte (e[cei to; pavlin kai; pavlin), non al fine di giungere all’attività (perché ilmovimento secondo loro è già ejnevrgeia), ma al fine di produrre da qualcheparte qualcos’altro, che è dopo di esso. E Simplicio continua citandoGiamblico : « Ma in che modo, dice Giamblico, è possibile dire che un’attività,che è la più perfetta tra tutte le cose, è imperfetta ? E in che modo, stando fissanel suo compiere azioni, l’attività si moltiplica ricominciando più volte, comele cose che procedono secondo il numero 59 ? (pw'~ dev, fhsi;n ’Iavmblico~, dunato;najtevleston ejnevrgeian levgein, h} pavntwn ejsti; telewtavth… tivna de; trovpon ejn tw' /e jnergei'n eJstw'sa plhquvetai kata; to; pavlin kai; pavlin, w{sper ta; kat’ ajriqmo;nproi>ovnta… — 307.6-9) ». Con questa critica Giamblico cerca di mettere subitoin luce la bizzarria della posizione teorica degli Stoici, che attribuirebberoalla nozione di ejnevrgeia, attraverso una sua identificazione con il movimento,proprietà contrarie tra loro, quali sono appunto la perfezione e l’imperfezio-ne. Subito dopo, però, Giamblico passa a fornire la sua propria interpretazio-ne del fatto che il movimento è detto da Aristotele imperfetto e, per far questo,utilizza la nozione di ejntelevceia, di cui egli ha già fatto un rapidissimo einaspettato utilizzo nel fr. 86 Larsen (= SIMPL., In Cat., 305.8). Dice infattiGiamblico in SIMPL., In Cat., 307.9-17 : « In generale il movimento, presso gliAntichi, è detto imperfetto non per contrapposizione all’attività (ouj pro;~ajntidiastolh;n th'~ ejnergeiva~) ; né infatti veniva chiamata imperfetta un’attività,bensì un’entelechia (oujde; ga;r ejnevrgeia ajll’ ejntelevceia ajtelh;~ ei[rhtai), perché
58 SIMPL., In Cat., 307.2-6.59 Scil. secondo il procedere dei numeri naturali ; cf. ARISTOT., Cat., 6, 4b23 ss. e SIMPL., In
Cat., 124.5-8.
82 GIOVANNA R. GIARDINA
c’è un’entelechia che in virtù della forma è continuità della perfezione (sunoch;kata; to; ei\do~ th'~ teleiovthto~), e un’altra entelechia che è conduzione dal mobilein potenza alla forma (ajpo; tou' dunavmei kinhtou' eij~ to; ei\do~ ajgwghv), e quest’ultimotipo di entelechia, essendo un movimento, è detta entelechia imperfetta incontrapposizione all’entelechia perfetta (pro;~ th;n th'~ teleiva~ ejnteleceiva~ajntidiastolhvn)60 , come, ad esempio, la cesellatura e la fabbricazione dellostampo della statua è movimento ed entelechia imperfetta (kivnhsi~ kai; ajtelh;~ejntelevceia)61 , mentre la forma <compiuta> della statua, ovverosia la statuacome tale, è l’entelechia perfetta (to; de; ei\do~ aujtou' kai; aujto;~ oJ ajndria;~ hJ teleivaejntelevceia), e perciò Aristotele ha definito il movimento entelechia di ciò cheè mobile in quanto mobile (dia; tou'to th;n kivnhsin oJ ’Aristotevlh~ wJrivsatoejntelevceian tou' kinhtou' h| / kinhtovn)62 , cioè entelechia che permane sempre al suostato imperfetto (tou't’ e[stin ejn ajtelei' ajei; mevnousa ejntelevceia), e che è stata daAristotele tenuta separata dall’attività (h{ti~ kecwvristai th'~ ejnergeiva~) »63 .
Questo passaggio di Giamblico mette molto bene a fuoco, a mio modo divedere, il rapporto che, nella filosofia di Aristotele, intercorre fra le nozioni diejntelevceia e di ejnevrgeia, sulle quali ho avuto già occasione di discutere in mieiprecedenti studi64 e che costituiscono sicuramente un nodo teorico moltodibattuto fra gli studiosi antichi e moderni di Aristotele. L’operazione di per séestremamente importante che qui Giamblico compie, è, infatti, quella didistinguere queste due nozioni mediante l’affermazione secondo cui l’entelechia,o almeno quella entelechia che conserva sempre imperfezione, è stata tenutaseparata (kecwvristai), verosimilmente dallo stesso Aristotele, dalla nozione diejnevrgeia. L’idea che queste due nozioni, ripeto le nozioni di ejntelevceia e diejnevrgeia, siano in verità nella filosofia di Aristotele un’unica nozione, detta condue termini fra loro sinonimi, è opinione di qualche studioso moderno65 in
60 Scil. all’atto compiuto, per dirla in termini aristotelici.61 Questa espressione, ajtelh;~ ejntelevceia, si trova in ARISTOT., Phys., VIII, 5, 257b8-9 in
riferimento al movimento.62 Vd. la definizione di ARISTOT., Phys., III, 2, 202a7-8.63 Scil. dall’ejnevrgeia che è l’atto come tale.64 In particolare si vd. GIARDINA, La Chimica Fisica di Aristotele cit., pp. 53-61.65 Così pensa, ad esempio, M. L. GILL, Aristotle’s Theory of Causal Action in Physics III 3,
« Phronesis », 25, 2, 1980, pp. 129-147, spec. p. 130 e p. 134. Questa sinonimia di ejntelevceia edejnevrgeia, che l’A. assume, causa alla stessa studiosa qualche problema ermeneutico, dalmomento che ella ammette giustamente che ejnevrgeia è un termine ambiguo (p. 131), perchétalvolta significa ‘attività’, talvolta ‘attualità’ nel senso della forma di una cosa, talaltra ‘attualitànel senso della cosa individua’ e che, sulla base di questa ambiguità, occorre decidere anche cometradurre entelechia (la Gill propende per tradurre entelechia con ‘actuality’, un senso che ècontrario alle indicazioni fornite da Giamblico nel fr. 87 Larsen qui in discussione, e con il qualeintendono l’entelechia anche L. A. KOSMAN, Aristotle’s Definition of Motion, « Phronesis », 14, 1969,pp. 40-62 e ID., Substance, Being, and Energeia cit. ; J. HINTIKKA, Aristotle on Modality and
83LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
evidente contrapposizione con quanto pensava Giamblico e — verisimilmente— anche Simplicio66 , ma anche con quanto aveva scritto Aristotele almeno indue passaggi della Metafisica, e precisamente Q, 3, 1047a30 ss. e Q, 8, 1050a22ss.67 . L’imperfezione che gli ‘Antichi’, compreso certamente Aristotele, attri-buiscono al movimento è l’imperfezione stessa dell’entelechia e nondell’ejnevrgeia che, secondo Giamblico, non è, e infatti non veniva chiamata —come precisa Giamblico —, ‘imperfetta’68 . Esiste quindi un’entelechia imper-fetta, con cui viene identificato il movimento, ma non un’ejnevrgeia imperfetta.
Determinism, « Acta Philosophica Fennica », 29, 1977, pp. 59-77). Traducono invece entelechiacon ‘attualizzazione’ W. D. Ross (Aristotle’s Physics. A Revised Text with Introduction andCommentary, by W. D. ROSS, Clarendon Press, Oxford 1936), ACKRILL, Aristotle’s Distinctionbetween Energeia and Kinesis cit., pp. 138-140, e T. PENNER, Verbs and the Identity of Actions, in O.P. WOOD, G. PITCHER eds., Ryle, a collection of critical essays, Anchor Books, Garden City N.Y 1970,pp. 427-433. Per R. Brague i due termini in questione sono sinonimi e, parlando dei tentativi chesono stati fatti per attribuire a ciascuno dei due termini un significato specifico, scrive : « Jem’avoue sceptique devant ces tentatives, car, si les mots sont, de fait, formés à partir de racinesdifférentes, ils sont interchangeables dans l’usage qui en est fait », vd. Notes sur la définition dumouvement (Physique, III, 1-3), in F. DE GANDT, P. SOUFFRIN éds., La Physique d’Aristote et lesconditions d’une science de la nature, Vrin, Paris 1991, p. 114. Legate a questo articolo di R. Braguesembrano le argomentazioni di B. BESNIER, La définition aristotélicienne du changement (PhysiqueIII, 1-3), in P. M. MOREL éd., Aristote et la notion de nature. Enjeux épistémologiques et pratiques,Press Universitaires de Bordeaux, Bordeaux 1997, pp. 15-34. Per ulteriori discussioni sulladifferenza fra ejntelevceia ed ejnevrgeia cf. anche L. COULOUBARITSIS, La Physique d’Aristote. Deuxièmeédition modifiée et augmentée de L’avenement de la science Physique, Ousia, Bruxelles 1997, pp.266 ss. ; M. T. LISKE, Kinesis und Energeia bei Aristoteles, « Phronesis », 36, 2, 1991, pp. 161-179 ;C. H. CHEN, Different Meanings of the Term Energeia in the Philosophy of Aristotle, « Philosophy andPhenomenological Research », 16, 1, 1956, pp. 56-65 e ID., The Relation between the Terms Energeiaand Entelekheia in the Philosophy of Aristotle, « The Classical Quarterly », n.s. 8, 1958, pp. 12-17.
66 Occorre osservare che SIMPLICIO, In Phys., 414,15 ss., commentando Phys., 201a9 ss., notaquanto segue : Aristotele all’inizio (ejn ajrch' /) avrebbe definito il movimento come ejnevrgeia delmobile in quanto tale ; Alessandro, Porfirio e Temistio, e con loro altri filosofi che hannointerpretato la definizione aristotelica di movimento, notando che poco dopo Aristotele chiamail movimento entelechia, e avendo trovato in alcune copie la scritta « l’entelechia di ciò che è inpotenza in quanto tale è movimento », hanno mutato in questa definizione ejnevrgeia in ejntelevceia,ritenendo che in Aristotele avessero lo stesso significato. Aristotele, però, aggiunge Simplicio,mai intende l’entelechia come applicabile alla perfezione (mhvpote de; th;n ejntelevceian oJ ’Aristotevlh~ejpi ; th'~ teleiovthto~ ajkouvei), mentre Simplicio pensa appunto che, almeno in certi casi, il sensodi ejnevrgeia sia appunto quello di perfezione.
67 A me sembra, contrariamente a quanto pensano altri, che in questi due passaggi Aristoteledistingua la nozione di ejnevrgeia da quella di ejntelevceia, perché nel primo dice che il termineejnevrgeia ‘è connesso’ (suntiqemevnh) all’ejntelevceia, mentre nel secondo dice che ‘tende’ (sunteivnei)all’entelechia, condizioni entrambe che non sarebbero comprensibili se avessimo a che fare conuna e identica nozione.
68 È questo un concetto che Giamblico ha già affrontato nel fr. 86 Larsen. Vd. in particolareSIMPL., In Cat., 304.2-7 in cui differenzia l’ejnevrgeia dalla kivnhsi~ e di cui ho discusso sopra.
84 GIOVANNA R. GIARDINA
Infatti, come si è già visto, l’ejnevrgeia è per Giamblico la nozione che esprimela compiutezza nel senso di totale mancanza di tensione verso un fine, ovveroverso una forma da realizzare, in quanto ha già in se stessa la sua formaperfetta69 . Ad essere imperfetta, come si diceva, è allora l’entelechia, che èuna nozione complessa, perché, come chiarisce Giamblico, comprende duesignificati diversi ma uniti fra loro, essendo al contempo, come si è visto,‘conduzione dal mobile in potenza alla forma’ e ‘continuità della perfezionein virtù della forma’. Come si vede, i due aspetti dell’entelechia imperfettariguardano entrambi la forma, ei\do~, perché essa è conduzione alla forma (eij~to; ei\do~ ajgwghv) — cioè realizzazione di una forma, che è l’aspetto grazie alquale si dice che il movimento è entelechia (e infatti Giamblico ha detto « […]Aristotele ha definito il movimento entelechia di ciò che è mobile in quantomobile, cioè entelechia che permane sempre al suo stato imperfetto ») —, purrappresentando al contempo la continuità della forma come perfezione(sunoch; kata; to; ei\do~ th'~ teleiovthto~). Nell’entelechia, in altri termini, sitroverebbero al contempo la processualità e la determinazione formale,l’essere e il divenire degli enti, la persistenza di una determinazione pur nellosvolgersi di un processo di divenire. In questa condizione di compresenza diessere e divenire, cioè di realizzazione formale che non ha acquisito il suotermine ultimo di ejnevrgeia, cioè di compiuta perfezione e immobilità, siconnettono appunto entelechia e movimento. L’ejntelevceia che in Phys., III, 1è chiamata da Aristotele atto incompiuto, ejnevrgeia ajtelhv~, incompiuto acausa della presenza dell’aspetto potenziale (dunatovn) dell’ente70 , corrispondein sostanza alla stessa nozione di cui parla Giamblico quando dice chel’entelechia è ‘conduzione’ alla forma. Aristotele spiega questa incompiutezzafacendo, come si sa, l’esempio del processo in corso della costruzione di unacasa, l’oijkodovmhsi~, in cui persiste ancora il costruibile, l’oijkodomhtovn, ovverol’aspetto potenziale di ciò che si sta costruendo, per cui l’oijkodovmhsi~ rappre-senta il movimento di realizzazione di una forma, quella della casa che, unavolta realizzata e cioè compiuta71 , comporterà l’assenza di movimento ovverodi quella che Giamblico chiama entelechia imperfetta. Giamblico in Simplicio,invece, fa l’esempio della cesellatura, tovreusi~, e della fabbricazione dellostampo di una statua, calkeiva tou' ajndriavnto~, che rappresentano le fasi delmovimento, ovvero dell’entelechia imperfetta, che si contrappongono allastatua realizzata, ovvero allo stato compiuto della forma della statua, cherappresenta la fase dell’entelechia perfetta. Come si è visto, infatti, Giamblicoopportunamente, dopo aver opposto la nozione di entelechia imperfetta a
69 Cf. SIMPL., In Cat., 304.7-8.70 ARISTOT., Phys., III, 2, 201b31 ss.71 Ed è questo lo stato che Aristotele chiama atto in senso assoluto, ejnevrgeia aJplh'.
85LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
quella di ejnevrgeia, che non può mai essere imperfetta, introduce anche unanozione di ejntelevceia perfetta che corrisponderebbe, verosimilmente,all’ejnevrgeia quale stato della forma che si è compiutamente realizzata attraver-so un movimento. Dal che si comprende facilmente che, se la vasta letteraturacritica che esiste sull’argomento non è sufficientemente chiarificatrice e ancormeno risolutiva del problema della distinzione fra ejnevrgeia ed ejntelevceia inAristotele, le ragioni di questa difficoltà nello stabilire la differenza tra le duenozioni esistono. Tantopiù che, a differenza di quello che stiamo leggendo neldiscorso di Giamblico, in cui l’ejnevrgeia è sempre una nozione che indica lacompiutezza e la perfezione, e solo l’ejntelevceia è, invece, contraddistinta,secondo Giamblico, da due stadi diversi (l’uno imperfetto, identificabile con lacondizione dell’ei\do~ in movimento, e l’altro perfetto, identificabile con lacondizione di completa realizzazione dell’ei\do~ e perciò dell’immobilità), checostituiscono verosimilmente la ragione per cui occorre distinguere la nozionedi ejntelevceia da quella di ejnevrgeia, nella filosofia di Aristotele, invece, l’ejnevrgeia,in virtù del fatto che è concepita in un duplice modo, e cioè ora comeincompiuta e ora come assoluta (aJplh'), assume ora il significato dell’operativitàe quindi della realizzazione in corso di un mutamento (che è propriamente ilsignificato dell’entelechia imperfetta di Giamblico e quindi della condizionedell’ei\do~ in movimento), ora invece il significato di atto compiuto72 (che èpropriamente il significato dell’entelechia perfetta). Resta fermo, tuttavia, cheGiamblico pensa che l’ejnevrgeia non abbia alcun rapporto con la potenza, e suquesto egli mette in guardia più volte, laddove, al contrario, l’entelechia ocoesiste insieme alla potenza, come nel caso dell’entelechia imperfetta, o harapporto con la potenza così come la perfezione rispetto all’imperfezione.Giamblico, dunque, sembra avere ben distinto le due nozioni di ejnevrgeia edejntelevceia, mentre Aristotele, sottolineando il duplice modo di intendere lanozione di ejnevrgeia, ora come incompiuta, ajtelhv~, ora come assoluta, aJplh',rischia di ottenere una certa indistinzione tra ejnevrgeia ed ejntelevceia, poichél’ejnevrgeia incompiuta appare come corrispondente all’ejntelevceia imperfetta dicui parla Giamblico, mentre l’ejnevrgeia assoluta appare come corrispondenteall’ejntelevceia perfetta ipotizzata dallo stesso Giamblico.
Orbene, questa apparente incongruità che Aristotele rivela a propositodella nozione di ejnevrgeia, che se non fosse solo illusoria finirebbe peraccreditare l’ipotesi di quanti ritengono che in ultima istanza le due nozioniin Aristotele siano un’unica e medesima nozione detta con due termini fraloro sinonimi, non deve al contrario condurre a questa conclusione teorica.Che le nozioni di ejntelevceia e di ejnevrgeia in Aristotele siano intimamente
72 Si vd. ad esempio ARISTOT., Phys., III, 1, 201b10-11.
86 GIOVANNA R. GIARDINA
legate fra loro è evidente già a partire dall’utilizzo stesso che Aristotele ne fain Phys., III, 1-3, in cui lo Stagirita le utilizza nei medesimi contesti, addirit-tura nelle stesse frasi73 . Ma che le due nozioni non siano reciprocamentesovrapponibili, ovverosia semanticamente intercambiabili, è, a mio avviso,un dato inoppugnabile. Il sottolineare un’articolazione di significati e diaspetti all’interno della nozione di ‘atto’, all’interno cioè di una nozione checostituisce l’affermazione di una precisa e incontrovertibile condizione dideterminazione ontologica, costituisce per Aristotele la soluzione stessa delproblema di come aprire un varco in seno alla verità, alla determinatezza eall’immobilità dell’essere, che era stata insegnata da Parmenide, e all’altret-tanto inconfutabile verità dell’esistenza del divenire. Occorre scoprire, inaltri termini — pensa Aristotele —, una plurivocità di sensi sulla base deiquali si può parlare scientificamente anche dell’essere in movimento. Esseree non essere, i due poli della riflessione eleatica, rimangono i due terminiestremi entro i quali collocare la verità del divenire in tutte le sue forme. Talitermini estremi sono da considerarsi, secondo Aristotele, i principi contraridel divenire, da un lato la privazione e dall’altro lato la forma compiutamenteacquisita, con l’accorgimento che il non essere, come hanno sottolineato gliEleati, non può essere pensato né detto per se stesso, ma può essere pensatoe detto — secondo Aristotele — perché esiste in rapporto all’essere, cioè esistecome ciò che assolutamente non è. In virtù di una privazione che è non esserein senso assoluto74 , perché, in rapporto all’essere, è mancanza della determi-nazione compiuta della forma, si può parlare di enti che pur non essendo unadeterminata cosa in potenza possono essere quella cosa che non sono. Ilproblema è precisamente quello della ‘conduzione’ dalla privazione allaforma, dal non essere all’essere, l’ajgwghv eij~ to; ei\do~ di cui parla ancheGiamblico, perché occorre sfuggire sia all’ammissione della generazionedell’essere dal non essere e del non essere dall’essere, che è impossibile, comeha insegnato Parmenide, sia al problema secondo cui ammettere un muta-mento degli enti potrebbe significare affidare la determinazione e perfezionedell’essere a tutta una infinita varietà di trasformazioni casuali che potrebbe-ro verificarsi in quella ‘conduzione alla forma’. Soltanto l’ei\do~ può, standocosì le cose, consentire di sfuggire a questo duplice pericolo, per il primoproblema in quanto fornisce determinazione alla privazione come non esseree, per il secondo problema, in quanto guida ogni mutamento sin dall’inizioverso la realizzazione di se stesso in quanto ei\do~ nell’ente. Qui interviene la
73 Si vd. ad esempio ARISTOT., Phys., III, 1, 201a27-29 ; III, 3, 202a13 ss.74 Vd. ARISTOT., Phys., I, 8, 191b15-16, in cui si dice che la stevrhsi~ è per se stessa non essere,
kaq’ aujto; mh; o[n.
87LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
nozione di entelechia, che è la nozione tramite la quale, potremmo dire,Aristotele fornisce la possibilità teorica di ragionare ontologicamente delmovimento, perché l’entelechia è appunto la nozione con cui si può pensarealla forma coinvolta in un processo di movimento che, di fatto, di per sésarebbe solo un dinamismo75 , cioè solo ‘passaggio’. L’entelechia è perciò lostato proprio degli enti naturali che, per definizione, sono coinvolti continua-mente nel movimento76 . Se quindi Aristotele, al contrario di quanto si è vistoin Giamblico, non parla nella Fisica dell’entelechia considerandola ora per-fetta ora imperfetta, ma ne parla come nozione univoca, e al contrario parladell’ejnevrgeia distinguendola ora come ejnevrgeia imperfetta, ora come ejnevrgeiaassoluta, allora è solo la prima, l’ejnevrgeia ajtelhv~, che può essere identificatacon l’entelechia e non anche la seconda, l’ejnevrgeia aJplh'. Giamblico, quindi,interpreta correttamente Aristotele se pensa che in ambedue queste nozioni,ejntelevceia ed ejnevrgeia, esiste un aspetto che mantiene la loro distinzione. Sein Aristotele sembra piuttosto che l’ejnevrgeia imperfetta corrisponda allanozione univoca di entelechia, che corrisponde, perciò, al movimento, laddovel’ejnevrgeia aJplh' indica l’atto compiuto e immobile, in Giamblico, invece,l’entelechia imperfetta corrisponde al movimento, con cui non si può metterein rapporto l’ejnevrgeia, né quella considerata nel suo genere puro né quelladerivata da questa prima, mentre l’entelechia perfetta sembra corrisponderea ciò che è attivo o ‘in atto’, in virtù del suo rapporto o meno con la potenza,e forse anche al tipo derivato dell’ejnevrgeia concepito come la forma che si ècompiutamente realizzata grazie a un movimento.
A conclusione di questa complessa argomentazione, Giamblico aggiungeuna nota, precisando che non ogni movimento è imperfetto, ma lo è soltantoquello che ha un principio e un limite, cioè il movimento rettilineo, mentre ilmovimento che non ha queste caratteristiche, quindi il movimento circolare,quale è il movimento del cielo, non è mai imperfetto, ma al contrario è semprein uno stato di perfezione (307.18-19).
5. Epilogo : Giamblico frr. 87-88 Larsen e SIMPLICIO, In Cat., 307.20-308.10— La confusione fra ciò che è attivo o ‘in atto’ (to; ejnergeiva/) e attività o atto(ejnevrgeia) — sostiene Giamblico — sconvolge il presente ragionamento (to;nparovnta lovgon). Il Neoplatonico non si riferisce alla sua ultima osservazione,e cioè al fatto che il movimento imperfetto è solo quello rettilineo e non anchequello circolare, che è, in questo contesto, considerazione accessoria, bensìal discorso principale che ha svolto in questo fr. 87, quello cioè relativo alla
75 Per comprendere meglio questa natura del movimento in Aristotele e la differenza rispettoal mutamento e al divenire, rimando al mio studio I fondamenti della Fisica cit., pp. 119-144.
76 Vd. ARISTOT., Phys., I, 2, 185a12-13.
88 GIOVANNA R. GIARDINA
differenza fra ejntelevceia ed ejnevrgeia. Se andiamo con la mente a quantoGiamblico ha detto nel fr. 86 (SIMPL., In Cat., 305.5 ss.), infatti, ciò che è attivoo ‘in atto’ (to; ejnergeiva/) è tale in virtù dell’attività o atto, ejnevrgeia, ed equivaleall’entelechia di ciascuna cosa, nel senso che ciò che è attivo o ‘in atto’corrisponde a una compiutezza o perfezione che rinvia alla condizione dipotenzialità con cui è in rapporto. In altri termini, volendo qui richiamareancora una volta l’esempio aristotelico di Phys., III, 2 della casa costruita o incostruzione, è lecito affermare che una casa compiutamente e perfettamentecostruita è una casa realmente e concretamente tale, perché la sua realtàdiscende dalla forma della casa in sé perfetta, cioè già costruita, e non dal suopoter essere costruita, e tuttavia mantiene un rapporto con uno stato poten-ziale in quanto è stata costruita (e perciò è perfetta) in rapporto alla suacondizione di non ancora costruita (o in costruzione, e perciò imperfetta). Inaltre parole, come casa già costruita è perfetta e compiuta in relazioneantitetica con la casa imperfetta e incompiuta che costituiva lo stato poten-ziale della casa che poteva essere costruita. In queste lin. 307.20 ss. Giamblicoriprende, quindi, la differenza fra to; ejnergeiva/ ed ejnevrgeia, perché questadifferenza è parte integrante della confutazione dell’argomento di Plotino incui si assimila il movimento, che Aristotele definisce come entelechia, conl’attività. Ciò che muta dall’essere in potenza a ciò che poteva <essere> (cioèche di fatto diviene ciò che poteva divenire : to; ga;r ajpo; tou' dunavmei metabavlloneij~ o} hjduvnato), dice Giamblico, — e quest’ultimo termine, che corrisponde aciò che è già divenuto, è una forma o una passione o un riposo (ei\do~, pavqo~,hjremiva — il bronzo <della statua>, ad esempio, procedendo dall’essere inpotenza all’essere in atto, una volta divenuto una statua, si realizza in unaforma (ei\do~), e ciò che è riscaldabile, quando viene riscaldato, procede versoun’affezione (pavqo~), e ciò che è attivo del movimento diviene riposo (hjremiva),quando è terminato in quest’ultimo stato) — è detto attivo o ‘in atto’ (to;ejnergeiva/). Ciò che è attivo o ‘in atto’ (to; ejnergeiva/), però, differisce dall’attivitào ‘atto’ (ejnevrgeia) nella misura in cui il primo sussiste in rapporto al poten-ziale (kaq’ o{son to; me;n ejnergeiva/ pro;~ to; dunavmei uJfivstatai), mentre l’attivitàesiste per se stessa (kaq ’ eJauth vn)77 . Simplicio comprende pienamente ildiscorso di Giamblico che egli stesso riporta, e aggiunge : « Si potrebbe dire,io credo, che, anche se ciò che è attivo (o ‘in atto’ — to; ejnergeiva/) è detto cosìin rapporto a ciò che è in potenza (pro;~ to; dunavmei), ciò che è attivo non indicaper niente un movimento, ma piuttosto la perfezione di ciò che prima eraimperfetto (ajlla; th;n tou' provteron o[nto~ ajtelou'~ teleiovthta) ». In altri termini,ciò che è attivo o ‘in atto’ (to; ejnergeiva/) indica quello stato di compiutezza, di
77 Qui termina il fr. 87 di Giamblico.
89LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
determinazione, di perfezione, che ad esso è conferito dall’ejnevrgeia, e seanche qualcuno può credere di dire ‘attivo’ o ‘in atto’ in rapporto a ciò che èin potenza, questo rapporto è quello di ciò che è determinato compiutamenterispetto a ciò che non lo è, è il rapporto del perfetto con l’imperfetto, per cuiciò che è attivo o ‘in atto’ non deve essere pensato come un movimento.
A questo punto Simplicio si appresta, non senza l’aiuto di un’ultimacitazione di Giamblico (ultima, intendo, per quanto concerne questa sezionedel suo commentario alle Categorie relativa all’agire, al movimento e all’attivi-tà), a confutare definitivamente la posizione di Plotino già presentata sopra,quella cioè di Enn., VI 1 [42], 16. « Plotino, tuttavia — continua Simplicio 78 —non concede che il movimento sia imperfetto, ma neppure — egli dice — puòessere perfezionato, al contrario <viene perfezionata> la cosa a cui <il movi-mento> tende […] (ÔO de; Plwti'no~ oujde; th;n kivnhsin ajtelh' sugcwrei' ei\nai oujde;teleiou'sqaiv fhsin aujthvn, ajlla; to; pra'gma ou| ejstocavzeto ...) ». Quando Simplicioafferma che Plotino « non concede che il movimento sia imperfetto » si riferi-sce all’inizio del paragrafo 16 di Enn., VI 1, in cui il filosofo, discutendodell’imperfezione che si attribuisce al movimento, chiarisce che questa im-perfezione non significa che il movimento non sia attività, ejnevrgeia, perchéanzi il movimento è attività in ogni caso (pavntw~), ma significa che il movi-mento ha la capacità di ricominciare più volte79 . La conseguenza del fatto cheil movimento è assimilato da Plotino all’‘attività’ è, allora, che il movimentonon può essere imperfetto, perché è già perfetto fin dall’inizio in quanto èattività, come deduce Simplicio. D’altra parte Plotino, prosegue Simplicio,non concede nemmeno che il movimento sia condotto a compimento, perchéin realtà viene portata a compimento la cosa che è coinvolta in un processodi cui il movimento costituisce l’aspetto dinamico. L’espressione ajlla; to;pra'gma ou| ejstocavzeto (307.31) apre una citazione alla lettera di Plotino :Simplicio, infatti, cita l’esempio che fa Plotino per far comprendere il fattoche non è il movimento che si compie, ma la cosa che si muove : il camminare,dice Plotino, è sempre, sin dall’inizio, camminare ; se però occorre cammina-re per uno stadio e non si completa il percorso, la parte incompiuta nonappartiene al camminare o al movimento, bensì al percorso stesso, cioè allacosa che tramite il movimento si doveva portare a compimento. È a questopunto che Simplicio chiama ancora una volta in causa Giamblico (fr. 88Larsen) contro Plotino. Giamblico contesta a quest’ultimo tre tipi di errore :
78 Alle lin. 307.27-308.1 Simplicio espone il pensiero di Plotino contenuto in Enn., VI 1 [42],16.9-13, prima di presentare l’ultima citazione di Giamblico, corrispondente al fr. 88 Larsen(308.1-3).
79 È sempre la posizione teorica che SIMPLICIO, In Cat., 307.2-6, ha detto che Giamblicoattribuiva agli Stoici, citando in verità Plotino.
90 GIOVANNA R. GIARDINA
1) Plotino non assume in quanto mobile l’operazione del movimento (oujc h| /kinhtovn, fhsivn, lambavnei~ to; e[rgon th'~ kinhvsew~ — 308.1-2), e questo si deducedal fatto che Plotino assimila il movimento all’ejnevrgeia, che, in quanto indica,secondo Giamblico, la compiutezza e la determinazione, non può averemobilità ; 2) Plotino non collega tale operazione svolta dal movimento allapotenza, laddove, come si è visto, per Giamblico il movimento è legato allapotenza, perché è in virtù dell’imperfezione e dell’incompiutezza che si hamovimento verso la perfezione e la compiutezza, e un mobile non è, avvertivaGiamblico, un intero, perché appunto in quanto mobile non ha ancora la suacompiutezza (pro;~ th;n duvnamin aujto; sunavptei~, ejpei; kaqo; kinhto;n ou[pw ejsti;no{lon — 308.2-3) ; 3) Plotino non assume l’entelechia come movimento delmobile (oujde; th;n ejntelevceian ou\n wJ~ kinhtou' lambavnei~ — 308.3). In effettiPlotino trascura del tutto la nozione di entelechia, nozione che nelle sueEnneadi ricorre soltanto undici volte e sempre in trattati relativi all’anima80 ,e, come si è visto, assimila piuttosto il movimento all’ejnevrgeia. D’altra partel’ejnevrgeia significa per Giamblico, così come per Aristotele, la condizione diperfezione e compiutezza dell’ei\do~, per cui giustamente egli imputa a Plotinodi non avere assunto l’entelechia come modo di essere del mobile. Giamblicodice bene — incalza Simplicio a questo punto e in riferimento, io credo,soprattutto a quest’ultimo errore che si attribuisce a Plotino —, perché Plotino,spiega Simplicio, sembra che consideri perfetto l’imperfetto, nel senso chel’imperfetto, se considerato assolutamente imperfetto, risulta ‘perfettamenteimperfetto’. Plotino, in altri termini, in quanto assimila il movimentoall’ejnevrgeia, considera perfetto (ejnevrgeia) l’imperfetto (kivnhsi~). Il movimento— conclude Simplicio, riassumendo brevissimamente l’insegnamento diGiamblico — è imperfetto (ajtelhv~) in quanto la sua natura è una mescolanzadi potenza ed entelechia, in quanto cioè esso nasce al contempo dall’indefinitoe dal definito, dal privo di forma e dalla forma, in breve dal non-essere edall’essere. Di qui, conclude Simplicio, risulta evidente che kivnhsi~ ed ejnevrgeiapura (si ricordi che del genere puro dell’ejnevrgeia — to; kaqaro;n gevno~ th'~ejnergeiva~ delle lin. 305.14-15 — si è già parlato) non hanno nulla in comune, inquanto la pura ejnevrgeia è scevra da ogni mescolanza di indefinito e definito,essendo appunto compiutamente e determinatamente ei\do~.
6. Considerazioni conclusive — Occorre a questo punto che io ricapitolibrevemente tutti gli elementi della mia analisi delle lin. 295.1-308.10 delCommentario di Simplicio alle Categorie di Aristotele, al fine di tentare difocalizzare in via conclusiva i risultati di tale analisi.
In primo luogo si è visto che Simplicio stabilisce — in termini ora espliciti,ora impliciti — una certa affinità di significati fra poiei'n ed ejnevrgeia. Alla lin.
80 Precisamente una volta in Enn., IV 2 e dieci volte in IV 7.
91LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
296.9, ad esempio, Simplicio afferma esplicitamente che ‘agire’ significa‘attività’ e che ‘patire’ significa ‘affezione’ (Shmaivnei de; to; me;n poiei'n ejnevrgeian,to; de; pavscein pavqo~). Agire e patire in quanto tali sono categorie separate enon sono pensabili necessariamente per reciproca relazione di contrarietà,perché sia l’agente che il paziente esistono a prescindere l’uno dall’altro e seè vero che l’agire significa attività, non ogni attività è relativa a un paziente(299.9-10). E ancora, secondo Simplicio, Aristotele ha posto giustamentecome categoria l’agire, e non l’agente o l’azione, perché l’agire significasemplicemente attività, mentre l’agente, to; poiou'n, comprende nel suo signi-ficato sia ciò che svolge un’attività (tou' ejnergou'nto~) sia l’attività stessa (th'~ejnergeiva~ — vd. lin. 301.29-31), e d’altra parte l’azione (poivhsi~) si dice in duesensi, perché significa sia attività, ejnevrgeia, sia l’esito dell’attività, to;ajpotevlesma th'~ ejnergeiva~ (vd. lin. 301.33-35). Il fatto, però, che agire significaattività, ejnevrgeia, o compiere un’attività, ejnergei'n, non deve far pensare cheagire e attività siano nozioni identiche. Mentre infatti to; poiei'n corrispondead una nozione che ha un carattere di genericità, l’‘agire’ appunto, che si dice,cioè, senza alcuna determinazione aggiuntiva, ejnevrgeia, invece, indica quellaprecisa determinazione in virtù della quale l’‘agire’ può essere connotatocome un agire particolare, ad esempio come il riscaldare o il raffreddare, ecosì via. In altri termini, ejnevrgeia sarebbe ciò in rapporto a cui l’agirerisulterebbe un movimento attivo specifico. Inoltre, è la medesima quellaproprietà formale che determina un movimento attivo e un altro passivo, percui se l’attività dell’agente risulta determinata ed è quindi un determinatoagire, determinata risulterà anche l’affezione del paziente sulla base dellamedesima determinazione formale che è comune ad ambedue i movimenti.L’ejnevrgeia così individuata appare, come dicevo, una sorta di connotatoreformale dei processi, per cui ejnergei'n altro non è che un agire determinato.
Tutto questo discorso suscita le seguenti domande : che cos’è precisamen-te l’ejnevrgeia, con cui Simplicio ha messo in rapporto l’agire ? Dato cheAristotele ha definito il movimento come ejnevrgeia ajtelhv~, che senso bisognadare a questa definizione e quindi al rapporto fra movimento ed ejnevrgeia ? Ein che rapporto stanno, di conseguenza, il movimento e l’agire ? A questedomande Simplicio risponde assumendo la posizione teorica di Giamblico,che egli cita diffusamente, con il duplice scopo di confutare la posizioneteorica di Plotino e di difendere Aristotele.
La seconda parte dell’argomentazione di Simplicio sul rapporto fra poiei'n edejnevrgeia si svolge intorno alla questione, posta da Plotino, secondo la quale, datoche l’agire equivale a trovarsi in una certa azione, cioè in una attività (to; poiei'n ejnpoihvsei ei\naiv tini, tou'to de; ejnergeiva/), Aristotele avrebbe dovuto porre comecategoria l’attività piuttosto che l’agire. Anzi, aggiunge Plotino, se l’attivitàattiene alla sostanza come movimento, allora Aristotele avrebbe dovuto assumere
92 GIOVANNA R. GIARDINA
come categoria il movimento piuttosto che l’attività. Plotino e coloro che lapensano come lui — contesta Simplicio — non tengono conto del fatto che ilmotore o l’agente primo del movimento (cioè l’agente quale principio del movi-mento) è immobile, come dice Aristotele, sicché, nel caso di ciò che patisce c’èsempre movimento, al contrario non c’è sempre movimento nel caso di ciò cheagisce ; ne consegue che il movimento non potrà essere il genere unico cheabbraccia sia l’agire che il patire. Agire e patire sono categorie separate, come siè detto, e tali le ha considerate anche Porfirio, il quale però non ha adottatoragionamenti congrui con il pensiero di Aristotele. Come insegna Giamblico, nontutte le azioni implicano due movimenti differenti, l’uno dell’agente e l’altro delpaziente, come pensa Porfirio, né c’è sempre contatto fra agente e paziente, comepensano gli Stoici. La condizione della reciprocità dell’agire e del patire risiedeinvece in una attitudine dell’agente rispetto al paziente (302.32-33), chiamataanche affinità o congenericità di potenza (303.8-9) fra i due : come Aristotele hainsegnato in Phys., III, 1, 200b28-32, in altri termini, affinché vi sia agire e patire,occorre che le condizioni potenziali dell’agente e del paziente abbiano relazionefra loro, occorre cioè che ‘ciò che è capace di agire’ (poihtikovn) e ‘ciò che è capacedi patire’ (paqhtikovn) siano congeneri e abbiano rapporto di contrarietà.
Se però Simplicio nega che il movimento possa essere il genere unicodell’agire e del patire, non è ancora chiaro in che rapporto stiano il movimentoe l’agire. In realtà, chiarisce Giamblico in Simplicio, il movimento non è affattouna comunanza di agire e di patire e non deve essere affatto concepito comequalcosa che include in sé l’azione e la passione in un’unica continuità, perchéil movimento è, al contrario, separato dall’agente e dal paziente e intermedio trai due ; e se da un lato procede dall’agente, dall’altro lato provoca l’affezione alpaziente. Giamblico ha ben compreso la natura che il movimento ha nellafilosofia aristotelica, perché lo individua come un processo che va da un termineiniziale a un termine finale senza mai possedere quest’ultimo in se stesso81 , comeun trascorrere in continuità da un contrario all’altro contrario (304.18-19). Inquesto modo Simplicio, tramite Giamblico, riesce sì a confutare l’idea di Plotinosecondo cui il movimento sarebbe la categoria che contiene sia l’agire che ilpatire, però non ha ancora confutato l’altra osservazione, sempre di Plotino,secondo la quale, dato che il movimento è un’ejnevrgeia ajtelhv~, in ragione diquesta imperfezione del movimento occorrerebbe assumere come categorial’ejnevrgeia. Questa seconda osservazione di Plotino spinge Simplicio a citare ipassaggi di Giamblico in cui questi dimostra che quella di movimento e quelladi attività sono due nozioni molto diverse fra loro.
81 Vd. ARISTOT., Meta., IX, 6, 1048b18 ss. in cui appunto Aristotele distingue i movimentiquali processi che non hanno un limite, pevra~, e sono perciò processi imperfetti, e le attività,ejnevrgeiai, che invece hanno il limite.
93LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
Movimento e attività non hanno, secondo Giamblico, nulla in comune fraloro, perché mentre il movimento si affretta verso il termine finale senzatuttavia mai possederlo, l’attività al contrario è fissa nel suo fine, perché èpiena di se stessa e della sua propria perfezione ; mentre il movimento è uncontinuo svolgersi e in quanto continuo è divisibile all’infinito, l’attività invecesi mantiene stabile in un solo limite (hJ de; ejnevrgeia kaq’ e}n pevra~ i{statai —304.11-12) ; mentre il movimento è divisibile e infinito e indeterminato, l’atti-vità invece è indivisibile ed è un limite e gode della sua identità ; mentre ilmovimento è un continuo trascorrere da un contrario all’altro contrario, senzaessere però nessuno dei due contrari considerati come termini estremi delmovimento stesso, l’attività sta fissa in uno solo dei contrari, cioè la forma, enon ha nulla della natura dell’altro contrario, cioè della privazione ; mentre ilmovimento si estende parallelamente al tempo, come se avesse una dimensio-ne, l’attività è priva di dimensione e si estende parallelamente all’eternità ed èpresente tutta intera nell’istante. Tutte queste differenze rendono impossibilela supposizione che le due nozioni possano avere natura omogenea tra loro eche l’attività possa essere genere del movimento, come pensa Plotino. L’attività— aggiunge Giamblico — preesiste come immobile, in quanto contenenteinsieme l’inizio e la fine del movimento in un unico momento di riposo, mentreil movimento è una processualità e uno svolgimento in continuità, e per questaragione ha realtà temporale e numerica. L’ejnevrgeia, come apprendiamo anchedalla citazione di Teofrasto interna alla citazione di Giamblico, è « essenza oforma specifica di ciascuna cosa » (eJkavstou oujsivan kai; to; oijkei'on ei\do~), ementre il movimento è in certo qual modo ejnevrgeia, per il fatto che questa locontiene (in quanto ne contiene l’inizio e la fine insieme in un unico momentodi riposo), l’ejnevrgeia invece non è mai movimento, per il fatto che è perfezionee compimento, laddove il movimento è imperfezione e incompletezza.
È evidente che l’ejnevrgeia acquista qui il significato che ha la formaimmobile aristotelica, motore immobile ed eterno, sostanza formale che senon esiste senza la sostanza composta è tuttavia eterna o corruttibile senza ilcorrompersi e generabile senza il generarsi82 . L’ejnevrgeia, quindi, è la formain virtù della quale ciò che è in attività, to; ejnergeiva/, è compiuto e perfetto. Ciòche è in attività, infatti, è tale non in virtù di un suo rapporto con la duvnami~,con cui ha rapporto nel modo di ciò che è perfetto rispetto all’imperfetto,bensì in virtù del suo rapporto con l’ejnevrgeia, che è un rapporto con la
82 Cf. ARISTOT., Meta., VIII, 5, 1044b21 ss., dove si dice che alcune cose, e precisamente leforme che sono esenti da materia, esistono o non esistono a prescindere dalla generazione edalla corruzione (e[nia a[neu genevsew~ kai; fqora'~ e[sti kai; oujk e[stin). Sulla sostanza formale cf.JAULIN, Eidos et Ousia cit., pp. 94-106 ; ma anche C. H. CHEN, Aristotle’s concept of primary ousiain books Z and H of the Metaphysics of Aristotle, « Phronesis », 2, 1957, pp. 46-59.
94 GIOVANNA R. GIARDINA
perfezione formale che lo rende a sua volta perfetto, cioè compiuto. Si scopreperò che ci sono due tipi di ejnevrgeia, l’uno chiamato da Giamblico generepuro dell’ejnevrgeia, che è separato dal movimento, e l’altro che è derivato dalprimo e non è privo di movimento. L’ejnevrgeia è per Giamblico, in ogni caso,una determinazione formale, che però ha due aspetti differenti : un tipo diejnevrgeia, quello derivato dal genere puro, è una forma immanente allamateria, si realizza nei processi ed è connotativa dell’agire e perfettiva delmovimento, in certo qual modo è affine all’agire ma va comunque distinta dalmovimento e dall’agire ; il genere puro dell’ejnevrgeia indica invece una formaimmobile ed esterna al movimento, risultando così anche sotto questo profilonozione totalmente diversa sia dal movimento che dall’agire, ai quali non èriconducibile. Infatti Giamblico precisa che, se si può tollerare il fatto che lanozione di attività venga abbassata, perché se esistono forme immanenti allamateria (ei[dh tina; h\n e[nula — 305.27), devono esistere anche attività immanentialla materia (aiJ e[nuloi ejnevrgeiai — 305.28), tuttavia non si possono tollerarecoloro che abbassano le attività al di sotto del movimento. Nessuno dei duetipi di ejnevrgeia elencati da Giamblico, quindi, è riconducibile al movimento :né il genere puro dell’ejnevrgeia in quanto è una forma sostanziale eterna eimmobile, né il tipo derivato da esso, perché, anche se corrisponde a unaforma immanente nella materia e quindi non è priva di movimento in quantogli enti materiali sono in movimento, non è, comunque, essa stessa inmovimento in quanto, per la sua natura di forma, è compiuta e perfetta.L’errore che secondo Giamblico commette Plotino è quello di non mantenereimmobile il principio del movimento e cioè di non comprendere, da un lato,che esiste un genere puro dell’ejnevrgeia che è nozione ben diversa sia dalmovimento che dall’agire, e, dall’altro lato, che anche il genere derivatodell’ejnevrgeia, seppure non esente da movimento, in quanto forma compiutaè nozione comunque diversa dal movimento e dall’agire.
Quest’ultimo ragionamento dà luogo a un’ulteriore questione, che è affron-tata da Giamblico, e quindi anche da Simplicio, a partire da un’opinione in cuisono collocati sullo stesso piano Plotino e gli Stoici, e cioè dall’opinionesecondo cui quando si parla di imperfezione del movimento non si intende direche esso non è ejnevrgeia, bensì che è qualcosa che ha la capacità di ricominciarepiù volte. Simplicio assume a questo proposito la posizione di Giamblico :imperfetta non è l’ejnevrgeia, poiché non si può dire che sia imperfetta la piùperfetta fra tutte le cose, bensì l’ejntelevceia. Ma anche dell’ejntelevceia ci sonodue tipi : l’entelechia imperfetta e l’entelechia perfetta. La prima, cioè quellaimperfetta, corrisponde alla nozione di movimento nel suo aspetto ontologico,perché entelechia imperfetta indica al contempo la forma e il suo realizzarsi,per cui entelechia è ad esempio il processo di fabbricazione di una statua.Questo tipo di entelechia, in quanto indica assieme alla forma anche la
95LE NOZIONI FISICHE DI KINESIS, ENERGHEIA E POIESIS
realizzazione in corso, rimane sempre allo stato di imperfezione ed è l’entelechiache Aristotele ha sempre tenuta distinta dall’ejnevrgeia, come sottolineaperspicuamente Giamblico. Del secondo tipo di entelechia, quella perfetta,Giamblico dice soltanto che corrisponde alla forma compiuta della statua,cioè, di fatto, alla forma di una sostanza composta. In questo senso, allora, misembra di capire che l’entelechia perfetta corrisponderebbe al secondo tipodell’ejnevrgeia (quello derivato dal genere puro dell’ejnevrgeia) di cui ha parlatoGiamblico e anche a ciò che è attivo o ‘in atto’, to; ejnergeiva/, a proposito delquale, in effetti, Giamblico aveva detto che è ad esempio la forma della statuae l’entelechia di ciascuna cosa (305.7-8). L’entelechia, del resto, in Aristotele,come ho detto prima, costituisce la realtà dell’essere che conserva un rapportodi contrarietà con il non essere dello stato potenziale, così come, in Giamblico,ciò che è attivo o ‘in atto’ ha con lo stato potenziale il medesimo rapporto cheha il perfetto — e ciò che è attivo o ‘in atto’ è tale perché assume la suaperfezione dall’ejnevrgeia — con il suo contrario, cioè l’imperfetto. Non è questo,invece, il rapporto che l’entelechia imperfetta ha con la potenza, perché nelcaso dell’entelechia imperfetta è la sussistenza della potenza ciò che dà imper-fezione all’entelechia e al movimento.
Sintetizzando tutte le argomentazioni fatte, quindi, Giamblico, e Simplicioche lo segue, ribadiscono la loro accusa contro Plotino che avrebbe commessotre ordini di errori : 1) non assume in quanto mobile l’operazione del movimen-to (oujc h| / kinhtovn, fhsivn, lambavnei~ to; e[rgon th'~ kinhvsew~ — 308.1-2), per il fattoche assimila il movimento all’ejnevrgeia, che è determinazione compiuta eperfezione e immobilità ; 2) non collega l’operazione svolta dal movimento allapotenza, perché l’ejnevrgeia non è uno stato di compresenza con la potenza, masta fissa solo nella compiutezza e perfezione della forma ; 3) non assumel’entelechia come appartenente al mobile (oujde; th;n ejntelevceian ou\n wJ~ kinhtou'lambavnei~ — 308.3), mentre il movimento è precisamente per Giamblicoentelechia imperfetta. Simplicio concorda con Giamblico : assimilare il movi-mento all’ejnevrgeia anziché all’entelechia significa considerare perfetto l’im-perfetto. In questo è consistito l’errore di Plotino. In definitiva, né l’ejnevrgeia èmovimento, né il movimento è genere comune dell’agire e del patire. Maneppure l’agire è ejnevrgeia, perché esso indica semmai l’attività ancora nel suosvolgimento (302.2-3), ovvero una forma che si sta realizzando, per cui èsemmai connotato onticamente dall’ejnevrgeia. L’agire e il patire sono, dunque,da considerarsi giustamente categorie, come Aristotele ha insegnato, anzicategorie fra loro separate e non legate da una relazione necessaria.
96 GIOVANNA R. GIARDINA
ABSTRACT
This paper will focus attention on Simplicius’ In Cat., 295.1-308.10. Taking cuesfrom Iamblichus, this passage refutes Plotinus’ interpretation of Aristotle and supportsthe latter, who had considered affecting and being affected as separate categories, andhad rejected motion (or even better ejnevrgeia) as their only unifying category. Simplicius’analysis starts from a logical issue, but develops different and important physicalnotions: affecting, poiei'n (together with those of agent, to; poiou'n, and action, poivhsi~),motion, kivnhsi~, activity or actuality, ejnevrgeia (these ones include what is active or inactuality, to; ejnergeiva/, as well as all that is performing an activity, tou' ejnergou'nto~, orcan perform one, ejnergei'n), and entelechy, ejntelevceia. As has been said, Simpliciusagrees with Iamblichus when he emphasizes that Aristotle has given the role of firstagent or immovable mover to form. Such a role not only distinguishes affecting frombeing affected (as the patient, and not just the agent, is always in motion), but itprevents motion from being seen as their only unifying category. ’Enevrgeia, in fact,cannot be mixed up with motion because it is a perfect and immovable formaldetermination. Moreover, it can be considered in two ways, i.e., as pure actuality,completely separated from motion, or as the actuality of compound substance, that isboth connotative of affecting and perfective of motion. Entelechy : according toSimplicius-Iamblichus, it has two different aspects too : imperfect entelechycorresponds to motion ; perfect entelechy is the form of compound substance, as wellas what is active or in actuality, to; ejnergeiva/, the latter, for Iamblichus, being theentelechy of each thing (305.7-8). Finally, other than ejnevrgeia, which exists per se(kaq’ eJauthvn), entelechy and what is active or in actuality, relates to duvnami~. Thishermeneutical system enables Simplicius-Iamblichus to refute Plotinus’ interpretationof those particular Aristotelian notions, as well as to prove the correctness ofAristotle’s theory as a whole.
GIOVANNA R. GIARDINA, Università di [email protected]






















































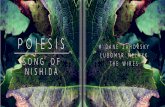
![O orgulho dos artistas do corpo: entre doenças do ideal, techne e poiesis [Tradução]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322269064690856e109073f/o-orgulho-dos-artistas-do-corpo-entre-doencas-do-ideal-techne-e-poiesis-traducao.jpg)
















