Le coordenate letterarie dei transmissori
Transcript of Le coordenate letterarie dei transmissori
JOSÉ M. CANDAU
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI. LA STORIOGRAFIA GRECA FRAMMENTARIA
NEGLI AUTORI DELL’EPOCA IMPERIALE** Studiare “l’età romana” della storiografia greca frammentaria,
significa fondamentalmente parlare di letteratura. La tradizione anti-ca, intesa come l’insieme dei testi che ci sono pervenuti dall’anti-chità classica, presenta differenze al suo interno. Innanzitutto, com-prende produzioni di tipo letterario o indirizzate ad un pubblico ge-neralmente colto: rientrano in questa categoria le opere di autori classificati come oratori, poeti, drammaturghi, storici o filosofi. Un altro insieme è quello costituito da scritti generalmente anonimi, come scolii, enciclopedie, lessici, ossia documenti che circolavano at-traverso canali propri e che non erano destinati ad un pubblico col-to, ma piuttosto a professionisti della letteratura o a personalità inse-rite nel mondo dell’erudizione. L’analisi di questo ambito “dotto” della tradizione trova nella filologia alessandrina e nell’umanesimo bizantino il suo punto di partenza ideale. Saranno quindi altri che entreranno, se lo ritengono opportuno, nel merito della valutazione delle informazioni che il ramo erudito della nostra tradizione offre in relazione agli storici greci perduti. Il mio compito si focalizza piut-tosto nell’esaminare le citazioni e le notizie offerte da autori attivi
* Traduzione all’italiano a cura di M. Beatrice Truffelli.
JOSÉ M. CANDAU 12
durante l’epoca della Roma imperiale e considerati generalmente come “fonti letterarie”.
Un compito che presenta diverse difficoltà. Nella Grecia classica la storiografia non era tanto una disciplina, quanto un genere lette-rario1. Sicuramente si tratta di un genere particolare, dal momento che l’accuratezza nella descrizione dei fatti e la necessità di fornire un racconto fedele alla realtà costituiscono la caratteristica che, in ac-cordo con la precettistica greca, distingue e identifica l’opera storica rispetto ad altri tipi di compilazioni2. Eppure, è ugualmente vero che le correnti artistiche successivamente dominanti nella storia della Grecia hanno lasciato una chiara impronta nella produzione degli storici. La complessità dell’espressione arcaica si riflette nelle Storie di Erodoto; l’opera di Tucidide, che è stata paragonata alle odi di Pin-daro o alla scultura del V secolo a.C., riflette i modelli estetici del-l’Atene classica; il barocco ellenistico si esprime fervidamente in de-terminati storici del IV e III secolo a.C. come Clitarco o Timeo3; in-fine, il classicismo predominante a partire da Augusto ha un impatto decisivo sulla storiografia greca dell’epoca imperiale. Alla luce di tut-
1 Riguardo alla stretta relazione tra poesia e storia si veda CIC., De or. 2, 62-64;
Orat. 37 e 207. Sulla storia come poesia si veda DION. HAL., Pomp., 3, 21. 2 L’enfasi sull’obiettività, nel carattere neutro e austero dell’esposizione
storica, può trarre in inganno. Si è detto che in Tucidide, un emblema per coloro che presentano la storiografia greca come un’attività dominata dall’imparzialità, l’obiettività non è un principio, quanto piuttosto un’attitudine d’autore, un pro-cedimento attraverso il quale l’autore stabilisce la sua relazione con i lettori piutto-sto che con la materia: si veda W.R. CONNOR, Thucydides, Princeton 1985, p. 6.
3 La presenza dei procedimenti letterari arcaici in Erodoto è stata messa in evidenza negli studi classici di H. FRÄNKEL (Wege und Formen frühgriechischen Den-kens, München 19552, pp. 62-85), e H.R. IMMERWAHR (Form and Thought in He-rodotus, Atlanta 1966, pp. 46-78). Rappresenta un classico anche il libro nel quale J. DE ROMILLY (Histoire et raison chez Thucydide, Paris 1966, pp. 89-106), compara i principi compositivi di Tucidide con quelli vigenti in Pindaro, la tragedia del V secolo e Platone. La penetrazione delle tendenze letterarie ellenistiche nella storio-grafia dell’epoca può essere esemplificata da Clitarco: si veda F. JACOBY, s.v. Kleitarchos 2, RE XI/1 (1921), coll. 645-650.
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 13
to questo, risulta altamente probabile che, quando si parla di fonti letterarie, i motivi stilistici, compositivi o artistici, in breve, le circo-stanze estetiche, il gusto predominante dell’epoca, intervengano condizionando la capacità della fonte in questione di trasmettere in maniera imparziale i testi storiografici perduti.
Nel periodo importante della trasmissione romana, il periodo imperiale, l’atticismo rappresenta la tendenza artistica dominante. È risaputo che l’atticismo portò con sé un rifiuto della letteratura e, in generale, dei modelli estetici vigenti nell’epoca immediatamente pre-cedente, quella ellenistica. Tale rifiuto è una caratteristica ricorrente nei diversi classicismi che si sono succeduti nella storia occidentale. E l’atticismo costituisce un chiaro esempio di movimento classicista4. La sua instaurazione a partire dal principato di Augusto5 è un dato fondamentale per il tema che qui trattiamo, lo studio dei trasmissori di frammenti storiografici attivi in epoca imperiale. Quindi, da ora in avanti, le opere storiche dell’epoca precedente saranno viste e giudicate secondo il loro grado di conformità o meno con il canone atticista. Di conseguenza, le notizie riguardanti le produzioni stori-
4 Il tomo 25 degli Entretiens sur l’antiquité classique (Vandoeuvres-Genève
1978), dal titolo Le classicisme a Rome aux I siècles avant et après J. C., sosteneva già la visione dell’atticismo e del classicismo augusteo in generale come movimento para-gonabile ad altri classicismi apparsi nella storia della letteratura europea; special-mente rilevanti a riguardo sono i contributi di T. GELZER (Klassizismus, Attizismus und Asianismus, pp. 1-55), H. FLASHAR (Die klasizistiche Theorie der mimesis, pp. 79-111) e F. LASSERRE (Prose grecque clasicisante, pp. 135-73).
5 L’atticismo si fa cominciare, com’è noto, prima di Augusto, e raggiunge il suo apice alla fine del I secolo o inizio del II d.C.: si veda A. DIHLE, Der Beginn des Atticismus, in «A&A» XXIII (1977), pp. 162 -177; ID., Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit, München 1989, pp. 62-74. È bene sottolineare che la pole-mica tra atticismo e asianismo (lo stesso vale per il contrasto tra arte ellenistica e classica) non si deve esagerare: si vedano le riflessioni al riguardo fatte da G. ANDERSON (The Second Sophistic. A Cultural Phenomenon in the Roman Empire, New York 1993, p. 89) e A. BARCHIESI (Learned Eyes: Poets, Viewers, Image Makers, in K. GALINSKY (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Augustus, Cambridge 2007, pp. 281-305, in part. pp. 300-301).
JOSÉ M. CANDAU 14
che andate perdute saranno presentate secondo il criterio dell’appro-vazione o del rifiuto, e saranno esposte sotto una o l’altra luce a se-conda del loro grado di adeguatezza ai principi difesi dalla precetti-stica, o della loro incompatibilità con gli stessi.
Apparentemente, l’atticismo è una tendenza stilistica. Per que-sto motivo, è stato definito «un movimento letterario (...) che sostie-ne l’uso del greco attico come lingua scritta dei Greci»6; i suoi difen-sori «autocostituitisi guardiani dell’antica lingua attica (...) concepi-rono l’audace idea di ristabilire l’attico classico in tutto il suo splen-dore»7. Ciò suppone il fatto di tornare alla lingua – apparentemente “semplice” e “pura” – usata dagli autori del V e IV secolo a.C., origi-nari o no di Atene, visto che il termine “attico” non si riferisce all’origine geografica. Questo ritorno al passato, che attesta il feno-meno della diglossia greca, pretende di instaurare, come veicolo della letteratura, una lingua differente da quella parlata all’epoca; al suo posto, l’autore dovrà ricorrere esclusivamente ai canali espressivi, os-sia, al lessico, alla sintassi, oltre che alle espressioni idiomatiche pre-senti nei testi considerati come modello e canone, giacché la consa-crazione di canoni artistici più o meno inamovibili rappresenta un’altra caratteristica che vede l’atticismo come uno dei tanti movi-menti classicisti8.
6 H. TONNET, Histoire du grec moderne. La formation d’une langue, Paris, 20032
p. 284. 7 E.A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C.
146 to A.D. 1100), Cambridge (Harvard) – London 1914, p. 6. 8 Si può considerare pietra fondante degli studi moderni sull’atticismo
l’opera di W. SCHMID, Der Attizismus in seinen Hauptvertretern, Stuttgart 1887-1896, i quali eccessi, comunque, devono essere corretti mediante la lettura della bibliografia più recente. Buone definizioni di atticismo come movimento letterario le offrono B.P. REARDON (Courants littéraires grecques des II et III siècles après J.C., Paris 1971, pp. 64-96), DIHLE (Die griechische, cit.) e ANDERSON, (The Second Sophis-tic cit., pp. 85-99). Sugli aspetti linguistici dell’atticismo occorre consultare le esposizioni di R. BROWNING (H ellhnikhv glwvssa mesaiwnikhv kai neva, trad. gr., Aqhvna 1988, pp. 71-79) e G. HORROCKS (Greek: A History of the Language and its Speakers, London 20102, pp. 133-141). Si veda anche J.N. KAZAKIS, Atticism, in
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 15
È evidente che un programma di questa natura, tanto per le sue conseguenze quanto per le sue implicazioni, non è esclusivamente stilistico, cioè non si limita alla parte formale9. La dimensione intel-lettuale dell’atticismo, la sua carica ideologica, si impose come mani-festo già nell’antichità. Un famoso testo di Dionigi di Alicarnasso mette in relazione il predominio del classicimo nella letteratura con l’instaurazione dell’ordine politico inaugurato dall’arrivo di Augusto. Studi recenti hanno dimostrato la validità dell’affermazione di Dio-nigi, rimarcando non tanto l’importanza dei cambiamenti che si ve-rificano nell’uno o nell’altro ambito, quanto il parallelismo alla base di questi cambiamenti10. In riferimento alla trasformazione – afferma
A.F. CHRISTIDIS (ed.), A History of Ancient Greek Language. From the Beginnings to Late Antiquity, trad. ingl., Cambridge 2007, pp. 1200-1217. Si deve tenere presente che una cosa è l’atticismo inteso come programma letterario inquadrato all’interno del classicismo augusteo e un’altra è l’ammirazione e l’incoronazione a modelli dei grandi maestri della letteratura ateniese anteriore all’epoca ellenistica; quest’ultima tendenza nasce già nel IV secolo a.C. e perdura per tutto il periodo ellenistico: si veda DIHLE, Der Beginn cit.
9 i\ndice di questo anche la presenza persistente dell’atticismo nella letteratura greca medievale e moderna. Sulla sopravvivenza dell’atticismo durante l’epoca bizantina si veda la sintesi che offre R. BROWNING, s.v. Atticism, in The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford 1991, 1, coll. 229-230. Esposizioni succinte e chiare di quella che potrebbe essere definita “questione della lingua nazionale greca” dall’epoca bizantina le offrono P. MACKRIDGE (The Modern Greek Language. A Descriptive Analysis of Standard Modern Greek, Oxford 1985, pp. 6-11) e A. LIAKOS («From Greek into our common language»: Language and history in the making of Modern Greece, in CHRISTIDIS (ed.), A History cit., pp. 1287-1295. È curioso che ancora nel 1988 D. SWTHROPOLOS, nel prologo alla traduzione del citato lavoro di Browning, possa parlare di «h attikhv diavlekto~» come di una soluzione proposta nell’attualità, sebbene non condivisa da egli stesso, al problema della lingua nazio-nale greca: Eisagwghv tou metafravstou, in BROWNING, H ellhnikhv cit., p. 12).
10 DION. HAL., Vett. Cens. 3. Insieme ad altri, hanno commentato il testo in data relativamente recente P. ZANKER, The Power of Images in the Age of Augustus, trad. ingl., Ann Arbor 1988, p. 239; E. GABBA, Dionysius and The History of Archaic Rome, Berkeley 1991, pp. 23-59; K. GALINSKY, Augustan Culture, Princeton 1996, pp. 332-363; T. HIDBER, Das klassizistische Manifest des Dionys von Halikarnass, Stuttgart - Leipzig 1996, pp. 42-43; A. WALLACE-HADRILL, Mutatio morum: The idea
JOSÉ M. CANDAU 16
A. Wallace-Hadrill – prodotta dall’instaurazione del regno di Augu-sto, la questione più importante riguarda come la rivoluzione politi-ca si riflette sulla società e sulla cultura11.
In un passaggio dei Moralia, Plutarco specifica qual’è il pubblico della sua opera. Egli stesso parla di a[ndre~ filovlogoi kai; politikoiv, espressione che si potrebbe tradurre come “uomini amanti della lette-ratura e interessati alle questioni inerenti al potere”; inoltre, Plutarco contrappone questo pubblico ideale alla massa (oiJ polloiv)12. Altri scritti di autori greci dell’epoca imperiale sottolineano la stessa idea. Dionigi di Alicarnasso indirizza le sue Antichità romane a coloro che praticano l’oratoria o si occupano della filosofia, ma anche a coloro in grado di dimostrare il possesso di un’istruzione selettiva (ajo-clhvtou diagwgh'~) in materia storica. Strabone si aspetta che la sua opera venga letta da uomini liberi, amanti della sapienza e in posses-so dell’educazione superiore a loro comune; lo stesso passaggio allu-de ai personaggi insigni (ejn tai'~ uJperocai'~), mediante la stessa e-spressione a sua volta utilizzata da Nicola di Damasco13. Queste cita-zioni ci parlano di una minoranza situata all’apice della società greco-romana, alla quale gli autori menzionati indirizzano le loro opere. È legittimo pensare che queste siano le minoranze che, con l’arrivo di Augusto, ascesero al potere politico ed economico nel mondo medi-terraneo. Allo stesso modo, è legittimo ammettere che la loro ascesa politica ed economica venne accompagnata da una generale accetta-zione di valori comuni, e che l’adesione a questo sistema di credenze servisse come elemento di coesione delle élites contro qualunque o- of a cultural revolution, in T. HABINEK - A. SCHIESARO, (eds.), The Roman Cultural Revolution, Cambridge 1997, pp. 3-22, in part., pp. 10-11; G. WOOLF, Provincial Perspectives, in GALINSKY, The Cambridge Companion, cit., pp. 106-129, in part., pp. 117-118.
11 A. WALLACE-HADRILL, Mutatas Formas: the Augustan Transformation of Ro-man Knowledge, in GALINSKY (ed.), The Cambridge Companion, cit., pp. 55-84, p. 55.
12 PLUT., Tuend. san.. 137a. 13 DION. HAL., Ant. Rom. I 8, 3; STRAB. I 1, 22-23; NIC. DAM., FGrHist 90 F
135 (= Excerpta de virtutibus et vitiis, 327, p. 3 Büttner Wobst - Roos). Questi tre testi sono citati e commentati da GABBA, Dionysius cit., pp. 49-52.
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 17
stacolo di tipo geografico o di qualsiasi altra natura. Quanto detto induce a considerare il classicismo augusteo e l’atticismo come un veicolo espressivo, come un codice di comunicazione nato dal susse-guirsi delle nuove circostanze.
Un codice che serve a manifestare non solo concordanze ma an-che differenze o, per così dire, questioni da negoziare. Una delle prime questioni da trattare è il grado di accettazione del codice stes-so e i limiti che si devono stabilire alle sue regole. A volte, l’atticismo si è praticato e si è promosso attraverso una grande rigidità, in una maniera talmente coercitiva e dogmatica da incorrere nel ridicolo e da risultare difficilmente ammissibile. Non mancavano, già nell’anti-chità, autori che criticavano, satireggiavano o semplicemente ignora-vano questa forma di puritanesimo letterario. Testi significativi a questo proposito si trovano con facilità nel Lexiphanes o nel Rhetorum praeceptor di Luciano, così come nelle opere di Galeno14. Nonostante ciò, in tali critiche o negazioni non c’è un rifiuto radicale né un ten-tativo di demolire i postulati della tendenza dominante. Un caso e-semplare è quello di Plutarco. La lingua di Plutarco mostra una forte impronta attica, però presenta anche delle caratteristiche proprie della koinh; non attica15; la sua condanna nei confronti dell’atticismo radicale si riflette non solo nella pratica, negli elementi visibili della sua scrittura, ma anche in esplicite dichiarazioni16. Tuttavia, sono va-ri i legami che collegano Plutarco con autori compresi nell’atticismo. Il suo pubblico, composto, come già si è menzionato, dalle classi e-gemoniche dell’impero, è identico a quello degli scrittori considerati atticisti; in conformità con quanto affermato, i suoi testi utilizzano la stessa lingua franca per quanto riguarda le valutazioni estetiche e mo-
14 Si veda BROWNING, H ellhnikhv, cit., pp. 73-75; ANDERSON, The Second So-
phistic, cit., pp. 86-93; KAZAKIS, Atticisim, cit., pp. 16-17. Un esempio breve ma espressivo della rigidezza della precettistica atticista si può leggere in TONNET, Histoire, cit., pp. 46-47.
15 Cfr. K. ZIEGLER, Plutarco, trad. it., Brescia 1965, pp. 352-353 [= ID., s.v. Plutarchos von Chaironeia”, RE XXI/1 (1951), coll. 636-962).
16 Si veda, ad. es.: Mor. 42b; 45f; 79d.
JOSÉ M. CANDAU 18
rali; infatti, il discorso di Plutarco, così come quello dei suddetti scrittori, si appoggia sui principi e sulle norme in vigore nell’élite gre-co-romana17. Inoltre, il suo atteggiamento nei confronti del periodo precedente, l’epoca ellenistica, è di condanna, una condanna che comprende tanto la sfera della storia politica come le manifestazioni artistiche o letterarie18. Il rifiuto verso tutto ciò che rappresenta il mondo ellenistico – una caratteristica essenziale del movimento clas-sicista – rinforza l’inclusione di Plutarco nelle coordinate basilari dell’atticismo.
La critica nei confronti dell’atticismo, o meglio, nei confronti degli eccessi di determinati rappresentanti dell’atticismo, avviene dall’interno. Non significa né negazione né auto-esclusione né soste-gno a tendenze alternative. Difatti, non poteva essere altrimenti. Dal I al IV secolo dell’era cristiana, nessuno scrittore greco erudito sfug-ge all’atticismo19. L’universalità, l’accettazione unanime dell’atticismo, si può mettere in relazione con le circostanze sociali e culturali che favorirono la sua creazione. Il regime fondato da Augusto si presen-tava come la soluzione ai problemi di divisione e frazionamento in-terno che aveva subito la classe dirigente. Nella repubblica, ha osser-vato A. Wallace-Hadrill, la minoranza che monopolizzava il potere usava la sua forza per impedire il passaggio agli estranei e per proteg-gere i suoi interessi; anche durante il principato governa un’oligar-
17 Riguardo all’argomento si può consultare P.A. STADTER, Plutarchs’s Lives:
The Statesman as a Moral Actor, in C. SCHRADER - V. RAMÓN - J. VELA (eds.), Plutarco y la historia. Actas del V Simposio español sobre Plutarco (Zaragoza 20-22 de junio de 1996), Zaragoza 1997, pp. 65-81; ID., The Rhetoric of Virtue in Plutarch’s Lives, in L. VAN DER STOCKT (ed.), Rhetorical Theory and Praxis in Plutarch. Acta of the IVth International Congress of the International Plutarch Society, Louvain - Namour 2000, pp. 493-510; ID., Mirroring Virtue in Plutarch’s Lives, in «Ploutarchos» n.s. I (2003/2004), pp. 89-96; si veda anche M.D. SMITH, Enkrateia: Plutarch on Self-Control and the Politics of Excess, ibid., pp. 77-87.
18 Si veda P. DESIDERI, Impero di Alessandro e impero di Roma secondo Plutarco, in A. CASANOVA (ed.), Plutarco e l’Etá Ellenistica. Atti del convegno internazionale di studi (Firenze, 23-24 Settembre 2004), Firenze 2005, pp. 3-19.
19 KAZAKIS, Atticism, cit., p. 1204.
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 19
chia, ma il potere si elargisce dal centro e l’imperatore, suo massimo dispensatore, cerca di evitare emarginazioni ostili20. Così facendo, ossia distribuendo il potere tra varie élites disseminate in tutte le aree dell’impero, Augusto non fa altro che favorire un processo già in at-to. In questo modo, il cambiamento conseguente all’instaurazione del principato sarebbe un altro aspetto della trasformazione che ri-guarda contemporaneamente tutto il Mediterraneo. In quell’epoca, afferma G. Woolf, i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Inoltre, la crescita economica delle classi superiori favori-sce la nascita di un sistema comune di valori21. Nella letteratura im-periale si nota un tentativo di superare, o perlomeno armonizzare, le differenze tra le culture greca e romana. Oltre a ciò, si rileva la pro-pensione a conciliare l’identità locale – il patriottismo locale – con altre identità, specialmente il patriottismo romano22. Si sarebbe ten-tati di vedere in tutto ciò la somma degli sforzi impiegati tanto dall’élite centrale quanto dalle élite locali dell’impero. La promozio-ne di una lingua letteraria – la lingua “attica” –, l’istituzione di ca-noni per i differenti ambiti artistici, si possono considerare come programmi destinati a propagare un codice di comunicazione e una
20 WALLACE-HADRILL, Mutatas Formas, cit., p. 57. 21 WOOLF, Provincial Perspectives, cit., pp. 110-117. 22 Così avviene in Plutarco; già nel 1972 C.P. JONES scrisse (Plutarch and
Rome, Oxford 1972, p. 124): «When Plutarch surveys Roman culture, including those aspects of it which he dislikes, he does so less from a Greek than from a Greco-Roman point of view». Per Ateneo, si veda D. BRAUND, Learning, Luxury and Empire. Athenaeus’ Roman Patron, in D. BRAUND - J. WILKINS (eds.), Athenaeus and his World. Reading Greek Culture in the Roman Empire, Exeter 2000, pp. 3-22, in part., pp. 19-20. La compatibilità tra diverse identità culturali è stata trattata re-centemente da S. STEPHENS, Cultural identity, in T. WHITMARSH (ed.), The Cam-bridge Companion to the Greek and Roman Novel, Cambridge 2008, pp. 56-71. Sul patriottismo romano come creazione di Augusto, la sua dimensione universale e il suo riflesso sulla letteratura e sulle arti, si veda W. EDER, Augustus and the Power of Tradition, in GALINSKY (ed.), The Cambridge Companion, cit., pp. 13-32, in part., pp. 27-30; N. PURCELL, Romans in the Roman World, ibid., pp. 85-105; D.E.E. KLEINER, Semblance and Storytelling in Augustan Rome, ibid., pp. 197-233, in part., pp. 225-232.
JOSÉ M. CANDAU 20
trama di principi che unisca i gruppi dirigenti minoritari e preservi il loro monopolio del potere. Ad ogni modo, il carattere universale proprio dell’atticismo e la sua definizione come codice di comunica-zione facilitano la comprensione di alcune caratteristiche tipiche dei testi greci di epoca imperiale. Una di queste caratteristiche è l’uso di un discorso qualificabile come obliquo. In questo tipo di testo le al-lusioni, le chiavi comunicative e l’ironia sostituiscono frequente-mente l’enunciato diretto. Un passaggio di Plutarco può essere e-semplificativo.
I due capitoli iniziali della Vita di Romolo rivelano l’esistenza di una gran quantità di storie e versioni riguardanti le origini di Roma. Abbondano le espressioni indeterminate («secondo alcuni», «altri di-cono», «altri in cambio», «altri alla fine»), che immergono il lettore in un clima di confusione e incertezza23. Il terzo capitolo inizia con un testo per il quale si presentano due alternative di traduzione:
a) «Tuttavia, il racconto con più credibilità (pivstin) e con mag-
gior numero di testimoni (mavrtura~) è quello le cui parti essenziali furono pubblicate per la prima volta da Diocle di Pepareto in Grecia (ejxevdwke eij~ tou;~ ÓEllhna~), dal quale prese spunto, in linea genera-le, persino Fabio Pittore. Esistono anche varianti riguardo ai dettagli però in sintesi è così».
b) «Tuttavia, il racconto con più credibilità e con maggior nu-
mero di testimoni è quello le cui parti essenziali furono pubblicate per la prima volta da Diocle di Pepareto in Grecia e che, in linea ge-nerale, accettò persino Fabio Pittore. Esistono anche varianti riguar-do ai dettagli però in sintesi è così»24.
23 L’inizio della biografia è un priamel. Su questo e altri aspetti del testo che abbiamo commentato, si veda J.M. CANDAU, Ironía en Plutarco. el prólogo a las Vidas de Teseo y Rómulo y Diocles Peparecio, in A. PÉREZ JIMÉNEZ - F. TITCHENER (eds.), Historical and Biographical Values of Plutarch’s Work. Studies Devoted to Professor Philip A. Stadter by The International Plutarch Society, Málaga–Utah 2005, pp. 107-119.
24 PLUT., Rom. 3, 1. Nella versione a) l’antecedente del relativo w/| sarebbe Dioklh̀~ Peparhvqio~; nella b) l’antecedente sarebbe il lovgou che appare all’inizio.
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 21
Segue l’esposizione della celebre leggenda sulla nascita, l’infanzia
e la prima giovinezza di Romolo. Questa esposizione termina alla fi-ne del capitolo 8. Arrivato a questo punto, Plutarco chiude la cita-zione cominciata nel capitolo 3 con un nuovo riferimento a Fabio e Diocle:
«Di questi avvenimenti, la maggior parte è esposta tanto da Fabio quanto da Diocle di Pepareto, che apparentemente fu il primo a pubblicare (dwkei' prw'ton ejkdou'nai) una Fondazione di Roma; e se ad alcuni sembra sospetta la sua drammatica ar-tificiosità (to; dramatiko;n kai; plasmatw'de~), si deve abbando-nare lo scetticismo (ouj dei' dVajpistei'n) quando si vede di quali opere (oi{wn poihmavtwn) è autrice la fortuna, e quando si consi-dera la storia di Roma, nella convinzione che non avrebbe rag-giunto tale livello di magnificenza se la sua nascita non fosse stata di indole divina, ma sprovvista di grandiosità e caratteri-stiche straordinarie (mhde;n mevga mhde; paravdoxon e[cousan)»25.
Il testo di Romolo 3,1 è stato interpretato e analizzato da un
numero considerevole di studiosi del XIX e degli inizi del XX seco-lo26. Una delle interpretazioni – quella di Hermann Peter- parte dalla traduzione b e dall’incertezza – riflessa nel dwkei' – che particolarizza la dichiarazione del secondo testo, a dire del quale Diocle fu il primo a pubblicare una Fondazione di Roma. A giudizio di Peter, dalle af-fermazioni di Plutarco non si deduce che fosse Fabio a prendere da Diocle la leggenda sulla nascita di Romolo e Remo (in realtà quello che dice il testo è che Fabio prende spunto dalla stessa versione che appare in Diocle); non si deduce nemmeno che Diocle fosse anterio-
25 PLUT., Rom. 8, 9. 26 Si vedano i riferimenti che forniscono K. VON HOLZINGER (Diokles von
Peparethos als Quelle des Fabius Pictor, in «WS» XXXIV [1912], pp. 175-202) e A. MOMIGLIANO (Emanuele Ciaceri, Le origini di Roma: la monarchia e la prima fase dell’età repubblicana (dal sec. VIII alla metà del sec. V a.C.), in «JRS» XXXIII [1943], pp. 100-103).
JOSÉ M. CANDAU 22
re a Fabio27. L’ipotesi di Peter è una delle tante comprese nel grande gruppo di contributi sui passaggi già citati di Plutarco. La polemica comincia con Niehbur e in essa sono intervenuti alcuni grandi nomi della filologia e degli studi classici: Schlegel, Schwegler, Dahlmann, Christ, Mommsen, Schwartz, Susemihl. I dibattiti sull’anteriorità di Diocle rispetto a Fabio o viceversa, sulla relazione fra i due e sul-l’origine della notizia di Plutarco portarono a diverse soluzioni. Tut-te si basarono su supposizioni usuali all’epoca, per le quali rivestiva-no speciale importanza gli approcci propri della ricerca delle fonti, la Quellenforschung. Si suppose che tanto Fabio quanto Plutarco dipen-dessero da Diocle, però, mentre la dipendenza di Fabio sarebbe stata diretta, Plutarco avrebbe conosciuto Diocle grazie a un erudito dell’epoca imperiale (Schwartz)28; si suppose inoltre che il racconto di Fabio derivasse, oltre che da Diocle, anche dall’opera teatrale di Nevio Alimonia Remi et Romuli, e che quindi entrambi, Diocle e Ne-vio, avessero come fonte la tragedia perduta di Sofocle, Tiro (Sol-tau)29; infine, si ipotizzò che Plutarco conoscesse i racconti di Fabio e Diocle, però attraverso le excerpta di un erudito dell’epoca augustea (von Holzinger)30.
Gli studiosi che si muovevano entro i principi della Quellenfor-schung individuavano frequentemente i problemi, sebbene li risolves-sero in maniera erronea. Questo avviene con i passaggi sopra citati di Plutarco. La difficoltà di base risiede nell’oscurità stessa della figura di Diocle di Pepareto. Ci sono pervenute solo due notizie relative al suo nome. Una è quella contenuta nel testo di Plutarco riportato an-teriormente. L’altra è una citazione breve e indiretta proveniente da Ateneo e che consiste nella menzione fugace di un giudizio che, se-condo l’autore, formulò Demetrio di Scepsi a proposito dello stile di
27 H. PETER, HRR, I (1914), pp. LXXXI-LXXXIII. 28 E. SCHWARTZ, s.v. Diokles von Peparethos, RE X (1903), col. 798. 29 W. SOLTAU, Die Entstehung der Romuluslegende, in «Archiv für Religionswis-
senschaft» XII (1909), pp. 101-125, in part., pp. 105-111. 30 VON HOLZINGER, Diokles, cit., pp.177-182.
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 23
Diocle31. Dionigi di Alicarnasso, nel capitolo delle sue Antichità ro-mane relativo agli scrittori greci che trattano della fondazione di Ro-ma (I 72), non include Diocle. D’altra parte, per i primi storici ro-mani – i primi analisti – le origini di Roma costituiscono una que-stione la cui trattazione è praticamente obbligatoria; la sua opera, di conseguenza, raccoglieva il materiale mitico relativo agli inizi della città32. Inoltre, Fabio Pittore veniva considerato il fondatore, l’inven-tor, della tradizione storiografica romana33, e pertanto il suo nome si accorda perfettamente con un testo che racconta la leggenda di Ro-molo e Remo. Invece, con Diocle di Pepareto avviene il contrario. Risulta stravagante, se non irrisorio, che il praticamente ignorato Diocle di Pepareto figuri accanto al rinomato e famoso Fabio Pitto-re, per di più a proposito di un argomento tanto diffuso e tanto si-gnificativo dal punto di vista ideologico come la leggenda della fon-dazione di Roma.
Nel primo dei passaggi citati, Plutarco giustifica la sua scelta del-la versione presente in Diocle e Fabio spiegando che è questo «il rac-conto con più credibilità (pivstin) e con maggior numero di testimo-ni (mavrtura~)». Nella teoria retorica, pivsti~ (latino argumentatio, pro-batio o confirmatio) designa quella parte del discorso che stabilisce la
31 ATH. II 22. 32 Cfr. D. TIMPE, Fabius Pictor und die Anfänge der römischen Historiographie, in
ANRW I 2 (1972), pp. 928-969; W. KIERDORF, Catos Origines und die Anfänge der römischen Geschichtsschreibung, in «Chiron» X (1980), pp. 205-224. Un testo base sullo spazio storico e la distribuzione compositiva del materiale nei primi storici latini lo fornisce DIONISIO DI ALICARNASSO (Ant. Rom. I 6, 2-3), sulla cui interpretazione si vedano, oltre ai già menzionati studi di TIMPE (pp. 932-933) e KIERDORF (p. 219), le osservazioni di M. CHASSIGNET (L’Annalistique romaine. Tome I. Les annales des pontifes et l’annalistique ancienne [fragments], Paris 1996, pp. LXII-LXIV) e H. BECK - U. WALTER, (Die frühen römischen Historiker. Band I. Von Fabius Pictor bis Cn. Gellius, Darmstadt 2001, p. 61).
33 Cfr. LIV. II 40, 10 (=FGrHist 809 F 14): Fabium longe antiquissimum auc-torem; ID. I 44, 1 (= FGrHist 809 F 9): scriptorum antiquissimus Fabius Pictor; DION. HAL., Ant. Rom. VI 71, 1 (=FGrHist 809 F 13b): «palaiovtato~ ga;r ajnh;r tw’n ta; ïRwmaika; suntaxamevnwn».
JOSÉ M. CANDAU 24
credibilità del punto di vista sostenuto34. Componente fondamentale del discorso, la pivsti~ consta di una o varie prove. Le prove possono essere artistiche (e[vtecnoi) o non artistiche (a[tecnoi). Queste ultime non sono prodotte dall’abilità del retore, ma esistono al di fuori del discorso e fra loro hanno speciale importanza le deposizioni dei te-stimoni, deposizioni che si designano con il nome di mavrture~35. Quindi, Plutarco giustifica la sua scelta mediante termini inizialmen-te inapplicabili ad una leggenda. Così ritiene la precettistica storio-grafica antica, che esige un abbandono della pivsti~ quando la mate-ria narrata possiede un carattere mitico. «Detto questo, se improvvi-samente sorge un mito», – scrive Luciano nell’unico trattato di teoria storiografica che si è conservato – «bisogna narrarlo, senza però con-cedergli una totale credibilità (ouj mh;n pistwtevo~ pavntw~) e sottopo-nendolo invece a giudizio del pubblico affinchè pensi su di esso ciò che vuole»36. L’affermazione di Luciano costituisce una tesi storiogra-fica accettata e sostenuta da diversi storici37. Tuttavia, non è necessa-rio ricorrere a fonti esterne. Anche Plutarco dimostra il suo accordo con la stessa tesi e lo fa nel prologo stesso alle vite di Teseo e Romo-lo. Nel commentare le difficoltà che nascono dalla composizione di entrambe le vite, a causa della loro distanza cronologica, il biografo dichiara:
«Allo stesso modo, anche io, quando nella redazione delle Vi-te Parallele raggiunsi i limiti temporali del racconto verosimile e accettabile per i canoni di una storia che si deve attenere ai
34 ARIST., Rh. III 13, 1414a 35 – 1414b 18; CIC., Inv. 1, 34; QUINT. V
prohem., 5: cfr. H. LAUSBERG, Manual de retórica literaria, trad. spagn., I, Madrid 1975, pp. 2997-2998 (§ 348).
35 ARIST., Rh. I 2, 1355b 35-37; QUINT. V 1, 1; V 7, 1-5: cfr. H. LAUSBERG, Manual, cit., pp. 298-299 (§§ 349-351).
36 LUCIAN., Hist. conscr. 60. 37 Il tema ricorrente appare in una serie di autori che vanno da Erodoto (II
123) e Tucidide (VI 2, 1) fino a Cassio Dione (LIV 35, 4): si veda G. AVENARIUS, Lukians Schrift zur Geschichtsschreibung, Meisenheim/Glan 1956, pp. 163-164.
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 25
fatti, potevo dire: “al di là, fatti prodigiosi e materia per tragi-ci: là abitano poeti e mitografi, e non c’è più né credibilità (pivstin), né certezza”»38.
Plutarco dimostra la credibilità dell’avvenimento che narra, la
leggenda di Romolo e Remo, con argomenti che trasgrediscono le regole e le opinioni della precettistica storiografica; inoltre, lo fa uti-lizzando una terminologia che si riferisce chiaramente ai principi tra-sgrediti. Pertanto, si tratta di argomentazioni che invitano a essere smentite. La stessa cosa succede nel secondo passaggio, quello inclu-so nel capitolo 8, e che contiene la seconda menzione di Fabio e Diocle. Plutarco parla, in questa sede, degli elementi drammatici e artificiosi (to; dramatiko;n kai; plasmatw'de~) presenti nel racconto di Fabio e Diocle, elementi ammissibili se si considera quali sono le opere dovute alla fortuna (th;n tuvchn oJrw'nta~ oi{wn poihmavtwn dhmiourgov~ ejsti). Il termine poivhma rimanda, come dramatiko;~ e plasmatw'de~, al mondo della creazione poetica. Più concretamente, i tre termini alludono ad una nuova convenzione storiografica, quel-la del parallelismo tra storia e poesia. La posizione maggioritaria a tal proposito, la formula, ancora una volta, Luciano nel paragrafo se-guente del suo de historia conscribenda:
«Tali autori sembrano inoltre ignorare che la poesia e la com-posizione poetica (poihtikh'~ me;n kai; poihmavtwn) hanno prin-cipi e regole proprie, differenti da quelle della storia (…) grave errore -anzi, molto grave- sarebbe questo, ossia il non saper di-stinguere ciò che appartiene alla poesia da ciò che invece ap-partiene alla storia e introdurre nella storia gli ornamenti del-la poesia – il mito (mu'qon), l’encomio e le esagerazioni che en-trambi comportano»39.
Luciano presenta in questo testo un luogo comune della precet-
tistica storiografica che risale a Tucidide e che viene ripreso da Poli-
38 PLUT., Thes. 1, 4 39 LUCIAN., Hist. conscr. 8.
JOSÉ M. CANDAU 26
bio, Diodoro, Cicerone ed altri autori40. La poesia si contrappone al-la storia come la realtà alla finzione, come il contrasto tra la libera invenzione che aspira al diletto, obiettivo della poesia, e la necessità di attenersi ai fatti e di ambire alla verità, che è il fine della storia. La stessa idea compare anche in Plutarco. Il passaggio che con maggior chiarezza espone il tema centrale, con un riferimento esplicito alla storia, si trova nel de gloria Atheniensium; tuttavia, è possibile citare al-tri passaggi dell’opera di Plutarco che utilizzano le stesse idee: il mito e la finzione come ingredienti comuni della poesia, l’inganno e l’assenza di verità come elementi propri del mito41.
La seconda menzione di Fabio e Diocle ripete pertanto il proce-dimento utilizzato nel paragrafo che contiene la prima citazione. An-cora una volta Plutarco infrange le regole abituali della precettistica e i principi che egli stesso suppone; e ancora una volta, la presenza di termini chiave sono indice della trasgressione che sta compiendo, di modo che il lettore è chiamato a contraddire, a confutare gli argo-menti addotti nel testo. Si potrebbe affermare che entrambi i passag-gi funzionano come un virgolettato ironico. Plutarco, attraverso que-sti passaggi, intende mostrare la sua riserva nei confronti della mate-ria trattata.
Una riserva interpretabile da diverse angolazioni. La leggenda di Romolo e Remo, venerabile e carica di significato ideologico, circo-lava meglio in ambienti puramente romani piuttosto che tra un pub-blico greco42. Le circostanze fantastiche relative all’origine e all’ascesa al trono di Romolo, primo re di Roma, evocavano le contraddizioni che, da Augusto, si radunavano intorno alla figura del princeps, al-l’imperatore romano. L’imperatore era simultaneamente monarca oggetto di culto e restauratore di antiche tradizioni repubblicane, di-fensore dei diritti e delle patrie libertà e al tempo stesso distruttore
40 POLYB. II 56, 11-12; DIOD. I 2, 7; CIC., Leg. 1, 5. Il tema ricorrente trova la sua origine nella famosa affermazione di THUC. I 22, 4). Discussione riguardo all’argomento e apporto di più testi in G. AVENARIUS, Lukians, cit., pp. 16-22.
41 PLUT., Glor. Ath. 348c; Aud. poet. 16a, 25d; Mul. virt. 247f. 42 Cfr. A. ERSKINE, Troy between Greece and Rome. Local Tradition and Imperial
Power, Oxford 2001, pp. 37-43.
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 27
degli stessi43. Per Plutarco, infine, risultava complicato ammettere senza obiezione un racconto mitico all’interno di una delle sue bio-grafie, teoricamente basate su dati e personaggi reali. Ancora più complesso era il problema legato alla figura stessa di Fabio Pittore. L’immagine di Fabio Pittore, membro di un’illustrissima famiglia, padre della storiografia romana, senatore e primo rappresentante della storiografia senatoriale, esigeva rispetto e considerazione. A Fa-bio, inoltre, si attribuiva la versione più diffusa della leggenda di Romolo e Remo. Tuttavia, i principi compositivi ed estetici che gui-davano la sua opera lo allontanavano non solo da Plutarco, ma an-che dai gusti e dai modelli propri del classicismo imperiale. Fabio, com’è noto, scrisse in greco, analogamente ai suoi contemporanei Cincio Alimento, Gaio Acilio e Postumio Albino. Si avvalse, inoltre, del sistema di datazione basato sulle Olimpiadi, utilizzò unità di mi-sura greche e scrisse sotto la pressione letteraria di modelli greci. Or-bene, i modelli che gli funsero da ispirazione non furono né Tucidi-de né Erodoto, ma gli storici ellenistici che godevano di prestigio all’epoca dello stesso Fabio, alla fine del III secolo44. I frammenti in-dicano che la sua opera non doveva essere molto differente da quella storiografia incline agli effetti drammatici e all’inclusione dei miti tanto in voga durante l’epoca ellenistica. Fabio si iscrive così in co-ordinate letterarie, quelle dell’estetica ellenistica, rifiutate dalla pre-cettistica classicista e dallo stesso Plutarco.
Occupandosi della nascita mitica di Romolo, ossia delle circo-stanze leggendarie che portano alla fondazione di Roma, Plutarco af-frontava un tema pieno di tensioni. Considerazione e rifiuto, rispet-to e negazione della credibilità, contraddizioni difficilmente conci-
43 Riguardo alle tensioni, alla polisemia e all’ambiguità date da questo tema, si veda BARCHIESI, Learned Eyes, cit., pp. 292-293.
44 Si veda, ad es., CHASSIGNET, L’Annalistique romaine, cit., pp. XLII-LIV; BECK - WALTER, Die frühen, cit., pp. 23-25, 41. Sulla teoria, attualmente consider-ata errata, secondo la quale la storiografia romana discenderebbe direttamente dalle tabulae dealbatae redatte dai pontefici, si veda G.P. VERBRUGGHE, On the meaning of Annales, on the Meaning of Annalist, in «Philologus» CXXXIII (1989), pp. 192-230; CHASSIGNET, ibid., pp. VII-VIII; BECK - WALTER, ibid., pp. 19-21.
JOSÉ M. CANDAU 28
liabili, questioni politicamente delicate per le quali si esigeva una certa ambiguità: Plutarco reagisce a tutto ciò attraverso due passaggi che, in forma ironica, indicano il suo distacco e i suoi scrupoli ri-spetto a ciò che egli stesso sta narrando. Da una parte, utilizza come impronta la duplice citazione del celebre Fabio Pittore e dell’igno-rato Diocle di Pepareto; dall’altra, l’introduzione di termini ed e-spressioni che inducono a confutare i suoi propri argomenti. Il di-scorso di Plutarco utilizza così indicazioni trasversali, indirette, per esprimere se non il rifiuto, almeno la critica e la necessità di mante-nere cautela davanti ad un determinato testo storiografico.
Ci si potrebbe chiedere se questo modus operandi sia usuale. I passaggi commentati della Vita di Romolo contengono un ampio frammento riferito a Fabio e a Diocle. Se si accetta l’ipotesi postula-ta, questi passaggi conterrebbero un’informazione imprescindibile per una corretta interpretazione del frammento. Tuttavia, la suddet-ta informazione, piuttosto che diretta, sarebbe tacita, dal momento che utilizza chiavi e allusioni a conoscenze previe. Si tratta, pertanto, di indicazioni che devono essere estrapolate, interpretate e che pre-suppongono un codice di comunicazione. Risulta pertinente chie-dersi se questa è una condizione ricorrente, ovvero se i frammenti storiografici presenti nelle fonti letterarie dell’epoca imperiale ri-chiedano normalmente questo tipo di interpretazione. Plutarco, com’è noto, nasconde sotto la sua apparente facilità una scrittura particolarmente complessa45. Inoltre, è molto probabile che la leg-genda di Romolo costituisse un assunto particolarmente delicato. Detto ciò, è bene aggiungere che l’allusione, i significati nascosti, il linguaggio illusorio, la dissimulazione ironica, sono stati considerati
45 Come già anni fa mise in evidenza D.A. RUSSELL, On Reading Plutarch’s
Lives, in «G&R» XIII (1966), pp. 139-154. La bibliografia recente su Plutarco ha trattato questo tema in numerosi studi. Si veda, ad. es., H.G. INGEKAMP, Plutarch und die konservative Verhaltensnorm, in ANRW II/33.6 (1992), pp. 4624-4644 (sulla complessità della scala morale impiegata nelle Vite Parallele); C.B.R. PELLING, Synk-risis Revisited, in PÉREZ JIMÉNEZ - TITCHENER (eds.), Historical, cit., pp. 325-340 (sulla complessità dei riferimenti storici e letterari usati da Plutarco).
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 29
strumenti tipici degli scrittori greci del periodo romano46. Si è osserva-to inoltre che i suddetti scrittori concepiscono la letteratura come “performance”, come uno spettacolo teatrale che richiede uno scena-rio e un pubblico e che si muove, pertanto, nell’impronta di un conte-sto reale e non sempre visibile47; non risulta strano, ma anzi è preve-dibile che in tali circostanze si ricorra a delle chiavi, ad un codice che faciliti lo scambio di informazioni tra l’autore e il suo pubblico.
I frammenti storici forniti dagli autori colti del periodo imperia-le richiedono frequentemente, in accordo con quanto detto, un’at-tenta decodifica. Segnali indiretti e messaggi distorti possono causare un’apparenza confusa, polisemica, che rende difficile l’interpretazio-ne delle notizie storiografiche. Risulta indicativo il parallelismo tra testi di critica storiografica risalenti alle epoche ellenistica e imperia-le. L’unico storico ellenistico del quale ci sono pervenuti libri com-pleti, Polibio, dedica diverse sezioni della sua opera a discutere sulle produzioni di altri storici dello stesso periodo48. Due delle critiche più severe sono quelle che riguardano Filarco di Atene, nel libro II, e Timeo di Tauromenio, tema principale di discussione nei copiosi re-sti che ci sono pervenuti del libro X49. In entrambi i casi, Polibio in-
46 Si veda T. WHITMARSH, Greek Literature and the Roman Empire. The Politics
of Imitation, Oxford 2001, pp. 32-35. 47 ANDERSON, The Second Sophistic, cit., p. 236. 48 Sono molti gli storici di cui parla Polibio, sia per valorizzarli positivamente
(in scarse occasioni) sia per criticarli con maggiore o minore asprezza: Eforo, Teopompo, Callistene, Filino e Fabio Pittore, Sosilo, Cherea, Zenone e Antistene di Rodi. In relazione al tema risultano imprescindibili i libri di K. MEISTER (Historische Kritik bei Polybios, Wiesbaden 1975) e G. SCHEPENS - J. BOLLANSÉE (eds.) (The Shadow of Polybius. Intertextuality as a Research Tool in Greek Historiography. Proceedings of the International Colloquium [Leuven, 21-22 September 2001] [Studia Hellenistica, 42], Leuven – Paris – Dudley [MA] 2005).
49 POLYB. II 56-63. All’interno della bibliografia recente sulla critica di Poli-bio a Filarco si devono distaccare i contributi di G. SCHEPENS (Polybius on Phy-larchus’ “Tragic” Historiography) e L. VAN DER STOCKT (“Polubiavsasqai”? Plutarch on Timaeus and “Tragic” History), entrambi in SCHEPENS - BOLLANSÉE, The Shadow, cit., pp. 143-164 e 271-305. La bibliografia sulla critica a Timeo è raccolta nel lavoro di
JOSÉ M. CANDAU 30
troduce una polemica forte e diretta. Non mancano certo parole graffianti, termini offensivi, insulti personali o eccessi di diversa na-tura. Si è supposto che le critiche, per non dire invettive, di questo tipo, fossero usuali negli storici ellenistici50. Le notizie sul trattamen-to declassante e oltraggiante che riservava lo stesso Timeo a scrittori più o meno contemporanei conferiscono verosimilità a quanto sup-posto51. Quando passiamo all’epoca posteriore, quella imperiale, il panorama cambia considerevolmente. In primo luogo, gli scrittori del periodo imperiale solo occasionalmente -almeno fino a Filostra-to- si citano tra loro52. Pertanto, non è possibile trovare passaggi di critica storiografica riferiti esplicitamente ad autori contemporanei (che in sè è un elemento significativo). Qualcosa di lontanamente simile a polemiche come quelle di Polibio si può trovare in un capi-tolo di Plutarco, il prologo alle Vite di Nicia e Crasso, il cui tema è la censura dello storico siciliano Timeo di Tauromenio. Tuttavia, è ne-cessario rilevare innanzitutto che né per ampiezza né per livello di aggressività è possibile paragonare questa censura alle critiche che formula Polibio. In secondo luogo, si deve sottolineare che si tratta di un testo inusuale all’interno delle Vite Parallele, e che in nes-sun’altra delle sue biografie Plutarco effettua un attacco del genere.
C. BARON, The use and abuse of historians: Polybius’ Book XII and our evidence for Ti-maeus, in «AncSoc» XXXIX (2009), pp. 1-34.
50 G. SCHEPENS Polemic and methodology in Polybius’ Book XII, in H. VERDIN - G. SCHEPENS - E. DE KAYSER (eds.) Purposes of History. Studies in the Greek Historiog-raphy from the 4th to the 2th Centuries B.C. Proceedings of the International Colloquium (Leuven, 24-26 May 1988) (Studia Hellenistica, 30), Lovanii 1990, pp. 40-41; J. MARINCOLA, Autority and tradition in ancient historiograpy, Cambridge 1997, pp. 228-229.
51 Si vedano, ad. es., le accuse che formula Timeo contro Aristotele (POLYB. XII 8, 1-4) o contro Callistene (POLYB. XII 12b, 2). Sull’asprezza critica come caratteristica generale della letteratura ellenistica si veda M. ISNARDI, Tevknh und h\qo~ in der historiographischen Methodologie des Polybios, trad. ted., in K. STIEWE –
N. HOLZBERG (eds.) Polybios, Darmstadt, 1982, pp. 262-264. 52 Cfr. E. BOWIE, Literary milieux, in WHITMARSH (ed.), The Cambridge Com-
panion, cit., pp. 17-38, p.18.
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 31
Infine, è necessario mettere in rilievo il fatto che non ci troviamo qui davanti al tono diretto percettibile nelle critiche di Polibio; inve-ce, i paradossi e i significati nascosti rendono questo testo altamente complesso53.
In un determinato momento del prologo, Plutarco afferma ciò che segue:
«E (afferma Timeo) che era logico che anche Eracle aiutasse i Siracusani a causa di Core, con l’aiuto della quale si impos-sessò di Cerbero, e che provasse collera contro gli Ateniesi, perchè accorrevano in aiuto degli abitanti di Segesta, discen-denti dei Troiani, mentre egli stesso, offeso da Laomedonte, devastò la città di Troia»54.
Il paragrafo fa riferimento a un episodio della Guerra del Pelo-
ponneso, precisamente alla spedizione di Atene contro la Sicilia, il cui epilogo, come è ben noto, fu la disastrosa sconfitta ateniese con-tro Siracusa. Secondo Plutarco, Timeo spiegava questa sconfitta fa-cendo appello a Eracle e alla sua saga mitica: Eracle avrebbe appog-giato i Siracusani per gratitudine nei confronti di Core, legata alla Sicilia, e per avversione nei confronti degli abitanti di Segesta, nemi-ci di Siracusa e discendenti di quei Troiani che lo stesso Eracle aveva affrontato. A partire da frammenti come questo, specialisti in storio-grafia greca tanto perspicaci come Jacoby e Momigliano formularono un giudizio severo nei confronti di Timeo. Banalità, mentalità chiusa e lontana dalla realtà, pedanteria, erudizione superficiale, mancanza
53 Sui problemi posti da tale prologo e sulle fonti su cui si basa la biografia di
Plutarco, si veda F. MUCCIOLI, La critica di Plutarco a Filisto e Timeo, in VAN DER
STOCKT (ed.), Rhetorical Theory, cit., pp. 291-307; J.M. CANDAU, Plutarco como transmisor de Timeo. La Vida de Nicias, in «Ploutarchos» n.s. II (2004/2005), pp. 11-34; G. VANOTTI, L’Ermocrate di Plutarco (e/o di Timeo?), in R. SCUDERI – C. ZIZZA (a cura di), In ricordo di Dino Ambaglio. Atti del convegno (Università di Pavia 9-10 dicembre 2009), Pavia 2011, pp. 91-102.
54 PLUT., Nic. 1, 3.
JOSÉ M. CANDAU 32
di comprensione storica, sono alcuni dei termini che usano entram-bi gli studiosi55. Il panorama cambia quando si considera lo sfondo ideologico e le coordinate culturali in cui si muovono sia lo storico trasmesso, Timeo, sia la fonte trasmettitrice, Plutarco.
Nel contesto siciliano, il nome di Eracle, colonizzatore leggen-dario dell’isola, non è privo di connotazioni politiche. La propagan-da filo-dorica esaltò la sua figura come emblema di resistenza contro i progetti egemonici sull’isola tramati da Atene. D’altro canto, le proposte che evidenziavano le origini troiane delle città siciliane ri-spondevano ad un movimento propagandistico contrario; in questo modo, i suoi promotori svalutavano le tesi filo-doriche legate ad Era-cle e tracciavano una mappa mitologica della Sicilia più conforme agli interessi di Atene56. È possibile che l’eco di questo dibattito poli-tico-propagandistico risuoni nel frammento di Timeo che abbiamo commentato. Ad ogni modo, la saga troiana costituì una questione importante nella pubblicistica prodotta riguardo alla spedizione di Pirro in Sicilia e nell’Italia continentale. Non ci è dato sapere come Pirro utilizzò i motivi legati alla suddetta questione, ma appare evi-dente che, grazie alla sua campagna, le tradizioni sulle origini miti-che della zona furono riprese e utilizzate in qualche maniera57. Ti-meo visse a cavallo tra il IV e il III secolo a.C., e fu testimone della campagna di Pirro in terra occidentale, intrapresa tra il 278 e il 275; si occupò inoltre della suddetta campagna nell’ultima parte di
55 F. JACOBY, FGrHist 566, Komm., pp. 533-535; A. MOMIGLIANO, Atene nel
III secolo e la scoperta di Roma nelle storie di Timeo di Tauromenio, in ID., Terzo Contributo alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico, Roma, 1966, pp. 23-51 (= «RSI » VII [1959], pp. 529-556); si veda anche R. LAQUEUR, s.v. Timaios 3, RE 6/A1 (1936), coll. 1191-1192.
56 Su Eracle e la saga troiana come elementi propagandistici nella storiografia e la pubblicistica greca in Sicilia, si veda R. SAMMARTANO, Origines gentium Siciliae. Ellanico, Antioco, Tucidide. Roma, 1998, pp. 43-126; G. VANOTTI, Egesta ed Esione da Ellanico di Lesbo a Dionisio di Alicarnasso, in A. ALONI - M. ORNAGHI (a cura di), Tra panellenismo e tradizioni locali. Nuovi contributi, Messina 2011, pp. 317- 347.
57 Si veda ERSKINE, Troy,cit., pp. 157-161.
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 33
un’opera molto diffusa e presente nella tradizione posteriore, la sua Storia della Sicilia (Sikelikav)58. È probabile che le disquisizioni sulla figura di Eracle di cui ci informa il prologo alla Vita di Nicia si inse-rissero in un resoconto riguardante i tempi leggendari dei territori invasi dal re epirota. Timeo, in tal modo, affronterebbe un tema che, lungi dal costituire un assunto banale o dettato da un’erudizione va-cua, riprendeva una polemica attuale e viva, chiaramente collegata ad un argomento di così forte impatto nella sua epoca come le guer-re di Pirro in Italia. Inoltre, tale ipotesi viene avallata da un ragio-namento più vasto. Le tradizioni locali e precisamente il passato mi-tico delle città o dei territori, furono temi abbondantemente utilizza-ti dalla diplomazia ellenistica nelle trattative avviate per raccogliere sostegno, stabilire alleanze o porre le basi per relazioni interstatali di diversa natura59. Che uno storico raccolga tali argomenti all’interno della sua opera non è indice del suo allontanamento dalla realtà o del suo isolamento rispetto al presente; al contrario, indica attenzio-ne nei confronti dei temi e delle polemiche di attualità nella vita pubblica dell’epoca.
Il passaggio della Vita di Nicia che abbiamo commentato induce in inganno. Non sappiamo fino a che punto il suo autore era co-sciente del significato che potevano avere le leggende locali trattate da Timeo. All’epoca dello stesso Plutarco, queste leggende sembrano conservare la loro validità come prove in grado di giustificare lo sta-
58 FGrHist 566 T9. Non sappiamo quasi niente della parte dell’opera di Timeo dedicata a Pirro (vd. Ibid., Komm., pp. 545-546), però, sulle sue possibili motivazioni e carattere si consulti R. VATTUONE, Sapienza d’occidente. Il pensiero storico di Timeo di Tauromenio, Bologna, 1991, pp. 268-273.
59 Dal V secolo a.C. fino almeno al II d.C. le tradizioni locali e le origini mitiche furono una parte importante degli argomenti utilizzati nel linguaggio diplomatico per giustificare le relazioni interstatali: si veda J. M. HALL, Politics and Greek Myth, in R.D. WOODARD (ed.), The Cambridge Companion to Greek Mythology, Cambridge, 2007, pp. 331-354, p. 331. Sulla diffusione di questa pratica in epoca ellenistica, si veda A. ERSKINE, Troy, cit., pp. 163-168; T. S. SCHEER, The Past in a Hellenistic Present: Myth and Local Tradition, in A. ERSKINE (ed.), A Companion to the Hellenistic World, Oxford, 2003, pp. 216-231.
JOSÉ M. CANDAU 34
tus di una determinata città o territorio60. Ad ogni modo, ciò che fa in questo caso il trasmissore, Plutarco, è riunire affermazioni concre-te dell’autore trasmesso, Timeo, per poi includerle, isolate dal loro contesto originale, all’interno di un nuovo discorso. Un discorso al-tamente negativo. L’opera di Timeo raggiunse un’enorme diffusione nella sua epoca61. Diffusione alla quale seguì molto presto un’accesa polemica. Le prime notizie sembrano risalire a Istro il Callimacheo, che compose nel III secolo a.C. un’opera intitolata Confutazioni a Timeo62, e a Polemone il Periegeta, autore, in data di poco posteriore, di un trattato Contro Timeo63. Il furibondo attacco che gli indirizza Polibio lasciò un profondo segno ma non cambiò la reputazione di Timeo. Anche Cicerone si riferisce a lui in termini positivi64. Fu con l’instaurazione del classicismo che la reputazione di Timeo soffrì una
60 Si vedano le notizie (velate da ironia) riguardo ad ambasciate greche che
offre TAC., Ann. 3, 61; 4, 43; 4, 55-56; 12, 61. Per il materiale epigrafico, si consultino i dati registrati da HALL, Politics, cit., e BOWIE, Literary, cit., p. 20.
61 Citazioni dirette di Timeo appaiono in Agatarchide, Ps-Scimno, Filodemo, Cicerone e Nepote (Agatharch., De m. Rubr. 64 = FGrHist 566 T 14 ; [Scymn], Perieg. 125-6 = T 14; PHLD., Po. 5 col. 5, 22 Jensen; CIC., ep. V 12, 2 = T 9a; ID., de or. 2, 58 = T 20; ID, Brut. 325 = T 21; ID, ep. VI 1, 18 = T 29; NEP., Alc. 11, 1 = F 99). Possediamo anche citazioni indirette di Artemidoro di Efeso e Cecilio di Calacte (Artemidoro in STR., XIV 1, 22 = FGrHist 566 T 27; Cecilio in [LONGI-
NUS], Subl., 4 = 566 F 23. Jacoby, inoltre, rilevò la presenza di Timeo in una serie di autori tra poeti (Callimaco, Licofrone, Apollonio Rodio) eruditi, antiquari e grammatici (Eratostene, Demetrio di Scepsi, Varrone, Didimo), storici e geografi (Posidonio) (FGrHist 566, Komm., pp. 527-528). Abbondanti studi moderni, da J. GEFFCKEN almeno (Timaios’ Geographie des Westens, Berlin 1892 pp. 177-178), evidenziano la grande diffusione dell’opera di Timeo in epoca ellenistica: si veda sull’argomento J.M. CANDAU, Timeo en el léxico Suda, in G. Vanotti (a cura di), Il lessico Suda e gli storici greci in frammenti. Atti dell’incontro Internazionale (Vercelli, 6-7 novembre 2008), Tivoli (Roma) 2010, pp. 300-301. Riguardo al potente impatto di Timeo sulla prima storiografia romana, si veda D. FEENEY, Caesar’s Calendar: An-cient Times and the Beginnings of History (Sather Classical Lectures, 65), University of California Press 2007, pp. 52-53.
62 FGrHist 566 T 16 = ATH. VI 103. 63 FGrHist 566 T 26 = ATH. X 9. 64 CIC., de or. 2, 58 = FGrHist 566 T 20.
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 35
caduta ed egli si convertì in un autore le cui citazioni comportavano discredito65. Chiaramente, l’impatto raggiunto precedentemente dal-la sua opera non permise una sua completa scomparsa; ed effettiva-mente il nome di Timeo appare in testi di carattere erudito66, spe-cialmente in quelli che riguardano la Sicilia e in generale l’occidente greco. Ciò non succede nelle opere indirizzate ad un pubblico colto, a quella minoranza politica e sociale il cui veicolo di espressione era l’atticismo. In quest’ultimo ambiente, ossia il pubblico a cui Plutarco si rivolge, la condanna di Timeo ha un grande peso e i riferimenti al-la sua persona riflettono un generale consenso di discredito.
La censura di Timeo nel prologo della Vita di Nicia riflette que-sto consenso negativo. Mediante esso, Plutarco rende omaggio agli accordi e alle valutazioni che condivide con il suo pubblico o, in al-tre parole, inserisce il suo testo nelle coordinate, nella lingua franca assiologica che unisce gli scrittori imperiali con la élite colta dei suoi lettori. Nel paragrafo che abbiamo commentato non c’è un’offensiva diretta e chiara, in accordo con lo stile usuale nell’epoca ellenistica, se mai Polibio ne è un esempio rappresentativo. Plutarco stimola il lettore. Per fare questo, isola la citazione di Timeo e la svuota dei si-gnificati legati al loro contesto principale. L’eliminazione del conte-sto originale fa sì che le parole dell’autore trasmesso rimangano, in un certo senso, alla mercè del trasmissore che imprimerà su di esse il significato pertinente in funzione al suo discorso. La critica agisce così in maniera indiretta e velata.
Evidentemente, la scrittura di Plutarco è complessa, come lo so-no le sue relazioni con Timeo e, in generale, le sue valutazioni lette-rarie. Riguardo ad Ateneo, la cui importanza come fonte per la sto-
65 Si vedano le opinioni screditanti di Dioniso di Alicarnasso (Din. 8 =
FGrHist 566 T 22) e dell’autore di Peri; u{you~ (4 = FGrHist 566 T 23). Il discredito di cui risente Timeo con l’arrivo del classicismo fu evidenziato già da U. VON
WILAMOWITZ-MOELLENDORF (Asianismus und Atticismus, in «Hermes» XXXV [1900], pp. 1-52, p. 8).
66 La lista dei trasmissori di frammenti di Timeo che offre l’edizione elettronica dei FGrHist contiene 41 citazioni di scolii.
JOSÉ M. CANDAU 36
riografia perduta è perlomeno uguale a quella di Plutarco, si è detto, in uno studio classico sui frammenti storici, che rappresentava un trasmissore affidabile e sicuro67. Pubblicazioni posteriori hanno so-stenuto il contrario: Ateneo distorce, occulta ed è ben lungi dal co-stituire un testimone fedele degli storici perduti. Procedimenti iden-tici o simili a quelli che abbiamo visto con Plutarco -svuotare il frammento dei suoi contenuti contestuali per inserirlo in un nuovo discorso- sono stati rilevati negli scritti di Ateneo e descritti con ter-mini come riorientamento68, riqualificazione69, banalizzazione70 del frammento. L’opera di Ateneo, effettivamente, ha una sua dimen-sione letteraria e quindi la sua scrittura sviluppa la trama ed è condi-zionata dall’idea che stabilisce l’autore. Pretendere che sia possibile inserire in quella trama una citazione senza adattare il contenuto del-la stessa non sembra accettabile. Tutto ciò è stato confermato da quegli studi focalizzati sulle citazioni di Ateneo il cui contenuto è ac-cessibile, ossia i frammenti di storici preservati. Christopher Pelling si basò esattamente su questo tipo di materiale, ossia del parallelismo tra le citazioni di Ateneo e gli stessi passaggi come appaiono nel-l’opera di origine, per sollevare un’ipotesi suggestiva. È difficile, os-serva Pelling, giustificare le divergenze testuali risultanti da questo parallelismo. Una possibile spiegazione consiste nel supporre che si tratti di divergenze volute dallo stesso autore, errori ricercati e fun-zionali a mandare un messaggio al lettore: fun with fragments71. Nel-
67 P. A. BRUNT, On Historical Fragments and Epitomes, «CQ» XXX (1980),pp. 447-494, p. 481 («We may then assume that in general Athenaeus is fairly reli-able»).
68 D. LENFANT, Les «fragments» d’Herodote dans les Deipnosophistes, in D. LEN-
FANT (ed.), Athénée et les fragments d’historiens. Actes du colloque de Strasbourg (16-18 juin 2005), Paris 2007, pp.43-72, in part., pp. 60-63.
69 C. MAISONNEUVE, Les «fragments» de Xénophon dans les Deipnosophistes, in LENFANT, Athénée, cit., pp. 73-106, pp. 91-92.
70 P. GIOVANELLI-JOUANNA, Les fragments de Duris de Samos chez Athénée, in LENFANT, Athénée, cit., pp. 215-237, pp. 227-229.
71 C. PELLING, Fun with Fragments. Athenaeus and the Historians, in BRAUND - WILKINS (eds.), Athenaeus, cit., pp. 171-190.
LE COORDINATE LETTERARIE DEI TRASMISSORI 37
l’atmosfera di insinuazioni e ironia, di mistificazione, di paradosso, di comunicazione indiretta o allusiva che frequentemente predomi-na nella letteratura greca imperiale, tale ipotesi risulta verosimile.
Nei trasmissori letterari dell’epoca imperiale si compie piena-mente la premessa formulata da Schepens: le loro citazioni preserva-no («protect»), occultano («conceal») e rinchiudono («enclose») il te-sto trasmesso72. Restituire al testo il suo senso originale richiede che il primo passaggio sia quello di smontare l’involucro letterario del frammento per epurarlo dal significato acquisito, impresso dal tra-smissore. Il secondo passaggio, strettamente legato al primo, sarà quello di ubicarlo nel suo proprio universo e restituirgli le risonanze originali. Entrambi i passaggi comportano procedimenti complessi e in molte occasioni, forse nella maggioranza dei casi, l’obiettivo finale risulta irraggiungibile. Tuttavia, se vogliamo comprendere pienamen-te le grandi opere della letteratura greca, risulta imprescindibile la ri-costruzione del terreno ove nacquero e questo compito può essere svolto solamente dallo studio della letteratura frammentaria. Ad o-gni modo, la pratica di lucidare e pulire, di smontare e spiegare un frammento storiografico comporta insegnamenti che interessano non solo l’autore trasmesso, ma anche il trasmissore, la sua epoca e la sua maniera di affrontare il passato. Tutto ciò rappresenta una pratica dalla quale la filologia ottiene sempre abbondanti benefici.
72 G. SCHEPENS, Jacoby’s FGrHist: Problems, Methods, Prospects, in G. MOST
(ed.), Collecting Fragments / Fragmente sammeln, Göttingen, 1997, pp. 66-67.



































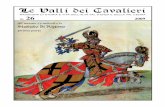

![Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631bb202665120b3330b7dd5/le-gallerie-cartacee-dei-ritratti-dei-vicere-e-governatori-spagnoli-in-italia-xvi-xvii.jpg)










