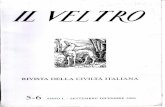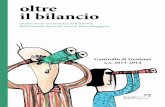La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
Transcript of La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre
LA PROSOPOPEA DI PERICLE IN ARCADIA E OLTRE*
di Mauro Sarnelli
«Il dovere esige da me che io termini […] una cantata drammaticaper la ricuperata salute di mons. Spinelli, e una canzonetta per il Papa. Leho promesse, e convien mantener la parola»:1 è questa la prima testimo-
* In apertura del presente lavoro, desidero ringraziare vivamente quanti hanno presoparte alla discussione seguìta al mio intervento e che hanno contribuito all’approfondi-mento di esso: in particolare, l’interesse suscitato dall’affissione della Prosopopea mon-tiana sull’erma di Pericle mi ha spinto a verificare quale testo sia stato stampato in taleoccasione, fornendo un contributo sinora non preso in considerazione nella storia te-stuale del brano. Circostanza che dimostra ulteriormente – qualora ve ne sia bisogno –l’imprescindibile funzione comunicativa degli incontri di studio. Doveroso (e piacevole)è altresì il ringraziamento alla professoressa Maria Teresa Acquaro Graziosi, CustodeGenerale dell’Accademia dell’Arcadia, alla dottoressa Marina Panetta, Direttrice dellaBiblioteca Angelica di Roma (presso la quale è custodita la Biblioteca arcadica), ed alpersonale tutto di quest’istituzione [citata come BAR], per l’imprescindibile disponi-bilità nella consultazione dei materiali, che ha reso agevole il mio studio. Nella trascri-zione dei brani tratti da mss. e stampe sette-ottocenteschi, si è adottato un criterio so-stanzialmente conservativo, intervenendo solo: 1) nello scioglimento delle abbreviazioni,tranne che nelle formule di cortesia codificate dall’uso; 2) nella normalizzazione degliapostrofi e degli accenti acuti e gravi, adeguandoli all’uso attuale; 3) nella correzione dilapsus calami e refusi tipografici, utilizzando il corsivo per le lettere ed i numeri singoli,le parentesi quadre per le espunzioni, e quelle uncinate per le integrazioni, secondo laprassi filologica in vigore; 4) nell’interpunzione, ma in misura molto parca e solo là doverisultava necessario alla perspicuità del senso dei testi.
1 VINCENZO MONTI, Epistolario, raccolto ordinato e annotato da Alfonso Bertoldi,Firenze, Le Monnier, 1928-31, 6 voll., I (1771-1796), 1928, lettera 56, A ClementinoVannetti – Rovereto, «[Roma,] 30 luglio 1779», pp. 77-78 (a p. 77). La cantata di cui
nianza montiana relativa alla Prosopopea di Pericle, la «canzonetta» che l’au-tore recita poco più di tre settimane dopo presso la sede estiva dell’Acca-demia dell’Arcadia, il Bosco Parrasio.
Mauro Sarnelli126
fa cenno il Monti era già stata annunciata dall’autore pressoché con le medesime pa-role nella dedicatoria Al Chiarissimo signor Abate Pietro Metastasio Poeta Cesareo, premessaalla ried. della Giunone placata Componimento drammatico per le Nozze dell’Eccellenze Loroil signor Don Filippo Caetani Principe di Teano e la signora Donna Elena de’ Principi Albani,nel Saggio di Poesie dell’Abate VINCENZO MONTI a Sua Eccellenza la signora Marchesa Ma-ria Maddalena Trotti Bevilacqua, Livorno, Dai Torchj dell’Enciclopedìa, 1779, pp. 220-24 (la cantata epitalamica [I ed. In Roma, Per il Casaletti, 1779, con una dedica poe-tica A Sua Eccellenza il Signor D. Filippo Caetani Principe di Teano, pp. 3-9], che com’ènoto chiude il volume, è alle pp. 225-40): «Intanto finché questa lettera trapassa lealpi, e viene a trovarla sul Danubio, io darò termine ad un altro mezzo Dramma (e que-sto sarà il secondo, e forse l’ultimo) che sto scrivendo per la ricuperata salute di S. E.R.ma Monsignore [scil., Ferdinando] Spinelli Governatore di Roma. […: scil., seguonole lodi di «quest’Uomo maraviglioso»] Le spedirei anche questo componimento finitoche l’avessi, e poi la lascierei in pace, né la disturberei mai più» (nell’ordine alle pp.223 e 224). Allo stato attuale delle ricerche, non si hanno ulteriori informazioni su tale«cantata drammatica», che Leone Vicchi identifica con il «Dramma […] serio» e«nuovo» menzionato dal Monti in una lettera datata «Roma 8 [scil., gennaio] del 80»,indirizzata al marchese Francesco Albergati Capacelli, che avrebbe dovuto «tentarnel’esito» presso i teatri veneziani: la lettera è citata dall’ed. procuratane da ANGELO RO-MANO, Giunte e ritocchi per l’epistolario montiano. La corrispondenza con Francesco AlbergatiCapacelli, in GSLI, CXII (1995), pp. 550-80, lettera [3], pp. 558-59 (a p. 559); pre-cedenti edd. moderne di essa sono, naturalmente, in MONTI, Epistolario, vol. I, lettera75, pp. 102-03 (nella n. in calce, il Bertoldi rimanda alle ipotesi relative a quella scrittaal Vannetti, «Roma, 6 Maggio 1780», lettera 81, pp. 112-14, a p. 114, dove lo stu-dioso riporta gli interrogativi di FERDINANDO PASINI, Nova montiana. Con un poemetto eundici lettere inedite, II ed. riveduta e ampliata, Capodistria, Tipografia Cobol & Priora,1905, pp. 38-39, n. 11 [I ed., senza sottotitolo, in “Pagine Istriane”, II [1904], pp.192-200, 236-46 e 271-92: il passo è alle pp. 243-44, n. 3, a cui lo studioso poi ag-giungerà la riflessione conclusiva]); ed in MONTI, Lettere d’affetti e di poesia, a c. di An-gelo Colombo, Roma, Salerno Editrice, 1993, lettera V, pp. 53-54. Come si è accen-nato, tale identificazione è avanzata da LEONE VICCHI, Vincenzo Monti, le lettere e la po-litica in Italia dal 1750 al 1830 (Triennio 1778-1780), Fusignano […], Da EdoardoMorandi venditore [Roma, Forzani e C., tipografi], 1885, p. 322: «Pare […] che ilMonti avesse allestito un dramma, probabilmente quello di cui scriveva al Metastasioe che voleva dedicare a monsignor Spinelli governatore di Roma, e che desiderasse farlorappresentare a Venezia, dove stava l’Albergati, agli 8 gennaio del 1780». Se non vi è(ancora) traccia di questa composizione, è invece testimoniato il sonetto che l’autorerivolge A Sua Eccellenza Monsig. Ferdinando Spinelli Governatore di Roma: «Questa, chemuta or vedi a Te davante», uscito nelle Rime degli Aborigeni recitate in diversi tempi nellaloro Adunanza in Roma. Parte I. Alla Santità di Nostro Signore Pio Sesto Pontefice Massimo,
Alla lettura degli Atti Arcadici, il mese di agosto del 1779 è intera-mente dedicato alle celebrazioni in onore del pontefice regnante, Pio VIBraschi, per cui vengono indette tre «Adunanze Generali» dell’Accade-
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 127
In Roma, Nella Stamperia di Generoso Salomoni, 1779, p. 152 (sulla Parte II dellaraccolta, che vede la luce due anni dopo insieme a due «Appendici», si veda infra, e n.25); e compreso in MONTI, Saggio di Poesie, p. 64 (poi in ID., Le poesie liriche, II ed. conaggiunta di cose inedite o rare a cura di Giosue Carducci, Firenze, G. Barbèra, editore,1862 [I ed. 1858], pp. 105-06). È interessante notare come l’inserimento di questo so-netto nel Saggio di Poesie sia con ogni probabilità avvenuto già in fase di stampa, poi-ché nell’esemplare della raccolta conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale“Vittorio Emanuele II” di Roma, alla segnatura 6. 14. D. 15, al posto di esso ne com-pare un altro: Per Monacazione di bellissima Giovane (incipit: «Qui presso al sacro altardolenti insieme»); che quest’esemplare testimoni una fase di allestimento della stampa,lo dimostra altresì la mancanza in esso dell’Errata Corrige, che nell’ed. “finale” è postosenza numerazione di pagina dopo la p. 240. Il sonetto allo Spinelli («con altri due»non indicati) al Monti «frutta il regalo di un bellissimo cammeo, rappresentante ungermanico giovane in pietra di color biondo e delicato, che va a perdersi insensibil-mente nel bianco a misura che la testa si scarna, e contornato di brillanti» (ID., Episto-lario, vol. I, lettera 45, al Vannetti, «Roma, 26 [scil., gennaio] del ’79», pp. 58-62, ap. 60; in maniera meno particolareggiata, ma più concreta, il Monti dà questa notiziaal fratello Cesare sei giorni prima: cfr. ibid., lettera 44, All’ab. Cesare Monti – Fusi-gnano, «Roma, 20 gennaio [1779]», pp. 57-58, a p. 58). Uno degli altri due sonetti inlode dello Spinelli menzionati dall’autore è con ogni probabilità quello sottoposto algiudizio di Ennio Quirino Visconti, ed a lui inviato con una doppia versione dell’inci-pit: «Venne la Morte, e su l’inferme [e mentre sulle] spoglie» (ibid., lettera 50, «[Roma,Giugno 1779]», pp. 67-68). Che il dono dello Spinelli provocasse la risposta epi-grammatica di Matteo Berardi («Monti l’anello, che il Pretor ti diede / Più, che allaman ti converrebbe al piede») è sostenuto da ACHILLE MONTI (Vincenzo Monti. Ricerchestoriche e letterarie, Roma, Tipografia Barbèra, 1873, pp. 135-38), GIUSEPPE CIMBALI
(Prefazione a NICOLA SPEDALIERI, L’Arte di governare, ed. eseguita sull’originale del 1779[...], Città di Castello, S. Lapi Tipografo Editore, 1886, pp. V-LII, alle pp. XLVIII-L;il brano è altresì in CIMBALI, Nicola Spedalieri pubblicista e riformatore del secolo XVIII,Città di Castello, Casa Tipografico-Editrice S. Lapi, II ed. 1906 [I ed. 1888, senza l’ag-giunta «e riformatore» nel titolo], 2 voll., I, pp. 118-19), GIUSEPPE DEL PINTO (Amoried odii di Vincenzo Monti a Roma, in “La Nuova Rassegna”, II [1894, 1° semestre], pp.722-26, a p. 722), e dal Bertoldi (MONTI, Epistolario, vol. I, n. in calce alla lettera 37,al fratello Cesare, «Roma, 6 Giugno 1778», pp. 48-49, a p. 49); mentre invece è smen-tito dal VICCHI (Vincenzo Monti, le lettere e la politica in Italia dal 1750 al 1830 (Trien-nio 1778-1780), pp. 278-82); ed è accennato in via ipotetica dal ROMANO (Le polemi-che romane del Monti e la disputa con Antonino Galfo [inedito e 2001], in Vincenzo Montia Roma, Manziana, Vecchiarelli, 2001, pp. 201-40, a p. 201; ripreso ad litteram in ID.,Le polemiche romane di Vincenzo Monti (1778-1797). Con una appendice di testi, Manziana,Vecchiarelli, 2005, pp. 5-41, a p. 6: l’ed. dell’epigramma riportato supra è contenuta
mia: la prima «Ordinaria», le restanti due «Straordinarie».2 In quella del12 agosto (differita dall’usuale cadenza, in quanto, «essendo impedito ilprimo Giovedì del mese, l’Adunanza si trasportò al secondo»),
il S.r Ab.e D. Niccola Spedalieri pronunciò un dotto Ragionamento inlode della Santità di N.ro Sig.re Papa Pio VI felicemente regnante. Par-lando l’Oratore sull’eccellenza del Governo Ecclesiastico, si aprì un largocampo per descrivere le incomparabili virtù dell’Ottimo Principe chene governa.3
Tale «largo campo» fa sì che
La Prosa fu eloquentissima, ed in grazia della brevità, stimò bene l’Aut-tore di dividerla in due parti; riserbandosi a legger la seconda nel se-guente Giovedì 19 dello stesso mese; al qual oggetto il Custode intimòla seconda pubblica Straordinaria Adunanza. […] Nell’una e nell’altraAccademia i Pastori Arcadi che eran presenti fecero risonare le proprieCetre sul medesimo sublime Argomento con varj brillanti Poetici Com-ponimenti.4
Mauro Sarnelli128
nell’Appendice I, Monti e Berardi, pp. 47-58, a p. 56, n° 10). Come ricordano GIOSUE
CARDUCCI (Famiglia del Monti, ed. procurata da ALFREDO COTTIGNOLI, Carducci editoree critico del Monti (con documenti inediti), in Vincenzo Monti nella cultura italiana, a c. diGennaro Barbarisi, Milano, Cisalpino, 2005, vol. I, t. I, pp. 389-442, alle pp. 403-16:p. 407), il VICCHI (Vincenzo Monti, le lettere e la politica in Italia dal 1750 al 1830 (Trien-nio 1778-1780), pp. 280-81), il CIMBALI (Prefazione a SPEDALIERI, L’Arte di governare,p. XLVIII; poi in CIMBALI, Nicola Spedalieri, vol. I, p. 118), WALTER BINNI (Monti poetadel consenso, Firenze, Sansoni, 1981, p. 68), ed ELENA PARRINI CANTINI (Il “Saggio diPoesie” tra citazione e autocitazione, in Vincenzo Monti nella cultura italiana, vol. I, t. II,pp. 547-71, a p. 555), i vv. 124-28 della canzone «Lasciami in pace, Amor. Per lo sen-tiero» celebrano il «provvido FERNANDO», al cui «giusto / Forte braccio» Pio VI«Commise il fren della difficil Roma, / Perché nato al commando / Ei sa porle le manientro la chioma» (MONTI, Saggio di Poesie, pp. 214-20, a p. 219; ed ID., Le poesie liriche,ed. Carducci, pp. 99-105, a p. 104).
2 BAR, Atti Arcadici, ms. 5, «20 ag. 1772 - 8 luglio 1790 / 5° Custode / Abb. Pizzi(Nivildo Amarinzio)», cc. 195-98 (rispettivamente alle cc. 195 e 196).
3 Ivi, c. 195. Si tratta del Ragionamento sulla influenza della Religione Cristiana nellaSocietà civile recitato in Arcadia per la ricuperata Salute di Pio Sesto Pontefice Massimo da NI-COLA SPEDALIERI Siciliano, In Roma, Per Michelangelo Barbiellini alla Minerva, 1779;su di esso, si veda almeno la documentazione offerta dal CIMBALI, Nicola Spedalieri, vol.I, pp. 119-28.
4 BAR, Atti Arcadici, ms. 5, c. 195 (corsivi aggiunti).
Da tenere a mente è la connotazione “sublime” fornita al tema trat-tato, che, di là dalla prevedibile topicità encomiastica del termine, ha insé notevoli implicazioni con le peculiarità concettuali, stilistiche, e piùampiamente storico-culturali del brano montiano, già del resto poste inevidenza dalla critica.5 Ed è proprio allo scopo di illuminare tali peculia-
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 129
5 Per limitare l’excursus ad alcune linee-guida, ancora risentono del giudizio di At-tilio Momigliano sulla tendenza “barocca” del neoclassicismo montiano sia CARLO MU-SCETTA, che definisce la Prosopopea «sfarzosa» e «la prima delle macchine encomiasticheinventate dal Monti» (Introduzione a MONTI, Opere, a c. di Manara Valgimigli e CarloMuscetta, Milano-Napoli, Ricciardi, 1953, pp. VII-XLIX, a p. XIX [rist. in ID., Versi.Caio Gracco. La Feroniade. Scelta, a c. di Carlo Muscetta, Torino, Einaudi, 1977, 2 tt., I];giudizio riproposto dallo studioso, Vincenzo Monti, in Letteratura italiana. I maggiori, Mi-lano, Marzorati, 1956, 2 tt., II, pp. 701-54, a p. 708); sia CALOGERO COLICCHIA [CO-LICCHI], secondo cui in essa si esprime «un “meraviglioso” che non è archeologico e rie-vocativo, ma attualissimo» (Il “Saggio di Poesie” del 1779 e la prima poetica montiana, Fi-renze, Le Monnier, 1961, p. 48); sia BINNI, che ne parla come di «un prodotto di effi-cace compromesso fra una volontà di adesione al neoclassicismo e un gusto istintiva-mente più florido, colorito, immaginoso di quello neoclassico teso al lineare, al conciso,al disegnato (e spesso persino a scialbi toni gessosi e a suoni monotoni per eccesso di pu-rezza, di serenità, di nobile semplicità)» (Monti poeta del consenso, p. 79; lo studioso avevarilevato come nella Prosopopea il Monti «volgesse le strofette savioliane al neoclassicismopiù scenografico e sontuoso», già nel saggio Ludovico Savioli e la poetica classicistico-rococò,compreso in ID., Classicismo e Neoclassicismo nella letteratura del Settecento, Firenze, La NuovaItalia, 1976 [rist. anast. dell’ed. 1963], pp. 51-83, a p. 82). Ad indicare il brano come«l’inizio della nuova attività poetica» dell’autore, pur «restando però poco più che unepisodio», è GENNARO BARBARISI (Vincenzo Monti e la cultura neoclassica, in Storia dellaLetteratura Italiana, diretta da Emilio Cecchi e Natalino Sapegno, L’Ottocento, Nuova ed.accresciuta e aggiornata, diretta da Natalino Sapegno, Milano, Garzanti, 2001 [rist.dell’ed. 1988; I ed. 1969], pp. 7-104, nell’ordine alle pp. 29 e 31). In conclusione delcapitolo incentrato sulla Prosopopea, NICOLÒ MINEO afferma che in essa «si può ricono-scere la prima, quasi casuale e certo ancora immatura, realizzazione di una poetica delsublime straordinario e della novità del processo conoscitivo della poesia» (Vincenzo Monti:la ricerca del sublime e il tempo della rivoluzione, Pisa, Giardini, 1992, pp. 17-37, a p. 37;in questo contributo, lo studioso riprende ed amplia le argomentazioni già sintetica-mente espresse nel suo La carriera di Vincenzo Monti, in La letteratura italiana. Storia e te-sti, Direttore Carlo Muscetta, vol. VII, Il primo Ottocento. L’età napoleonica e il Risorgimento,Roma-Bari, Laterza, 2 tt., 1975-77, I, 1977 [ed in MINEO, Cultura e letteratura dell’Ot-tocento e l’età napoleonica, Roma-Bari, Laterza, 1977], pp. 145-74, p. 149). Secondo FA-BIO FINOTTI, la cifra spirituale ed espressiva del brano è nella «declinazione insieme su-blime e patetica dell’eredità umanistica e del suo mito di rinascita, […] approfonditadal Monti con la cantica La bellezza dell’universo» (Il “sublime patetico” del Monti, in “LI”,L [1998], pp. 528-53, a p. 540). Infine ARNALDO BRUNI ne pone in luce «la determi-
rità, e di indagare sulle loro origini e sui loro sviluppi, che qui ed in sé-guito si è scelto di ampliare l’analisi al contesto in cui la Prosopopea nascee prende forma: una forma – come si avrà modo di rilevare – non a casoin progress.
A proposito del contesto, almeno un accenno va fatto al carattere «bril-lante» delle composizioni recitate in àmbito accademico (arcadico e non),poiché a ragione Gennaro Barbarisi ha affermato come «mai sia da di-menticare la cornice mondana di questa poesia».6 Cornice che emerge intutta la sua fastosità, aulica e “rituale”, se si continua a leggere il reso-conto degli eventi promossi dall’Arcadia, giungendo all’«Adunanza Ge-nerale Straordinaria» di domenica 22 agosto, in cui, come già era avve-nuto cinque anni prima in onore di Clemente XIV Ganganelli,7 vengonocelebrati i voti quinquennali per Pio VI:
Dovendo il Custode aprire il Bosco Parrasio credette bene di non allon-tanarsi dall’applaudito antecedente Argomento, e dare la terza dimo-strazione del pubblico giubilo per la ricuperata Salute dell’Augu<s>toPontefice benemerito della Religione, e Promotore della pubblica feli-cità, e celebrare in tale occasione i Voti Quinquennali in onore della San-
Mauro Sarnelli130
nazione sperimentale», l’«inquietudine stilistica entro il crogiuolo di quelle suggestioniderivate da un ambiente segnato da stimoli innovatori», per cui «non sembra esageratoosservare che la canzonetta eserciti un’autentica funzione canonica, in qualche modo pa-ragonabile, fatte le debite proporzioni, al Giuramento degli Orazi di Jacques-Louis Da-vid, esposto di lì a poco (luglio 1785) nel Palazzo Costanzi» (Monti nella Roma neoclas-sica, in “Rassegna europea di letteratura italiana”, 23 [2004], pp. 23-42, a p. 31; lo stu-dioso è tornato su queste riflessioni nel suo La funzione Monti, in Vincenzo Monti nella cul-tura italiana, vol. I, t. II, pp. 445-62, alle pp. 447-49). L’accostamento con la celeber-rima tela davidiana era stato avanzato già dal BINNI, La poetica neoclassica in Italia, inClassicismo e Neoclassicismo, pp. 87-100 (a p. 94).
6 BARBARISI, Vincenzo Monti e la cultura neoclassica, p. 30.7 Per il resoconto della «solenne Adunanza di Canto nel Bosco Parrasio celebran-
dosi uno de’ Giuochi Olimpici pe’ Voti Quinquennali ad onore della Santità di NostroSignore Papa Clemente XIV per le presenti faustissime circostanze di Pace», che haluogo domenica 26 giugno 1774, «Giorno lietissimo», si vedano BAR, Atti Arcadici,ms. 5, cc. 55-56 (le citazioni sono rispettivamente dalle cc. 56 e 55: il verbale reca lafirma di «Alesindo Latmio Sotto Cust.e», cioè dell’abate Antonio Scarpelli); e DiarioOrdinario, nr. 8592, In data delli 2 Luglio 1774, In Roma, Nella Stamperia Cracas pressoS. Marco al Corso, 1774, pp. 5-8. In tale occasione viene stampato L’Oracolo. Giuoco Olim-pico celebrato dagli Arcadi nelle presenti circostanze di Pace pe’ Voti Quinquennali ad Onore dellaSantità di N. S. Papa Clemente XIV Pastor Massimo acclamato col Nome di Pistofilo Elidense,In Roma, pe’l Salomoni [colophon], 1774.
tità Sua. […] L’ornata decenza del Luogo adattato alle Poetiche Adu-nanze, il buon ordine non interrotto della funzione, la moltitudine de-gli Uditori sceltissimi che intervennero, fece riuscir magnifica l’Acca-demia […]. Le virtù dell’Ottimo Principe che ne governa aprirono unlargo campo all’estro de’ Poeti, e fu grandissimo l’applauso che riscos-sero tutte le produzioni ascoltate in simile occasione. I dotti Arcadi cheformavano l’Accademia, corrisposero tutti coll’eccellenza delle Rime, edella dotta Prosa al grande Argomento proposto, e alla celebrità del loronome.8
Dei ventuno brani recitati (tutti poetici, tranne la Prosa iniziale dimonsignor Aurelio Roverella), il sedicesimo è appunto l’«Anacreontica»del Monti, «uno de’ XII Colleghi d’Arcadia».9 A confermare l’accoglienzatrionfale della composizione, e ad informarci sulla sua pressoché fulmi-nea stesura, interviene lo stesso autore in una dettagliata cronaca speditadue giorni dopo al Vannetti, che risulta essere quindi il primo destinata-rio di essa:
io vi mando, per non star ozioso, una canzonetta recitata domenica seraal Bosco Parrasio per i voti quinquennali in onore di N. S. Pio Sesto.Dacché sono in Roma io non ho mai detta in Accademia cosa che abbia destatomaggior strepito di questa canzonetta, [la quale] non è la cosa la più insof-fribile, eppure fu ste[sa nel termine] di due soli giorni. Un Cardinale hapensato [che si] debba far copiare in carattere dorato (vedete che paz-zia!) e attaccarla con un bottone di metallo tra due laminette di cedroall’erma di Pericle, quando sarà portata in Vaticano.10 Ma non si farà
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 131
8 BAR, Atti Arcadici, ms. 5, nell’ordine cc. 196 (le prime due citazioni) e 197 (larestante). Per quanto concerne il secondo ed il terzo brano trascritto, è interessante ri-levare la quasi perfetta rispondenza fra il verbale arcadico ed il Diario Ordinario, nr. 486,In data delli 28 Agosto 1779, In Roma, Nella Stamperia Cracas presso S. Marco al Corso,1779, rispettivamente pp. 7 ed 8.
9 BAR, Atti Arcadici, ms. 5, c. 198; cfr. Diario Ordinario, nr. 486, p. 10.10 Sempre al Vannetti, che evidentemente gli aveva chiesto chi avesse lanciata tale
idea, l’autore poco più di tre settimane dopo risponde: «Il Cardinale che vorrebbe la can-zonetta di Pericle appesa al busto del medesimo è [scil., il faentino Giovanni Carlo] Bo-schi» (MONTI, Epistolario, vol. I, lettera 63, «Roma, 19 Settembre 1779», pp. 86-88, ap. 87), che però non viene annoverato fra i sette «E.mi Cardinali» presenti in quell’Adu-nanza (BAR, Atti Arcadici, ms. 5, c. 196, dove sono menzionati «[scil., Andrea] Corsini,[scil., Lazzaro Opizio] Pallavicini Segretario di Stato, [scil., Bernardino] Giraud, [scil.,Leonardo] Antonelli, [scil., Marcantonio] Marcolini, Gio. Battista Rezzonico, e [scil.,
niente di questo, perché io non darò mai a’ miei nemici questa occasionedi mettermi in ridicolo. Questa canzonetta si stampa adesso in Romada due stampatori differenti in due raccolte,11 e si stamperà forse ancora
Mauro Sarnelli132
Romualdo] Guidi»). Tale numero è specificato anche nel resoconto dell’adunanza chel’autore fa al fratello Francesco tre giorni dopo di essa: «Domenica sera al Bosco Parra-sio si tenne adunanza per i voti quinquennali del Papa. Io recitai una canzonetta, la qualemise furore in tutta l’udienza, finita la quale i Cardinali che erano venuti a sentire l’Ac-cademia in numero di sette, mi chiamarono e si rallegrarono meco di una maniera parti-colare. Sopra tutti il Cardinale Segretario di Stato, da cui devo portarmi dimattina conuna copia ben polita della canzonetta. Ve ne saprò dir l’esito» (MONTI, Epistolario, vol.I, lettera 60, A Francesco Monti – Fusignano, «Roma, 25 Agosto 1779», pp. 83-85, ap. 84; corsivo aggiunto).
11 Quest’affermazione è solo per metà suffragata dalle testimonianze editoriali, poi-ché a tutt’oggi si conosce la prima stampa arcadica della Prosopopea, in I Voti Quinquen-nali celebrati dagli Arcadi nel Bosco Parrasio ad Onore della Santità di Nostro Signore PapaPio VI (s.l. [ma Roma], Nella Stamperia Salomoni [colophon], s.a. [ma 1779 (citati comeVQ)], pp. 55-60), ma non un’altra romana dello stesso anno, e ne dovranno trascorreredue per trovarla inserita nel tomo XIV delle Rime degli Arcadi (In Roma, Presso PaoloGiunchi, 1781 [citato come A], pp. 58-63). Al riguardo, viene da formulare un’ipotesi,tenendo presente che in quest’ultimo tomo confluiscono, oltre al brano montiano, altretre composizioni già stampate in VQ, e precisamente i sonetti «Va, FIGLIO, e regna; esul regnar primiero», in cui «Parla la Gloria», del padre somasco GIO. BATTISTA RIVA
(VQ, p. 53; A, p. 40, dove manca la didascalia iniziale, sostituita dal titolo riportatonell’Indice del tomo, pp. Ir-XIIv finali non num., a p. IIv: Al Grande ed immortale PIOVI. La Gloria); «Quei voti, o PIO, che un dì superba e strana», dell’abate GIUSEPPE MA-ROTTI (VQ, p. 74; A, p. 183: nell’Indice, p. VIr finale non num., il titolo è I voti quin-quennali celebrati alla Santità di N. S. Papa Pio Sesto); e «La torbid’onda, che le Volscheapriche», dell’abate DOMENICO TESTA (VQ, p. 75; A, p. 403, dove il brano presenta al-cune varianti, a partire dall’incipit: «L’onda orgogliosa, che le Volsche apriche»). Si po-trebbe pensare ad un previsto e non realizzato inserimento della Prosopopea e di altre com-posizioni presenti in VQ all’interno del tomo XIII delle Rime degli Arcadi (In Roma,Presso Paolo Giunchi, 1780), la cui «Compilazione […] fu posta in ordine fin dal prin-cipio dell’anno precorso, e poi interrotta per dovere attendere le poesie di qualche illu-stre Autore» (Ai Leggitori, pp. xii-xiii, a p. xiii) – tomo in cui campeggiano i nomi deimaggiori «Compastori delle Colonie Italiane» (ibid., p. xii), dal Parini al Bettinelli, dalRezzonico ad Agostino Paradisi, dal Savioli al Cesarotti, dal Varano all’Algarotti, dalPindemonte al Bertòla, con l’aggiunta post mortem del Frugoni –: inserimento poi rite-nuto fuori luogo (proprio in senso geografico) e dirottato, con il molto parziale “recu-pero” delle quattro composizioni poco sopra menzionate, nel già progettato A (infattiibid., p. xiii, si legge come fosse «già in pronto una simile collezione di Rime degli Ar-cadi esistenti in Roma pel Tomo XIV»). Sulla circostanza per cui il Pizzi, «legandosi alBettinelli e a tutti i letterati della fascia lombarda, veneta ed emiliana (in particolare,[…] ai poeti della Colonia parmense), grazie cioè ad una operazione di recupero e di
in Ferrara,12 perché un mio amico l’ha mandata colà a questo effetto. Iorido del fanatismo, per destar il quale ci vuole così poco. Leggete voi ilcomponimento, e conoscete quanto siano sciocche le menti degli uo-mini.13
Di là dalla topica deminutio con cui il Monti parla della sua opera, laprecisione nel descrivere l’eventuale collocazione di essa e la repentinasmentita di tale possibilità danno più l’impressione di un timore che ilprivilegio non venga concesso (magari attraverso l’intercessione del Se-gretario di Stato Pallavicini),14 che di una reale contrarietà dell’autore, ilquale – come si avrà modo di vedere – cinque anni dopo non solo accon-sentirà all’esposizione della Prosopopea, ma altresì vi interverrà sul testoper la quinta, e penultima, volta. Anche perché il Monti si rende benconto che si tratterebbe di un onore altissimo, a lui concesso più o menoin contemporanea, e non a distanza di secoli o comunque di decenni,com’era accaduto ai carmi latini di Baldassarre Castiglione e di Agostino
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 133
riassorbimento delle più vive energie poetiche, poteva […] sperare di restituire all’Ar-cadia, nonché un certo formale prestigio, anche una rinnovata funzione culturale», si ve-dano LUCIO FELICI, L’Arcadia romana tra Illuminismo e Neoclassicismo, in “Arcadia. Acca-demia Letteraria Italiana. Atti e Memorie”, s. 3a, vol. V, fasc. 2°-3° (1971), pp. 167-82(la citazione è da p. 173); e MARIA TERESA ACQUARO GRAZIOSI, L’Arcadia. Trecento annidi storia, Roma, Palombi, 1991, p. 36. A latere, possono risultare interessanti due cir-costanze: la prima è che, scorrendo «il Catalogo» degli arcadi partecipanti all’adunanzadel 22 agosto, elencati «secondo l’ordine che recitarono», soltanto il Riva, il Marotti edovviamente il Monti vi presentano i loro componimenti, indicati come di consuetudinecon la sola forma metrica (BAR, Atti Arcadici, ms. 5, cc. 197-98, a c. 197); la secondaè che il sonetto del Testa celebra l’opera di bonifica promossa dal pontefice, e che al v.9 «L’Autore allude al suo Poemetto intitolato: Il Disseccamento delle Paludi Pontine» (VQ,p. 75, n. 1; tale n. non compare in A, p. 403), pubblicato l’anno precedente l’evento ar-cadico (In Roma, Dalle Stampe del Casaletti a S. Eustachio, 1778), e da annoverarequindi nel filone delle opere che conducono alla Feroniade montiana (su tale tematica, sivedano altresì, infra, nn. 18 e 25).
12 In Raccolta di Opuscoli Scientifici, e Letterarj di Ch. Autori Italiani, In Ferrara, PerGiuseppe Rinaldi, 1779, 3 tt., III [citato come F], pp. 182-87; entrambi gli imprima-tur di questo tomo recano la data «Die 20 Nov. 1779» (p. non num. che segue l’Indiceposto al termine delle pp. iniziali, con numerazione autonoma, p. 23).
13 MONTI, Epistolario, vol. I, lettera 59, al Vannetti, «[Roma,] 24 Agosto [1779]»,pp. 82-83; corsivi aggiunti.
14 Il passo della lettera al fratello Francesco, relativo all’interesse di questo cardi-nale per il brano montiano, è riportato supra, n. 10.
Favoriti sulla statua ritenuta di Cleopatra (ma raffigurante in realtà Ariannaabbandonata), i quali, «incisi in marmi per ordine di Clemente XI […],[…] veggonsi nel Museo [scil., Pio-Clementino] a’ lati del simulacro».15
Si è già constatato come l’iniziativa editoriale di VQ traduca in pla-quette l’evento del 22 agosto, rispondendo alla duplice funzione sincro-nico-celebrativa e diacronico-memoriale, con variazioni ed accrescimentivòlti a fornirle un carattere autonomo. A confrontare il verbale dell’adu-nanza con VQ, emerge una sostanziale rispondenza, pur se vanno riscon-trati un’omissione,16 alcuni spostamenti nell’ordine dei brani (giustifi-
Mauro Sarnelli134
15 ENNIO QUIRINO VISCONTI, Le Opere, Classe Prima, Il Museo Pio Clementino [nelfrontespizio del solo vol. I compare altresì il nome del padre GIAMBATTISTA, che era statoprefetto delle antichità di Roma; nei voll. VI-VII fra i due aggettivi è aggiunto il trat-tino], Milano, Per Nicolò Bettoni [così nel vol. I, mentre nei voll. II-VII: Presso gli Edi-tori], 1818-22, 7 voll., II, 1819, Tavola XLIV (Cleopatra), pp. 280-88 (a p. 280, n. 1).Su questa scultura, si veda altresì S<IMON>.-C<ELESTIN>. CROZE-MAGNAN [tt. I e II]– E<NNIO>.-Q<UIRINO>. VISCONTI ET T<OUSSAINT>.-B<ERNARD>. ÉMERIC-DAVID [tt.III e IV], Le Musée français, recueil complet des tableaux, statues et bas-reliefs, qui composent lacollection nationale; Avec l’explication des Sujets, et des Discours historiques sur la Peinture, laSculpture et la Gravure, Publié par Robillard-Péronville et <Pierre-François> Laurent,Paris, De l’Imprimerie de L.-É. Herhan [tt. I-III] – De l’Imprimerie de Mame Frères [t.IV], 1803-09, 4 tt., IV, 1809, «troisième partie», [n° 9,] Ariadne, dite la Cléopâtre, sta-tue. Negli esemplari consultati della monumentale opera (vera e propria esaltazione delclassicismo napoleonico), custoditi presso la Città del Vaticano, Biblioteca ApostolicaVaticana [citata come BAV], alla segnatura Cicognara. XII. 3413, le quattro parti del t.IV si trovano rilegate nel t. III, 1807 (dopo l’iniziale Discours historique sur la Gravure entaille-douce et sur la Gravure en bois, pp. 1-60), e viceversa (sempre dopo l’iniziale Discourshistorique sur la Peinture moderne, pp. 1-100), e presentano una numerazione delle pagineevidentemente aggiunta a posteriori, con una stampigliatura meccanica ad inchiostro neroposta sul recto di ognuna di esse, al margine inferiore destro, in quanto tali parti veni-vano stampate come una sorta di “fascicoli” autonomi; lo testimonia una nota posta incalce alla tavola di «Antiques du Musée Napoléon contenues dans la seconde partie dutome IV» (p. 82r), di cui si trascrive l’inizio:«Cet ordre, qui ne sauroit être regardé quecomme provisoire, est proposé ici pour la commodité des Souscripteurs qui voudroientfaire relier les différentes parties du Musée français avant que les quatre-vingts livrai-sons, composant les quatre volumes, soient distribuées». Secondo la numerazione ag-giunta delle pagine del t. III, la scultura in questione viene trattata alle pp. 148r-v, acui fa séguito l’incisione di essa («Dessiné par [scil., Pierre] Bouillon. Gravé par [scil.,Albert (o Albrecht) Christoph] Reindel»), p. 149r. Sulle “fonti” della Prosopopea, tra lequali il brano del Castiglione occupa un posto preminente, si veda infra. Là dove nonspecificato diversamente, il Visconti di cui si parlerà e da cui si citerà è Ennio Quirino.
16 Si tratta del sonetto recitato da «Monsig.r Onofrio Alfani Uditore della Segna-tura di Giustizia» (BAR, Atti Arcadici, ms. 5, c. 198).
cati nel colophon),17 e diverse aggiunte, fra cui la più interessante ai fini diun discorso incentrato sul Monti è quella relativa al sonetto «Biancha laveste, e bianchi i vanni avea».18
Il successo di quest’operazione encomiastica è immaginabile, e vienesancito nei primi giorni dell’anno successivo dalle “Effemeridi Letterariedi Roma”, che esordiscono l’annuncio della raccolta con l’approvazionedel tema prescelto, e lo siglano con la lode dei partecipanti, fra cui l’«erededell’Ovidiana spontanea facilità il Sig. Ab. Monti»:
Qual più felice, più fecondo, e più giusto argomento di canto per l’Apol-lineo coro, che quello di far de’ voti per la lunga, e prospera vita dell’im-mortale PIO VI? […] Niuna maraviglia adunque se fra le raccolte Ar-cadiche, che son pur tutte squisite, e ripiene di elegantissime produ-zioni, si distingua in certo modo, e sovra le altre si erga questa, che oraannunciamo. […] ve n’ha in somma di tutti i più canori cigni, che fannoora più soavemente risuonare il nostro Bosco Parrasio, e che sembrano anzi
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 135
17 Il colophon del volumetto esprime soltanto la parte relativa al lavoro di collazionetipografica, con una speciale attenzione a non urtare la suscettibilità degli autori in me-rito alla sequenza dei brani: «Le presenti Rime, approvate da’ Censori d’Arcadia, nonritengono altr’ordine, che quello che loro han dato il tempo, in cui sono state raccolte,e la miglior disposizione della stampa».
18 VQ, p. 61: è questo certamente uno dei due sonetti la cui trascrizione è annun-ciata dall’autore nella già ricordata lettera dell’8 gennaio 1780 all’Albergati Capacelli,e che «riguardano tutti e due le lodi di Pio Sesto, e sono di diverso carattere tra loro»(ROMANO, Giunte e ritocchi per l’epistolario montiano, p. 559; per le precedenti edd. di que-sta lettera, si veda supra, n. 1); dell’altro, a tutt’oggi non si ha traccia. Ulteriori aggiunte,extramontiane, sono gli sciolti Alla Santità di Nostro Signore Papa Pio Sesto, del PIZZI, cheaprono VQ, pp. 1-4; la parafrasi in distici latini del sonetto «O sempre lieto ed onoratogiorno» (dell’abate FRANCESCO ANTONIO ZACCARIA), «Dum tua, MAGNE PATER, repe-tis post taedia morbi», ad opera dell’abate GIUSEPPE NICCOLÒ PLACIDI, a cui si deve an-che l’epigramma «Gratia sit superis! Morbi vis improba cessit» (ibid., nell’ordine pp.36-37 e 38); l’altro epigramma «Pontinos late campos demergier undis», dell’abate GIO-VANNI FRANCESCO BORGHI (ibid., p. 62: su questo tema, si veda supra, n. 11, ed infra,n. 25); il sonetto «Non tanto plauso fé il Tarpeo, che avvinti», del padre agostinianoscalzo GIUSEPPE MARIA NICOLAI (ibid., p. 66); il lungo capitolo in terzine «Sacro è a PIOquesto dì: per l’aria i venti», del MAROTTI (ibid., pp. 67-73); il già ricordato sonetto delTESTA (cfr. nuovamente supra, n. 11); quello del conte GIAMBATTISTA CRISOLINI, «Quelveggio innanzi, a cui tutto s’oscura» (ibid., p. 76); e l’ode-canzonetta finale «Roma letristi lagrime», del conte GIROLAMO FANTAGUZZI, che riprende nel metro la quartinasavioliana adottata dal Monti nella Prosopopea (ibid., pp. 77-79).
avere ingrandita, e nobilitata la loro maniera nel dover cantare su di un sì su-blime argomento.19
Eppure, come lo stesso Monti ricorda in una lettera di poco meno didue mesi dopo al Vannetti, una voce che si distacca da tale coro festeg-giante è quella inizialmente attribuita ad «un certo Abate Galfo, ex ge-suita siciliano», che «fu autore di una satira contro l’Accademia del Bo-sco Parrasio (nella quale io recitai la canzonetta di Pericle) e in essa ogniaccademico era ferito, chi più, chi meno».20 Questa «satira» è il sonettocaudato tràdito da Giovanni Cristofano Amaduzzi, dal titolo Per l’adu-nanza Arcadica nel Bosco Parrasio il dì 22 7bre [sic] 1779, nel quale il Montiviene sostanzialmente accusato di plagio, con l’affermazione che «del suoMinzon volò sull’ali».21 E nella stessa lettera al Vannetti, il Monti tra-scrive i due sonetti satirici, che secondo la consuetudine di tale generesono anch’essi caudati, nei quali parte al contrattacco di quello che a taledata ritiene essere l’autore del brano incriminato: «E un tristo Lojolita,un Prete macro», ed «O nudrito del tosco e della bava».22 Salvo poi chetale attribuzione di responsabilità viene prima spostata dal Monti, poismentita dal Galfo: dal primo, in una lettera indirizzata sempre al Van-netti il mese successivo a quella appena ricordata, dove come ispiratore èfatto invece il nome del fondatore dell’Accademia degli Aborigeni (su cui
Mauro Sarnelli136
19 “Effemeridi Letterarie di Roma”, t. IX («contenente le opere enunciate nell’annoMDCCLXXX»), n° II («Li 8 Gennaro»), rispettivamente pp. 9 (le prime due citazioni)e 9-10 (la restante): il corsivo aggiunto è per ribadire la topicità del concetto di «su-blime» applicato alla letteratura laudativa, e più ancora per far risaltare la sintonia dellacomposizione montiana con le aspettative concettuali e le linee di gusto dell’ambienteentro cui questa prende forma.
20 MONTI, Epistolario, vol. VI (1824-1828), Appendice ai volumi precedenti, let-tera 3045, al Vannetti, «Roma, 16 Ottobre 1779», pp. 419-21 (a p. 420).
21 Le due citazioni sono da ROMANO, Le polemiche romane del Monti, nell’ordine p.225, n. 75, e p. 226 (ripreso ad litteram in ID., Le polemiche romane di Vincenzo Monti (1778-1797), p. 27, n. 83, e p. 28). Il sonetto aveva vista la luce grazie al VICCHI, VincenzoMonti, le lettere e la politica in Italia dal 1750 al 1830 (Triennio 1778-1780), pp. 309-10,che ne aveva mutato il titolo in Per l’adunanza del 23 agosto 1779 in lode di Pio VI (spie-gandone la motivazione a p. 310, n. 1), titolo riproposto nei due contributi del Romanoappena ricordati.
22 MONTI, Epistolario, vol. VI, rispettivamente pp. 420-21 e 421. Tale ed. è tra-scritta in ROMANO, Le polemiche romane del Monti, pp. 227 e 227-28; ed in ID., Le pole-miche romane di Vincenzo Monti (1778-1797), pp. 29 e 29-30.
si ritornerà poco oltre), il canonico Francesco Maria Turris, destinatariodi un sonetto satirico composto per l’occasione, nella cui coda vengonoindicati alcuni probabili autori, il primo dei quali è il Galfo;23 dal se-condo, in una «lettera apologetica» stampata l’anno seguente, in conclu-sione della quale egli nega di essere «stato l’autore del clandestino male-dico sonettuccio».24
Per contribuire ad illuminare il clima ben più che emulativo, anzifortemente agonistico, delle accademie romane – composite espressionidi realtà politiche e culturali in bilico fra l’istituzionale ed il personali-stico –, converrà ricordare come, nell’ultima terzina del sonetto controil Turris, il Monti faccia cenno della circostanza per cui «l’Accademiac-cia di que’ suoi / Disgraziati poeti Turdinoni / Atterrì quella che facesteVoi». Il riferimento è all’Adunanza tenuta dagli Aborigeni il dì XIII LuglioMDCCLXXIX in ossequiosa dimostrazione di vivo, e sincero giubilo per la rista-bilità Salute di Sua Santità Pio Sesto Pontefice Massimo gloriosamente regnante:un evento che batte sul tempo quello arcadico del mese successivo sulmedesimo tema, in cui verrà appunto recitata la Prosopopea. Come perl’adunanza arcadica del 22 agosto, anche questa riunione degli Abori-geni ha il suo esito editoriale, molto meno ravvicinato però dell’altro, inquanto vedrà la luce due anni dopo, quale prima delle due «Appendici»che fanno séguito alla Parte II delle Rime degli Aborigeni.25 Per tale cele-
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 137
23 Cfr. MONTI, Epistolario, vol. I, lettera 71, al Vannetti, «Roma, 19 Novembre1779», pp. 96-98 (nell’ordine alle pp. 97 e 97-98): «Per riempire il foglio eccoti un so-netto satirico sopra un certo canonico Turris, dittatore d’una certa accademia degli Abo-rigeni, che Pizzi chiama la Turdinona. Così appella[r]si in Roma il teatro dove recitansile commedie e le tragedie per il popolaccio transteverino. Questo Turris fu promulga-tore di quella satira sopra i Voti quinquennali, di cui vi scrissi tempo fa, attribuita a Galfo,e in risposta della quale io feci quei due sonetti»; i vv. 21-24 della coda del sonetto,dall’incipit “epistolare” «Pizzi agli Arcadi invitti. Ho alfin saputo», suonano infatti: «Mai versi chi li fe’? / Non so dirvi se Galfo, o pur [scil., Giuseppe] Casali, / O [scil., Gre-gorio] Nardecchia, o Berardi [su cui si veda supra, n. 1] od altri tali / Poetici animali».
24 ANTONINO GALFO, Il trionfo della verità o sia lettera apologetica [1780], ed. modernain ROMANO, Le polemiche romane di Vincenzo Monti (1778-1797), pp. 107-23 (a p. 123).
25 Adunanza tenuta dagli Aborigeni il dì XIII Luglio MDCCLXXIX […], in Rime degliAborigeni prodotte in diversi tempi nella loro Adunanza in Roma. Parte II. Alla Santità di No-stro Signore Pio Sesto Pontefice Massimo, Roma, Dalla Salomoniana addetta alla medesimaAccademia, 1781, pp. 137-90. La seconda «Appendice» è costituita dagli atti dell’Adu-nanza tenuta dagli Aborigeni li XX Giugno MDCCLXXX ad onore della Santità di N. S. Pio Se-sto Pontefice Massimo Principe Provvidentissimo (con numerazione autonoma delle pagine):
brazione vengono stampati i brani composti non soltanto da due dei quat-tro «Poetici animali» di cui il Monti fa il nome (cioè il Nardecchia ed ilGalfo),26 ma altresì dall’autore di cui era stato ritenuto l’epigono nella«satira» poco sopra menzionata (ovvero, come si ricorderà, il Minzoni).27
Mauro Sarnelli138
in essa – introdotta dalla Prosa di monsignor ALESSIO FALCONIERI (pp. 3-15), e conclusadalle sedici ottave di LUIGI ROMANELLI (Gl’infortunj di Roma dileguati dalla Clemenza diTito, pp. 50-55) –, riveste una speciale importanza la tematica inerente alla bonifica pon-tina (sulla quale si vedano supra, nn. 11 e 18), celebrata nell’«Anacreontica» dell’abateFRANCESCO PISTAROZZI, in quartine savioliane (Per il diseccamento delle Paludi Pontine, pp.20-24); nei sonetti degli abati FRANCESCO TRUZZI (Si allude al prosciugamento delle Pa-ludi Pontine, ed al ristauramento della Via Appia, p. 28, la cui seconda quartina è artico-lata in due domande dirette di quelle che al v. 1 sono definite «Di Claudio, e d’Otta-vian l’Ombre affannose») ed ALESSANDRO VISCONTI (Disseccamento delle Paludi Pontine,p. 35), nonché in quello del canonico LUIGI SUBLEYRAS (Disseccamento delle Paludi Pon-tine tentato invano da molti, e soltanto eseguito sotto gli auspicj di Sua Beatitudine, p. 45); e ri-cordata in numerose altre composizioni. La medesima tematica si trova celebrata altresìnella Parte II delle Rime degli Aborigeni: nella seconda quartina del sonetto iniziale,dell’abate LORENZO SPARZIANI («Dalle virtudi, ond’è il gran PIO vestito», p. 17), ed inquello di monsignor ANTONIO PALOMBI (Disseccamento delle Paludi Pontine ordinato, ed ese-guito dalla Santità di N. S. PIO SESTO Pontefice Massimo, p. 125). Sul sonetto conclusivodi questa raccolta, si veda infra, e n. 121. Per i resoconti di queste due adunanze, si vedail Diario Ordinario: nr. 474, In data delli 17 Luglio 1779, In Roma, Nella Stamperia Cra-cas presso S. Marco al Corso, 1779, pp. 12-14; e nr. 574, In data del I Luglio 1780, InRoma, Nella Stamperia Cracas presso S. Marco al Corso, 1780, pp. 2-6.
26 In Adunanza tenuta dagli Aborigeni il dì XIII Luglio MDCCLXXIX, sono rispettiva-mente: il sonetto «Nel dì, che l’almo Successor di Piero», del NARDECCHIA, p. 169; el’«Anacreontica» in quartine savioliane «Muse, mentr’io di lagrime», del GALFO, pp.182-89. Di questi due autori, la Parte II delle Rime degli Aborigeni presenta, del primo,un sonetto e tre «Anacreontiche» in strofe savioliane (nell’ordine pp. 33, 34-39, 40-46e 47-52: quest’ultima, dal titolo La Porpora, definita «Canzonetta Anacreontica»); e delsecondo, cinque sonetti ed una «Canzonetta», anch’essa in quartine savioliane (rispetti-vamente pp. 19, 97, 107-09 e 98-106). Degli altri due «Poetici animali», ossia il Ca-sali ed il Berardi, le raccolte di quest’Accademia annoverano, del primo, cinque sonetti(i tre iniziali della Parte I delle Rime degli Aborigeni, pp. 17-19; uno nella Parte II, p. 60;ed uno nell’Adunanza tenuta dagli Aborigeni li XX Giugno MDCCLXXX, p. 34); e del se-condo, un sonetto (nella Parte II, p. 54).
27 In Adunanza tenuta dagli Aborigeni il dì XIII Luglio MDCCLXXIX, p. 181, si trattadel sonetto «Vieni, diceva il Ciel, vieni grand’Alma». Ad una lettura delle due Partidelle Rime degli Aborigeni, il Minzoni appare come uno degli autori più rappresentati, inparticolare nella I di esse, in cui sono compresi ben venti suoi sonetti (pp. 34-41, 59-62 [di cui gli ultimi due costituenti un dittico sui personaggi ariosteschi di Rodomonte,Ruggiero e Mandricardo], 86-88, 93-96 [una corona composta Sulla morte del Padredell’Autore in occasione di un’Accademia fatta poco dopo in lode di M. V. alla quale soleva ogni
E considerato il fatto che, come il Monti dichiarerà nella nota alla suaultima redazione della Prosopopea, questa viene «scritta ad insinuazionedel fu Ennio Quirino Visconti, mentre che egli era Direttore del MuseoVaticano»,28 assume un rilievo significativo la presenza di quest’ultimo,con il sonetto Pel passaggio della Santità di N. S. PIO PP. VI dal suo sog-giorno del Vaticano a quello del Quirinale dopo essersi ristabilito dalla lungaMalattia,29 ad un’adunanza nella cui Introduzione, del padre GregorioGiusti, sono contenuti alcuni spunti che potrebbero andare ad arricchirel’indagine sul panorama in cui il nostro brano si viene a calare.
Ma per far risaltare nella giusta prospettiva il rapporto Monti-Visconti,quale fondamentale motore ideativo della Prosopopea, prima di affrontarela lettura del lungo panegirico del Giusti, è necessario compiere un passoindietro, prendendo in considerazione uno stralcio del Discorso preliminare(indirizzato proprio al Visconti) al Saggio di Poesie, dedicatoria che risultagià scritta alla fine di giugno del 1779.30 Nel finale di essa, dopo l’esal-
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 139
anno assistere] e 99), e gli «Sciolti» Donasi ad un Fanciullo la Immagine di San Luigi Gon-zaga (pp. 63-70); mentre la Parte II testimonia tre sonetti (pp. 122-24).
28 MONTI, Opere varie, Milano, Dalla Società Tipog. dei Classici Italiani, 1825-27,8 voll., III, Poesie varie, 1826 [citate come M], p. 297, n. 12 (riferita a p. 49: la Prosopo-pea infatti è alle pp. 49-53).
29 Adunanza tenuta dagli Aborigeni il dì XIII Luglio MDCCLXXIX, p. 180 (incipit: «Nonè, Fiume Roman, questo che scuote»); poi compreso in VISCONTI, Versi, Raccolti percura di Pietro Visconti suo Nipote ed al Ch. Sig. Ab. Don Melchiorre Missirini dedi-cati, in Opere varie Italiane e Francesi, Raccolte e pubblicate per cura del Dottor GiovanniLabus, Milano, Co’ torchi della Società Tip. de’ Classici Italiani [vol. I] - Presso Anto-nio Fortunato Stella e Figli [voll. II-IV: sul retrofrontespizio di questi voll. comparel’indicazione: «Co’ torchi della Società Tipogr. de’ Classici Italiani» (nel IV, con la va-riante: «Dalla Società Tipografica de’ Classici Italiani»)], 1827-31, 4 voll., IV, 1831,pp. 601-96 (a p. 614). A latere, si fa presente che presso la BAR, alla segnatura SS. [concapanna intera] 10. 1*, interno 11, è conservato un estratto di questi Versi, con nume-razione autonoma delle pp., che però non comprende la traduzione dell’Ecuba euripidea(sulla quale si veda infra, n. 32).
30 Cfr. MONTI, Epistolario, vol. I, lettera 53, al Vannetti, «Roma, 30 Giugno 1779»,pp. 72-74 (a p. 72): «[scil., nel Saggio] Oltre alla lettera che troverete a voi diretta ve nesaranno altre due. Una all’abate Minzoni celebre, e l’altra a mons. Visconti di Roma,giovane dell’età mia, e di talenti maravigliosi ed unici in questa città». I riferimentisono ad ID., Saggio di Poesie, nell’ordine pp. 65-73 (Lettera dell’Autore al Sig. CavaliereClementino Vannetti di Roveredo), pp. 158-68 (Al Signor Abate Onofrio Minzoni Ferrarese), epp. xiij-xxx (Discorso preliminare al Chiarissimo Monsignore Ennio Quirino Visconti Camerierd’onore di Nostro Signore Pio Sesto). Su di esse e sulle altre quattro dedicatorie contenute
tazione della poesia davidica, l’autore si rivolge al suo interlocutore peresortarlo ad occuparsi ancora di letteratura, facendo esplicita menzionedel ritrovamento dell’erma di Pericle, a cui significativamente è già at-tribuito un carattere personificato, «che prefigura la prossima scadenzapoetica»:31
Ma io sono un pedante in ripeter cose già note, specialmente a Voi, ve-neratissimo Monsignore, che più d’una volta vi siete accordato meco afavore di David contro i vostri Greci. Dico vostri, perché sin dall’età ditredici anni voi ne succhiaste il latte, e stringeste con essi familiarità,recando fin d’allora in sì bei versi toscani qualche tragedia d’Euripide,che Roma se ne ricorda ancora con maraviglia.32 I Greci intanto sonostati essi che vi hanno reso quel nobile e leggiadro poeta che siete. Diqui nasce a voi la ragione di esserne tanto innamorato: ma se fosse le-
Mauro Sarnelli140
nell’opera (Incomparabile Climene Teutonica, pp. v-xij, datata «ROMA, 8 Giugno 1779»;Al Nobil Uomo il Signor Conte Francesco Marescalchi Patrizio Ferrarese, pp. 130-33; A Mon-sieur Jean Ferry de Fano, pp. 195-203; e quella al Metastasio, ricordata supra, n. 1), dopola segnalazione di ANTONIO VISCARDI (Le dedicatorie montiane del “Saggio” livornese, in“Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti”, s. II, vol. LXI [1928], pp.791-98), si è appuntata l’attenzione degli studiosi che si sono dedicati a questa fase dellaproduzione poetica dell’autore: ai contributi critici ricordati supra, n. 5, si aggiungaquello filologico di IVANOS CIANI, Le prime raccolte poetiche di Vincenzo Monti, in “SFI”,vol. XXXVII (1979), pp. 413-95 (alle pp. 428-44). Di tali dedicatorie, quelle al Vi-sconti ed al Ferry (Giovanni Ferri) hanno avuta l’ed. moderna, a c. di Carlo Muscetta,in MONTI, Opere, rispettivamente pp. 999-1009 e 1010-14.
31 BRUNI, Monti nella Roma neoclassica, p. 27.32 Il riferimento è qui alla «versione dell’Ecuba di Euripide fatta sul testo greco dal
N. A. nella età di tredici anni. Essa fu impressa in Roma presso Arcangelo Casalettinel 1765, ma l’edizione riuscì scorrettissima, e gli esemplari non vennero posti in com-mercio. Noi, mercè l’amicizia onde ci onora l’insigne archeologo Bartolommeo Bor-ghesi, abbiamo potuto averne una copia tratta da quello che conservasi nella Biblio-teca di Savignano, sopra il quale è scritto di carattere dell’Amaduzzi: “Opera non maipubblicata, essendo anche senza frontespizio, ch’è stato supplito da me colle stampe diPropaganda”» (premessa, firmata «Gli Editori», a VISCONTI, Versi, p. 602; l’Ecuba. Tra-gedia di EURIPIDE. Trasportata in Versi Italiani da Ennio Quirino Visconti Fanciullo Ro-mano, con l’indicazione fra parentesi della prima stampa, è ibid., pp. 635-96). In MONTI,Opere, ed. Muscetta, pp. 1007-08, n. 3, il curatore rimanda ad una «nota dell’ed. Re-snati», in cui è compendiata tale notizia (cfr. ID., Opere, Milano, Presso Giovanni Re-snati [t. I-II; i tt. III-VI aggiungono: «e Gius. Bernardoni di Gio.»], 1839-42, t. VI,Epistolario [...] riordinato ed accresciuto di molte lettere non prima stampate o raccolte, 1842,pp. 458-68, a p. 466, n. *).
cito indovinare i pensieri dei morti, si potrebbe credere che anche i Grecisiano innamorati di Voi, o che almeno abbiano la smania, dirò così, divedervi, e di essere veduti. Ne avete una prova in Pericle, il quale dopo diessere stato nascosto per tanti secoli agli occhi diligenti della curiosa posterità,dalle campagne di Tivoli di dove è stato disotterrato, è venuto ultimamente a tro-varvi, e a farsi da voi riconoscere in persona con un bel volto degno veramented’Aspasia, e con un grand’elmo in testa scolpito dal bravo artefice forsesulla forma di quello che portava quel giorno che vinse i Sicioni. Ma ionon vorrei che in grazia di Pericle vi dimenticaste di Pindaro. Egli daqualche tempo si lamenta che voi interrotta abbiate quella nobilissimaincominciata versione delle sue Odi,33 colla quale sperava vendicarsidelle storpiature fattegli finora da tanti infelici suoi traduttori. Ricor-datevi, Monsignore, che Pindaro non merita questo abbandono. In vecedi contemplare la testa di Pericle, o di esaminar qualche medaglia nonben conosciuta, giacché di medaglie e di antiquaria ne sapete abbastanza,date di piglio alla lira di Pindaro, e arricchitela d’auree corde toscane.34
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 141
33 Il riferimento montiano è qui alle traduzioni dell’XI e XII Olimpica di PINDARO,entrambe in quartine savioliane, poi comprese nelle Riflessioni sulla maniera di tradurPindaro, in VISCONTI, Opere varie Italiane e Francesi, vol. II, 1829, pp. 448-57, nell’or-dine alle pp. 450-51 (note alle pp. 452-53) e 454-55 (note alle pp. 456-57). Il ms. dellaprima di esse: Traduzione dell’Ode XII de’ Vincitori Olimpici di PINDARO, preceduta da unArgomento, e con accanto la «Versio Latina ad litteram», è custodito presso la BAV, allasegnatura Vat. Lat. 10306 (ENNIUS [questo primo nome è un’aggiunta posteriore, e pre-cede la svista «Ioannes», cancellata con un tratto orizzontale] QUIRINUS VISCONTI, Poesieautografe), cc. 1ar-2r. In MONTI, Opere, ed. Muscetta, p. 1008, n. 2, il curatore rinvia aduna n. dell’ed. di questa dedicatoria compresa in ID., Prose scelte critiche e letterarie, connote e prefazione del prof. Raffaello Fornaciari, Firenze, G. Barbèra, Editore, 1896, pp.357-70 (a p. 369, n. 2), dove però il curatore afferma che «le Olimpiche si conservano ine-dite fra i manoscritti della Biblioteca di Parigi», riferendosi evidentemente ai trenta-cinque volumi in-folio che raccolgono i Papiers de l’antiquaire ENNIUS-QUIRINUS VISCONTI,l’inventario dei quali è riprodotto in Bibliothèque National. Catalogue général des manu-scrits français, par Henri Omont, Nouvelles acquisitions françaises, vol. II, Nos 3061-6500,Paris, Ernest Leroux, Éditeur, 1900, pp. 382-94, nni 5966-6000 (in cui non vi è trac-cia di questa traduzione); per le indicazioni sugli altri mss. viscontiani che fanno partedi questa sezione, si veda ibid., Table générale alphabétique des Ancien et nouveaux fonds (Nos
1-33264) et des Nouvelles acquisitions (Nos 1-10000), par A<lexandre>. Vidier et P<aul>.Perrier, t. VI, Paris, s.e. [Bibliothèque National (Le Puy-en-Velay, Imp. “La Haute-Loire”)], 1948, p. 346, ad v.
34 MONTI, Discorso preliminare, pp. xxvij-xxix (corsivo aggiunto); ed. moderna, inOpere, ed. Muscetta, pp. 1007-08.
Alla luce di tali affermazioni, in cui è palese l’insistenza sul busto (esulla figura) di Pericle, come anche sull’importanza della poesia, il sug-gerimento viscontiano a comporre la Prosopopea assume il senso di un “ri-lancio” dell’invito fatto dal Monti: come questi infatti esorta il cultoredella classicità a proseguire la sua opera di trasposizione dell’antico informe moderne, così per converso l’altro lo sprona a creare ispirandosi aduna memoria riapparsa dal glorioso passato.
È facile immaginare la circolazione di questi concetti non dicotomici,bensì assimilativi del dualismo antico/moderno, all’interno dell’ambienteculturale romano dell’epoca, tanto che, per tornare all’Introduzione del Giu-sti, nella parte conclusiva di essa il discorso procede da un contesto cheesalta il «disseccamento delle Pontine Paludi» e la conseguente riaper-tura della via Appia, giungendo ad applicare alla contemporaneità poli-tico-ecclesiastica i moduli del «“classicismo burocratico”» sanciti da Pli-nio il Giovane nel Panegyricus gratulatorio all’imperatore Traiano, espres-samente citato e tradotto pressoché ad litteram dall’autore:35
Deh se potessero dalle lor tombe inalzare le teste gli Appj, i Trajani, iCesari, i Bonifazj, i Martini, deh come tutti palma a palma battendo,non applaudirebbero a PIO? Quelli in vedere dopo lo scorrere neghit-toso e lento di tanti Lustri ritornare novellamente alla luce sciolte dallimaccioso fango, in cui erano sepolte, cotante illustri lor opere; e Que-sti nel veder finalmente eseguita quell’intrapresa, cui, ad onta delle piùgravi spese, applicazioni, e travagli, non poterono aver la gloria di ve-dere a fine condotta. Che se la Morte, come immatura, ed acerba, ri-guardata esser dee di chiunque opere medita grandi, e immortali, e checon nuove, ed utili imprese il nome, e la memoria vie più sempre eter-nando, qualche nuovo ideato intraprendimento tutt’ora in mente rav-volge, forza è che noi, augurando agli aurei giorni di PIO SESTO glianni più lunghi di Nestore, preghiamo che, ravvolgendo la Parca sem-pre più lento di Sua bella vita lo stame, Ei non lo rompa ai giorni no-stri giammai. Sì questo è l’unico sincero universal voto di tutti, che alpietoso Signore ravvolti con incessanti suppliche il dimandano, e di cuiaffidati al Dio proteggitore della Cristianitade, e di Roma, con fervo-rose voci lo pregano. Noi non vi dimandiamo, gli dicano colle parole di
Mauro Sarnelli142
35 L’espressione è di GIAN FRANCO GIANOTTI, Il principe e il retore: classicismo comeconsenso in età imperiale, in “Sigma”, n.s., XII, 2/3 (1979), Gli antichi e i moderni: la que-stione del Classicismo, pp. 67-83 (a p. 80).
Plinio, concordia, non sicurezza, non vi dimandiamo ricchezze, ed onori;è il voto di tutti semplice sì, ma che tutto questo comprende: noi vi di-mandiamo la Salute del PRINCIPE.36 Questa dimandano tutti i buoni daLui sempre amati, le virtù da Lui sempre accarezzate, e protette, le scienzeda Lui sempre seguite, e apprezzate, le arti, e l’industria da Lui in sommariputazione portate, le campagne, l’agricoltura, il commercio da Luitanto giovati; ma quello sopra di tutto più importa, la Religione, e laChiesa che, inalzato nella Sedia di Pietro, Lo venerò, Lo applaudì, e chein ammirarlo animato dalla più forte costanza si ripromette bene a ra-gione, che inimica oltraggiatrice insidia non prevarrà giammai controdi Essa.37
Con la sola differenza che la Prosopopea prende l’avvio dalle campagnedi scavo promosse dal pontefice,38 e non dall’opera di bonifica, in questaparte del brano del Giusti è facile rinvenire almeno cinque spunti ripresidal Monti (trattandosi di un confronto basato su una prospettiva conte-
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 143
36 Cfr. C<AII>. PLINII CAECILII SECUNDI Panegyricus dictus Traiano imperatori, 94, 2,in XII Panegyrici Latini, Recognovit Dominicus Lassandro, Augustae Taurinorum, Inaedibus Io. Bapt. Paraviae et sociorum, 1992, pp. 1-112 (a p. 110): «non concordiam,non securitatem, non opes oramus, non honores: simplex cunctaque ista complexumomnium votum est, salus principis».
37 GREGORIO GIUSTI, Introduzione ad Adunanza tenuta dagli Aborigeni il dì XIII LuglioMDCCLXXIX, pp. 139-63 (alle pp. 161-63).
38 La n. iniziale alla prima redazione del brano montiano recita infatti: «Prosopo-pea di Pericle il di cui busto unico, probabilmente lavoro di Fidia, è stato ultimamentescavato in Tivoli nelle ruine della Villa di Cassio, dopo di essere stata trovata negli anniscorsi l’Erma di parecchi uomini illustri della Grecia, ed anche quella di Aspasia» (VQ,p. 55). Nell’introdurre le descrizioni di tali busti, il Visconti ne sottolinea i ritrovamentigrazie alla politica archeologica patrocinata del pontefice: il primo «Fu trovato vicino aTivoli nello scavo altre volte ricordato della Pianella di Cassio, fatto proseguire a spesedi Sua Santità», ed «Il ritratto di questo illustre Ateniese, ugualmente celebre nella sto-ria civile che in quella delle lettere e delle arti, si è dovuto agli scavi che la munificenzadi Nostro Signore fece proseguire a sue spese ne’ colli Tiburtini, ove si congettura es-sere stata in antico la villa di Cassio» (VISCONTI, Il Museo Pio-Clementino, vol. VI, 1821,Tavola XXIX [Pericle], pp. 150-54, rispettivamente a p. 150, n. *, e nel testo); quellodi Aspasia «fu trovato negli scavi più volte mentovati di Castro-novo, o sia della Chia-ruccia, sul lido del mare, poco discosto da Civitavecchia, intrapresi per ordine di N. S.»(ibid., Tavola XXX [Aspasia], pp. 154-56, a p. 154, n. *). I due busti vengono altresìdescritti in ID., Le Opere, Classe seconda, Iconografia Greca, Recata in italiana favella dalDott. Giovanni Labus, Milano, Presso gli Editori, 1823-25, 3 voll., I, 1823, Tavola XV(Pericle), pp. 176-79; e Tavola XVa (Aspasia), pp. 179-81.
stualizzante, le citazioni sono tratte da VQ):39
1) l’atteggiamento di chi risorge dall’oscurità sepolcrale: «Da i ciechiregni io Pericle / De gli estinti ritorno / L’ingenua luce amabile / A rive-der del giorno» (Prosopopea, vv. 5-8, p. 55);
2) la riemersione dopo un tempo di negativo e colpevole oblio: «Inseno a la recondita / Campagna Tiburtina / Mi seppellì la barbara / Van-dalica ruina» (vv. 9-12, ibid.);
3) la preminenza dell’età moderna sull’antica: «Ed aspettai benefica /Etade in cui l’amica / Dimenticar di Cassio / Magnificenza antica. // […]// Oh come fia che ignobile / Allor vi sembri, e mesta / La bella età di Pe-ricle / In paragon di questa!» (vv. 29-32 ed 89-92, nell’ordine pp. 56 e58);
4) l’augurio di massima longevità, formulato al pontefice da tutti co-loro che lo amano: «Vivi, o SIGNOR. Tardissimo / Al Mondo il ciel ti furi,/ E con l’amor[e] de i popoli / Il viver tuo misuri» (vv. 141-44, p. 60);
5) l’esaltazione della religione cattolica, a conseguente e prevedibilediscapito del paganesimo del vir illustris antico: «Spirto profano e lurido/ A l’ombre avvezzo io sono, / Ma i voti miei non temono / La luce del tuotrono. // Anche del greco Elisio / Nel disprezzato regno / V’è qualche il-lustre Spirito, / Che d’onorarti è degno» (vv. 145-52, ibid.).
Avendo individuati gli spunti che il Monti potrebbe aver assunto, at-traverso il Visconti, dall’attualità, risulterà certo opportuno ampliare talediscorso ad una rassegna di quelle che sono state indicate come le “ma-cro-fonti” della Prosopopea, a partire dalle quattro indicate dal Carducci,ossia due elegie di Properzio (la 2 e la 11 del libro IV), e due carmi latinidel Castiglione (la già ricordata Cleopatra e la Prosopopoeia Ludovici Pici Mi-randulani).40 Di esse, particolarmente significative appaiono la prima delle
Mauro Sarnelli144
39 Nelle esemplificazioni che seguono, si adotta la numerazione originaria dei versi(valida anche per la redazione in F): altrove tale numerazione verrà sempre specificata,per distinguerla da quella che prevede la quartina aggiunta a partire da A (si veda infra,e n. 65).
40 Cfr. CARDUCCI, Famiglia del Monti, pp. 412-13. Per quanto riguarda i carmi delCastiglione, all’ed. segnalata dal Cottignoli (ibid., p. 413, n. 135), si aggiungano quelleprecedenti indicate nelle Note di FRANCESCO BERNI - BALDASSARRE CASTIGLIONE - GIO-VANNI DELLA CASA, Carmina, testo e note a c. di Massimo Scorsone (p. [4]), Torino, Edi-
due elegie properziane e la Cleopatra castiglionesca: l’una perché in essal’artificio retorico della prosopopea viene applicato alla statua di un dio,Vertumno, che eziologicamente parla anche del passaggio da un’antichitàrievocata al presente, concludendosi con l’elogio dell’opera d’arte e conversi forse riecheggiati dal Monti;41 l’altra, «per la concezione classicis-sima […], per il tema archeologico […] e per l’elogio che […] vien fattodel pontefice» (nel caso specifico, Leone X, a cui prima di assurgere alpontificato si deve una prosopopea in giambi che celebra una scultura raf-figurante Lucrezia).42
Dal punto di vista testuale, sono almeno quattro i riscontri offertidalla Cleopatra del Castiglione:
1) i “plutarchiani” vv. 7-10, in cui la regina rivendica la propria ori-gine regale («Illa ego progenies tot ducta ab origine regum, / Quam Pha-
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 145
zioni Res, 1995, pp. 125-26; e le ristampe segnalate da GIAN PIERO MARAGONI, Sado-leto e il Laocoonte. Di un modo di descrivere l’arte, Parma, Edizioni Zara, 1986, p. 10, n. 5.Cinque di essi (Cleopatra, De Elisabella Gonzaga canente [solo i vv. 1-12], Hippolyte Balthas-sari Castilioni coniugi, Prosopopeia Ludovici Pici Mirandulani, e De morte Raphaelis pictoris)sono editi in Renaissance Latin Verse. An Anthology, compiled and edited by AlessandroPerosa and John Sparrow, London, Duckworth, 1979, nell’ordine pp. 193-95, 195-96,196-99, 199-201, e 202.
41 Si confrontino l’immagine dell’«ubbidiente e docile / […] bronzo» (Prosopopea,vv. 101-02 [numerazione originaria], in VQ, p. 58) con quella del mitico scultore Ma-murio Veturio «formae caelator aenae, / […] / qui me tam docilis potuisti fundere inusus» (SEXTI PROPERTI IV, 2, 61 e 63, cit. da EIUSD. Elegiarum libri IV, Edidit PaulusFedeli, «Editio correctior», Stutgardiae et Lipsiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1994 [Ied. 1984], p. 229); e l’affermazione in cui Pericle colora di «giusta invidia» l’apprezza-mento per essere «opra e studio / De lo scalpel di Fidia» (Prosopopea, vv. 62 e 63-64 [nu-merazione originaria], in VQ, p. 57), con quella finale dell’elegia, dov’è espresso in ma-niera diretta lo stesso concetto di ammirazione: «unum opus est, operi non datur unushonos» (PROPERTI IV, 2, 64, p. 229). Meno utilizzabile intertestualmente ai fini dellacomposizione montiana è l’altra elegia segnalata dal Carducci, in cui la prosopopea delladefunta Cornelia assume i toni dell’apologia di ascendenza giudiziale (ibid., pp. 275-83).
42 GIOVANNI PARENTI, Per Castiglione latino, in Per Cesare Bozzetti. Studi di lettera-tura e filologia italiana, a c. di Simone Albonico, Andrea Comboni, Giorgio Panizza,Claudio Vela, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 1996, pp. 185-218(a p. 211; e, per l’indicazione del carme del cardinale Giovanni de’ Medici, p. 212 e n.58); alla fine di quest’importante contributo, lo studioso fa un esplicito riferimento allaProsopopea montiana, definendo il carme latino «un incunabolo del nostro neoclassici-smo» (ibid., p. 218).
rii coluit gens fortunata Canopi, / Deliciis fovitque suis Aegyptia tellus,/ Atque Oriens omnis divûm dignatus honore est»),43 trovano un’eco nellaquartina iniziale della Prosopopea («Io degli Eroi di Grecia / Fra l’inclitafamiglia / D’Atene, a i prischi secoli, / Splendore e maraviglia», in VQ,p. 55);
2) i vv. 21-24, dove al concetto dell’aspirazione alla memoria futuraè unito quello dell’arte che dà vita alla materia («Neu longaeva vetustasfacti famam aboleret, / Aut seris mea sors ignota nepotibus esset, / Effi-giem excudi spiranti e marmore iussit, / Testari et casus fatum miserabilenostri»),44 il primo riecheggiato “in positivo” nei vv. 13-16 del branomontiano («Ne ricercaro i posteri / Gelosi il sito e l’orme, / E paventar laperdita / De le scolpite forme», in VQ, p. 55), il secondo rielaborato perben quattro volte, là dove Pericle parla della «difficile / Arte che ottienvirtude / Di dar sembianza ed anima / Al marmo freddo e rude»; nellaquartina «Vedi dal suolo emergere / Ancor parlanti e vive / Di Periandro,e Antistene / Le sculte forme Argive»; e nelle due successive, in cui ven-gono descritte le erme di Biante, Eschine e Demostene (ospitate nel Mu-seo Pio-Clementino insieme a quella di Pericle, alle due appena ricordate,
Mauro Sarnelli146
43 Ed. moderna, in BERNI - CASTIGLIONE - DELLA CASA, Carmina, pp. 30-32 (a p.31). Come rilevano i due curatori di Renaissance Latin Verse, p. 193, n. al v. 7, questo è«taken almost verbatim from Plutarch» (ossia da PLUT. Ant., 85, 8); e verrà riecheggiatoda SHAKESPEARE, Antony and Cleopatra, V, II, 325-26: per il tramite inglese della “fonte”greca (PLUTARCH’s Lives of the Noble Grecians and Romanes, translated by Sir Thomas North[1579], The Life of Marcus Antonius), e per una discussione complessiva sui riscontri in-tertestuali di questa tragedia, si veda almeno il classico Narrative and Dramatic Sourcesof Shakespeare, Edited by Geoffrey Bullough, Reprinted, London and New York, Rou-tledge, 1999 (I ed. London, Routledge and Kegan Paul – New York, Columbia Uni-versity Press, 1957-75), 8 voll., V, The Roman Plays: Julius Cæsar, Antony and Cleopatra,Coriolanus (I ed. 1964), rispettivamente pp. 254-318 (a p. 316) e 213-53; per le altre“fonti”, certe o probabili, si vedano le pp. 318-449.
44 Ed. moderna, in BERNI - CASTIGLIONE - DELLA CASA, Carmina, p. 31; i nessi «lon-gaeva vetustas» e «spiranti e marmore» variano quelli inseriti da IACOPO SADOLETO nelcarme esametrico che costituisce l’immediato modello offerto all’aemulatio del Casti-glione, ovvero il notissimo Laocoon, nell’ordine vv. 5 e 52 («docta vetustas» e «spirantiin marmore», ed. moderna, in Renaissance Latin Verse, pp. 185-86, rispettivamente allepp. 185 e 186), sui quali si veda infra, e nn. 61 e 63. A latere, si fa notare che una suc-cessiva ed. di quest’ultimo brano è in MARZIO PIERI, Postfazione a MARAGONI, Sadoleto eil Laocoonte, pp. 45-55 (alle pp. 47-48; lo studioso ne offre una traduzione poetica allepp. 49-51).
ed a quella di Aspasia, a cui sono dedicate poco oltre due quartine);45 inquella «Dunque spiranti e lucide / Mi scorgerò d’intorno / Di tanti Eroile immagini / Che fur Pelasghi un giorno?»; e là dove l’eroe si vanta chegrazie a lui «tersi e morbidi / Sotto la man de i fabri / Volto e vigor pren-deano / I massi informi e scabri»;46
3) i successivi vv. 25-27, che celebrano la collocazione della statua so-pra una fontana da parte del pontefice Giulio II Della Rovere «forse col
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 147
45 Illuminando finemente la rispondenza fra i personaggi menzionati dall’autore edi busti del Museo Pio-Clementino, PIETRO PAOLO TROMPEO in una «Conferenza tenutaall’Associazione Culturale Italiana a Torino, Genova, Milano e Roma nel marzo 1954»afferma: «Il suo primo trionfo, in questa Roma [scil., di Pio VI], fu infatti un trionfoquasi più archeologico che poetico: quello che ottenne in Arcadia, l’anno dopo il suo ar-rivo nella capitale, con la recitazione dell’ode Prosopopea di Pericle, suggeritagli da EnnioQuirino Visconti per la scoperta che s’era fatta presso Tivoli d’un busto del grande ate-niese. È tutto un inno alle scoperte archeologiche fatte in quegli anni, delle quali si ve-niva via via arricchendo il museo Pio-Clementino. E per gli atri e le sale di quel museopar di aggirarsi col poeta, canoro cicerone che ci conduce nella galleria di busti e ce neaddita i più insigni […]. Questo impetuoso tra inno e catalogo si chiude con la cele-brazione di Pio VI, nuovo Pericle, e del suo glorioso mecenatismo» (Vincenzo Monti aRoma, in Mostra Vincenzo Monti a Roma (Roma, Palazzo Braschi, marzo-aprile 1955), ac. degli Amici dei Musei di Roma, Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1955, pp. 9-29,alle pp. 29, 11 e 12; l’ed. di questo contributo compresa in ID., Diporti italiani, Con pre-fazione di Nello Vian, Roma, Palombi, 1984, pp. 16-35, non riporta l’indicazione re-lativa alla conferenza; e nel secondo dei passi citati, nell’ordine alle pp. 18 e 19, per unasvista manca l’aggettivo «glorioso»). Nello stesso volume in cui il VISCONTI parla delleerme di Pericle e di Aspasia, volume dedicato a «quella classe di monumenti […] par-ticolarmente addetta alla Iconografia, e che si noma nelle Collezioni la serie DELLE TESTE
E DEI BUSTI», si trovano le descrizioni di tutte le sculture raffiguranti i viri illustres grecicelebrati dal Monti nella Prosopopea, e rinvenute durante gli scavi della stessa villa diCassio da cui è emersa quella di Pericle (Il Museo Pio-Clementino, vol. VI, rispettivamentePrefazione dell’Autore, pp. 5-29, alle pp. 6-7, e Tavole XXII [Biante e frammenti d’Ermid’altri Savj della Grecia], e XXII a [Periandro e frammenti d’Ermi d’altri Savj della Grecia],pp. 129-33, XXIII [Biante Prieneo], pp. 134-35, XXV [Periandro Corintio], pp. 137-40,XXXV [Antistene], pp. 171-74, XXXVI [Eschine], pp. 174-76, e XXXVII [Demostene],pp. 176-77 [per la provenienza di quest’ultima, che qui non viene dichiarata, si vedapoco oltre]). Su queste erme, si veda altresì ID., Iconografia Greca, vol. I, nell’ordine Ta-vole IX (Periandro), pp. 124-31, X (Biante), pp. 135-37, XXII (Antistene), pp. 248-51,XXIX (Demostene), pp. 326-35 (a p. 334, n. 3, è affermato che «essa fu tolta dalla villaAlbani»), e XXIX b (Eschine), pp. 337-42.
46 MONTI, Prosopopea, vv. 21-24, 45-48, 81-84 e 97-100 [numerazione originaria],in VQ, rispettivamente pp. 56 (le prime due quartine) e 58 (le restanti due).
consiglio di Bramante nel fondo del gran corridore, o via coperta di Bel-vedere»,47 in Vaticano («Quam deinde, ingenium artificis miratus Iulus/ Egregium, celebri visendam sede locavit / Signa inter veterum heroum[…]»),48 trovano una loro renovatio nella poco sopra menzionata quartinaai vv. 81-84 (VQ, p. 58);
4) i vv. 36-37, con l’invocazione a Leone X restitutor dell’antica etàdell’oro («At tu, magne Leo, divûm genus, aurea sub quo / Saecula et an-tiquae redierunt laudis honoris»),49 hanno il loro parallelo nella quartinaai vv. 33-36 («Al mio desir propizia / La chiesta etade uscìo, / E tu su’lbiondo Tevere / La conducesti, o PIO», in VQ, p. 56).
E per illuminare il Fortleben del carme del Castiglione, non a caso sem-pre in àmbito romano, occorre fare un salto di un secolo e mezzo, per in-contrarne il “palinsesto”50 ad opera di uno degli esponenti della PleiasAlexandrina, ossia il gruppo di poeti neolatini ruotante attorno al ponte-fice Alessandro VII Chigi: si tratta del carme esametrico Cleopatra in Hor-tis Vaticanis, composto da Agostino Favoriti ed indirizzato alla regina Cri-stina di Svezia, la memoria del quale è ancora ben viva nel Visconti, ac-canto naturalmente a quella del suo modello.51
Mauro Sarnelli148
47 VISCONTI, Il Museo Pio-Clementino, vol. II, Tavola XLIV, p. 288.48 Ed. moderna, in BERNI - CASTIGLIONE - DELLA CASA, Carmina, p. 31.49 Ibid., p. 32.50 Il termine rimanda naturalmente a GÉRARD GENETTE, Palimpsestes. La littérature
au second degré, Paris, Éditions du Seuil, 1982; trad. it., Palinsesti. La letteratura al secondogrado, Torino, Einaudi, 1997.
51 Sulle edd. della Cleopatra in Hortis Vaticanis. Ad Christinam, Suecorum, Gothorum,Vandalorum Reginam, si veda PARENTI, Per Castiglione latino, p. 217, n. 67; ad esse vannofatte precedere quelle, sempre nei Poemata AUGUSTINI FAVORITI […], nella prima ed. enella ristampa dei Septem Illustrium Virorum Poemata, Antuerpiae, Ex Officina PlantinianaBalthasaris Moreti, 1660 e 1662, pp. 43-111 (alle pp. 73-76). Sulla menzione che deidue carmi fa il Visconti, cfr. supra, e n. 15. Passi della composizione del Favoriti acco-stabili alla Prosopopea montiana sono: «REGINA, heroum nulli virtute secunda, / Aureaquos olim tulit aetas […]» (vv. 5-6, ed. 1660, p. 73); «[…] Illa ego sum Latijs cele-berrima fastis / Femina […]» (vv. 10-11, ibid.); «[…] nec est indigna videri / Formaloci, et sacris regio gratissima Musis» (vv. 13-14, ibid.); «Hîc ubi Graiorum artificummiranda videbis / Signa antiqua, tuae gentis quibus ira pepercit, / Abstinuitque manusartem mirata vetustas» (vv. 17-19, ibid., p. 74); la concitata e ricca parte ecfrastica aivv. 20-40 (ibid., pp. 74-75), da cui emergono il «Phidiacus labor Alcides […]» (v. 27,p. 74), e le immagini che l’arte rende palpitanti («Et vivos illinc discunt effingere vul-tus», v. 35, ibid.; «Spirantes docto in silice […]», v. 37, ibid.; e «[…] quos omnes dae-
In quello che è il primo ed a tutt’oggi il più rilevante contributo scien-tifico (e variantistico) sul brano montiano, anche Giovanni Mestica ri-manda all’elegia IV, 2 di Properzio, suggerendo un’ispirazione di questaalla satira I, 8, di Orazio, in cui la prosopopea del «deus» ligneo Priapoha in realtà ben poco a che vedere con l’aulicità periclea;52 e propone unriscontro, anche se in maniera estremamente dubitativa, con la Rispostadi Roma a Plutarco del Tasso, «la quale nel principio contiene appunto ilconcetto fondamentale che anima l’ode di cui parliamo, la grandezza diRoma cristiana a raffronto di Roma pagana; il qual concetto, del resto,per secoli ricantato, e […] comunissimo in quel periodo della vita delpoeta, non si può credere che il Monti avesse bisogno di ricercarlo nellaprosa oratoria di quel grande scrittore».53
A tali indicazioni di “macro-fonti”, rimandando anche – evidentemente
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 149
dala, et ipsi / Aemula Naturae finxit manus? […]», vv. 39-40, pp. 74-75); «[…] hicerit, hic vir [scil., prevedibilmente, Alessandro VII], / Olim qui Latiam regnando resti-tuat rem, / Qui veteres artes, et saecula prisca reducat» (vv. 55-57, ibid., p. 75); e «Nam-que ego te rerum seriem, eventusque docebo, / Qui super heroum sedes, super aetheratollent / Nomen ALEXANDRI, sub mortem plurima quando, / Et longe faciem venientiscernimus aevi» (vv. 62-65, ibid., pp. 75-76).
52 Q<UINTUS>. HORATIUS FLACCUS, Serm., I, 8, 3, in Opera, Edidit D<avid>. R<oy>.Shackleton Bailey, «Editio quarta», Monachii et Lipsiae, In aedibus K.G. Saur, 2001 (Ied. Stutgardiae, In aedibus B.G. Teubneri, 1985), p. 197.
53 GIOVANNI MESTICA, La prima ode di Vincenzo Monti in Roma, in “Nuova Antologia”,XXIV (1889), pp. 39-62 (a p. 53). Il passo tassiano a cui lo studioso si riferisce è con ogniprobabilità quello con cui ha inizio la prosopopea della città: «Non sono (dice) o Plutarco,non sono Roma trionfante, non sono Roma regina del mondo, ma Roma ristorata per lavirtù di uno, anzi di molti Santissimi Pontefici; Roma divenuta umile di superba, paci-fica di guerriera, e quasi celeste di terrena; che nella nuova gloria della verissima Religionenon tanto mi vanto della prima grandezza, quanto delle cose presenti mi rallegro» (TOR-QUATO TASSO, Risposta di Roma a Plutarco, in Opere, Napoli, Stabilimento del Guttemberg,1840, 4 voll., IV, pp. 113-33, a p. 116; rist. anast., in ID., Risposta di Roma a Plutarco emarginalia, a c. di Paola Volpe Cacciatore, con una nota di Marcello Andria, Roma, Edi-zioni di Storia e Letteratura, 2004). Per un’indagine filologica su quest’opera, si veda ilcontributo di EMILIO RUSSO, Sul testo della “Risposta di Roma a Plutarco”, in “FeC”, XXVII(2002), pp. 321-62 (preliminare all’ed. critica di essa, a c. dello studioso, con il commentodi Claudio Gigante, annunciata presso le Edizioni Res di Torino). Ulteriori indicazioni bi-bliografiche sono fornite dal RUSSO nel cap. IV, Per la “Risposta di Roma a Plutarco”, delsuo L’ordine, la fantasia e l’arte. Ricerche per un quinquennio tassiano (1588-1592), Roma, Bul-zoni, 2002, pp. 233-68; e da DOMENICO CHIODO, La “Risposta di Roma a Plutarco”, in Tassoa Roma, Atti della Giornata di Studi (Roma, Biblioteca Casanatense, 24 novembre 1999),a c. di Guido Baldassarri, Modena, Panini, 2004, pp. 49-54.
per quelle “micro” – al commento del Bertoldi,54 Attilio Butti aggiungedue “accostamenti”, non al fine «d’indicar fonti, ma di raccogliere intornoa quell’ode fasci di luce prossima e lontana», che consistono nell’ode Ura-nia di Agostino Paradisi e nel carme Laocoon di Iacopo Sadoleto.55
Il componimento del Paradisi utilizza proprio lo strumento retoricodella prosopopea, ed è un epitalamio in due parti di complessive sedicistrofe di settenari ed endecasillabi, composto per le nozze di Nicolao Mon-tecatini Gigli e Maria Caterina Buonvisi, celebrate a Lucca lunedì 30 gen-naio 1769, stampato nella raccolta allestita per l’occasione (in cui ogniautore offre la propria voce poetica ad una delle Muse, dopo l’introdu-zione in endecasillabi sciolti fatta a nome di Apollo), e poi compreso neltomo XIII delle Rime degli Arcadi.56 In esso l’unico altro elemento che lo
Mauro Sarnelli150
54 MONTI, Poesie, scelte illustrate e commentate da Alfonso Bertoldi, Nuova ed. in-teramente rifatta e notevolmente arricchita, Firenze, Sansoni, 1908 (I ed. 1891), pp. 3-12 (nella rist. anast. arricchita dalla Nuova presentazione di Bruno Maier, ibid., 1978,è riprodotto un esemplare che presenta la copertina ed il frontespizio della «Nuova ti-ratura» della I ed., ibid., 1904, ma il testo di quella riveduta).
55 ATTILIO BUTTI, Rileggendo la prima ode di Vincenzo Monti, in GSLI, XXVIII (1910),pp. 104-10 (le due citazioni sono nell’ordine dalle pp. 104 [ribadita a p. 110] e 110, n. 2).
56 Per la data di queste nozze, si veda Descendenza, e descrizione della Nobile FamigliaMontecatini di Lucca dimostrativa dell’Albero genealogico posto appiè di queste notizie, raunateper la maggior parte dal Chiarissimo Sig. Canonico GIUSEPPE VINCENZIO BARONI NobileLucchese, in Delizie degli Eruditi Toscani, t. XI, Istoria fiorentina di MARCHIONNE DI COPPO
STEFANI, pubblicata, e di Annotazioni, e di antichi Munimenti accresciuta, ed illustratada Fr. Ildefonso di San Luigi Carmelitano Scalzo [...], vol. V, In Firenze, Per Gaet. Cam-biagi Stampator Granducale, 1778 [ma la liberatoria dei «Censori, e Deputati dell’Ac-cademia della Crusca», posta a p. xj non num., reca la data «Adì 4. Gennaio 1779.»], pp.168-98 (a p. 197, nr. 42). L’elegante silloge epitalamica relativa a quest’evento reca il ti-tolo: Il Coro delle Muse Festeggiante le Nozze del Nobil Uomo Signor Nicolao Montecatini Giglicon la Nobile Donzella Signora M.a Caterina Buonvisi Patrizi Lucchesi, s.n.t. [ma con ogniprobabilità: Lucca 1769]: Urania è alle pp. LIII-LVIII. Gli altri autori partecipanti allaraccolta – aperta dalla dedicatoria di BARTOLOMEO SARDI Alla Nobil Donna la Signora Ma-ria Garzoni Buonvisi (pp. [IIIr-Vv] non num.), e dagli sciolti di FERRANTE CITTADELLA
CASTRUCCI Al Nobil Uomo il Signore Bartolomeo Sardi Patrizio Lucchese (pp. I-VI) – sono:FRANCESCO FRANCESCHI (Apollo, pp. VII-XII); il CITTADELLA CASTRUCCI (Clio, pp. XIII-XVII: come si legge a p. XIII, n. 1, «Essendo già cominciata la stampa della presenteRaccolta, e mancato il Componimento di un illustre Poeta, è stato l’autore obbligato asupplire con la presente Canzone»); FILIPPO HERCOLANI (Melpomene, pp. XVIII-XXI);LUIGI CERRETTI (Talia, pp. XXII-XXVIII); GIULIANO CASSIANI (Euterpe, pp. XXIX-XXXII); un non meglio specificato «Sig. G. L. B. Nobile Veronese» (Tersicore, pp. XXXIII-XXXVI: la citazione è dall’Indice degli Autori, pp. [LXXVII-LXXVIII] non num., a p.
possa in qualche modo collegare alla composizione montiana è l’afferma-zione iniziale della Musa, la cui «aurea lira […] ricusa / ogni suggettoumìle»:57 non è molto, e la consonanza diviene ancora più labile, se sitiene presente che siamo di fronte ad una vera e propria “micro-tradi-zione”, rappresentata dalle raccolte epitalamiche contenenti poesie in
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 151
[LXXVII]); GIUSEPPE COLPANI (Erato, pp. XXVII-XLII); il PIZZI (Calliope, pp. XLIII-LII); ed ANTON MARIA PEROTTI (Polinnia, pp. LIX-LXXIV; seguìta dall’ode-canzonetta«O Imene provvido», in quartine savioliane, pp. LXXIV-LXXV); sigla l’opuscolo unaquartina di endecasillabi contenente la canonica Protesta degli Autori («Qui cantaron leMuse, e de’ lor fregi / Ornare i canti loro ebber diletto. / Fra i Vati lor non v’è chi non sipregi / Pura celeste Fé nudrire in petto», p. [LXXIX] non num.). Due ulteriori notazionia latere su questa plaquette: come afferma il Sardi nella dedicatoria iniziale, l’allestimentodi essa si deve «al Sig. FERRANTE CITTADELLA CASTRUCCI [...], il quale come valoroso Co-noscitore della buona Poesia, e de’ più chiari Ingegni d’Italia, ha potuto unire quest’ec-cellenti Composizioni, acciocché degnamente a Nozze così conspicue si faccia applauso»(pp. Vr-v); mentre la prosopopea di Apollo sarebbe dovuta essere composta dal Frugoni,scomparso a Parma il 20 dicembre 1768 («Nel mentre che il Chiarissimo Sig. AbbateFrugoni stava componendo per la presente Raccolta in persona d’Apollo, mancò di vi-vere, e ha dovuto l’Autore [scil., come si è visto, il Franceschi] in pochi giorni eseguire ledi lui veci», p. IX, n. *). Come si è accennato, la prosopopea del Paradisi è inserita nelleRime degli Arcadi, t. XIII, pp. 221-25 (nell’Indice del tomo, pp. Ir-XIv finali non num., ap. VIIr [Dd5], il sottotitolo di essa è Ode per le nozze Montecatini e Buonvisi in Lucca). L’ed.moderna del brano, che presenta il sottotitolo Per le nozze d’un Montecatini di Lucca (giàadottato nell’ed. in Lirici del secolo XVIII, a c. di G<iosue>. Carducci, Firenze, G. Barbèra,Editore, 1871, pp. 63-68), è in Poeti minori del Settecento, a c. di Alessandro Donati, Bari,Laterza, 1912-13, [2 voll., I,] Savioli – Pompei – Paradisi – Cerretti ed altri, pp. 163-67.
57 Ed. moderna, in Poeti minori del Settecento, [vol. I,] rispettivamente vv. 4 e 5-6, p.163. La prima strofe del brano, contenente questi versi, è riportata integralmente da Be-nedetto Croce, in un contributo volto a stigmatizzare «gli scrittori che di proposito e afreddo fanno sfoggio di alti concetti, di profonda filosofia, di severi e delicati sentimentimorali, di interessamento per la religione e per la cosa pubblica» (Verseggiatori del grave edel sublime [1946], in La letteratura italiana del Settecento. Note critiche, Bari, Laterza, 1949,pp. 352-62, alle pp. 358 [la strofe del Paradisi] e 352 [la severa affermazione critica]). No-nostante, come si è constatato, una lettura intertestuale delle prosopopee del Paradisi e delMonti non faccia emergere particolari punti di contatto fra esse, appare interessante l’ipo-tesi del Butti relativa alla conoscenza che il nostro autore poteva avere dell’ode paradisiana,stampata inizialmente come inedita dal giornale milanese “Il Poligrafo” (III [1813], N.VII, pp. 97-100), dove però viene subito dopo rettificato che «questa ode è stata detta ine-dita per isbaglio» (Errata, ibid., N. VIII, p. 28). Riguardo a tale rettifica, il BUTTI afferma:«Ma il Monti, parte importantissima del circolo paradisiano, conosceva que’ versi, e forsefu lui ad avvertire gli amici [scil., Luigi] Lamberti e [scil., Urbano] Lampredi che Uraniaaveva già veduto la luce» (Rileggendo la prima ode di Vincenzo Monti, p. 107).
forma di prosopopee delle Muse, come intorno alla metà del secolo era av-venuto a Ferrara con Gli Augurj delle nove Muse per le Nozze del Signor Mar-chese Francesco Calcagnini colla Signora Marchesa Donna Alessandra Scotti.58
Il carme del Sadoleto celebra in esametri, attraverso la tecnica dell’ec-frasi, l’importante ritrovamento del gruppo marmoreo del I secolo a.C.,opera degli scultori rodî Agesandro, Atenodoro e Polidoro, che ha luogoa Roma nel 1506, durante gli scavi del palazzo di Tito sull’Esquilino, pro-mossi da papa Giulio II. Nei primi sette versi, riportati dal Butti,59 il Sa-doleto tocca tre tasti a cui il Monti sarà sensibile, ovvero la riapparizionedi tale scultura dalla terra,60 l’eccellenza di essa,61 ed il suo affacciarsi inuna nuova Roma.62 Nella sezione finale del carme poi, che segue la lungaparte ecfrastica (vv. 8-43), si trova l’immagine degli scultori che rendonola materia viva,63 immagine che il nostro autore ritiene così importante,da riproporla addirittura in quattro momenti del brano.64
Mauro Sarnelli152
58 In Ferrara, Presso Giuseppe Rinaldi, 1753: come viene dichiarato nell’avvertenzaAi dotti cortesi Lettori, «poiché si è voluto applaudere a così illustri, ed aspettate Nozzecol mezzo d’una Raccolta, si è pur voluto, che Raccolta non sia delle volgari e plebee; esi è pensato all’idea d’introdurre le Muse a una per una a complimentar cogli Sposi, e aregalarli de’ loro augurj e consigli» (pp. 5-10, a p. 8). Gli autori dei componimenti sono:il PEROTTI (il più rappresentato, a cui si devono l’Idillio d’Introduzione agli Augurj, pp.11-18; Urania, pp. 19-25; Tersicore, pp. 75-84; e gli sciolti conclusivi, pp. 84-85); CA-MILLO ZAMPIERI (Talia, pp. 26-33); AGOSTINO MARIA SONSIS (Calliope, pp. 34-44); GI-ROLAMO FERRI (Euterpe, pp. 45-49); JACOPO AGNELLI (Erato, pp. 50-56); FRANCESCO RIN-GHIERI (Clio, pp. 57-62); DOMENICO FELICE LEONARDI (Polinnia, pp. 63-70); ed IGNA-ZIO VARI (Melpomene, pp. 71-74).
59 BUTTI, Rileggendo la prima ode di Vincenzo Monti, p. 110.60 SADOLETO, Laocoon, vv. 1-3: «Ecce alto terrae e cumulo ingentisque ruinae / vi-
sceribus iterum reducem longinqua retexit / Laocoonta dies […]» (ed. moderna, in Re-naissance Latin Verse, p. 185).
61 Ibid., vv. 5-6: «divinae simulacrum artis, nec docta vetustas / nobilius spectabatopus […]». Sulla variatio a cui il Castiglione sottoporrà il nesso «docta vetustas», si vedasupra, e n. 44.
62 Ibid., vv. 6-7: «[…] nunc celsa revisit / exemptum tenebris redivivae moenia Ro-mae»; il concetto è ribadito nella conclusione del brano, vv. 55-58, p. 186: «[…] ve-strae iacuerunt artis honores / tempore ab immenso, quos rursum in luce secunda / Romavidet celebratque frequens, operisque vetusti / gratia parta recens […]».
63 Ibid., vv. 51-54: «Vos rigidum lapidem vivis animare figuris / eximii et verosspiranti in marmore sensus / inserere: aspicimus motumque iramque doloremque, / etpaene audimus gemitus […]». Anche in questo caso, sulla variatio del nesso «spirantiin marmore» da parte del Castiglione, si veda supra, e n. 44.
64 Al riguardo, cfr. supra, e n. 46.
Ed iniziando a spingere lo sguardo alla storia redazionale della Proso-popea, in questo discorso andrà rammentato che l’unica quartina aggiun-tavi a partire dalla terza edizione (in A) riguarda appunto l’arte scultorea,la cui personificazione è oggetto di una scena “archeologico-sepolcrale”del tutto in linea con il classicistico “sublime patetico” dell’autore: «Ed’Adriano e Cassio, / Sparsa le greche chiome, / Fra gl’insepolti ruderi /Mi andò chiamando a nome».65
Per proseguire la panoramica sulle “macro-fonti” del brano, il Barba-risi indica altri due autori e, parlando degli «elementi di novità che de-cretarono subito il successo dell’ode», offre uno spunto che, ai fini dellacontestualizzazione di essa, risulta particolarmente significativo: i due au-tori menzionati dallo studioso sono Alessandro Guidi ed Ennio QuirinoVisconti, mentre lo spunto concerne «l’atmosfera della visione profetica»,creata dal Monti attraverso l’uso della prosopopea.66 Il riferimento al Guidied alle sue «grandiose celebrazioni» di Roma antica,67 intrise della poe-tica del rovinismo primo-arcadico, trova riscontro probante in una di-chiarazione dello stesso Monti, che, nel già ricordato Discorso preliminareal Saggio di Poesie, ne esalta proprio la «fantasia […] grande e robusta»,pur eccessiva, ma testimone di «una immaginazione calda e profonda».68
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 153
65 MONTI, Prosopopea, vv. 25-28, in A, pp. 58-63 (a p. 59). Nella versione finale delbrano sono sostituiti: 26 A greche] M belle; e 28 A Mi andò] M M’andò: quest’ultimalezione era già nelle tre precedenti redazioni (S, V1-2-3, B: per lo scioglimento di questesigle, si veda il prospetto delle edd. elencate infra), e nella successiva ristampa (Vr: perquesta sigla, si veda infra, n. 94).
66 BARBARISI, Vincenzo Monti e la cultura neoclassica, nell’ordine pp. 29-30 e 30.67 Ibid., p. 28. Utilizza la medesima espressione ILARIA MAGNANI CAMPANACCI,
Monti e i neoclassici emiliani: Savioli, Cassiani, Mazza, in Vincenzo Monti nella cultura ita-liana, vol. I, t. I, pp. 237-93 (a p. 252).
68 Per una comprensione del punto di vista dell’autore nel formulare tale giudizio,che evidentemente ne esprime la concezione della poesia e l’opzione di gusto su cui atale altezza cronologica questa si fonda, gioverà riportare per intero il passo: «Chi tro-var vuole i difetti d’un poeta deve cercarli nell’eccesso delle qualità che ne costituisconoil carattere. Ogni poeta pone sempre ne’ suoi versi molte di quelle cose che poco gli co-stano. Chiabrera Guidi Frugoni peccano di soverchio entusiasmo: sono caricati qualchevolta e giganteschi. Segno che la lor fantasia era grande e robusta: i loro difetti stessi neformano l’elogio. Una immaginazione delicata e gentile diverrà vitiosa per troppa sot-tigliezza e raffinamento: all’incontro una immaginazione calda e profonda eccederà nellagrandezza e nel disordine delle idee. Somiglio la prima ad un piccolo rivolo che mor-mora languidamente, ed ha il margine sì gremito di fiori, che non dà varco ad accostar-visi senza calpestarne, ed opprimerne molti coi piedi. Somiglio la seconda ad un fiume
Dal Guidi, il nostro autore mutua quello che acutamente Bruno Maier hadefinito il «caratteristico “pindarismo cristiano” o “cattolico”» del poeta,69
con cui il Monti si mostra in sintonia, ritenendo che «Omero Pindaro Vir-gilio siano grandi e maestosi» – pur se inferiori a David e ad Isaia.70
Ugualmente, e forse ancora più produttivo è il confronto con il Vi-sconti, di cui il nostro autore «perfeziona i tentativi encomiastici»:71 giàil Mestica menzionava le ventitré Ottave sul Possesso di Nostro Signore PioSesto P. M., stampate in un’elegante edizione in 4° all’indomani dell’ele-zione del pontefice,72 ma ancor più vicina alla Prosopopea è un’ode-canzo-netta scritta anch’essa Per l’esaltazione al Pontificato di Papa Pio VI, ed in-
Mauro Sarnelli154
reale che torbide sì qualche volta, ma sonanti e maestose porta al mare le sue onde, eregge sul dosso le navi, laddove quel ruscelletto appena tragge seco le povere foglie chei fanciulli vi gittano per giuoco. Zappi Rolli e cento Francesi sono del primo carattere.Dante Ariosto Milton sono del secondo. Io non disprezzo le delicate fantasie smorfiose;ma io vorrei essere Omero piuttosto che Anacreonte, e rinuncierei di buon grado a centoleggiadre cose di questo per aver dieci sole bellezze di quello benché da molti difetti ac-compagnate. E tanto più volentieri io lo farei, quanto che Longino ci fa intendere intuono di serietà, che le produzioni d’un grande ingegno con molti errori e inavvertenzesono infinitamente preferibili alle opere d’un autore d’inferior grado scrupolosamenteesatte e conformi a tutte le regole dello scrivere corretto [scil., cfr. PSEUDO–LONGINO,Del sublime, XXXIII-XXXVI]» (MONTI, Discorso preliminare, pp. xviij-xix; dall’ed. mo-derna, in Opere, ed. Muscetta, pp. 1002-03, sono state confortate le tre sostituzioni com-piute: il punto fermo al termine della prima frase, al posto di quello interrogativo chesi trova nella settecentina; e l’inversione dei due pronomi dimostrativi riferiti ad Omeroe ad Anacreonte, segnalata con i corsivi).
69 BRUNO MAIER, Introduzione ad ALESSANDRO GUIDI, Poesie approvate: L’Endimione- La Dafne - Rime - Sonetti - Sei omelie, a c. di Bruno Maier, Ravenna, Longo, 1981, pp.7-74 (a p. 42).
70 MONTI, Discorso preliminare, p. xxi; ed. moderna, in Opere, ed. Muscetta, p. 1004.71 BARBARISI, Vincenzo Monti e la cultura neoclassica, p. 29.72 Cfr. MESTICA, La prima ode di Vincenzo Monti in Roma, p. 42: sono le Ottave sul Pos-
sesso di Nostro Signore Pio Sesto P. M. Dedicate all’Eminentissimo, e Reverendissimo Principe ilSignor Cardinale Gian Carlo Bandi Vescovo d’Imola da ENNIO QUIRINO VISCONTI Camerierod’onore di S. S., In Roma, Nella Stamperia di Giovanni Zempel, 1775; poi comprese inVersi, pp. 629-34. L’autografo di esse, ricco di correzioni, è nel già ricordato ms. BAV,Vat. Lat. 10306, cc. 31r-v e 33r-35v: per una svista nella rilegatura delle cc., fra la 31e la 33 è inserita una c. di formato minore, regolarmente numerata (32), che sul rectopresenta il sonetto «Posa ai sospir de’ miseri mortali» (un’altra redazione del quale è ac. 4r; poi stampato con il titolo Per l’Assunzione di Maria Vergine in Versi, p. 611), men-tre sul verso è bianca; inoltre, per un errore nella numerazione originaria delle cc., la 33presenta l’indicazione del numero aggiunta a matita sopra il non cancellato «83».
titolata La gara delle Virtù.73 Gli aspetti che rendono questa composizioneassolutamente non trascurabile, nel percorso che conduce al nostro brano,sono innanzi tutto l’adozione metrica della quartina savioliana, quindil’impiego della prosopopea nella sezione centrale, là dove a parlare è laPietà (vv. 85-124), la presenza di due tematiche peculiari dell’encomia-stica rivolta a Pio VI, come l’eccellenza dell’età moderna e la renovatio ar-tium,74 ed infine alcuni elementi della quartina conclusiva (vv. 161-64),di cui il Monti si servirà per suggellare un’allusiva – e complice – «agni-zione di lettura»:75
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 155
73 I ed. in Triplice Omaggio offerto dagli Arcadi al Padre Principe e Pastore Massimo Fe-lice Augusto Papa Pio VI tra gli Arcadi Acclamati Timio Nemèo nella sua Esaltazione al SommoPontificato, In Roma, Dalle Stampe del Salomoni [colophon], 1775, pp. XLVI-LII: fa partedella prima delle tre adunanze indette dall’Accademia per celebrare l’evento, che hannoluogo rispettivamente domenica 20 agosto (pp. I-LXVI), venerdì 25 (pp. LXVII-CXXXIV), e martedì 29 (pp. CXXXV-CLXXXVII), alle quali nel volume fa séguitoil sonetto L’Epilogo del Pizzi (incipit: «Purpurei Padri, al cui splendor si vede», p.LXXXVIII). I resoconti delle tre «Adunanze Generali Straordinarie» sono in BAR, AttiArcadici, ms. 5, cc. 88-89; ed in Diario Ordinario, nr. 70, In data delli 2 Settembre 1775,In Roma, Nella Stamperia Cracas presso S. Marco al Corso, 1775, pp. 12-14 (dopo l’an-nuncio ibid., nr. 68, In data delli 26 Agosto 1775, In Roma, Nella Stamperia Cracas pressoS. Marco al Corso, 1775, p. 16). La gara delle Virtù è poi compresa in VISCONTI, Versi,pp. 620-22.
74 Cfr. ibid., nell’ordine vv. 137-44, p. 621: «Non con sì lieto auspicio, / Né con sìbei destini / Fregiasti un dì nel Lazio / I primieri Antonini. // L’are non mai t’intesero /Più care al suol romano / Suonar, né mai più fulgido / Ti vide il Vaticano» (per cui siveda MONTI, Prosopopea, vv. 89-92 [numerazione originaria], in VQ, riportati supra); evv. 157-60, p. 622: «Ma d’ulivo pacifico / All’alme ombre cresciute / Vedrai corona in-tesserti / L’Arti loquaci e mute» (amplificati in MONTI, Prosopopea, vv. 131-40 [nume-razione originaria], in VQ, pp. 59-60: «E le bell’arti corsero / Del Tebbro in su le rive.// Qui poser franche e libere / Il fuggitivo piede, / E accolte si compiacquero / De la can-giata sede. // Ed or fastose obbliano / L’onta del Goto orrore, / Or che il gran PIO le ven-dica / Del vilipeso onore»).
75 L’espressione rimanda a GIOVANNI NENCIONI, Agnizioni di lettura [1967], in Tragrammatica e retorica. Da Dante a Pirandello, Torino, Einaudi, 1983, pp. 132-40; a montedei numerosissimi contributi sulla tecnica dell’allusione è naturalmente quello di GIOR-GIO PASQUALI, Arte allusiva [1942], ora in Pagine stravaganti di un filologo, a c. di CarloFerdinando Russo, Firenze, Le Lettere, 1994, 2 voll., II, Terze pagine stravaganti. Stra-vaganze quarte e supreme, nel testo originale, pp. 275-82. È da notare che il VISCONTI uti-lizza il metro savioliano, oltre che nelle traduzioni da Pindaro ricordate supra, n. 33, an-che nella «Canzone» La Nube e nell’Ode sopra la Passione (BAV, Vat. Lat. 10306, rispet-tivamente cc. 19r-20v e 36r-37r: una diversa redazione di quest’ultima, senza il titolo
Vedrai fastoso il secolo Per lei già l’altre scorronoD’eternità sul monte, Men luminose e conte,Rubello al tempo, ascendere Perché di PIO non portanoCol tuo ben nome in fronte. L’augusto nome in fronte.76
Più sottile ed indiretto appare invece il legame con il genere delle “vi-sioni”, che il nostro autore mutua dal dantismo di Alfonso Varano, «li-berandole tuttavia del loro carattere più marcatamente funereo»,77 nei trecapitoli risalenti alla fine del periodo ferrarese, ossia La Visione d’Ezechiello,in lode del predicatore Francesco Filippo Giannotti,78 il Componimento Poe-
Mauro Sarnelli156
e ricca anch’essa di varianti, è alle cc. 17r-18v); e nelle odi epitalamiche Le Muse. – Pernozze Braschi (1781), ed Il Triangolo (1789), queste ultime due comprese in Versi, nell’or-dine pp. 615-17 e 618-19. Nella prima delle due epitalamiche viene esaltata la Saladelle Muse nel Museo Pio-Clementino («S’altro non giova, ah dissipi / Il dubbio e la di-mora / Pio, che d’un nuovo tempio / Sul Vatican v’onora», vv. 53-56, p. 615), dove sonocollocate le «immagini / Vive in spiranti marmi» di esse (vv. 57-58, p. 616), rinvenutenegli scavi della medesima villa di Cassio da cui sono emerse le erme di Pericle e deglialtri personaggi greci menzionati dal Monti nella Prosopopea (cfr. supra, e n. 45); mentrela seconda riprende sia l’impianto retorico del brano montiano (a rivolgersi agli sposi,infatti, è la costellazione boreale), sia l’enjambement «difficile / Arte» (vv. 65-66, p. 619),che si trova in MONTI, Prosopopea, vv. 21-22 (numerazione originaria), in VQ, p. 56.Come già le ottave menzionate supra, e n. 72, anche queste due odi epitalamiche del Vi-sconti sono state poste in relazione con il nostro brano dal MESTICA, La prima ode di Vin-cenzo Monti in Roma, pp. 57-59.
76 MONTI, Prosopopea, vv. 37-40 (numerazione originaria), in VQ, p. 56.77 WILLIAM SPAGGIARI, Monti, Minzoni, Varano: gli esordi poetici, in Vincenzo Monti
nella cultura italiana, vol. I, t. I, pp. 215-36 (a p. 232).78 Il primo ed il terzo brano confluiscono nelle Rime degli Aborigeni, Parte I, rispet-
tivamente pp. 119-25 e 139-49; ed in MONTI, Saggio di Poesie, nell’ordine pp. 22-29 e41-53. La più recente ed. di essi si deve al ROMANO, Note sulla prima poetica montiana: il“Saggio di Poesie” del 1779, Onofrio Minzoni, Alfonso Varano e Clementino Vannetti, in Vin-cenzo Monti a Roma, pp. 99-200 (rispettivamente alle pp. 128-32, 138-46 e 149-57; ilparagrafo 3 di questo capitolo è monograficamente dedicato ai rapporti fra Monti e Va-rano, pp. 119-65). Oltre che nei tre componimenti appena menzionati, influssi vara-niani sono altresì rintracciabili in tre dei sei capitoli presenti in MONTI, Saggio di Poesie:i due Per la Passione di Nostro Signore («Tristo pensier, che dal funereo monte», pp. 7-12,ora edita in ROMANO, Note sulla prima poetica montiana, pp. 159-62; ed «Ohimè le roseeguance! Ohimè il bel viso!», già stampata, con il titolo Per l’Accademia di Passione nel Ve-nerdì Santo, nelle Rime degli Aborigeni, Parte I, pp. 127-32), e quello Per S. E. il Sig. Ba-rone Francesco Ludovico d’Erthal Principe del S. R. I. eletto Vescovo d’Erbipoli (pp. 13-21);nonché sia nel successivo poemetto in due canti Il Pellegrino Apostolico, scritto nel pienodel periodo romano dell’autore (1782), per celebrare il viaggio diplomatico di papa Bra-
tico per la Promozione alla Sagra Porpora di Sua Eminenza il Signor CardinaleGuido Calcagnini (entrambi del 1776), e quello Per Sua Altezza D. PietroVigilio de’ Principi Thunn eletto Vescovo di Trento (1777). Calata nell’àmbitodei fermenti archeologici romani, ed alleggerita nelle forme grazie all’ab-bandono della terzina dantesca, la visione si colora di toni mondani e ce-lebrativi, facendosi entusiasticamente profetica nell’allocuzione ai «TardiNepoti e secoli / Che dopo PIO verrete», il cui «sguardo attonito» andràa tutto svantaggio della pur “industriosa” e magnifica età periclea.79
Ed a proposito del metro savioliano, non risulterà superfluo ricordare,con la scorta del Carducci, che proprio grazie alla «strofetta» ideata dalmaestro del Savioli, Angelo Michele Rota, «sembrò che […] si potessefare miglior prova a tradurre gli elegiaci romani».80 Né appare casuale la
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 157
schi a Vienna, presso l’imperatore Giuseppe II (la cui I ed. è in Versi dell’Abate VINCENZO
MONTI. Alla Santità di N. S. Pio VI, Parte Prima, In Siena, Nella Stamperia di VincenzoPazzini Carli e Figli, 1783, pp. 1-21; com’è noto, la Parte Seconda di questa raccolta,dedicata A S. E. il Sig. Conte D. Luigi Braschi Onesti Nipote di N. S., reca i medesimi datieditoriali [citate come S, I e II]); sia nella più celebre Bassvilliana (1793, di cui si vedal’ed. con varianti in MONTI, Poesie, ed. Bertoldi, pp. 209-68).
79 MONTI, Prosopopea, vv. 85-86, 87 e (per l’aggettivo coniato sul montiano «Indu-stria») 117, in VQ, nell’ordine pp. 58 (nei primi due casi) e 59 (nel restante). Cfr. EN-RICO MATTIODA, parr. 7-18 di MARCO CERRUTI e ENRICO MATTIODA, La letteratura delNeoclassicismo. Vincenzo Monti, in Storia della letteratura italiana, Diretta da Enrico Ma-lato, vol. VII, Il primo Ottocento, Roma, Salerno Editrice, 1998, pp. 324-70 (p. 329): nellaProsopopea «Monti riprende un metro arcadico, su cui innesta lo schema tipico della vi-sione varaniana: ne risulta una personificazione di Pericle che esalta la Roma di Pio VI,giungendo all’iperbole di dichiararla superiore all’Atene del quinto secolo».
80 CARDUCCI, Della poesia melica italiana e di alcuni poeti erotici del secolo XVIII [1868],in Opere, Ed. nazionale, vol. XV, Lirica e storia nei secoli XVII e XVIII, Bologna, Zanichelli,1944, pp. 83-144 (a p. 114). Sulla quartina savioliana, si vedano altresì MARIO FUBINI,Introduzione a Lirici del Settecento, a c. di Bruno Maier, con la collaborazione di Mario Fu-bini, Dante Isella, Giorgio Piccitto, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. IX-CXIX (allepp. XL-XLVII; poi sintetizzata nel contributo Metrica e poesia del Settecento [1962 (ma editonel 1965, con il titolo La poesia settecentesca nella storia delle forme metriche italiane)], in M.FUBINI, Saggi e ricordi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1971, pp. 3-45, alle pp. 17-18); PIE-TRO G. BELTRAMI, La metrica italiana, Bologna, il Mulino, IV ed. 2002 (I ed. 1991), pp.139-40; FRANCESCO BAUSI, Il Settecento, in ID. – MARIO MARTELLI, La metrica italiana. Teo-ria e storia, Firenze, Le Lettere, I ristampa riveduta e aggiornata 1996 (I ed. 1993), pp.205-31 (alle pp. 206-079; ALDO MENICHETTI, Metrica italiana. Fondamenti metrici, proso-dia, rima, Padova, Antenore, 1993, p. 561; e RODOLFO ZUCCO, Istituti metrici del Settecento.L’ode e la canzonetta, Genova, Name, 2001, pp. 204-06 (a p. 205 lo studioso indica ottodelle dieci composizioni qui elencate infra, e nn. 83-89).
spiccata predilezione del Monti a «sollevare agli onori dell’ode le strofesaviolesche»,81 già privilegiate fra gli altri – come si è visto – anche dalVisconti, al fine di sciogliere i contenuti encomiastici in una cantabilitàche sembra voler accordare la densità properziana (si pensi all’elegia se-gnalata come “macro-fonte” della Prosopopea) all’«Ovidiana spontanea fa-cilità», riconosciuta come caratteristica precipua dello stile dell’autore.82
Una rassegna delle composizioni montiane in cui è impiegato il me-tro savioliano si rivela particolarmente ricca di titoli, che ne abbraccianopressoché tutto l’arco della produzione poetica, annoverando le tre con-tenute nel Saggio di Poesie, cioè le due «Canzonette» Alla Fanciulla Inferma(disconosciuta dall’autore in un «Avviso» posto alla fine dell’Errata cor-rige finale del volume, in quanto ricalcata palesemente sull’ode-canzonettaAll’amica inferma del Savioli)83 ed Alla Medesima [scil., «Alla Nobil Donnala Signora Contessa Eleonora Cicognari»], quando recitò la parte di Clarice nellaTragicomedia di questo nome, e l’«Anacreontica» Sopra un Fanciullo;84 il no-stro brano; la «Canzonetta» Amor peregrino;85 la celeberrima ode Al signor
Mauro Sarnelli158
81 CARDUCCI, Dello svolgimento dell’ode in Italia [1902], in Opere, Ed. nazionale, vol.XV, pp. 1-81, a p. 78, dove l’autore rinvia implicitamente ad un brano del suo Dellapoesia melica italiana, p. 120, in cui afferma: «il Parini il Mazza ed il Monti, i quali diversi s’intesero, spero, se altri mai, […] tolsero in prestito dal Savioli quel suo metro peralcune loro odi che vanno fra le più belle e più rapidamente liriche dei loro canzonierie della poesia italiana».
82 Cfr. supra, e rispettivamente nn. 41 e 19.83 Cfr. MONTI, Saggio di Poesie, Errata corrige: «Tutti questi errori di Ortografia vanno
a conto dello Stampatore. Uno solo se ne ascriva a conto mio, quello cioè di aver perinavvertenza lasciato correre la stampa della Canzonetta posta alla p. 94 la quale non do-veva aver luogo nella presente Raccolta, perché frutto d’un’età assai giovanile, in cuitroppo facilmente si usurpano gli altrui versi e le altrui idee per mancanza delle proprie.Vizio per altro di cui molti non guariscono mai» (venenum in cauda!). L’ode-canzonettadel Savioli è la XVIII di quelle comprese nell’ed. definitiva degli Amori, di cui si vedanole edd. in Poeti minori del Settecento, vol. I, pp. 3-69 (alle pp. 50-52); ed in LODOVICO SA-VIOLI, Amori. Con una scelta di liriche neoclassiche, [a c. di Attilio Momigliano,] Firenze,Sansoni, 1944, pp. 5-74 (alle pp. 55-57).
84 MONTI, Saggio di Poesie, nell’ordine pp. 94-97, 122-29 e 134-43; una precedenteredazione della «Canzonetta» alla contessa Cicognari, stampata a Ferrara nel 1777 conil titolo Alla valorosissima dama la signora contessa Eleonora Cicognari protagonista del dramma“La Clarice”, ed indicata metricamente con il termine «Anacreontica» (come si è vistosupra, e n. 9, quest’equivalenza viene attribuita anche alla Prosopopea), è edita in Appen-dice dal CIANI, Le prime raccolte poetiche di Vincenzo Monti, pp. 486-91.
85 S, II, pp. 74-80; se ne veda l’ed. in MONTI, Poesie, a c. di Guido Bezzola, Torino,
di Montgolfier (1784);86 la «Canzonetta» La fecondità (1786);87 Amor ver-gognoso e la «Canzonetta» Per nozze illustri (1786);88 ed infine l’altra pro-sopopea Le api panacridi in Alvisopoli (1811), scritta per celebrare al con-tempo la nascita del figlio di Napoleone e Maria Luisa d’Asburgo-Lorena(il «Re di Roma»), e le opere promosse dal patrizio veneziano Alvise IMocenigo, patrocinatore della composizione.89 E nell’ode composta In oc-casione del parto della vice-regina d’Italia e del decreto del 14 marzo 1807 su ilicei convitti,90 il Monti non tralascia di utilizzare anche l’amplificatio ditale schema metrico, accresciuto di due versi (l’uno settenario sdrucciolo,l’altro endecasillabo tronco), e con le strofe geminate, secondo una strut-tura i cui due più illustri esempi sono le odi Il dono – Per la marchesa PaolaCastiglioni (1790) e Per l’inclita Nice (1793) del Parini – che peraltro nelleodi Piramo e Tisbe – Ad uno improvvisatore (I ed. 1791) ed A Silvia (1795)impiega le quartine savioliane.91
È venuto il momento di affrontare il discorso intorno alla storia re-dazionale della nostra Prosopopea, sulla quale ha fatto luce il Mestica, ri-preso dal Bertoldi.92 Le sei edizioni indicate dai due studiosi sono:
1) VQ, pp. 55-60;2) F, pp. 182-87;
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 159
Utet, 1969, pp. 103-08 (dove però la sua composizione viene postdatata a «verso il1786», p. 103).
86 Ed. con varianti, in MONTI, Poesie, ed. Bertoldi, pp. 46-55.87 Se ne veda l’ed. in MONTI, Poesie, ed. Bezzola, pp. 108-11.88 Versi dell’Abate VINCENZO MONTI, Parma, Dalla Stamperia Reale, 1787, Parte Se-
conda, rispettivamente pp. 84-90 e 91-95; la Parte Prima di questa raccolta reca i me-desimi dati editoriali [citate come B, I e II]. Delle due composizioni qui ricordate, siveda altresì l’ed. in ID., Le poesie liriche, ed. Carducci, nell’ordine pp. 250-55 e 256-59:le «nozze illustri» a cui fa riferimento il titolo della seconda di esse si palesano andan-done a ritrovare la I ed. (a cui verrà aggiunta la quartina iniziale ed apportate varianti),in Per le Nozze degli Eccellentissimi Signori Donna Marianna Altieri e Don Antonio Carac-ciolo Duca di Castelluccio. Poesie de’ Pastori Arcadi, [colophon:] In Roma, Nella StamperiaPagliarini, 1786, pp. LI-LIV.
89 Ed. con varianti, in MONTI, Poesie, ed. Bertoldi, pp. 104-10.90 Ed. con varianti, ibid., pp. 96-104.91 GIUSEPPE PARINI, Le odi, ed. critica a c. di Dante Isella, Milano-Napoli, Ricciardi,
1975, rispettivamente XXI, pp. 144-48, XXIII, pp. 164-71, XVII, pp. 120-22, e XXIV,pp. 172-79. Su questo tipo di strofe esastiche e geminate, si veda ZUCCO, Istituti metrici delSettecento, pp. 152-53; le due odi pariniane in quartine savioliane sono indicate ibid., p. 205.
92 Cfr. supra, nell’ordine nn. 53 e 54.
3) A, pp. 58-63;4) S, I, pp. 57-63 (qui citata tout court come S);5) B, I, pp. 74-82 (qui citata tout court come B);6) M, pp. 49-53 (e nn. 12 e 13 a p. 297, relative nell’ordine alle pp.
49 e 51).93
Ad una collazione fra di esse, la numero 5 presenta un solo motivod’interesse, cioè la forma analitica della preposizione articolata al v.136 (B su le),94 poi accolta in M, al posto di quella sintetica (S sulle).Per tutto il resto, B risulta esemplata su S, dalla quale diverge o permotivi esclusivamente tipografici (nello scioglimento dell’abbrevia-zione presente nel titolo;95 nell’uso delle maiuscole;96 o in quello di
Mauro Sarnelli160
93 Esemplata su questa è la contemporanea ed. del brano in Opere del Cavaliere VIN-CENZO MONTI, Italia, s.t. [voll. I-IV] – Bologna, Dalla Stamperia delle Muse [voll. V-VIII], 1821-28, 8 voll., IV, 1826 [citata come I], pp. 253-58 (e n. 3 a p. 347 e n. 4 ap. 348, relative rispettivamente alle pp. 253 e 255). Le differenze fra le due edd. sono:1) tipografiche: titolo M Prosopopea di Pericle. / Alla Santità di Pio VI.] I PROSOPO-PEA DI PERICLE / ALLA SANTITÀ DI PIO VI. n. al v. 72 M d’Aspasia] I di [in finale diriga] Aspasia. 40, 43, 90, 143 M PIO] I Pio. 54 M Qua] I Quà; 136 M su le] I sulle.141 M obblíano] I obblïano; 2) interpuntiva: n. al v. 72 M Tivoli, ] I Tivoli; 3) l’evi-dente refuso: 75 M afflitta] I aflitta.
94 È quest’unica micro-variante che accerta di ritenere esemplata su B la successivaed. della Prosopopea, in Poesie dell’Abate VINCENZO MONTI, Parte Prima, Versi, Verona, Aspese di Pietro Bisesti, 1801 [citati come Vr], pp. 80-86. Così infatti sostiene il finan-ziatore di quest’ed. all’inizio della breve dedicatoria Ai benevoli Associati: «Eccovi le tantoricercate Poesie dell’Abate Vincenzo Monti, per quanto da me si è potuto, diligente-mente ristampate secondo le edizioni di Parma, e di Roma [scil., per la Bassvilliana checostituisce la Parte Terza della raccolta]» (pp. 5-6 non num., a p. 5). I punti in cui l’ed.veronese si discosta dalla precedente sono: 4 B maraviglia] Vr meraviglia. 5 B io, Peri-cle] Vr , io Pericle. 22 B infelice ] Vr infelice, . 24 B Arte] Vr arte. 56 B sembiante. ]Vr sembiante: . 65 B d’età] Vr di età. 69 B Aspasia, ] Vr Aspasia . 121 B cielo] Vr Cielo.147 B de’] Vr de. Le restanti due Parti dell’ed. veronese comprendono: la Seconda, l’Ari-stodemo, con proprio frontespizio (Verona, Nella Stamperia Giuliari. A spese di PietroBisesti, 1801), ed altri Versi, anch’essi con proprio frontespizio (recante i medesimi datieditoriali di quello della tragedia), e con numerazione autonoma delle pp.; e la Terza,con la variante Poesie del Cittadino VINCENZO MONTI, la Bassvilliana, il cui frontespizioreca i medesimi dati editoriali di quello della Parte Prima.
95 S PROSOPOPEA / DI PERICLE / ALLA SANTITÀ / DI N. S. PIO VI .] B PROSO-POPEA / DI PERICLE / ALLA SANTITÀ / DI NOSTRO SIGNORE / PIO VI .
96 24 S arte] B Arte. 64 S fato] B Fato. 80 S amore] B Amore. 82 S fati] B Fati. 88S Pelasghi] B pelasghi. 125 S dimentici] B Dimentici. 126 S numi] B Numi. 132 S la-tina] B Latina. 135 S arti] B Arti. 146 S ciel] B Ciel.
accenti97 ed apostrofi),98 o nell’interpunzione (cassando le virgole primadella congiunzione «e»;99 oppure al contrario inserendole per scandirel’ordine logico del discorso;100 o infine mutandola, nel medesimo in-tento di contribuire alla perspicuità del dettato).101
Prima di B vanno inserite le stampe su fogli singoli, effettuate inun’occasione con tutti i crismi dell’ufficialità, ovvero la (scaramantica-mente) in precedenza rifiutata esposizione della Prosopopea accanto al bu-sto di Pericle,102 nella Sala delle Muse del Museo Pio-Clementino, rea-lizzata dall’architetto Michelangelo Simonetti.103 Secondo la ricevuta dipagamento reperita da Carlo Pietrangeli presso l’Archivio Storico dei Mu-sei Vaticani, il 7 aprile 1784 Stefano Piale riceve dal padre del Visconti,il prefetto Giovan Battista, «scudi sei moneta per due miniature fatte alcontorno delle Pergamene della prosopopea di Pericle».104 Tale biglietto
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 161
97 29 S che] B chè. 48 S obblio] B obblío. 54 S Quà] B Qua. 69 S Quì] B Qui. 74S quì] B qui. 105 S Ubbidiente] B Ubbidíente. 110 S apriro] B apríro. 112 S usciro] Buscíro. 113 S lamentaro] B lamentàro. 137 S Quì] B Qui. 141 S obbliano] B obblíano.
98 86 S d’intorno] B dintorno.99 4 S Splendore, e] B Splendore e. 8 S tempo, e] B tempo e. 12 S rabbia, e] B rab-
bia e. 14 S loco, e] B loco e. 47 S secoli, ] B secoli . 51 S Periandro, e] B Periandro e. 68S Travaglio, e] B Travaglio e. 83 S Samo, e] B Samo e. 98 S templi, e] B templi e. 128S altari, ed] B altari ed.
100 5 S io Pericle ] B io, Pericle, . 6 S latino ] B latino, . 19 S eccidio ] B eccidio, .34 S Etade in] B Etade, in. 42 S conte ] B conte, . 65 S Io che] B Io, che. 69 S Aspasia] B Aspasia, . 70 S diletta ] B diletta, . 71 S Pericle ] B Pericle, . 75 S lagnisi ] B la-gnisi, . 87 S immagini ] B immagini, . 89 S secoli ] B secoli, . 97 S portici ] B portici,. 126 S numi ] B Numi, . 142 S orrore ] B orrore, . 149 S lurido ] B lurido, . 155 S spi-rito ] B spirito, .
101 4 S maraviglia; ] B maraviglia, . 24 S animatrice. ] B animatrice; . 28 S nome.] B nome: . 32 S giorno. ] B giorno; . 44 S fronte. ] B fronte: . 52 S argive. ] B argive:. 92 S volgerete; ] B volgerete, . 104 S scabri. ] B scabri: . 108 S dea. ] B dea: . 140 Ssede. ] B sede; .
102 Per le affermazioni dell’autore, e per una riflessione su di esse, si veda supra, enn. 10 e 13-14.
103 Questa sala è stata già ricordata supra, n. 75, a proposito dell’ode Le Muse delVisconti.
104 Il prezioso documento è riprodotto da CARLO PIETRANGELI, Stefano Piale minia-tore, incisore e archeologo romano [1987], in Scritti scelti, a c. di Angela Cipriani, DanielaGallavotti Cavallero, Paolo Liverani, Gaetana Scano, Roma, Quasar, 1995, pp. 271-73e 548 (per le figg. 332-34), a p. 548, fig. 334. Nel trascriverlo a p. 271, lo studioso in-corre nella svista di rendere al singolare l’indicazione «delle Pergamene», indicazioneche viene comprovata da due degli esemplari da me rinvenuti presso la BAV (su di essi,
consente di datare le stampe rinvenute presso la BAV, alla segnatura Fer-raioli. IV. 8533, int. [28],105 che consistono in tre fogli singoli (citati comeV1, V2 e V3): i prime due di formato grande (il primo di mm 610 × 450;il secondo di mm 610 × 360), con ogni probabilità approntati per esseresottoposti all’opera di miniatura del Piale; il terzo di formato ridotto (mm480 × 200), e conforme nel testo alle due più grandi, eccetto cinque dif-ferenze.106 I primi due sono quanto rimane della pergamena che nel 1784viene «collocata in una Tavoletta dietro il busto di Pericle»,107 e che «trail 1881 ed il 1882 non ci si trovava più, perché la tolsero di là i custodidel museo, sembrando ad essi che soverchiamente fosse deperita».108 Meno
Mauro Sarnelli162
si veda infra). In un più recente contributo sull’autore dell’impianto iconografico di que-sta stampa, RONALD T. RIDLEY (The forgotten topographer: Stefano Piale, in “Xenia Anti-qua”, IX [2000], pp. 179-200, a p. 184) ritiene invece che le «two miniatures» in que-stione si trovino «around the manuscript» della Prosopopea. Per quanto concerne il Piale,a latere è da segnalare che, nella Biblioteca Digitale dell’Archivio Viaggiatori Italiani aRoma e nel Lazio (http://www.avirel.it/bd/), sono consultabili le edd. moderne di AN-DREA MANAZZALE, Itinerario di Roma e suoi contorni […], Tradotta dalla III Ed. Franceseed aumentata da Stefano Piale Pittore e Socio dell’Accademia Archeologica Romana, 2tt., I, edited Alice Tudino, 2 aprile 2003 (I ed. Roma, Dai Torchj del Mordacchini,1817), e II, edited Jacopo Aizpiru, 14 novembre 2002 (il frontespizio della I ed. reca imedesimi dati del t. I, ma la data: 1816); e di La Città di Roma […], Nuova Ed. Rive-duta ed Aumentata da Stefano Piale Pittore, Accademico Corrispondente Ercolanense eSocio Ordinario dell’Accademia Romana di Archeologia, 2 tt., I, edited Eva Magrini,23 marzo 2003 (I ed. In Roma, A spese di Venanzio Monaldini Librajo […]. Nella Stam-peria Cannetti, 1826), e II, edited Paolo Badalì, 7 aprile 2004 (il frontespizio della I ed.reca i medesimi dati del t. I).
105 Presso il catalogo cartaceo della BAV, i tre fogli risultano schedati, nonostantealla conclusione dell’indice manoscritto di questa miscellanea, posto su due fogli a ri-ghe inseriti all’inizio del volume, al di sotto dell’int. 27 si legga la generica indicazione:«[Vi sono aggiunti 3 fogli con poesie].».
106 65 V1-2 di età] V3 d’età. 118 V1-2 cigolio] V3 cigolío. 120 V1-2 udio] V3 udío.139 V1-2 si] V3 sì [evidente refuso]. Inoltre al termine vi compare l’indicazione: «Dell’Ab.Vincenzo Monti».
107 M, p. 297, n. 12 (relativa a p. 49).108 VICCHI, Vincenzo Monti, le lettere e la politica in Italia dal 1750 al 1830 (Decennio
1781-1790), Faenza […], Stabilimento P. Conti stampatore – Fusignano […], Da EdoardoMorandi venditore, 1883, p. 309, n. 1; di séguito, lo studioso ne fornisce una descrizionedettagliata: «L’intestazione in caratteri rossi era questa: Prosopopea di Pericle alla Santitàdi N. S. Pio VI [scil., è trascritta partitamente infra, n. 109]. La poesia non portava la sot-toscrizione dell’autore, né l’indicazione dell’anno, della città e dello stampatore. Nel fo-glio a stampa, che misurava cent. 62 d’altezza e cent. 22 di larghezza [scil., era evidente-
perspicua appare la funzione di V3, forse da interpretare come una sortadi “prova di stampa” in formato minore, oppure come testimone dell’ini-ziale progetto di esporre la Prosopopea in una dimensione più contenuta.
La lettura della redazione stampata in V1-2-3 apporta nuovi elementialla vicenda compositiva del nostro brano, in quanto il Monti attende aquest’occasione preziosa ed importante rielaborandone ancora una voltail testo, in tal modo suggellando l’iter creativo di esso a cinque anni dallasua prima stesura, con esiti non raccolti nelle due successive edizioni B eVr, esemplate (come si è visto) su S, dell’anno precedente i tre fogli; nénel prodotto dell’ultima, e molto più lontana cronologicamente, fase re-dazionale del brano, ossia M.
Le modifiche significative apportate da V1-2-3 alla precedente reda-zione S riguardano due luoghi:
1) 14-15 S Gelosi il loco, e l’orme, / E il fato incerto piansero] V1-2-3
L’incerto loco, e l’orme, / E le vicende piansero; 2) 112 S Le gran colonne usciro] V1-2-3 L’alte colonne usciro;
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 163
mente stato rifilato per essere inserito nella «Tavoletta» ricordata supra, e n. precedente],si vedevano alcuni fregi in acquarello; nell’alto lo stemma dei Braschi in campo rosso; ailati quattro gigli e dodici stelle, e al basso quattro aquile, due per angolo. Eransi presetutte le precauzioni perché la poesia del Monti si conservasse gran tempo, avendola in-collata sopra una lamina d’ottone e postala con suo cristallo in una cornice dello stessometallo». Tali «precauzioni» avevano prodotto invece un effetto contrario, facendo sì chequesta fosse «deperita molto prima, poiché la polvere e le tarle non avrebbero a quest’oraoperata la rovina a cui soggiacque la poesia per quella patina muffata che si produce so-pra l’ottone, se non tiensi lustrato periodicamente» (ibid.). Il foglio che ancora oggi sitrova al lato sinistro dell’erma di Pericle, al numero 44 della Sala delle Muse – dove lo siè consultato –, è una copia tardottocentesca (il cui testo riproduce con alcune variantiquello di V1-2-3), come ricordano il Catalogo, a c. di Carlo Pietrangeli e Giovanni Incisadella Rocchetta, della Mostra Vincenzo Monti a Roma, pp. 31-96 (a p. 47, n° 4); e PIE-TRANGELI, Stefano Piale miniatore, incisore e archeologo romano, p. 271.
109 Titolo S PROSOPOPEA / DI PERICLE / ALLA SANTITÀ / DI N. S. PIO VI .] V1-2-3
PROSOPOPEA / DI PERICLE / ALLA SANTITÀ / DI N. S. PIO SESTO . (M Proso-popea di Pericle. / Alla Santità di Pio VI.). 22 S infelìce] V1-2-3 infelice (M infelice). 52 Sargive] V1-2-3 Argive (M argive). 65 S d’età] V1-2 di età (M d’età). 73 S argolici] V1-2-3
Argolici (M argolici). 109 S parie] V1-2-3 Parie (M parie). 113 S tessali] V1-2-3 Tessali(M tessali). 118 S cigolío] V1-2 cigolio (M cigolío). 120 S udìo] V1-2 udio (M udío). 121S industria] V1-2-3 Industria (M Industria). 134 S achive] V1-2-3 Achive (M achive). 139S si] V1-2 sì [evidente refuso] (M si). 142 S goto] V1-2-3 Goto (M goto).
mentre negli altri casi si tratta di più usuali varianti tipografiche,109
allotropiche,110 o interpuntive,111 e di un recupero da F.112
E tanto impegno variantistico nell’arco del primo quinquennio di vitadella Prosopopea fa sì che su ognuna delle cinque edizioni di essa il Montiponga mano: «segno evidente dell’importanza che – giustamente – egli[…] annetteva» a quest’ode,113 il cui sicuro successo lo motiverà a reci-tarla ancora l’anno successivo a V1-2-3, in conclusione di «un’Accademiasemipubblica di Argomento libero», tenuta dai «Sigg. Accademici Qui-rini […] nella Sala dell’Ercole del Palazzo Sora», la domenica 1° maggiodel 1785.114
Un successo, fra l’altro, che scaturisce da una tale sintonia della Pro-sopopea con quelli che – seguendo Jurij Lotman – si possono definire i «si-stemi semiotici interdipendenti» dell’età di Pio VI,115 da essere in gradodi arricchire con il suo esempio i moduli concettuali ed espressivi dellapoesia encomiastica, diffondendosi nella medietas dell’ambiente culturalee letterario contemporaneo, già di per sé predisposto ad accogliere un mes-saggio che prende le mosse dai medesimi tópoi che caratterizzano tale am-biente. Questa “circolarità” è una delle motivazioni basilari della fortunaarrisa alla Prosopopea, alle quali va aggiunta la carica immaginativa im-
Mauro Sarnelli164
110 4 S maraviglia] V1-2-3 meraviglia (M maraviglia). 125 S dimentici] V1-2-3 di-mentichi (M Dimentici).
111 6 S latino ] V1-2-3 latino, (M latino,). 87 S immagini ] V1-2-3 immagini, (M im-magini ). 121 S arrise: ] V1-2-3 arrise. (M arrise:).
112 100 F, V1-2-3 gli ebbi (VQ, A, S, B, Vr, M l’ebbi).113 BEZZOLA, introduzione alla Prosopopea, in MONTI, Poesie, ed. Bezzola, p. 60.114 Diario Ordinario, nr. 1080, In data delli 7 Maggio 1785, In Roma, Nella Stam-
peria Cracas Presso S. Marco al Corso, 1785, p. 11; e poco oltre, p. 12: «Terminò l’Ac-cademia con una Canzone del Sig. Abate Vincenzo Monti sopra Pericle». Associandola,anche se ipoteticamente, a questa circostanza, il VICCHI ritiene la pergamena vaticanastampata nel 1785: «Forse, avendola abbellita, fu in quest’anno che il Monti la fece stam-pare in foglio separato» (Vincenzo Monti, le lettere e la politica in Italia dal 1750 al 1830(Decennio 1781-1790), p. 309).
115 Di quest’autore si vedano almeno, in traduzione italiana, Un modello dinamico delsistema semiotico [1974], in Testo e contesto. Semiotica dell’arte e della cultura, a c. di Simo-netta Salvestroni, Roma-Bari, Laterza, 1980, pp. 9-27; La semiosfera [1984], in La se-miosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pesanti, a c. di Simonetta Salvestroni, Ve-nezia, Marsilio, II ed. 1992 (I ed. 1985), pp. 55-76; e la raccolta postuma Cercare lastrada. Modelli della cultura, introduzione di Maria Corti, Venezia, Marsilio, 1994.
pressavi dall’autore nel tradurre in forma poetica il proprio modo di con-cepire l’esaltazione del presente, ed il suo rapporto con la memoria delpassato.
Detto in altri termini, a voler leggere il nostro brano con la lente delladialettica “norma”/“scarto”, risulta piuttosto palese che gli “scarti” di essonon comportano un allontanamento dal canone, bensì un’eccedenza rispettoad esso: stanno cioè nell’accrescimento, o meglio retoricamente nell’am-plificazione dei suoi nuclei fondamentali, sull’onda di una «poetica dell’en-tusiasmo e del sublime»,116 declinata dal Monti in termini più vicini alleposizioni di un Bettinelli (nonostante i rapporti non sempre idilliaci frai due), piuttosto che a quelle di un Paradisi.117
E guardando più vicino al milieu in cui il nostro autore agisce, si tro-vano delle vere e proprie dichiarazioni di poetica orientate in tal senso,come quella posta dal suo futuro “rivale” Luigi Godard in apertura delRagionamento che nel 1776 aveva funto da proemio alla contrastatissimalaurea capitolina di Corilla Olimpica, e che testimonia efficacemente di«quel flusso di velleità nuove ed estravaganti che aveva trovato il suosbocco nella seconda Arcadia»:118
La Poesia, la quale al dir di Bacone di Verulamio è sogno della Filoso-
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 165
116 CARLO DIONISOTTI, Ricordo di Cimante Micenio, in “Arcadia. Accademia Lettera-ria Italiana. Atti e Memorie”, s. 3a, vol. I (1948), pp. 94-121 (a p. 105).
117 Cfr. ANDREA BATTISTINI - EZIO RAIMONDI, Retoriche e poetiche dominanti, in Lette-ratura italiana, Direzione di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, III, Le forme del testo,1984, 2 tt., I, Teoria e poesia, pp. 5-339; poi IID., Le figure della retorica. Una storia lettera-ria italiana, Torino, Einaudi, 1990, p. 248: «Nella versione italiana, invero mediocre esfumata nel suo provincialismo, il dibattito sul significato da assegnare all’entusiasmo coin-volge il Bettinelli e Agostino Paradisi. Tra il primo, che lo intende quale elevazionedell’anima che desta la passione contagiando gli altri, e il secondo che, sulle orme di unWinckelmann senza rapimenti, lo ripone nel piacere quieto e statuario di chi contemplala bellezza associata alla perfezione, la vera differenza risiede nel patetico, ammesso dal Bet-tinelli ed escluso dal Paradisi il quale, forse non dimentico dello Pseudo-Longino, associail sublime alla semplicità esprema». Ibid., n. 3, molto opportunamente i due studiosi rin-viano a BINNI, Lo sviluppo del neoclassicismo nelle discussioni sul “gusto presente”, in Classicismoe Neoclassicismo, pp. 123-44 (a p. 129). Sui rapporti fra il Monti ed il Bettinelli, si vedanole indicazioni fornite dal ROMANO, Le polemiche romane del Monti, pp. 213-15; ripreso adlitteram in ID., Le polemiche romane di Vincenzo Monti (1778-1797), pp. 16-19.
118 DIONISOTTI, Ricordo di Cimante Micenio, p. 114.119 Cfr. FRANCIS BACON, De dignitate et augmentis scientiarum libri IX, liber III, caput I:
«Poësis [...] doctrinae tanquam somnium» (cit. da The works, Collected and Edited by Ja-
fia,119 può colla magìa de’ colori, colla evidenza delle immagini, col su-blime, col meraviglioso, col grande, e più colle precisioni fantastiche edastrazioni far in maniera, che il finto lasci su noi le stesse impressionidel vero, destando negli animi le gagliarde passioni, i patetici movi-menti, le sensibili idee, e dipingendo que’ costumi medesimi, che la Fi-losofia ci fa ravvisare negli uomini col soccorso della meditazione.120
Per aprire una finestra, sia pure minima e parziale, sulla ricezione dellaProsopopea nella prassi letteraria della Roma dell’inizio degli anni Ottanta– e quindi per illuminare il più generale discrimine fra sintonia ed ecce-denza del Monti rispetto a tale contesto –, può riuscire fruttuoso il con-fronto con un sonetto dell’abate Giuseppe Petrosellini (il futuro libretti-sta, fra l’altro, del Barbiere di Siviglia di Giovanni Paisiello), che sigla laParte II delle Rime degli Aborigeni, e che fin dal titolo testimonia della for-tuna del procedimento da cui trae origine l’ode montiana: Essendosi ulti-mamente scoperti in una Vigna presso la Porta Capena i sepolcri degli antichi Sci-pioni, si prende da ciò argomento di lodare la Santità di N. S. PIO PAPA SE-STO. Alla lettura di tale sonetto balza agli occhi come, nonostante la vo-luta allusione argomentativa, la forma metrica impiegata dall’autore, ed
Mauro Sarnelli166
mes Spedding [...]; Robert Leslie Ellis [...]; and Douglas Denon Heath [...], vol. II, NewYork, Hurd and Houghton [...] – Boston, Taggard and Thompson, 1864 [Republished:St. Clair Shores (Michigan), Scholarly Press, s.d. (ma 1976)], p. 251); ed Of the dignity andadvancement of learning, book III, chapter I: «Poesy is as a dream of learning» (ibid., vol. VIII,Being Translations of the philosophical works, vol. I, Boston, Published by Taggard and Thom-pson, 1863 [Republished: St. Clair Shores (Michigan), Scholarly Press, 1976], p. 470).
120 LUIGI GODARD, Ragionamento, in Atti della solenne Coronazione fatta in Campido-glio della insigne Poetessa D.na Maria Maddalena Morelli Fernandez Pistoiese tra gli ArcadiCorilla Olimpica, [colophon:] Parma, Stamperia Reale, 1779, pp. 45-60 (a p. 45); l’ed. mo-derna dell’opera costituisce l’Appendice III di ANNALISA NACINOVICH, «Il sogno incan-tatore della filosofia». L’Arcadia di Gioacchino Pizzi. 1772-1790, Firenze, Olschki, 2003,pp. 205-10 (il passo citato è, naturalmente, a p. 205). Non risulterà forse inutile ricor-dare due circostanze: la prima, che l’ed. di tali Atti ha luogo tre anni dopo l’evento ca-pitolino (avvenuto nella tarda sera del 31 agosto 1776), e precisamente poco meno didue mesi prima delle adunanze arcadiche indette per celebrare i voti quinquennali inonore di Pio VI (il colophon del volume, p. 296, reca come data della stampa «IL DI XXX
GIUGNO»); la seconda, che nel breve Ragionamento del Godard il termine «entusiasmo»ricorre non a caso per ben nove volte (ibid., alle pp. 46, 47 [in questa sola p., tre volte],48, 49, 55, 56 e 58; nell’ed. moderna, in NACINOVICH, «Il sogno incantatore della filoso-fia», alle pp. 205, 206, 208 e 209).
ancor più il classicismo tardo-petrarchista che pervade il brano, segnalinoun ben diverso approccio al confronto antico/moderno, pareggiando l’ar-dito ribaltamento di prospettiva esaltato dal Monti attraverso il ricorsotopicissimo ai concetti di esemplarità «de’ prischi Eroi» e della renovatiovirtutis sancita dal pontefice.
Trattandosi di un brano pressoché sconosciuto, gioverà qui trascri-verlo integralmente:
Non basta, invida età, che in seno a DiteGiacciansi i forti Scipion già spenti,Ch’ove germoglia tortuosa vite,Crudele, anche i lor nomi asconder tenti?Dopo mill’anni e mille all’aere usciteMiseri sì, ma illustri monumentiDe’ prischi Eroi, che fer con alme arditeD’Africa, e d’Asia impallidir le Genti.Nomi sacri alla Gloria, in cui s’unìoQuanto mai di più grande in pace, o in guerraDa man di Marte, o di Minerva uscìo.Nomi, che sdegnan di più star sotterra,Or, che ritrovan nel bel cor di PIOQuella virtù, che un dì regnava in Terra.121
Rientrando da tale sguardo al contesto, per affrontare un ragionamentosulle varianti della Prosopopea, appare interessante notare come, dopo l’“evo-luzionistico” giudizio del Vicchi,122 esse siano state più o meno unani-
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 167
121 Rime degli Aborigeni, Parte II, p. 135.122 Questo studioso, caldeggiando l’iniziativa «di raccogliere in un volume le poe-
sie del Monti, delle quali per sorte si posseggono varie lezioni con precisione di data»,al fine di «conoscere i progressi e le evoluzioni intellettuali del primo poeta dell’epoca»,pone a confronto parte della prima e dell’ultima redazione del nostro brano (ossia VQed M, da lui retrodatata di tre anni per una svista), traendone la conclusione «dellaenorme differenza fra le due lezioni e della sproporzionata superiorità della seconda aparagone della prima. La seconda ha più concetti, più gusto, più versi, più fondo sto-rico, più compitezza» (VICCHI, Vincenzo Monti, le lettere e la politica in Italia dal 1750 al1830 (Triennio 1778-1780), nell’ordine pp. 306, 307 e 308).
123 MUSCETTA, introduzione alla Prosopopea, in MONTI, Versi. Caio Gracco. La Fero-niade. Scelta, p. 8; ibid., Introduzione, pp. XVIII-XIX, lo studioso afferma che il Monti«su quest’ode ritornò amorosamente, la corresse, la lucidò, la rivestì di nuovi esornativi,di sonanti nomi propri» (brano ripreso ad litteram in MUSCETTA, Vincenzo Monti, p. 707).
memente interpretate come il segno del «passaggio al gusto, o diciamomeglio, all’oratoria neoclassica»,123 nel senso di una tendenza «all’elimi-nazione del prosastico»,124 o «di forme più direttamente frugoniane e ar-cadiche»,125 verso «l’armonia di impianto e linguaggio classicistici»,126
e «come emergenza di un nuovo gusto di ostentazione neoclassica».127
Rilievi senza dubbio calzanti nell’ottica di una considerazione generaledell’esito compositivo dell’ode, ma che ad una lettura particolare dellasua stratificazione redazionale assumono contorni più sfumati. Poiché in-fatti ben si adattano a comprendere passaggi come quello, eclatante, delverso iniziale da «Io degli Eroi di Grecia» (VQ), ad «Io degli Achei ma-gnanimi» (F; A de gli), ad «Io de’ forti Cecropidi» (da S in poi);128 o comequello che sintetizza i vv. 9-10 da «In seno a la recondita / Campagna Ti-burtina» (VQ), ad «In grembo al suol di Catilo» (come suona il v. 9 da F
Mauro Sarnelli168
124 CIANI, Le prime raccolte poetiche di Vincenzo Monti, p. 447; a p. 456, confrontandoi vv. 61-64 della nostra ode quali si leggono in A ed in S (trascrivendoli però con svi-ste, e con un prelievo da M per il v. 64 di S: lavoro al posto di travaglio), lo studioso af-ferma: «l’altra variante di una certa consistenza poco mi sembra dettata da esigenze stret-tamente artistiche e molto dalla volontà di accentuarne il carattere celebrativo dell’etàdi Pio VI, destinatario, con tanto di dedica altisonante, della Parte I dei Versi».
125 BINNI, Monti poeta del consenso, p. 82, n. 1: «La prima redazione è piena di formepiù direttamente frugoniane e arcadiche, in direzione languida e facile, oltreché di veree proprie sciatterie. In genere la revisione asseconda la intonazione più eletta, classi-cheggiante, solenne […], e tende a rafforzare la costruzione energica e rapida, elimi-nando le sbavature più languide e scialbe per un impasto cromatico più splendente esmaltato» (ibid., p. 82, lo studioso ritiene però che la «redazione definitiva» sia S).
126 MINEO, Vincenzo Monti: la ricerca del sublime, p. 37 (anche in questo caso, la re-dazione indicata come punto d’arrivo è S).
127 ROSSANO PESTARINO, Spunti di (auto)critica letteraria nel “Persio”, in Vincenzo Montinella cultura italiana, vol. I, t. II, pp. 1059-95 (a p. 1082), dove lo studioso riscontra –focalizzandovi la sua attenzione – come «clausole su nomi propri, sdruccioli in virtù delmetro, abbondino […] in tutta la […] Prosopopea, magari anche frutto del processo va-riantistico, da una parte come retaggio metrico settecentesco, dall’altra come emergenzadi un nuovo gusto di ostentazione neoclassica» (p. 1081).
128 Molto opportunamente PESTARINO, Spunti di (auto)critica letteraria nel “Persio”,p. 1082, commenta a questo riguardo che nella «redazione definitiva […] la designa-zione culta del popolo ateniese riceve, ad intonazione confacente, il massimo rilievo pos-sibile», consonante altresì con le varianti della quartina dei vv. 9-12. Ibid., n. 56, lo stu-dioso ricorda «la folle / teologia di Cecrope» nell’ode Amor peregrino, vv. 58-59 (in MONTI,Poesie, ed. Bezzola, p. 105); ma vanno altresì menzionate «le cecropie ruine» negli scioltiAlla marchesa Anna Malaspina della Bastia, v. 77 (ed. con varianti in Poesie, ed. Bertoldi,pp. 59-68, a p. 65).
in poi); o come quello conclusivo da «Spirto profano e lurido» (145 [nu-merazione originaria] VQ; F profano, e lurido; 149 A, S, V1-2-3 e B), a«Spirto profan dell’Erebo» (M). In queste varianti (ed in particolar modonella climax rielaborativa del primo verso), la connotazione “neoclassica”risiede in una tensione alla raritas dicendi, nella ricerca di epiteti al con-tempo preziosi ed intrisi di memorie dell’antico.
E sempre in un ordine di ragioni poetiche viranti al “neoclassico”, ri-sulta interessante notare come, fin dal passaggio da VQ ad F (si ricordi,del medesimo anno), il Monti nella seconda quartina intervenga radical-mente, cassando il già ricordato quadro prima sepolcrale, poi idilliaco(«Da i ciechi regni io Pericle / De gli estinti ritorno / L’ingenua luce ama-bile / A riveder del giorno»),129 a favore del ben più programmatico «Ariveder io Pericle / Ritorno il ciel latino, / Trionfator de’ barbari, / Deltempo, e del destino».130
Accanto a queste ed altre varianti che rispondono ad un concetto “mo-numentale” della poesia, si trovano interventi che o sembrano evocare unapoetica della vaghezza, come quello al v. 3 (ugualmente già da VQ ad F),che trasforma il definito «a i prischi secoli» nella litote «un dì non ul-timo»; o procedono verso approdi di maggiore linearità espressiva, anchenell’intento di evitare duplicati o vere e proprie ripetizioni. Là dove in-fatti la tormentata terza quartina da VQ ad F sostituisce ai vv. 11-12 laconnotazione aggettivale «Mi seppellì la barbara / Vandalica ruina» conl’ancor più pronunciato enjambement «Mi seppellì del Vandalo / Ladronl’ira, e lo scempio»,131 tale specificazione fa sì che al v. 26 (in queste dueprime redazioni non è stata ancora aggiunta l’ulteriore quartina sull’artescultorea) l’originario «De l’Unno infesto e truce» sia mutato nel più al-lusivo «Del già sofferto scorno».132 Ed a maggior ragione, quando con A
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 169
129 Tale duplice quadro viene recuperato a partire da A, rispettivamente vv. 25-28e 35-36 (si veda infra, e nn. 134 e 135). La trasformazione di questa quartina di VQ fasì che il «giorno» qui in sede rimica al v. 8 venga reintrodotto al v. 28 da F in poi: VQE disprezzai la luce: ] F Ed ebbi orror del giorno: (A, S, V1-2-3, M utilizzano il punto fi-nale; B, Vr il punto e virgola).
130 5 B io, Pericle, ; Vr , io Pericle, . 6 A Latino ; S latino . 8 A, V1-2-3, B, Vr, Mtempo e.
131 A Mi seppellir del Vandalo / Ladron le stragi e l’ire; S, V1-2-3, B, Vr, M Mi sep-pellì del Vandalo / La rabbia [S ,] e l’ignoranza.
132 Al v. sg., soltanto F testimonia la variante «più grave ingiuria», al posto dellasuccessiva e poi definitiva «novella ingiuria» (da A in poi).
vengono modificati i vv. 21-24, che in VQ ed F suonano «Sen dolse ladifficile / Arte che ottien virtude / Di dar sembianza [F ,] ed anima / Almarmo freddo [F ,] e rude»,133 e soprattutto viene introdotta la quartinaappena ricordata, in cui il Monti recupera l’atmosfera sepolcrale cassataai vv. 5-6,134 l’inserimento del nome di Cassio (sempre in sede rimica)produce la sua omissione nella quartina dei vv. 33-36 e la conseguenterielaborazione di essa, che si conclude con un altro recupero, ossia quellodella scena idilliaca ai vv. 7-8 di VQ:
Ed aspettai benefica Ed aspettai benefica Ed aspettai beneficaEtade in cui l’amica Etade, in cui l’antico Etade in cui securoDimenticar di Cassio Più non bramar di Cassio Levar la fronte, e l’etereMagnificenza antica (VQ). Genio dell’arti amico (F). Fruir sereno e puro (A).135
Continuando ad indagare dall’interno l’officina creativa del Monti,s’incontrano forme che nei vari passaggi aspirano in maniera palese adun’espressività tragica, come quelle che conducono alla redazione finaledel v. 10, inizialmente seconda parte del già ricordato enjambement “ar-cheologico-topografico” indicante la villa di Cassio («In seno alla recon-dita / Campagna Tiburtina», VQ, vv. 9-10), poi mutato in «Con esecrandoesempio» (F), quindi in «Con scellerato ardire» (A), ed infine nell’escla-mativo «(Funesta rimembranza!)» (da S in poi).
Insieme alla terza quartina, anche la successiva è frutto di più fasi re-dazionali, tendenti a sviluppare in diverse forme il carattere “incerto” delritrovamento delle rimpiante vestigia di Pericle, del quale solo in M vieneribadita, grazie all’aggiunta dell’aggettivo possessivo «mie perdute forme»,
Mauro Sarnelli170
133 A Carca d’alto rammarico / Sen dolse l’infelice / Del marmo freddo e ruvido /Bell’arte [B Arte] animatrice. [B, Vr, M ;]. A latere, è da ricordare che di tale immaginedella scultura il Monti si ricorderà quasi trent’anni dopo, nell’ode In occasione del partodella vice-regina d’Italia […], vv. 79-82, in cui quest’arte è raffigurata mentre «agita /[…] di marmi il fervido / Animator scalpello» (MONTI, Poesie, ed. Bertoldi, p. 101).
134 Su questa quartina aggiunta, si veda supra, e n. 65.135 34 B, Vr Etade, in. M sicuro. 36 S, V1-2-3, B, Vr, M tranquillo e.136 13 F, A Posteri. 14 F sito, e. 16 F Delle.137 14 S loco, e. 16 S, B, Vr Delle.
Ne ricercaro i posteri Ne ricercaro i posteri Ne ricercaro i posteriGelosi il sito e l’orme, L’incerto loco, e l’orme, Gelosi il loco e l’orme,E paventar la perdita E le vicende piansero E il fato incerto pianseroDe le scolpite forme (VQ, F, A).136 Delle perdute forme (V1-2-3). Di mie perdute forme (M).137
l’intonazione monologica:Varianti più minute interessano le quartine dei vv. 37-60, e paiono
tutte accomunate dall’intento di innalzarne il livello stilistico, attraversomodifiche lessicali che mutano «la chiesta etade» (VQ, F, A) in «l’età bra-mata» (38 da S in poi); «biondo Tevere» (da VQ a Vr) in «sacro Tevere»(39 M); «scorrono» (VQ) in «giacciono» (F, A), quindi in «caddero» (41da S in poi), con una scelta del tempo verbale con ogni probabilità solle-citata dalla più immediata sostituzione in sede di rima sdrucciola di «por-tano» (VQ) in «ebbero» (43 da F in poi); e «la lingua irrita [F ,] e scalda»(VQ, F) in «alla [A a la] tenzon si scalda» (60 da A in poi).
Come già le quartine ai vv. 9-16, anche quelle ai vv. 61-68 vengonosottoposte dall’autore ad un cambiamento abbastanza consistente, che neraddoppia il tono encomiastico,138 mantenendolo nella prima di esse e ri-proponendolo all’inizio della seconda:
Forse restar doveami Forse restar doveamiFra tanti io solo ascoso, Fra tanti io sol celato,Ed un momento attendere E miglior tempo attenderePiù fausto e glorioso? Dall’ordine del Fato? Io che cent’altri accendersi Io, che d’età sì fulgidaFarò di giusta invidia, Più ch’altri assai son degno?Poiché son opra e studio Io della man di FidiaDe lo scalpel di Fidia? (VQ, F, A)139 Lavoro e dell’ingegno? (M)140
A partire dalla quartina successiva, tutte le altre varianti si appuntanosu singole forme, di volta in volta:
1) tese ad accentuare il tono patetico, come nelle quartine dedicate adAspasia, dove gli originari «formosa» (VQ), «degna» (VQ, F, A), «ri-messa» (VQ), ed «ancor» (VQ), diventano nell’ordine «fedele» (69 da Fin poi), il forte latinismo «donna» (71 da S in poi), «dimessa» (74 da Fin poi), ed «Amor» (79 da F in poi), che istituisce una preziosa ciclicitàcon l’«Amore» in sede rimica al v. successivo;
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 171
138 Cfr. il giudizio del CIANI, riportato supra, n. 124.139 60 (numerazione originaria) F fausto, e. 63 F opra, e. 64 F Dello.140 65 S, V1-2-3 Io che] B, Vr Io, che. S, V3, B d’età] V1-2, Vr di età. 66 S, V1-2-3 de-
gno. ] B, Vr degno, . 68 S, V1-2-3 Travaglio, e] B, Vr Travaglio e.
2) frutto di un’amplificatio, come quella che aumenta i «cento voltiArgolici» (da VQ a Vr),141 a «mille» (73 M), con probabile allusione agliaccrescimenti del Museo Pio-Clementino; o come quella del v. finale, dovel’originario «onorarti» (VQ, F, A) diventa «adorarti» (da S in poi);
3) potenzianti il carattere paratattico-sentenzioso, come quella chemuta «Ma lo vedrà, che immemore» (VQ, F, A)142 in «Ma ben vedrallo:immemore» (77 da S in poi);
4) gravitanti con varie sfumature nel campo sinonimico, come «Pela-ghi» (VQ, F, A, S, B, Vr)143 trasformato in «Ellèni» (88 M); «qua tersi»(VQ, F, A)144 in «nitenti» (101 da S in poi); «offriro» (VQ) in «usciro»(112 da F in poi);145
5) fonetiche, come i passaggi da «prendeano» (VQ, F, A) a «prende-vano» (103 da S in poi); da «dimentichi» (l’unica variante che unisce VQe V1-2-3, senza toccare la tradizione intermedia) a «dimentici» (F, A, S, B,Vr, M), da «Tebbro» (VQ) a «Tebro» (136 da F in poi);
6) evitanti una sinalefe dura, come «Là ubbidiente» (VQ, F, A)146 chediventa tout court «Ubbidiente».147
Calata la sua ideazione nel contesto dell’iter letterario dell’autore, ed
Mauro Sarnelli172
141 73 F, S, B, Vr, M argolici.142 73 (numerazione originaria) F vedrà; ; A vedrà: .143 88 B, Vr pelasghi.144 97 (numerazione originaria) F quà tersi, e.145 112 Vr vseìro [evidente refuso].146 101 (numerazione originaria) F ubbiente, [evidente refuso].147 Varianti più minute appaiono le modifiche di: 2 VQ, F Fra l’inclita] da S in poi
Nell’inclita (A Ne l’); 18 VQ, A a i (F ai) figli sui] da S in poi a’ figli sui; 96 da VQ aVr In paragon] M Al paragon; 100 VQ, A, S, B, Vr, M l’ebbi] F, V1-2-3 gli ebbi; 102VQ, A de i (F dei) fabri] da S in poi de’ fabri; 136 VQ, F, A in su le rive] S, V1-2-3 sulle(B, Vr, M su le); 147 VQ con l’amor[e] ] da F in poi coll’amor (A co l’amor); e dell’im-mediatamente successivo 147 VQ, A de i (F dei) popoli] da S in poi de’ (Vr de) popoli.Due varianti di mancate elisioni interessano unicamente F (numerazione originaria): 118di Atene; 152 di onorarti.
148 Il riferimento è all’opera che esalta il più che ventennale pontificato del Braschi(15 febbraio 1775–29 agosto 1799), a cinque anni dalla sua scomparsa: GIO. BATISTA
TAVANTI, Fasti del S. P. Pio VI con note critiche documenti autentici e rami allegorici, Italia[ma Firenze], A spese di Gio. G. Chiari, 1804, 3 tt. Nella narrazione delle due impresedi cui si è spesso parlato durante quest’intervento, ossia il mecenatismo culturale e l’operadi bonifica pontina, il TAVANTI (si veda in particolare ibid., t. I, capp III e IV, nell’or-
in quelli strettamente intersecantisi dei «Fasti di Pio VI»148 e della se-conda Arcadia, seguìto il suo percorso compositivo attraverso l’analisidelle varianti, focalizzate le sue tensioni poetiche ed ideali, la Prosopopeaacquista un volto ed un significato che rendono ragione del non sopitointeresse dell’autore per essa, e della sua fortuna critica, sancita dal Car-ducci, che la individua come lo snodo di transizione fra le prime due «se-rie» dell’attività poetica montiana.149 Nella nostra ode, infatti, la cele-brazione della memoria e del ritorno dell’antico viene declinata dal Montiin una pluralità di chiavi, che spaziano dall’archeologia all’encomiastica,dalla cantabilità arcadica ai fermenti neoclassici, dall’afflato neoumani-stico all’entusiasmo sublime.
E non appare casuale, in un clima di rinnovato (e sia pure “bizantino”)classicismo, la circostanza per cui il primo saggio scientifico e varianti-stico su questo brano, ossia quello più volte ricordato di Giovanni Me-stica, venga elaborato nel medesimo periodo, e veda la luce nel medesimofascicolo della romana “Nuova Antologia”, in cui D’Annunzio pubblicale sei composizioni dedicate a Villa Chigi, che entreranno a far parte del
La Prosopopea di Pericle in Arcadia e oltre 173
dine pp. 49-80 ed 81-124 passim) si dimostra più volte debitore della di poco precedenteStoria di Pio VI Pontefice Ott. Mass. Dell’Ab. F<RANCESCO>. B<ECATTINI>. Acc<ademico>.Ap<atista>., Venezia, Presso Antonio Zatta qu: Giac., 1801-02, 4 tt., I, 1801, libri IIIe IV, rispettivamente pp. 78-117 e 118-200 passim.
149 Cfr. CARDUCCI, Vincenzo Monti, I, Prefazione a “Le poesie liriche di Vincenzo Monti”[1858], in Opere, Ed. nazionale, vol. XVIII, Poeti e figure del Risorgimento. Serie prima,1939, pp. 125-31 (alle pp. 127-28): «Desunsi dalle mutazioni degli avvenimenti in ri-spetto alla storia e del poeta e de’ tempi una partizione ragionevole in cinque comodeserie. Delle quali contiene la prima i versi scritti dal 1770 al 1780, nell’adolescenza egiovinezza in Ferrara e ne’ primi due anni del soggiorno di Roma, sotto le impressionidella poesia del Varano del Minzoni per certa conformità d’ingegno sentite e avvertite,o sotto l’influenza delle scuole frugoniane e arcadiche per compiacere alla moda subìte;quasi tutti piacenti per gioconda floridezza, promettenti tutti generosa maturità. Si ter-mina colla Prosopopea di Pericle, mirabile di virile parchezza: che accenna anzi già mostrail carattere dei versi della seconda serie, scritta dall’81 al ’96 negli aurei tempi di PioVI». All’inizio del successivo Il Monti principiante [1882], ibid., pp. 115-21 (a p. 117),l’autore sviluppa ulteriormente tale argomentazione, sostenendo come «i primi versi cheannunziarono in Vincenzo Monti all’Italia il poeta il quale avrebbe eseguito più vir-tualmente la trasformazione artistica della nuova generazione o rappresentato in sé losvolgimento dell’Arcadia al neoclassicismo italiano furono la Prosopopea di Pericle e la Bel-lezza dell’universo».
150 GABRIELE D’ANNUNZIO, Elegie romane. Villa Chigi, in “Nuova Antologia”, XXIV(1989), pp. 158-63; se ne veda l’ed. in Versi d’Amore e di Gloria, ed. diretta da Luciano
libro II delle sue Elegie romane.150 Non si vuole certo replicare qui il vul-gato abbinamento Monti-D’Annunzio, ma porre ancora una volta l’ac-cento sulle consonanze storiche, culturali e letterarie, cioè, in una parola,di poetica, che scandiscono gli approcci agli autori e ne indirizzano il For-tleben, il loro essere recepiti oltre il contesto/i contesti entro i quali si sonoespressi. Poiché, come Aby Warburg ha illuminato con l’usuale pregnanzadi visione, a proposito di una celeberrima scultura antica di cui si è fattocenno nel corso di quest’intervento, «se anche non avesse scoperto il grupposofferente del Laocoonte, il Rinascimento l’avrebbe comunque inventatoin ragione della sua sconvolgente eloquenza patetica».151 Il che equivalea dire ancora una volta – qualora ve ne sia necessità – che il senso di ogniavvenimento storico lo dà la storia.
Mauro Sarnelli174
Anceschi, a c. di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, Introduzione di Luciano Ance-schi, Milano, Mondadori, 1982-84, 2 voll., I, [a c. di Niva Lorenzini,] V ed. 2001, pp.341-92 (alle pp. 364-69).
151 ABY WARBURG, L’ingresso dello stile ideale anticheggiante nella pittura del primo Ri-nascimento, in Opere, vol. I, La rinascita del paganesimo antico e altri scritti (1889-1914), ac. di Maurizio Ghelardi, Torino, Aragno, 2004, pp. 583-683 (a p. 676; come indica ilcuratore a p. 583, «La conferenza fu tenuta da Warburg al Kunsthistorisches Institutdi Firenze il 20 aprile 1914»). In un precedente contributo, riferendosi sempre alla sco-perta del Laocoonte, lo studioso rilevava che «in quell’occasione si trovò semplicementequello che da tempo si era cercato (e che infine si trovò) nell’Antico, vale a dire la formaestrema della gestualità e della fisiognomica, stilizzata nella sublime tragicità» (Dürere l’Antichità italiana [1906], ibid., pp. 403-24, a p. 417). Devo la citazione delle rifles-sioni warburghiane su questo gruppo ad un raffinato contributo di SALVATORE SETTIS,Laocoonte. Fama e stile, Roma, Donzelli, II ed. 2006 (I ed. 1999), p. 20.





























































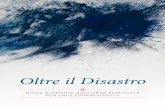
![Monni, S. (2013) “ Oltre il velo di Maya: il ruolo delle idee e delle Istituzioni” [in Italian].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63225731050768990e0fd043/monni-s-2013-oltre-il-velo-di-maya-il-ruolo-delle-idee-e-delle-istituzioni.jpg)