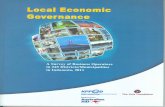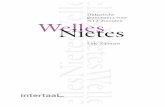243-EN-local-economic-governance-in-indonesia-a ... - Neliti
M. Ricucci, Oltre i confini di Babele; riflessioni per una didattica della grammatica latina con il...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of M. Ricucci, Oltre i confini di Babele; riflessioni per una didattica della grammatica latina con il...
CENTRO DE ESTUDOS CLÁSSICOSFA C U L D A D E D E L E T R A S D E L I S B O A
EVPHROSYNEREVISTA DE FILOLOGIA CLÁSSICA
NOVA SÉRIE VOLUME XLII
MMXIV
E V P H R O S Y N EREVISTA DE FILOLO GIA CL ÁSSICACentro de Estudos Clássicos – Faculdade de Letras
PT – 1600-214 [email protected]
ORIENTAÇÕES PARA PREPARAÇÃO DE ORIGINAIS
1. Euphrosyne — Revista de Filologia Clássica, órgão do Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, está aberta à colaboração da comunidade cientí!ca na área da !lologia clássica, entendendo esta em sentido largo da diacronia da tradição, das áreas cientí!cas especí!cas e respectivas disciplinas.
2. Os artigos poderão ser enviados por correio electrónico para [email protected] ou para a morada do Centro de Estudos Clássicos.
3. Os originais enviados para publicação devem ser inéditos e não estar submetidos a outra entidade editorial; serão remetidos à Direcção de Euphrosyne em forma de!nitiva e apresentados segundo as normas da revista. Os originais não serão devolvidos, assumindo-se que os autores conservam cópia dos mesmos. Os trabalhos considerados a publicação são sujeitos a arbitragem cientí!ca.
4. Serão aceites até 31 de Dezembro trabalhos para publicação no volume do ano seguinte; será dada informação sobre a aceitação da publicação até 30 de Abril do ano da publicação do volume.
5. O original será sempre apresentado electronicamente e em forma dupla: em documento de texto (Word/.doc(x) -pref.) e em PDF.
6. O artigo será encabeçado por: a) título (breve e explícito); b) nome e apelidos do autor; c) instituição académica ou cientí!ca a que está adstrito; d) endereço electrónico; e) resumo (não superior a 10 linhas) em língua inglesa; f) indicação de três palavras-chave em língua inglesa.
7. A extensão recomendada para os artigos é de 10 páginas, não devendo ultrapassar 20 páginas de A4, a corpo 12 e duplo espaço.
8. Sistema de notas: !m de artigo (endnotes); numeração automática seguida. Na publicação, as notas de artigo sairão em fundo de página (footnotes).
9. Sistema de referências: a) Não é permitida remissão para páginas do interior do artigo. b) Referências (em nota): Monogra!as: J. "# R$%&''(, La crainte et l’angoisse dans le théâtre d’Eschyle, Paris, 1959, pp. 120-130
(casa editora mencionada apenas para edições antigas). Ou em 2.ª ref.: J. "# R$%&''(, op. cit., p. 78. Revistas: R. S. C)'"*#'', “+e Misogyny of Eteocles”, Arethusa, 6, 1973, 193-231 (vol., ano, pp.).
Ou em 2.ª ref.: R. S. C)'"*#'', loc. cit. Obras colectivas: G. C),)''$, “La circolazione dei testi greci nell’Europa dell’Alto Medioevo” in J.
Hamesse (ed.), Rencontres de cultures dans la Philosophie Médiévale - Traductions et traducteurs de l'Antiquité tardive au XIVe siècle, Louvain-la-Neuve, 1990, pp. 47-64.
c) Abreviaturas: Seguir-se-ão as abreviaturas convencionadas por "LL, para autores latinos; Liddel-Scott-Jones, para autores gregos; Année Philologique, para títulos de revistas; para as abreviaturas mais comuns: p. / pp.; ed. / edd.; cf.; s.u.; supra; op. cit.; loc. cit.; uid.; a.C./d.C. (em redondo).
d) Citações: Devem ser colocadas entre comas “...” (não as de textos gregos); os itálicos serão utilizados apenas para sublinhar palavras ou pequenas frases; as citações em latim ou em grego serão breves.
10. Eventuais !guras ou imagens serão de qualidade grá!ca (de preferência no formato TIF, com a res-olução mínima de 200 p.p.), fornecidas em suporte electrónico (como os originais) e com a indicação precisa da referência no texto e na ordem assim como do título (devem ser acautelados os direitos de reprodução por parte do autor do artigo).
11. Aos autores não será fornecido mais do que um jogo de provas; estas deverão ser devolvidas num prazo máximo de 7 dias. Em princípio, não serão permitidas alterações ao original.
12. Aos autores será fornecido um exemplar do volume e a versão electrónica do respectivo artigo.
E V P H R O S Y N EREVISTA DE FILOLO GIA CL ÁSSICA
!
CENTRO DE ESTUD OS CL ÁSSIC OSFACULDADE DE LETR AS DE LISB OA
PT - 1600.214 LISBOAPORTUGAL
e-mail: [email protected]ítio electrónico: http://www.letras.ulisboa.pt/cec/
D&/#01$/)M)/&) C/&21&3) "# C)21/$-M)&) "# S$42) P&%#31#'
C$%&225$ "# R#")065$A7#' "$ N)20&%#31$ P#3), A3) M)/8) S)309#: T)//8$, A/3)'"$ M$31#&/$ "$ E2;8/&1$ S)31$, J$2< P#"/$ S&',) S)31$2 S#//), M)34#' J$2< "# S$42) B)/7$2), P)4'$ F)/%9$42# A'7#/1$, V)3") M)/&) C$41&39$ G)//&"$
A3)21=0&$
C$32#'9$ Cľ>&0$A&/#2 A4?421$ "$ N)20&%#31$ (U. Lisboa), C)/'$2 S)31&3& (U. Perugia), C)/%#3 C$"$@#/ (U. Salamanca), E%&'&$ S4=/#: "# ') T$//# (U. Pompeu Fabra), J$A' T9$%)2 (U. Perpignan), J$2< M)34#' D8): "# B421)%)31# (U. de Santiago de Compostela), M)34#' A'#B)3"/# JC3&$/ (U. Lisboa), M)/0 M)(#/ ( O'&,< (U. Barcelona), P)$'$ F#"#'& (U. Bari),
T9$%)2 E)/'# (U. Oxford)
C$32#'9$ "# A/7&1/)?#% Cľ>&0) Á3?#' Ú/7)3 (U. Córdoba), A33) B#''#11&3& DCSICE, B)//( T)('$/ (+e British Library), C)/%#3 M$/#3&'') (U. Valencia), C#2)/ M$11) R&$2 (U. Belo Horizonte), C'=4"&) T#&B#&/) (U. Évora), D),&" G4#11#/ (U. Windsor), D),&" P)3&)?4) (U. Salamanca), E%)34#'# D#11$/& (U. Roma II – Tor Vergata), F)7&$ S1$F (U. Roma II – Tor Vergata), F#/3)3") B/)2#1# (U. Aveiro), F&$3) M)0&31$29 (U. Oxford), G&)30)/'$ A77)%$31# (U. Napoli Federico II), G&)3'4&?& B)'"$ (U. Padova), G&42#;;# F')%%&3& (U. Macerata), G/):&)3) B/#20&) (U. Foggia), I") G&'") M)21/$/$2) (U. Firenze), J)0G4#2 E'>)22& (U. Metz), J#)3 M#(#/2 (U. Montpellier), J$5$ T$//5$ (U. Aveiro), J$)G4&% P&39#&/$ (U. Madeira), J$2< M)/8) M)#21/# M)#21/# (U. Cádiz), J4)3 G&' (Real Academia Española), M)11#$ P#''#?/&3$ (U. Foggia), M&/#&''# A/%&2#3-M)/09#11& (U. Toulouse II – Le Mirail), O3$>/&$ V$B (U. Del Salento, Lecce), R$7#/1$ C/&21$>$'& (U. Perugia), R$2)'7) D&%43"$ (U. Bari), S)3"/) R)%$2 M)'"$3)"$ (U. Cádiz), S)/)9 P#)/0# (U. Southampton), S1#>)3$ G/)::&3& (U. Salerno), V&01$/&) E%%) P)?=3 (U. Florida),
V&11$/&$ F#//)/$ (U. Roma 3), W&''&)% J. D$%&3&F (U. Otago)
Tiragem 500 exemplaresDepósito legal 178089/02
ISSN 0870-0133
PUBLICAÇÃO ANUAL SUJEITA A ARBITRAGEM CIENTÍFICA
R#>#/#30&)") #%L’ A33<# P9&'$'$?&G4# | M#"&$#,$ L)1&3$ | CSA L&3?4&21&02 A3" L)3?4)?# B#9),&$/
A721/)012 | B&7'&$?/);9&# I31#/3)1&$3)'# "# L’ H4%)3&2%# #1 "# ') R#%)3&22)30# | D&)'3#1ERIH | L)1&3"#B | SCOPUS | EBSCO
EVPHROSYNE, 42, 2014
Oltre i con!ni di Babele: ri"essioni per una didattica della grammatica latina
con il metodo neocomparativo!
M RUniversità degli Studi di Udine
Dumtaxat rerum magnarum parva potest resExemplare dare et vestigia notitiai…
(Tito Lucrezio Caro, De rerum natura II, -)
#. Premessa: innovare per non morire?
Innumerevoli interventi, anche recenti, lanciano l’allarme sulla precaria condizione dell’insegnamento delle lingue classiche nelle scuole, delineando non solo il quadro della competizione della cultura classica con la cultura scientifica, ma fornendo anche una sintesi delle ragioni di quella che viene indicata (ormai da lunga data) come una “crisi” dell’insegnamento del latino e del greco, e spesso propongono possibili “antidoti”, con riferimento sia all’individuazione delle finali-tà e delle motivazioni da assegnare a queste discipline sia, in stretta correlazione, alle possibili innovazioni da introdurre nella metodologia didattica.
! Recebido em 23-10-2013; aceite para publicação em 10-04-2014.1 Da ultimo i Convegni internazionali: “Langues anciennes et mondes modernes, refonder
l’enseignement du latin et du grec” (Parigi, 31 gennaio e 1 febbraio 2012); “Disegnare il futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco in Italia e nel mondo” (Torino-Ivrea,12-14 aprile 2012); “Lingue antiche e moderne dai licei all’università” (Udine, 23-24 maggio). Per gli Atti dei due Convegni italiani: L. C, U. C (a cura di), Disegnare il futuro con intelligen-za antica. L’insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo, Bologna, Il Mulino, 2013. R. O, U. C (a cura di), Lingue antiche e moderne dai licei all’università, Bologna, Il Mulino, 2012.
2 Ciò è stato ampiamente discusso sotto numerosi punti di vista nel corso degli ultimi due secoli: L. M, “Metodo natura e storia culturale”, in G. Milanese (a cura di), A ciascuno il suo latino, Lecce, Congedo, pp. 34-44. F. W, L’impero di un segno (XVI-XX secolo), Milano, Feltri-nelli, 2004, pp. 251-394.
3 G. I D M, “Didattica della lingua latina oggi. Tendenze scientifiche e prassi scolastico-editoriale”, Bollettini di Studi Latini, 24, 652-666; N. N, “La Didattica delle lin-
228 MARCO RICUCCI
Ci si interroga ansiosamente, come avviene da secoli, sul senso dell’insegnamento della lingua ciceroniana finendo a volte per dare risposte paradossali, e nello stesso tempo sulla legittimità del mantenimento di queste discipline nei curricula scolastici, anche a fronte dei risultati di apprendimento sconfortanti denunciati regolarmente confermati dai bollettini giornalistici di fine anno scolastico.
Molto è stato scritto su quella che è stata la proposta metodologica certo più innovativa del panorama italiano, che ancora in tempi recenti veniva evocato, po-lemicamente, come l’oggetto di “quella che da dieci anni sembra l’unica domanda didattica possibile in merito al latino – Ørberg sì, Ørberg no”.
Nell’ambito della riflessione sulla didattica delle lingue classiche, il dibattito ha riguardato prevalentemente gli aspetti del modello teorico della grammatica di riferimento e la metodologia, mentre solo recentemente, in particolare nel mon-do anglofono, l’attenzione degli studiosi e dei docenti si è rivolta ai risultati della ricerca provenienti dalla didattica delle lingue moderne, nella speranza di poter trovare nuove strategie e approcci, fondati su studi teorici ed empirici, per miglio-rare l’apprendimento delle lingue antiche.
gue classiche”, Euphrosyne, 33, 453-472; G. C, “La strada verso Atene: una nuova didattica del greco al ginnasio”, Annuario del Collegio Arcivescovile ‘C. Endrici’ in Trento, 72, 2006-2007, 183-189; idem, “Verso Atene: diario di viaggio”, Annuario del Collegio Arcivescovile ‘C. Endrici in Trento, 73, 2007-2008,140-146; P. M, “Il latino e il greco: due sciscipline ‘scientifiche’. L’ esperienza di-dattica presso il ‘Liceo classico per le Scienze Vittorio Alfieri di Torino’”, in L. Canfora, U. Cardinale (a cura di), Disegnare il futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 473-483.
4 “Dal Rinascimento agli anni centrali del Novecento, la storia della cultura occidentale può essere scritta nel segno del latino. La stessa lingua regnò nella scuola, si fece sentire nella chiesa, almeno nei paesi cattolici, e sino al XVIII secolo fu il veicolo principale del sapere nelle sue forme dotte. Anche quando il latino perdette di importanza, per esempio nella scuola degli anni intorno 1950, rimase comunque, e dappertutto, un elemento del contendere (…). A questo punto si pone in tutta evidenza una domanda: a che scopo il latino? Se la padronanza della lingua non era il vero obiettivo da raggiungere, per quali ragioni si proseguì, e per un lungo periodo, a studiarlo? Cosa ci si attendeva da questo studio, e come lo si giustificò? Al di là degli effetti indotti dal suo insegnamento, quale fu il ruolo assegnato alla lingua di Roma nella società moderna? Insomma, tra funzionamento e ragion d’essere, tra pratiche e discorsi, tra realtà e rappresentazioni, che legittimità aveva ormai il latino? Il ‘problema del latino’, lo si farà capito, non può essere risolto nel solo dibattito pedagogico. Converrà a questo punto cambiare prospettiva, se si vuole cogliere pienamente ciò che, nel mondo occidentale, volle dire il latino” (F. W, op. cit., pp. 251-254).
5 “L’ obiettivo principale di legittimare lo studio del latino (e soprattutto della lingua), riba-dendone – in modo paradossale – l’importanza, proprio in funzione della sua inadeguatezza a ri-spondere alle richieste della società contemporanea” (R. L, “Didattica del latino: rassegna bi-bliografica (1999-2005)”, Bollettini Studi Latini, 37, 2007, 217).
6 Cfr. Associazione “TreLLE”, Latino perché? Latino per chi? Confronti internazionali per un dibattito. Questioni aperte, maggio 2008, url: http://www.treellle.org/files/lll/QA1.pdf.
7 G. M, “Insegnare le lingue antiche, insegnare le lingue moderne. Convergenze e illusioni”, in R. Oniga, U. Cardinale (a cura di), Lingue antiche e moderne dai licei all’università, Bo-logna, Il Mulino, 2012, pp. 78-79.
229OLTRE I CONFINI DI BABELE: RIFLESSIONI PER UNA DIDATTICA DELLA GRAMMATICA LATINA
In questo passaggio delicato del terzo millennio, occorre ripensare la didatti-ca delle lingue classiche nei curricola delle scuole superiori, nella consapevolezza che i giovani studenti sono certamente “nativi digitali” e abitanti del “villaggio globale”, ma sono ancora capaci di ascoltare le voci lontani degli antichi uomini.
Si deve, dunque, partire dal chiarimento di alcuni nodi concettuali per poter meglio comprendere la novità e la valenza della proposta del cosiddetto “metodo neocomparativo” per l’insegnamento della lingua latina.
$. Oltre il metodo “Ørberg”
A distanza di quasi cinquanta anni dalla pubblicazione della prima edizione del manuale di Hans Ørberg, diffusosi in Italia grazie al lavoro di Luigi Mira-glia, le risposte da parte dei docenti sono ancora in buona parte polarizzate fra entusiasti sostenitori e fieri oppositori, talora arroccati al metodo grammaticale--traduttivo (d’ora in poi MGT) o metodo “tradizionale”.
Ma dalla disamina di vari contributi specialistici, ci pare che il “metodo in-duttivo-contestuale” (MIC), come d’ora innanzi chiameremo il “metodo Ørberg”, ha quanto meno titolo a essere considerato un metodo “antidepressivo” contro la crisi identitaria e didattica di cui sopra. Secondo un recente tentativo di illustrare meglio i presupposti teorici del MIC alla luce delle teorie dell’apprendimento di una L del linguista applicato americano Stephen D. Krashen, il MIC “funziona” sostanzialmente per tre motivi: la gradualità dei testi “artificiali”, adattatati e via via originali; l’esposizione dello studente a un testo reso il più possibile compren-sibile da elementi testuali, contestuale ed extratestuali; l’interesse – quasi la libe-
8 M. R. P, Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning, ousand Oaks (CA), Corwin, 2010.
9 M. M, B. R. P, !e Global Village, Oxford, OUP, 1989.10 Nella celebre lettera indirizzata al Vettori, datata 10 dicembre 1513, Machiavelli, uno dei
grandi intellettuali del Rinascimento, scrive: “Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrit-toio; e in sull’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro hore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro”.
11 H. H. Ø, Lingua Latina per se illustrata, Hauniae (Copenaghen),1990 (=2010, Lingua Latina per se illustrata Pars I-II, Montella).
12 L’ altra denominazione più diffusa, “metodo natura”, ha generato fuorvianti fraintendimenti. 13 Nella bibliografia sulla didattica delle lingue classiche sia di latino sia (ancor meno) di
greco, per quanto mi consta, manca uno studio che mostri, in un quadro concettualmente argomen-tato a livello teorico, un tentativo di interpretazione glottodidattica, impostata su basi “scientifiche”, del metodo Ørberg. Vedi: M. R, L’ apprendimento delle lingue classiche alla luce delle teorie di Stephen D. Krashen, in R. Oniga, U. Cardinale (a cura di), Lingue antiche e moderne dai licei all’uni-versità, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 199-216.
230 MARCO RICUCCI
ra curiositas contro l’imperiosa necessitas di cui parla Agostino – che il racconto suscita nei giovani scolari. Per gli studenti istruiti mediante il MIC nella lingua latina, “il profitto risulta mediamente più alto che con il MGT, per buona parte del I volume. Poi si attesta su valori simili, ma favorisce un’adesione meno scolastica alla lingua e un apprezzamento per i valori culturali e linguistici (non meramente grammaticali) della disciplina”.
Il corso di lingua greca basato sul MIC è la versione adattata da Miraglia e Borri per l’esigenze del liceo classico italiano, a partire dall’originale inglese di Balme e Lawall, ovvero Athénaze. In un recente studio che mira a una valu-tazione quantitativa dell’apprendimento della lingua greca antica in merito alla comprensione globale del testo antico, secondo un filone in voga degli anni Set-tanta per le lingue moderne denominato “comparative method studies”, grazie alla procedura denominata cloze, è emerso che la media delle risposte delle classi del ginnasio (biennio del liceo classico) istruite (per un totale di alunni) mediante il MIC (, %) è grosso modo superiore di / rispetto alla media delle classi del ginnasio (per un totale di alunni) istruite mediante il MGT (, %).
14 F. Z, “Modelli didattici nella prassi scolastica attuale”, in U. Cardinale (a cura di), Nuove chiavi per insegnare il classico, Torino, UTET, 2008, p. 466.
15 Per una sintesi sulla storia del liceo classico nel sistema di istruzione e sul suo ruolo nella società italiana cfr. A. S D L, Il liceo classico, Bologna, Il Mulino, 1999.
16 Il corso di greco inglese è basato in pratica sul reading method: M. B, G. L, Athenaze: An Introduction to Ancient Greek Book I/II, Oxford, OUP, 20032, mentre la versione ita-liana è adattata e impostata sulle premesse del MIC: M. B, G. L, L. M, F. B (1999=), Athenaze, due volumi, Montella, Vivarium Novum, 20022. Per la differenza tra le due impo-stazioni del reading method e il MIC, cfr. S. C M, “La crisi del grieco antiguo y los métodos antidepresivos”, Estudios Clásicos, 137, 2010, 91-92. Per l’applicazione del reading method all’insegnamento delle lingue moderne in voga nei primi decenni del Novecento, in particolare nel mondo anglofono, cfr. P. E. B, Le s"de di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Novara, Utet, 2012, pp. 16-18.
17 M. R, “La dimensione valutativa dell’apprendimento linguistico del greco antico. Contributo per uno studio comparativo del metodo induttivo-contestuale e il metodo grammati-cale-traduttivo”, EL.LE (Educazione Linguistica – Language Education), 5, 2014, in corso di pubbli-cazione.
18 Dal confronto della media matematica dei risultati conseguiti nei test delle classi dei due metodi MIC e MGT, negli a.s. 2010/2011 e 2011/2012, presso il primo biennio (ginnasio) dei licei classici statali “Manzoni” e “Beccaria” di Milano, emerge un dato tendenziale, per altro riscontrabile nella lettura dei singoli risultati, in merito alla comprensione globale di un testo greco antico, della lunghezza (più o meno) di una versione standard, senza l’ausilio di un dizionario bilingue, senza la conoscenza preventiva del lessico e senza l’accertamento propedeutico della conoscenza del contesto inerente al contenuto testuale.
19 Per una sintesi teorica sulla procedura cloze e la sua applicazione alla valutazione nella didattica delle lingue classiche cfr. M. R, “La comprensione del testo antico. Una risorsa psi-cocognitiva per l’apprendimento delle lingue classiche”, La Nuova Secondaria, 6, 2013, 68-71.
231OLTRE I CONFINI DI BABELE: RIFLESSIONI PER UNA DIDATTICA DELLA GRAMMATICA LATINA
%. Tra antico e moderno: Latinitas rediviva?
In questo quadro concettuale, si può constatare come sia plurisecolare il di-battito tra langues vivantes e langues mortes che si è spostato, negli ultimi anni, mutato il contesto storico-culturale e alla luce dei risultati delle scienze linguis-tiche, verso un “dialogo serio con la didattica delle lingue moderne, dalla quale comprendere quanto, in un secolo e mezzo di studio e applicazione, si è costruito e tentato. E, se il latino e il greco sono lingue, non si vede perché sfuggire dal confronto”.
Nel Manuale per l’insegnamento del latino nella scuola del #$$$, Giordano Rampioni, confrontando l’insegnamento delle lingue classiche e moderne, sot-tolinea da una parte gli elementi comuni: – l’oggetto dell’apprendimento: una lingua; – uno dei suoi fini: la comprensione della comunicazione; – la distanza culturale fra L e L;
dall’altra mette ben in chiaro le divergenze: – distanza temporale tra lingue moderne e latino; – sviluppo della competenza attiva soltanto per le lingue moderne; – tipo di comunicazione oggetto dell’apprendimento: ogni tipo di comu-
nicazione per le lingue moderne, sostanzialmente letteraria per le lingue antiche;
– diversi canali della comunicazione: voce e testo scritto per le lingue mo-derne, testo scritto per il latino, con conseguente possibile ricorso a sensi diversi nell’apprendimento: udito e vista per le lingue moderne, sostan-zialmente vista per le lingue antiche.
In modo legittimo ci si può interrogare come si differenzi l’insegnamento delle lingue moderne dalle lingue antiche a livello metodologico; ma la risposta non è affatto univoca.
Se una storia generale dei metodi glottodidattici nel “secolo ossessivo” della ri-cerca del metodo migliore (-) è stata scritta, corredata anche di un’analisi dei presupposti teorici per i metodi dell’insegnamento delle lingue moderne,
20 A. M. L (a cura di), La Querelle des Ancens e des Modernes XVIIe-XVIIIe, Gallimard, Paris, 2001.
21 G. M, op. cit., p. 80.22 A. G R, Manuale per l’insegnamento del latino nella scuola del 2000, Bo-
logna, Patron, 2002, p. 85, n. 47.23 G. K, 25 centuries of language teaching (500 BC – 1969), Rowley (Mass), Newbury,
19762.24 D. L-F, Techniques and principles in language teaching, Oxford, OUP, 20037;
J. R, T. R, Approaches and methods in Language Teaching, Cambridge, CUP, 20012; M. C. R, M. B, Metodi in classe per insegnare la lingua straniera. Teorie, Applicazioni e Materiali, Milano, Lend, 20072.
232 MARCO RICUCCI
il suo andamento ci può apparire come quello del “vento che sposta le dune di sabbia”.
Ma una svolta è costituita dallo spostarsi del dibattito metodologico, intor-no agli anni Settanta del XXo secolo, dall’insegnamento all’apprendimento, nella convinzione che, conoscendo in maniera più dettagliata i meccanismi con cui la mente umana apprende una L, sarebbe stato possibile migliorare, di conseguen-za, le strategie, le tecniche, l’approccio dell’insegnamento linguistico in vista di una maggiore efficacia. Nasceva così, dalla Linguistica Applicata, un campo di studi che ora viene chiamato Second Language Acquisition (d’ora in poi SLA).
La SLA è il campo di ricerca che focalizza il proprio oggetto di indagine sugli apprendenti e sull’apprendimento della L piuttosto che sugli insegnanti e sull’insegnamento, poiché è stato definito in maniera concisa: “the study of how learners create a new language system”. Cinque sono le aree centrali di indagine: la natura della L, la natura dello sviluppo dell’interlingua, i contributi della co-noscenza della L, l’ambiente linguistico e l’istruzione.
La SLA è un ambito di studi multidisciplinare, poiché attinge da una varietà di saperi come la linguistica, la psicologia, la didattica e la pedagogia, ma i ricer-catori di SLA sono spesso poco propensi ad applicare i risultati della loro ricerca direttamente alla didattica delle lingue riconoscendone il valore aggiunto per la formazione del docente .
Il docente di lingue classiche dovrebbe, dunque, abbeverarsi, per così dire, da questi studi, secondo un trend già esplicitato in contributi di area anglossasso-ne per migliorare la lettura e la comprensione dei testi della classicità.
25 A. D. M, “Changing winds and shiing sands”, MST English Quarterly, 21, 1972, 5.
26 A. P. R. H, A History of English Language Teaching, Oxford, OUP, 1984, p. 284.27 P. M. L, “Great Expectations: Second-Language Acquisition Research and
Classroom Teaching”, Applied Linguistics, 1985, 173-189.28 S. G, L. S, Second Language Acquisition: An Introductory Course, Hillsdale (NJ),
Routledge, 20083, p. 1.29 L. O, “Second language learning explained? SLA across nine contemporary theo-
ries”, in B. Van Patten and J. Williams Jessica (eds.), !eories in second language acquisition. An introduction, London, Routlege, 2007, pp. 225-226.
30 B. V, G. A. B, Key Terms in Second Language Acquisition, London, Con-tinuum, 2010, p. 7.
31 B. D. H, “Decoding or Sight-Reading? Problems with Understanding Latin”, Classical Outlook, 70, 1993, 126-130; W. S. H, “Teaching Latin Word Order for Reading Competence”, !e Classical Journal, 95, 1999, 173-180.; R. R. H, “Exercises for Developing Prediction Skills in Reading Latin Sentences”, Teaching Classical Languages, 2010, 1-30; D. D. M, D. P- R, “Reading proficiency in Latin through expectations and visualization”, Classical World, 98, 2004, 79-93; K. S. M, “Language Acquisition and Teaching Ancient Greek. Applying re-cent theories and technology”, in Gruber-Miller (ed.), When dead tongues speak. Teaching beginning Greek and Latin, Oxford, OUP, 2008, pp. 134-157; T. V H, “e Strategic Reading of Latin (and Greek) texts: A Research-based Approach”, in B. Lister (ed.), Meeting the Challenge. Interna-tional perspectives on the teaching of Latin, Cambridge, Cambridge University Publishing, 2008, pp. 54-70.
233OLTRE I CONFINI DI BABELE: RIFLESSIONI PER UNA DIDATTICA DELLA GRAMMATICA LATINA
&. Dai modelli grammaticali alla Second Language Acquisition (SLA)
Se il MIC può essere considerato una risposta ai mali che travagliano l’insegnamento delle lingue classiche a scuola contro l’ “ipertrofia grammaticale”, fra gli anni Settanta e Ottanta, nel dibattito sull’insegnamento delle lingue classi-che, in Italia, a seguito della diffusione e dello sviluppo dei risultati della ricer-ca della linguistica teorica e applicata, si rilevò che le critiche, per quanto varie, rivolte all’insegnamento delle lingue classiche nel corso dei secoli, avevano una caratteristica comune: contestavano il metodo senza mettere in discussione il mo-dello grammaticale ad esso sotteso; e ciò era la causa che aveva compromesso il successo delle proposte: “le riserve sollevate dal passato-remoto e meno-contro i metodi grammaticali impiegati nell’insegnamento delle lingue classiche, e alcu-ne conseguenti proposte di innovazione, non hanno sortito esiti positivi per una carenza di fondo, che oggi possiamo individuare nel mancato ricorso al metodo scientifico. Non si è pensato, cioè, che una critica ai procedimenti didattici con altri ritenuti più efficaci, avrebbe comportato, per riuscire produttiva, una verifica delle teorie linguistiche che soggiacevano ai metodi contestati”.
Mentre l’insegnamento delle lingue moderne si era rinnovato alla luce delle ultime acquisizioni della ricerca della linguistica, quella delle lingue classiche era rimasta ancorata alla grammatica nozionale e “tradizionale”, che risaliva alle teorie di Platone e Aristotele filtrate attraverso gli stoici, i grammatici di Pergamo, alessandrini, tardolatini, che riaffermarono il principio dell’esistenza di una stret-ta rispondenza fra le categorie grammaticali, le categorie logiche e le categorie dell’essere: la grammatica divenne così speculum della realtà, o grammatica spe-culativa.
La Grammaire générale et raisonnée di Antoine Arnauld (-) et Clau-de Lancelot (-), più conosciuta come Grammatica di Port-Royal, ha avuto amplissima influenza nell’Occidente. I due autori, docenti presso le Petites Eco-les de Port-Royal des Champs, redassero una serie di grammatiche (latina, greca, italiana, spagnola) che costituirono l’inizio di un rinnovato modo di insegnare le lingue straniere, basato sull’esposizione delle regole grammaticali e degli esempi nella lingua oggetto di studio.
L’opera di Arnauld et Lancelot proponeva una riflessione grammaticale che si inseriva in una corrente logica e filosofica (da cui la denominazione di “grammati-ca ragionata”) con il fine di superare lo studio di una lingua particolare, offrendo un insieme di principi comuni a tutte le lingue (donde “grammatica generale”), sebbene, in buona sostanza, sia stata la grammatica della lingua francese che cos-tituì l’essenza della loro riflessione.
32 F. W, op. cit., p. 62.33 G. P, Lingue classiche alla prova, Torino, 1981, p. 53.34 K. A, !e Western Classical Tradition in Linguistics, London, Equinox, 2007.35 R. S (a cura di), Grammatica e logica di Port-Royal, Roma, 1969.
234 MARCO RICUCCI
La Grammatica di Port-Royal è un caposaldo tra gli studi moderni della lin-guistica e ancora oggi è di grande interesse, in quanto è la rappresentazione di una visione della regola grammaticale in base alla quale gli usi linguistici si conforma-no al pensiero: la regola come prodotto di una regolarità della ragione.
Gli autori della Grammatica di Port-Royal non accettano l’idea che le parole possano in alcun modo agevolare il pensiero o la memoria, tesi centrale per esem-pio in Hobbes e nella linguistica del Rinascimento. La parola, invece, serve solo a comunicare, poiché è solo il risultato finale e il segno esterno del pensiero che esiste autonomamente prima della lingua.
La prima parte della Grammatica analizza e descrive i suoni, distinguendo sillabe, vocali e consonanti. La seconda parte della Grammatica classifica i tipi di parole in base al criterio tradizionale: nomi, pronomi, articoli, preposizioni, avverbi, verbi, participi, congiunzioni e interiezioni. Il testo della Grammati-ca analizza la morfologia dei nomi e i casi della declinazione, con una tesi per quei tempi originale: la declinazione nelle lingue antiche e l’articolo nelle lingue moderne hanno la stessa funzione, quella di esprimere i rapporti reciproci tra i nomi in una frase. L’ analogia funzionale tra declinazione dei casi e articolo è un esempio netto d’ identità logica profonda di grammatiche diverse che a prima vista sembrano incommensurabili: l’esempio, perciò, mostra anche che le lingue moderne sono “logiche” ed efficaci come quelle antiche, contrariamente a certe posizioni del tempo, in particolare di studiosi francesi.
Nella Grammatica di Port-Royal, grande importanza è data anche alla sin-tassi e alla costruzione della frase, che erano state fino ad allora marginali nelle grammatiche; la sintassi è anzi il vero e proprio elemento che differenzia le lin-gue in superficie: tutte le sintassi infatti sono di uguale valore poiché seguono una stessa sintassi logica profonda e generale. La scuola di Port-Royal fornisce un modello di analisi linguistica rigorosa e moderna per l’epoca () e, per la prima volta, inserì negli studi grammaticali la prospettiva diacronica che permise di spiegare le “eccezioni” alla regola.
Indubbiamente fu grazie alle ricerche dei grammatici di Port-Royal, che fu-rono poi riprese in seguito da Jean Jacques Rousseau, Ferdinand de Saussure e dai linguisti a noi contemporanei, se la linguistica ha assunto un ruolo essenziale nel campo delle scienze umane.
Dai primi anni del Novecento, de Saussere ebbe il merito di far cadere la presunta validità universalistica delle categorie grammaticali, secondo il mot-to: “la lingua è forma, non sostanza”. Da allora gli studi della linguistica si sono sviluppati e approfonditi nel corso del Novecento, tentando di trovare soluzio-ni e applicazioni didattiche per l’insegnamento della lingua: la “grammatica”, in una nuova prospettiva, può essere intesa come un meccanismo innato, che sta alla base delle capacità di intendere e produrre frasi ben formate di una lingua
36 J. R, B. E. R, General and rational grammar: the Port-Royale Grammar, Hague, Mouton, 1975.
235OLTRE I CONFINI DI BABELE: RIFLESSIONI PER UNA DIDATTICA DELLA GRAMMATICA LATINA
(Chomsky la chiama “competenza linguistica”); la “grammatica” può essere as-sunta come la descrizione ipotetica di questo meccanismo, effettuato sulla base del suo funzionamento, ossia sui comportamenti osservati: in questo senso si può parlare di grammatica come di “teoria” e, di conseguenza, di teorie grammaticali. L’ipotesi, o la teoria, è un modello della realtà indagata mediante l’osservazione, o l’osservabile: la “grammatica” quindi va intesa come il modello del meccanismo linguistico innato o della competenza linguistica. Perciò con l’espressione “mo-delli grammaticali” si intendono più teorie e dunque più grammatiche, che tenta-no di descrivere il meccanismo della capacità linguistica: non si tratta di modelli figurativi come le miniature o le carte topografiche, ma di “modelli formali”, ossia di rappresentazioni astratte o simboliche delle regole che governano il mecca-nismo linguistico, anche se non tutti i modelli sono dotati dello stesso grado di simbolizzazione o di formalizzazione.
Se la molteplicità dei modelli grammaticali elaborati dai linguisti nel corso del Novecento ha fornito la possibilità di applicazione didattica per l’insegnamento delle lingue moderne e classiche, e in special modo della lingua latina, tali mo-delli innovativi non hanno riscontrato, generalmente, un interesse da parte degli insegnanti di lingue classiche tanto che, “nonostante tentativi di applicare i nuovi modelli linguistici in campo glottodidattico (…) nessuno si è imposto in maniera definitiva prendendo il posto nell’insegnamento della grammatica tradizionale, e in particolar modo delle lingue classiche”, tranne il modello di modello Tesniè-re-Haap, cioè un modello grammaticale della verbodipendenza, applicato a un intero corso. L’ applicazione del modello strutturale teorizzato da Tesnère-Ha-pp nella pratica scolastica per lo studio della lingua latina è di tipo sintattico--funzionale e viene chiamato anche “grammatica della verbodipendenza”, poiché concentra la sua attenzione in modo sintattico-funzionale sul verbo, insistendo sia sul ruolo primario esercitato da quest’ultimo all’interno della frase sia sulla sostanziale “dipendenza” da esso degli altri elementi funzionali, distinti in “attan-
37 G. P, La s"da linguistica. Lingue classiche e modelli, Torino, Rosenberg ! Sellier, 1979, pp. 15-16.
38 P. G, Teorie grammaticali e implicazioni pedagogiche, Roma, Lombardo, 2000.39 A. G R, op. cit., p. 83.40 A. G R, op. cit., pp. 60-83.41 F. P (a cura di), La verbodipendenza per un insegnamento integrato della grammatica,
Bologna, IRRE Emilia Romagna, 2002.42 F. S, G. P, L. S, E. T, Fare latino, Torino, SEI, 1983.43 Cfr H. H, Grundfragen einer Dipendenz-Grammatik des Lateinischen, Göttingen, Van-
denhoeck ! Ruprecht, 1976; idem, “Möglichkeiten einer Dependenz-Grammatik des Lateinischen”, Gymnasium, 83, 1976, 35-58; idem, “Möglichkeiten und Grenzen bei der unterrichtlichen Anwen-dung einer Dependenz-Grammatik des Lateinischen”, Gymnasium, 8, 1977, 35-87; idem, “Syntaxe latine et théorie de la valence. Essai d’adaptation au latin des théories de Lucien Tesnière”, Les Études Classiques, 1977, 45, 337-366 (ristampa in Languages, 50, 1978, 51-70).
44 E. A F, “Progetto sequenziale per l’insegnamento della morfologia e della sintassi latina nel biennio secondo il modello Tesnière – Sabatini”, Au"dus, 5, 1988, 83-99; idem, “Il modello Tesnière – Sabatini e la sua applicazione al latino”, Atene e Roma, 31, 1997, 81-88.
236 MARCO RICUCCI
ti” (gli attori astratti che agiscono, in numero di tre: il soggetto, il complemento oggetto e d’agente) e “circostanti” (quelli che designano le accezioni di tempo, di modo, di luogo etc. molto più numerosi). Per sottolineare maggiormente il va-lore del verbo i funzionalisti assegnano ad esso il concetto di “valenza”, mutuato dalla chimica, per intendere la sua capacità di stringere altri elementi linguistici, i complementi vincolati, in grado di saturare a loro volta le valenze dei verbi, che saranno di volta in volta: a-valenti (impersonali), monovalenti (intransitivi), bi-valenti (transitivi), trivalenti (di-transitivi).Questo sistema sintattico-funzionale, che ha fatto pensare ad una piccola rappresentazione teatrale, per la sua sinteticità e schematicità viene indicato preferibilmente anche dai sostenitori del metodo breve come quello più rispondente ai requisiti di un modello “nuovo” e antitradi-zionalista di didattica applicata al latino.
Come è stato messo in rilievo, la proposta di insegnare latino secondo mo-delli teorici che descrivono la grammatica latina in maniera più rigorosa non è stata accolta dai docenti di lingue classiche, che preferiscono – a ragione o a torto – rimanere “fedeli” alla nozioni della grammatica tradizionale basata sostanzial-mente sulla grammatica di Port-Royale.
In questa fase, dove l’istruzione classica è in crisi, la proposta del metodo neocomparativo può essere un’efficace risposta, capace di suscitare curiosità e interesse da parte dei docenti di lingue classiche, qualora si comprendano ade-guatamente i presupposti teorico-concettuali in una visione più ampia sostenu-ta dai risultati della ricerca della SLA e della valorizzazione del perseguimento dell’educazione linguistica.
'. Il metodo neocomparativo per una glottodidattica del latino
'.#. Dalla prospettiva della SLA al modello della grammatica generativa
All’interno degli studi SLA più recenti, l’input è stato trattato in maniera diversa: se in molti di questi esso riveste ancora una funzione essenziale perché avvenga l’acquisizione, in altri, come nell’approccio della GU, ricopre un ruo-lo secondario, in quanto è un fattore che interagisce con una innata struttura. Il bambino che apprende una lingua costruisce una rappresentazione mentale della grammatica (competenza) sulla base delle evidenze che non devono essere ne-cessariamente presenti e visibili nell’input: l’acquisizione così è il risultato dell’in-
45 D. L-F, “State of the Art on Input in Second Language Acquisition”, in S. Gass, C. G. Madden (eds.), Input in Second Language Acquisition, Rowley, Newbury, 1985, pp. 433-444.
46 “Again, if one reviews major theories and research paradigms within SLA, we see input as a central construct. Even in instructed SLA, input is the primary data base on which learners build linguistic systems, hence the term input enhancement to describe current models of pedagogical intervention regarding formal features of language” (B. V, G. A. B, op. cit., p. 37).
237OLTRE I CONFINI DI BABELE: RIFLESSIONI PER UNA DIDATTICA DELLA GRAMMATICA LATINA
terazione dei dati dall’ambiente (input) e i meccanismi che fanno uso di questi principi interni.
Come scrive White: “Universal principles and language specific parameter settings must be triggered by input from the language being learned. In our exam-ples, learners acquiring an L with wh- movement will require input to motivate the +wh value of the parameter. However, once they have established that the L involves wh- movement, they will not require input to determine [constraints on that movement]; these come for free, so to speak”.
Nell’ampio settore degli studi della SLA, a partire dagli anni Sessanta, l’atten-zione ha cominciato ad essere focalizzata sul problema dell’apprendimento im-plicito e apprendimento esplicito delle lingue. In particolare, la ricerca nel campo della psicologia cognitiva ha cercato di individuare i diversi processi coinvolti nei due tipi di apprendimento, arrivando alla distinzione tra conoscenza dichiara-tiva e conoscenza procedurale. Si ipotizza che la conoscenza dichiarativa, o “knowledge about”, che consiste nella conoscenza esplicita delle regole grammati-cali, venga poi ‘proceduralizzata’, cioè diventi un metodo per eseguire un compito, ovvero “knowledge of how to”. In uno stadio successivo, la conoscenza procedu-rale è infine completamente automatizzata, cioè si usa la regola senza dover più pensare a essa, come ha messo in evidenza DeKeyser.
L’importanza della conoscenza esplicita ha assunto, dunque, un ruolo cen-trale anche all’interno della grammatica generativa, la quale si può presentare per sua natura come una teoria esplicita della conoscenza implicita che l’uomo ha del linguaggio.
In prospettiva generativa, l’abilità umana di acquisire una lingua nei primi anni di vita è spiegata con l’ipotesi dell’esistenza di una GU, innata nell’uomo, che
47 L. W, “Linguistic theory, universal grammar, and second language acquisition”, in B. Van Patten, J. Williams (eds.), !eories in second language acquisition, Mahwah (NJ), Erlbaum, p. 50.
48 J. R. A, !e architecture of cognition, Mahwah (NJ), Erlbaum, 1983; idem, Cogni-tive Psychology and its Implications, New York, Worth Publishers, 2009.
49 Scrive Ellis: “Implicit knowledge is tacit and intuitive whereas explicit knowledge is conscious. us, it is possible to talk about intuitive and conscious awareness of what is grammatical (…). For example, for past tense verbs, learners behave in accordance with a condition-action rule along the lines of ‘if the action to be referred to occurred in the past and is completed, then add -ed to the base form of a verb’. Explicit knowledge is comprised of facts about the L2. is is no different from encyclopedic knowledge of any other kind. I know, declaratively, that the Normans invaded England in 1066. Similarly, I know that verbs like ‘explain’ require an indirect object with ‘to’ and, further, that the indirect object usually follows the direct object. ese facts are only loosely con-nected; they do not constitute a ‘system’ in the same way that the implicit knowledge of proficient L2 users does. L2 learners’ procedural rules may or may not be target-like while their declarative rules are oen imprecise and inaccurate e condition-action rules that learners construct as part of their implicit knowledge may or may not conform to the native speaker rules” (R. E et alii, Implicit and Explicit Knowledge in Second Language Learning, Testing and Teaching, Wellington, Multilingual Matters, 2009, pp. 11-12).
50 R. K, “Implicit and explicit learning”, in C. Doughty, M. Long (eds.), Handbook of Second Language Acquisition, Oxford, OUP, 2003, pp. 313-348.
238 MARCO RICUCCI
permette di costruire rapidamente la grammatica specifica della lingua materna, fissando un certo numero di scelte tra i parametri che definiscono la variazione ammessa tra le lingue naturali. La grammatica generativa mira a investigare in termini formali i principi costanti e i parametri variabili della Grammatica Uni-versale. Gli studi della SLA basati sulla teoria generativa ipotizzano che le restri-zioni formali imposte dalla GU, operanti durante l’acquisizione della lingua ma-dre (=L), siano riattivate almeno in parte durante l’apprendimento di altre lingue seconde (=L), attraverso un confronto costante con la L.
A conferma di tale ipotesi, alcuni esperimenti di neurolinguistica hanno dimostrato che nel processo di apprendimento di una L sono attivate le stesse zone del cervello che normalmente vengono utilizzate per elaborare la L. Negli ultimi tempi si è assistito perciò ad una riscoperta del valore di una riflessione esplicita sul linguaggio, a discapito degli approcci che prevedevano l’eliminazione della grammatica e l’immersione nella lingua con poche istruzioni essenziali, i quali hanno dimostrato di non raggiungere i risultati sperati.
Partendo, infatti, dalla constatazione che i cosiddetti metodi “naturali” o “diretti” sviluppino abilità ricettive e produttive della lingua per una più efficace comunicazione, questi stessi non possono essere applicati alle lingue storicamen-te concluse come il latino e il greco antico di cui non esiste più nessun parlante latino. Se in alcuni corsi la grammatica latina è vista solo come un mezzo per la
51 L. W, Second language acquisition and Universal Grammar, Cambridge, CUP, 2003.52 A. M, I con"ni di Babele. Il cervello e il mistero delle lingue impossibili, Milano, Longa-
nesi, 2006.53 L’ anonimo reviewer del presente articolo ha posto una interessante questione circa al-
cune teorie delle scienze neurologiche in base alle quali l’apprendimento del latino non andrebbe collocato nella stessa zona cerebrale in cui si apprendono le lingue vive: alla luce di queste teorie, l’implicazione didattica sarebbe di mettere in discussione i metodi che applicano al latino i metodi dell’insegnamento della LS. Egli menziona infine alcuni casi occorsi in : persone colpite da ictus, do-centi universitari di lingue antiche, che non hanno perso la conoscenza dell’inglese e di altre lingue “vive” imparate, mentre hanno del tutto perso conoscenza, “dimenticato”, il latino. Naturalmente la questione è tanto complessa e interessante. Nella letteratura a me nota, non ho trovato alcun riferimento sostanziale a tale questione; Giuliana Gisuti e Renato Oniga, sostenitori del metodo comparativo, mettono in rilievo, sulla scorta degli studi di Andrea Moro, che, chi abbia studiato il latino con il MGT, in cui tale lingua è presentata quasi come una lingua “artificiale”, ha impiegato aree del proprio cervello che non sono quelle naturalmente deputate alla funzione del linguaggio. Di conseguenza non c’è affatto da stupirsi se il danneggiamento di queste aree ha colpito, per così dire, il latino ma non le lingue vive, e si potrebbe ipotizzare anche il contrario: qualcuno potrebbe essere colpito da afasia per le lingue parlate, conservando però la capacità di fare una versione di latino, come se fosse un problema di enigmistica (G. G, R. O, “Introduction: Why formal Linguistics for the teaching of Latin?”, in R. Oniga, R. Iovino, G. Giusti (eds.), Formal Linguistics and the Teaching of Latin. !eoretical and Applied Perspectives in Comparative Grammar, New Castle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2011, p. 3). Mi riservo di poter approfondire questa interessante e specifica questione in altra occasione, dopo adeguata preparazione e studio. Ringrazio l’anonimo reviewer per lo stimolante spunto.
54 P. B, R. P C, “Didattica delle lingue classiche e linguistica teorica”, Università e Scuola, 8, 2003, 38-53.
239OLTRE I CONFINI DI BABELE: RIFLESSIONI PER UNA DIDATTICA DELLA GRAMMATICA LATINA
comprensione globale del testo e pertanto non viene approfondita adeguatamen-te, essa, alla luce della ricerca più avanzata della linguistica, può essere considerata una vera e propria scienza, capace non solo di descrivere il come, ma anche di trovare in modo sempre più rigoroso il perché dei fenomeni grammaticali.
'.$. L’insegnamento della grammatica latina con il metodo neocomparativo
Per secoli la grammatica universalistica e razionale di Port Royal è stato il modello della grammatica delle lingue classiche, e in particolare del latino.
Nella scuola italiana si mantiene operativo una tradizione della didattica ba-sata su uno studio della grammatica analitica e su manuali basati sul MGT in cui la presentazione delle regola, con scopo applicativo, precede l’incontro con il testo in lingua: l’apprendimento della regola viene poi sperimentata su frasi singole a volte costruite ad hoc per gli assoluti principianti, poi si passi di autore, deconte-stualizzati.
La grammatica “tradizionale” non è, dunque, un modello teorico globale e coerente di descrizione linguistica rispetto a modelli elaborati dalla linguistica del Novecento: da una parte, essa presenta la descrizione sintattica inferiore (sintassi della frase) impostata sulla descrizione della frase come sequenze di parole, che non hanno un ordine gerarchico, mentre nella descrizione del sistema sintattico superiore (analisi del periodo), essa “mescola” la terminologica funzionalistica delle denominazione delle subordinate (oggettive, soggettive, attributive) con ter-minologia nozionistica (sostantiva, aggettiva).
Il saggio Syntatic structures che Noam Chomsky pubblicò nel rivoluzio-nò la concezione della grammatica tradizionale: nasceva la grammatica generati-vo-trasformazionale.
“Si chiama generativa la grammatica che si propone di spiegare come ven-gono generati gli enunciati della lingua; essa non esamina quindi gli enunciati
55 La linguistica ha spiegato che la struttura della frase è una gerarchia delle sue connessioni dove “categorie quali i complementi di specificazione, di argomento, di materia, di peso e affini non danno alcuna informazione sulla struttura della frasi” (M. B, Linguistica ed educazione linguistica, PBE, 1978, p.13). Un esempio può chiarire tale affermazione nel confronto tra due frasi latine: 1) Carinae ac prima statumina ex levi materia "ebant (Cesare); 2) Verres crateras ex aere abstulit e templo (Cicerone). “L’ analisi logica definisce complementi di materia entrambi i sintagmi sottolineati, senza cogliere le grandi differenze strutturale: 1) in ex levi materia fa parte del ‘gruppo del predicato’ o ‘sintagma verbale’ (‘la carena e l’ossatura della nave erano fatte di materia leggero’) ed è un argomento richiesto dal significato del predicato (come tale non può essere eliminato, pena il cambiamento del significato del predicato o l’agrammaticalità della frase); in 2) ex aere equivale ad un attributo di crateras e con esso costituisce il gruppo (o sintagma) nominale oggetto (‘Verre portò via dal tempio dei crateri di bronzo’), può essere sostituito da un aggettivo (crateras aeneos) ed esse-re eliminato con impoverimento d’informazioni, ma senz’alcuna conseguenza sulla grammaticalità della frase” (C. M, “Sperimentazione e tradizione: metodi e modelli in grammatiche scolastiche di latino”, Au"dus, 34, 199, p. 57).
240 MARCO RICUCCI
come un “ergon” fisso e finito, ma come emanazione di un principio agente, di una ‘energheia’; e perciò conclude che l’ ‘ergon’ finito (cioè l’unico aspetto della cosa, con cui si abbia un approccio immediato) può essere spiegato solo dedu-cendolo da un principio e seguendo il processo della sua generazione”; “nella nostra osservazione abbiamo più volte avuto bisogno di spostare lo sguardo dall’e-spressione concreta a ‘piani più alti di astrazione’. Invece di piani alti si potrebbe parlare di ‘sottosuoli’ giacenti al di sotto dell’ espressione di superficie, o di livelli più profondi rispetto a quello superficiale. Quest’ultima metafora è dominante nella grammatica generativa: si parla di strutture profonde in contrapposizione alle strutture superficiali dell’espressione (…). Il concetto di trasformazione si ma-nifesta o quando più strutture profonde corrispondono a una struttura superficia-le, o viceversa quando più strutture superficiali corrispondono ad una struttura più profonda”.
Recentemente, il tentativo di applicare in chiave didattica lo studio della grammatica latina in prospettiva generativo-trasformazionale si è concretizzato in un corso di latino pensato per studenti universitari e nell’elaborazione di una nuova descrizione grammaticale del latino secondo il metodo “comparativo” fra lo studio grammaticale delle lingue classiche e delle lingue moderne, nella con-vinzione che “se si svuota lo studio della grammatica del suo interesse scientifico, non si potrà poi difenderne il valore scientifico. La grammatica è per sua natura una teoria: la negazione dell’interesse teorico finisce inevitabilmente per condurre all’abbandono della grammatica stessa, intesa come riflessione critica e creativa, in favore dello sviluppo di automatismi da memorizzare supinamente”.
Adottando una metodologia comparativa all’insegnamento della grammati-ca, oltre a quella pratica di impararla per leggere i testi letterari, essa può contri-buire a migliorare una conoscenza consapevole della lingua madre e delle lingue straniere da parte degli studenti, all’interno di una riflessione linguistica più am-pia, e a produrre risultati positivi anche sulla loro comprensione e produzione.
56 H. S, “Sull’uso di una grammatica generativo-trasformazionale nell’insegnamen-to del latino” in G. Proverbio (a cura di), La s"da linguistica. Lingue classiche e modelli grammaticali, Torino, Rosengberg ! Sellier, p. 217.
57 H. S, op. cit., pp. 230 ss.58 M.T. C, Corso di latino, Roma, Kappa, 1993.59 R. O, “Grammatica latina e linguistica contemporanea”, Quaderni patavini di Lingui-
stica, 23, 2007, 67-83; idem, “La manualistica universitaria sulla lingua latina tra ricerca e didattica”, in S. Rocca (a cura di), Latina Didaxis, XXVIII, Genova, Compagnia dei Librai, 2008, 119-150; idem, “Insegnare il latino con il metodo comparativo”, in R. Oniga, R. Oniga (a cura di), Lingue antiche e moderne dai licei all’università, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 101-121.
60 Idem, Il latino. Breve introduzione linguistica, Milano, 20072, p. 19.61 Come scrive Odlin: “Work in generative linguistics has thus greatly renewed interest in
the relation between mind and language and in old philosophical questions such as the problem of innate ideas. Not all generative work, however, concurs with the philosophical agenda of Chomsky and others, nor does all of it concur with Chomskyan formulations of generative systems (…) Yet along with controversies concerning the best formulation of a generative grammar, a crucial ques-
241OLTRE I CONFINI DI BABELE: RIFLESSIONI PER UNA DIDATTICA DELLA GRAMMATICA LATINA
“L’ approccio comparativo si basa su alcuni presupposti fondamentali: in pri-mo luogo, compara le lingue per arrivare ad individuare le proprietà comuni a tutte (principi) e le aree di differenziazione (parametri). In questo modo è possi-bile raggiungere due obiettivi immediati: da un lato quello di descrivere in modo formale il maggior numero di fenomeni con il minor numero di regole e premesse teoriche e, dall’altro, quello di sviluppare la consapevolezza interlinguistica, aven-do una riflessione esplicita sulla grammatica e favorendo l’attivazione di processi mentali paralleli a quelli coinvolti nella competenza nativa di una lingua”.
'.%. Il metodo neocomparativo nella “s!da linguistica”
Sono stati svolti brevi percorsi mirati a saggiare l’applicabilità didattica di al-cune lezioni basate sulla presentazione della grammatica latina in chiave neocom-parativa, soprattutto tra italiano e latino, in vista consolidamento della riflessione metalinguistica più rigorosa per migliorare le competenze traduttive, di cui sono state resi noti i risultati mediante pubblicazioni.
Occorre, infine, segnalare un’interessante iniziativa in atto presso il Liceo Linguistico statale “Ludovico Ariosto” di Ferrara (Italia) perché si vede in hare-na la “sfida linguistica”, secondo l’espressione di Germano Proverbio, tra ricerca accademica e didattica date le premesse e le istanze del metodo neocomparati-vo: il Consiglio di Classe ha avviato, in via sperimentale e a partire dall’a.s. - e per il successivo, un interessante percorso di educazione linguistica basato sull’insegnamento dell’italiano, del latino, dell’inglese, del francese e del tedesco
tion for work in second language acquisition is the psychological reality of generative grammar” (T. O (ed.), Perspective on Pedagogical Grammar, Cambridge, CUP, 1993, p. 10).
62 R. I, A, C, G. G, “I vantaggi dell’approccio comparativo all’insegna-mento delle lingue”, in L. Canfora, U. Cardinale, (a cura di), Disegnare il futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 444-445.
63 N. P, “Applicazioni di elementi di linguistica formale alla didattica del latino”, in R. Oniga, L. Zennaro (a cura di), Atti della Giornata di Linguistica Latina,, Venezia, Cafoscarina, 2006, pp. 159-178; P. D T, “Working materials for the teaching of Latin in the perspective of contempo-rary linguistics”, in R. Oniga, Iovino, Giusti (eds.), Formal linguistics and the teaching of Latin: theoreti-cal and applied perspective in comparative grammar, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2011.
64 Secondo l’ordinamento nuovo della cosiddetta “Riforma Gelmini” (dal nome del Ministro 2008-2011), il liceo linguistico prevede al biennio, alla settimana, lo studio della lingua e letteratura italiana per 4 ore, di lingua latina per due ore, di tre lingue e culture straniere (prima lingua: 4 ore; seconda lingua: tre ore; terza lingua: tre ore). Nel successivo biennio, il latino non viene più studiato. Fino al 2010, il liceo linguistico prevedeva lo studio del latino per dure ore sia al biennio primo che secondo. (Cfr. A. B, “Latino perdente? Le opzioni offerte alla didattica del latino nel Liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane”, in R. Oniga, U. Cardinale (a cura di), Lingue antiche e moderne dai licei all’Università, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 175-195).
65 Stupazzini rileva che il valore educativo della riflessione metalinguistica tradizionalmente affidato all’insegnamento della lingua latina potrebbe, in realtà, “essere raggiunto egualmente bene con una riflessione sulla lingua materna o su qualsiasi lingua straniera” (L. S, “I ‘nuclei fondanti’ dell’insegnamento di latino”, Au"dus, 35, 1998, 60-61).
242 MARCO RICUCCI
alla luce dell’approccio comparativo, partendo dalla lettura attenta delle disposi-zioni ministeriali.
L’iniziativa, portata avanti dalle sinergie dei docenti dei Dipartimenti di Lin-gue moderne e Materie Letterarie, prevede anche la produzione di appositi mate-riali didattici, nell’idea centrale che “la comparazione non si rivolge solo al lessico (operazione peraltro non nuova), ma entra in modo fortemente operativo nelle ‘grammatiche’ e nelle strutture linguistiche, collocando il proprio punto di par-tenza non nei fenomeni grammaticali delle varie lingue, comprese quelle classiche (questo sarà il punto di arrivo), ma nell’aspetto cognitivo della mente umana, cioè nei principi universali e invarianti”.
Concretamente, oltre alla produzione di materiale didattico per uso inter-no alla classe, è previsto un momento iniziale, dove si evidenziano, nell’ottica di “grammatica e grammatiche”, alcuni principi universali comuni alle lingue moder-ne studiate, le lingue antiche (latino) e la madrelingua (italiano), con la seguente adozione di una terminologia metalinguistica il più possibile omogenea a tutte le lingue, al fine di creare una “grammatica mentale” dei principi più importanti nel campo della fonetica-fonologia, della morfo-sintassi e del lessico; inoltre, nel regolare svolgimento del programma di ciascuna lingua, sono contemplati mo-menti di confronto su alcuni contenuti linguistici, da realizzarsi mediante prove di verifica comuni alle varie discipline linguistiche; oltre al lavoro sull’educazione linguistica che include latino e lingue moderne, viene posta enfasi anche su aspetti di civiltà e storia in chiave neocomparativa.
66 “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali, guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre all’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6, DPR 89/2010); e gli studenti, alla fine del percorso quinquennale del liceo, dovranno “riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro” (All. A, DPR 89/2010).
67 C. B, “Il linguistico del l’Ariosto”, Abitare l’autonomia, 5, 2011/2012, 28, Url: http://www.liceoariosto.it/index.php?option=com_docman! task=doc_download! gid=113! Itemid=40.
68 R. W, “Il latino: da madrelingua nativa a lingua straniera”, in J. Herman (ed.), La transizione dal latino alle lingue romanze. Atti della Tavola Rotonda di Linguistica Storica. Università Ca’ Foscari di Venezia 14-15 giugno 1996, Tübingen, Niemeyer, 1998, pp. 77-85.
69 Flocchini ha molto insistito nel corso degli ultimi anni sul valore dell’insegnamento del latino per l’educazione linguistica (cfr. N. F, “Le valenze formative del latino”, Linea del tempo, 5, 2001, 9-20). Un altro importante contributo è il volume di G. G, Latino ed edu-cazione linguistica, Padova 1993 (Dipartimento di linguistica dell’Università di Padova. Quaderni Patavini di Linguistica. Monogra"e, 11).
70 P. B, “Apprendere il latino, apprendere l’inglese”, in Il latino e l’inglese: una storia di lunga durata, Atti del Convegno di Treviso, 25 novembre 2005, Parigi, Unione Latina, 2006, pp. 81-92; M. B, “Lingua franca oggi: l’inglese sulle orme del latino?”, in R. Oniga, U. Cardinale, Lingue antiche e moderne dai licei all’università, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 47-82.
71 Allo stato attuale della redazione di questo contributo, i materiali didattici, per quanto di notevole interesse, sono stati prodotti in autonomia (e senza la supervisione dello scrivente di cui è venuto a conoscenza in itinere) dai docenti, che hanno lavorato più su dati empirici che teorici. Dato
243OLTRE I CONFINI DI BABELE: RIFLESSIONI PER UNA DIDATTICA DELLA GRAMMATICA LATINA
Se occorre approfondire ancora le evidenze di questo progetto didattico con uno studio longitudinale di almeno due anni ovvero della durata del primo bien-nio del liceo liceo linguistico (il latino non viene più insegnato a partire dal terzo anno), è possibile almeno formulare la seguente riflessione.
Il processo del primo anno è stato documentato mediante la compilazione di “quaderno delle lingue” da parte di ogni alunno, che hanno apprezzato questa iniziativa per le seguenti ragioni.
a) utilità per la presa di consapevolezza della trasversalità delle lingue e cosa le lingue europee per ciò che hanno in comune;
b) la “facilitazione” dell’interiorizzazione di strutture grammaticali e di les-sico grazie alla memorizzazione di analogie e differenze;
c) la possibilità di assimilare un concetto o una struttura in una lingua che non erano stati assimilati adeguatamente in un’altra;
d) il ripasso prima delle verifiche comuni hanno consentito di “ragionare” sugli stessi argomenti studiati nelle diverse lingue.
Un esempio di riflessione comune, presente sul quaderno, può essere costi-tuito dalla posizione dell’aggettivo qualificativo all’interno della frase. In italiano l’aggettivo qualificativo gode di una certa “libertà di manovra” poiché il parlante ne regola la posizione a seconda del significato che vuole attribuire al suo mes-saggio. Non sarà quindi la stessa cosa dire gli inverni nevosi (valore distintivo o modificante) e i nevosi inverni (valore descrittivo o determinante) oppure una curiosa bambina o una bambina curiosa (dove cambia addirittura il significato).
il carattere sperimentale del progetto condotto in ambito scolastico, non è ancora possibile trarre conclusioni tali da essere presentate e discusse in modo appropriato in sede scientifica. Mi riservo dunque di darne conto più ampiamente in un momento successivo. Lo scrivente ringrazia la prof.ssa Cinzia Brancaleoni per avermi permesso di visionare i materiali didattici fin qui prodotti.
72 Negli studi della SLA sull’apprendimento di una L2 esistono due tipi di studi: longitu dinali (in inglese, longitudinal), in cui i medesimi apprendenti sono oggetto di indagine per un certo perio-do di tempo prolungato, e traversali (in inglese, cross-sectional), in cui i partecipanti di età o livello differente sono monitorati, con la possibilità di trarre inferenze sulle sequenze che si applichereb-bero allo sviluppo di singoli apprendenti. Cfr. P. M. L, N. S, How language are learned, Oxford, Oxford University Press, p. 198 e p. 202, Glossary, sub voce “cross-sectional studies” e “longitudinal studies”.
73 Traggo l’esempio di questo lavoro riportando in maniera letterale, previa autorizzazione delle prof.sse Cinzia Brancaleoni e Marina Gallerani, il contenuto di quanto scrittomi, su mia richie-sta di poter aver un riscontro tempestivo per codesto articolo sull’esito complessivo del primo anno di sperimentazione didattica, in una comunicazione personale. La citazione che parte da un esempio e arriva fino a ferien garantisce una testimonianza qualificata di chi ha affrontato il lavoro a contat-to con i ragazzi; ribadisco la necessità di ulteriori approfondimenti teorico-pedagogici. Ringrazio molto le docenti per la loro preziosa collaborazione e menziono tutti i colleghi e colleghe che hanno preso parte al progetto del liceo statale “Ludovico Ariosto” di Ferarra: Cinzia Brancaleoni (Lingua e cultura italiana e latina); Marina Gallerani (Lingua e cultura inglese); Alda Lucci (Lingua e cultura tedesca); Riccardo Nagliati (Lingua e cultura francese).
244 MARCO RICUCCI
In latino il problema della posizione dell’aggettivo qualificativo sembra an-cora non risolto e varie sono le scuole di pensiero: a) precede il nome se esprime una qualità da un punto di vista
soggettivo("rma amicitia); se è oggettivo lo segue (ripa dextra); b) gli aggettivi possono essere determinanti o modificanti a seconda dell’in-
tenzione del parlante (praetor urbanus = pretore urbano, della città / ur-banus vir = uomo elegante);
c) gli aggettivi possono variare la loro posizione a seconda della loro catego-ria (materia, età, misura ecc.)
Il problema comunque va ridotto, come in italiano, a fattori pragmatici, cioè tutto si concentra sull’intenzione del parlante, vale a dire dove egli vuole porre il focus della frase.
Osservando questi dati e confrontandoli con: a) la lingua inglese in cui gli aggettivi hanno una posizione precisa nella
frase ed anche un ordine predefinito tra di loro; b) la lingua francese in cui gli aggettivi sono posti generalmente dopo il
nome, tranne alcuni che si posizionano dopo e altri che cambiano signi-ficato a seconda della posizione;
c) la lingua tedesca in cui gli aggettivi attributivi si trovano sempre prima del nome.
Si è arrivati alla conclusione che esistono sostanzialmente due “blocchi” lin-guistici: lingue con posizionamento per lo più libero o meglio affidato alle inten-zioni del parlante (latino e italiano) e lingue con posizionamento fisso (inglese e tedesco); in una posizione intermedia la lingua francese che mostra alcune carat-teristiche del primo “blocco” e alcune del secondo.
Un altro spunto di riflessione è stato fornito dalla formazione del plurale. I principali meccanismi per formare il plurale sono tre:
. modifica del morfema grammaticale (desinenza) tipico del latino e dell’i-taliano (es. nauta – nautae; casa – case);
. aggiunta di un morfema alla fine della parola tipico di molte lingue come l’inglese, francese e tedesco: s – en – er;
. modifica del morfema lessicale (es. ingl. goose – geese).
In alcune lingue talvolta non c’è differenza tra singolare e plurale (es. ted. Fräulein).
Come in Latino, in tutte le altre lingue presenti nel curricolo (italiano, ingle-se, francese, tedesco) esistono i pluralia tantum cioè parole il cui significato fa rife-rimento all’insieme di due o più elementi: divitiae, forbici, trousers, lunettes, ferien.
245OLTRE I CONFINI DI BABELE: RIFLESSIONI PER UNA DIDATTICA DELLA GRAMMATICA LATINA
(. Conclusioni: un nuovo inizio?
Lunga, dunque, rimane la via da percorrere per poter conoscere in maniera più approfondita i meccanismi del linguaggio umano, ambito di ricerca di glot-tologi, linguistici sia teorici sia applicati, neuroscienziati, psicolinguisti… ciò che rimane a noi classicisti (perché tali siamo e dobbiamo rimanere) – studiosi e do-centi – è la consapevolezza di ciò che affermava Lucrezio: Dumtaxat rerum ma-gnarum parva potest res/Exemplare dare et vestigia notitiai (peraltro citato in eser-go nel saggio di Moro); e la speranza che anche questa convergenza – pur in uno spiraglio – di scienze antiche e moderne, ricerca accademica e pratica didattica nelle scuole sia un dialogo sempre più ricco e fecondo per stimolare i giovani alla libera curiositas di memoria agostiniana e – perché no? – all’amore delle lingue antiche in un mondo sempre più digitalizzato e on line.
A)*+,-.+: Classics instruction is facing an ever-increasingly widespread crisis and Latin and Ancient Greek have been redundant or even dismissed in secondary school all over Europe. Finding innovative approach for teaching classical languages can be an actual answer to the crisis. Port-Royal-based grammar which is traditionally dominant in schools instruction has been put into controversy by linguistics research: Chomsky’s standpoint on Universal Grammar, whose com-putational mechanisms rule all human languages acquisition, has shed regenerating light on pers-pective of implicit and explicit metalinguistic knowledge. If Latin can be scientifically described as a linguistic system at the light of generative grammar, we can follow a new path for teaching Latin to students: the neo-comparative approach, being able of showing those underlining principles and parameters common of (romance) modern languages (mother-tongue included). is contribution will aim at providing teachers who are anchored to Altertumswissencha% with essentials of the his-toriographical and conceptual background of this debate and at raising consciousness of this new approach.
K/0 12,3*: Classical; Languages; Pedagogy.
ICOMMENTATIONES
Un souvenir d’Antiphon dans la peinture de la Démocratie au livre VIII de la République de Platon (a – a)? – M M ................................
Etiology in Parthenius of Nicaea – M V .........................................
La φιλοστοργία negli animali: l’exemplum plutarcheo dell’ἄρκτος – G G ....................................................................................................................
Historia y ficción poética en la deductio moderna: el largo viaje de la novia en tres epitalamios latinos del siglo XV en honor de la Casa de Aragón – A S C .......................................................................................................
Dall’autopsia del codice Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, H , sondaggi sulla triade bizantina di Eschilo (Prometheus-Septem-Persae) – I P ....
En los márgenes de un tópico poético: El passerulus alicaído de Filippo Buonaccorsi (Callimachus Experiens) – M A. D! G ............................................
Una aproximación a los studia epigraphica de Conrad Peutinger: el testimonio de las inscripciones hispanas – G G G ..............................
Emblemas-florilegios sobre la amistad en el Emblematum Liber () de Jean Jacques Boissard – B A ......................................................................
Unamuno, La Es"nge y el Mito de Edipo – C M! V ..........
IISTVDIA BREVIORA
A propósito de φύσις y τέχνα en la cuarta oda ístmica de Píndaro – A M! B ...................................................................................................................
e hellebore in Persius’ Satires – S T ...........................................
Traducciones ibéricas de la obra retórica de Apuleyo – J M ......................
En torno a las composiciones litúrgicas latinas de la Hispania medieval en honor de Leandro de Sevilla († ) – J C M!-I ......................
326 RERVM INDEX
EVPHROSYNE, 42, 2014
O professor de Grego Mário de Carvalho, Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto – M F S............................................................
IIIVARIA NOSCENDA
Oltre i confini di Babele: riflessioni per una didattica della grammatica latina con il metodo neocomparativo – M R ........................................................
IVRES COMMEMORANDAE
In memoriam: Maria de Lourdes Flor de Oliveira, com afecto e saudade – M V " A A. N ............................................................................
José Guillermo Montes Cala. In memoriam – R J. G C#, M S O L " T S S ...............................
VDISPUTATIONES
Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia. Edizione critica a cura di Julia Becker – M M .......................................................
Elisabetta Patrizi, «Del congiungere le gemme de’ gentili con la sapientia de’ christiani», La biblioteca del card. Silvio Antoniano tra studia humanitatis e cultura ecclesiastica – M M ......................................................................
VILIBRI RECENSITI
a) Edições de texto. Comentários. Traduções. Estudos Linguísticos
A C, La Cité Parodique. Études sur les Acharnenses d’Aristophane – R C F ...........................................................................................
F$ R et J S, Stace. Achilléide – A L ..........................
D F!, La storia della distruzione di Troia. Introduzione, testo, traduzione e note a cura di Giovanni Garbugino – M J S B ....
A B, Obra poética. I – Epigramas; II – Antimória [-]. Fixação do texto latino, introdução, tradução, notas e comentários por Sebastião Tavares de Pinho e Walter de Medeiros – M J S B...............
327RERVM INDEX
EVPHROSYNE, 42, 2014
G B, Poetic Paraphrase of the Psalms of David (Psalmorum Dauidis paraphrasis poetica), edited, translated, and provided with introduction and commentary by Roger P. H. Green – M J S B ........
C M (dir.), Espace et temps en latin – M J S B ....................................................................................................................
b) Literatura. Cultura. História
B# A-H, Arion’s Lyre. Archaic Lyric into Hellenistic Poetry – R C F ..........................................................................................
E R (ed.), ‘Vox poetae’: manifestations auctoriales dans l’épopée gréco-latine. Actes du colloque organisé les et novembre par l’Université Lyon – M J% T R ..............................................
C C, Mythe et Histoire dans l’Antiquité Grecque. La création symbolique d’une colonie – N S& R ............................................................
L C, P G-J, F K-C (dir.), Hérodote et l’Égypte: Regards Croisés sur le Livre II de l’Enquête d’Hérodote. Actes de la Journée d’Étude Organisée à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée – N! C S .................................................
C S, M C F, M! C Á M, R M! I M (coord.), Norma ! Transgressão II – J C A#........................................................................................................
M B C (ed.), Paradossi e disarmonie nelle scienze e nelle arti – G C ........................................................................................
M S (ed.), Identités romaines. Conscience de soi et représentations de l’autre dans la Rome antique (IVe siècle av. J.-C. – VIIIe siècle apr. J.-C.) – N S& R ...................................................................................
E S T, A P J (coords.), Mito y Magia en Grecia y Roma – G S ........................................................................
H V, La métamorphose dans les Métamorphoses d’Ovide. Étude sur l’art de la variation – N S& R ..............................................................
S I " B D (eds.), B. B (colab.), Philon d’Alexandrie – Un Penseur à l’Intersection des Cultures Gréco-Romaine, Orientale, Juive et Chrétienne – N S& R ................................
O. D " G. F L (eds.), Poésie augustéenne et mémoires du passé de Rome. En hommage au Professeur Lucienne Deschamps – A L .....
328 RERVM INDEX
EVPHROSYNE, 42, 2014
J L! L B%, Máscaras dos Césares: Teatro e Moralidade nas Vidas Suetonianas – R N ..............................................................................
M P, S P (eds.), !e Construction of the Real and the Ideal in the Ancient Novel – F H# ....................................
M! F P, J P, R P (eds.), !e Ancient Novel and Early Christian and Jewish Narrative: Fictional Intersections – F H# ...............................................................................................
M! P. F P, S J. H (eds.), Fictional Traces. Receptions of the Ancient Novel – vol. & – J C A# ....................................
S R, Polémiques entre païens et chrétiens – I F .................
E V P H R O S Y N EREVISTA DE FILOLO GIA CL ÁSSICACentro de Estudos Clássicos – Faculdade de Letras
PT – 1600-214 [email protected]
ARTICLE SUBMISSION GUIDELINES
1. Euphrosyne — Revista de Filologia Clássica, the peer journal of the Centre for Classical Studies, pub-lishes papers on classical philology and its disciplines (including classical reception and tradition).
2. Papers can be sent to [email protected] or to the Centre for Classical Studies’ post mail.
3. Papers submitted: must be original; cannot be yield to other entity; must be sent in their definite version; have to be presented according to these guidelines; will not be returned to the author. Papers will be submitted to peer reviews.
4. Papers will be accepted until 31st of December in the year previous to publication; an acceptance notification will be sent to the author until 30th of April in the year of publication.
5. Originals must always be submitted in double electronic format (Word/.doc(x) and PDF). 6. Papers must have: a) title (short and clear); b) author’s name and surname; c) author’s academic
or scientific insti-tution; d) author’s email; e) abstract (10 lines) in English; f) three key-words in English.
7. Recommended size is 10 pages and never more than 20 A4 pages (font size 12, double spaced). 8. Notes: endnotes, with sequential numeration. When published, these will be converted to foot-
notes. 9. References: a) Remissions to pages within the paper are not allowed. b) Note references: Books: J. R, La crainte et l’angoisse dans le theatre d’Eschyle, Paris, Les Belles Letres,
1959, pp. 120-130; 2nd reference: J. R, op. cit., p. 78. Journals: R. S. C, “e Misogyny of Eteocles”, Arethusa, 6, 1973, 193-231 (vol., year,
pp.). 2nd reference: R. S. C, loc. cit. Multi-author volumes: G. C, “La circolazione dei testi greci nell’Europa dell’Alto Me-
dioevo” in J. Hamesse (ed.), Rencontres de cultures dans la Philosophie Medievale — Traduc-tions et traducteurs de l’Antiquite tardive au XIVe siecle, Paris, Les Belles Letres, 1971, pp. 47-64.
c) Abbreviations: to Latin authors will be followed !LL conventions; Liddel-Scott-Jones will be used to Greek authors; Année Philologique to abbreviate journal tides; common abbreviations: p. /pp.; ed. /edd.; cf.; s.u.; supra; op. cit.; loc. cit.; uid.; a.C. / d.C. (roman).
d) Quotations: Must be marked by quotes “...” (but not in Greek); italic is used to highlight words or short sentences; quotations in Latin or Greek must be brief.
10. Images must have quality (preferably in TIF format, minimum resolution 200 p.p.), provided in electronic format, with the precise indication of where they must be placed in the text, and who is their author. e author is responsible for obtaining any copyrights needed.
11. e author will not be provided with more than one set for review, which has to be returned within a week period. Originals cannot be modified.
12. Authors will receive a physical copy of the volume and the electronic version of their paper.