Ben oltre la diplomazia: L’accordo di emigrazione italo-tedesca del 1955
Transcript of Ben oltre la diplomazia: L’accordo di emigrazione italo-tedesca del 1955
t
BEN OI-TRE LA DIPLOMAZIA.L'ACCORDO DI EMIGRAZIONE
ITALO-TEDESCO DEL 1955
L'accordo di emigrazione, stipulato cinquant'anni fa tra l'Italia e laGermania', apre molte finestre sulla storia dei due Paesi e dei loro com-plessi rapporti lungo tutto il )O( secolo. L'accordo s'inserisce, prima ditutto, nella lunga storia delle migrazioni avvenute tra i due Paesi .ltizia-te giä nel medioevo (1), esse sono diventate un vero fenomeno di mas-sa soltanto nel )O( secolo (2). La migrazione italiana si Ö sviluppata intre grandi ondate: una prima che raggiunse la Germania a cavallo traOtto e Novecento, una seconda durante il fascismo elaterza dopo 111955,I'anno dell'accordo (3). I circa 150.000 italiani, soprattutto settentriona-li, che all'inizio del secolo entravano in Germania ogni anno, prestaro-no la loro opera soprattutto come stagionali nell'edilizia, nell'agricoltu-ra e nelle fornaci, guadagnandosi ben presto lafama di lavorare sodo (4).Dopo il 1890 la Germania guglielmina, forte di un costante e notevoleboom economico , avevabisogno di un sempre crescente numero di ma-nodopera (5).
Esisteva perö anche un altro tipo di migtazione, quella dei lavora-tori autonomi che operavano nel commercio o nelteruiario (6). Giä in-torno all'inizio del )O( secolo, ad esempio, si stabilirono in Germania iprimi gelataidel Veneto, che ben presto ebbero alle loro dipendenze pu-re dei tedeschi, tra cui il giovane studente Erich Maria Remarque (7). Chegli italiani siano sempre stati anche degli imprenditori, i quali cfeavanoaddirittura posti di lavoro, ö un fenomeno sottovalutato ancora oggi inGermania (8).
La classe politica italiar:a guardava con favore all'emigtazione, per-ch€ essa attefluava almeno in pafte un problema fondamentale dell'Ita-
(*) Intervento in occasione della presentazione del numero speciale del .Veltro, su .Le
relazioni tra |'rtalia e la Germania; (xllx lzoo5it, 4-6), tenutasi a Roma il 28 matzo 2006all'Istituto Italiano di Studi Germanici - Villa Sciarra-Wurts sul Gianicolo.
483
lia, cioö la disoccupazione strutturale. T:uttavia, soltanto durante il fasci-smo la migrazione cominciö ad essere organizzata e ptogrammata (9).Nel 1938 I'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista ionclusero unaccordo sull'invio di operai italiani in Germania. Lo scopo non fu soloquello di ridurre la disoccupazione inrtalia, ma anche diappianare il de-ficit italiano, conseguenza dell'importazione massiccia di materie primetedesche dovuta alla preparazione di una guerra di aggressione. i circa500:000 "proletari dell'asse, lavoravano tra l'altto nell'industria degri ar-mamenti dove sostituivano, dopo lo scoppio della guerra, gli operai te-deschi spediti come soldati al fronte (10). Nell,estate del L943 si troya-vano ancora cica 100.000 lavoratori italiani nel territorio del Reicb chefurono presi "in ostaggio, nel momento del crollo del regime fascista. Aloro si aggiunsero i circa 600.000 soldati italiani caduti in mano tedescadopo la capitolazione dell'8 settembre 7943; essi furono trasferiti comelavoratori forzati nell'industria tedesca che aveva disperato bisogno dimanodopera. come ha illustrato Gabriele Harnmermann, i soldati furo-no trattati in un modo assolutamente inumano; circa 45.ooo italiani mo-rirono di fame e di maltrattamenti durante il loro internamento nei lagerdella Germania (71).
Anche l'accordo del7955 rnirava, in un primo momento, a ridurrela disoccupazione inltalia (12). Secondo le statistiche ufficiali esisteva,alTora, un'eccedenza di manodopera di 800.000 unitä. proprio per que-sto motivo l'iniziativa parti dall'Italia (13).Infatti, a partke dagli anni ses-santa ufi mezzo milione di .Gastarbeiter" italiani, provenienti ora so-prattutto dal Sud della penisola, si stabili al di lä del Brennero per mori-vi di lavoro (14).
Nello stesso momento, perö, l'accordo del 1955 rimanda a contestipolitici, economici, e socioculturali molto piü ampi che hanno caratte-rizzato i rapporti dei due Paesi nel )o( secolo (15). Esso va dunque vistoquale risultato di un progetto politico piü vasto, vale a dire della crea-zione dell'"occidente Libero,. Il piano Marshall americano, continuatonel Trattato di Roma, si poneva come obiettivo lalibera ckcolazione del-le merci, dei servizi, e - appunto - degli uomini nell'Europa occidenta-le che in tal modo si sarebbe stabilizzata dal punto di vista politico, eresa immune dai pericoli del comunismo (16). D'altro canto si volevadimostrare la superioritä del modello capitalistico nello scontro dei si-stemi. In questa prospettiva la migrazione italiana verso la Germania ö,in ultima conseguenza, anche un frutto della "guerta ftedda,,.
Ne ö la prova che uno dei motivi per la stipula dell'accordo fu I'in-troduzione del servizio militare obbligatorio in Germania, avvenuta nel1956, come parte integrante del sistema di difesa occidentale. Gli ope-rai italiani, infatti, dovevano sostituire i giovani tedeschi che la chiama-ta alle armi avrebbe sottratto al mercato del lavoro tedesco (17).
Dopo la costruzione del muro di Berlino nellg6l,che rappresentöun primo apice della "guertafredda", il reclutamento di operai stranieri,
484
e di italiani in particolare, crebbe ancora in importanza per la Repubbli-ca federale di Germania che stipulö un tale accordo anche con altre na-zioni (18). Chiudendo infatti l'ultimo buco nella cortina di ferro, si esauril'affhenza di profughi, provenienti dalla Germania orientale, che fino aquel momento avevano costituito il serbatoio piü importante di mano-dopera per l'economia della Germania occidentale, ormai in forte cre-scita (19).
Questo ö un secondo aspetto importante in cui s'inserisce l'accor-do del 1955, cioö il cosiddetto miracolo economico che la Germania el'ltalia hanno conosciuto nella seconda metä del )O( secolo (20). Finoad oggi c'ö poca consapevolezza, nei tedeschi, che la secolare ripresaeconomica della Repubblica federale era anche dovuta ai considerevolisforzi sopportati dai quattro milioni di lavoratoriitaliani. Mentre sarä nuo-vo anche per molti italianiche le rimesse degli emigrati, inviate dalla Get-mania, favorivano la ripresa economica in patria (21). Soltanto alloral'Italia riusci, infatti, a fare il salto da paese prevalentemente agricolo ver-so uno Stato industriale moderno.
L'accordo del 7955 si comprende inoltre soltanto all'interno dellacornice dei rapporti commerciali, tradizionalmente molto stretti, tra laGermania el'Italia. L'invio della manodopera in Germania avrebbe do-vuto riequilibrare il bilancio commerciale negativo, creatosi a causadelle massicce importazionidi beni industriali tedeschi inltalia. Ben pre-sto, infatti, Ia Germania divenne fluovamente il partner commercialepiü importante dell'Italia, com'era stato quasi sempre dopo l'unitä politica awenuta nei due Paesi (22).
Per riequilibrare labtlancia commerciale negativa, i due Stati con-fidavano Ceftamente nel lavoro degLi italiani in Germania, ma anche neiflussi turistici tedeschi verso l'Italia. Effettivamente, milioni di turisti han-no visitato il Bel Paese dalla fine degli anni Cinquanta. Quasi un tede-sco su due ö venuto inltalia almeno una volta (23).
Meno conosciuto ö il flusso turistico nella direzione opposta che ini-ziö ben plesto e raggiunse nel corso degli anni una considerevole con-sistenza. Come ha dimostrato Alessandra Ferretti in un eccellente con-tributo sulla storia del turismo italiano in Germania, ogni anno quasi duemilioni di italiani trascorrono oggi le loro vacaflze in Germania, occu-pando, per numero, il terzo posto tra i turisti sttanieti (24).
Si ö sviluppato dunque uno scambio di uomini tta Nord a Sud, e
viceversa, in un ordine di grandezza che non ha precedenti (25).E que-sto scambio massiccio di uominiha pottato infine, nei due Stati, a con-siderevoli cambiamenti socioculturali. Sia a causa del lavoro in Germa-nia che in occasione delle vacanze in Italia o Germania, i tedeschi e gliitalianisono arrivati a conoscersi almeno un poco meglio, e comunicandotra di loro hanno arricchito la loro rispettiva cultura nazionale.
A questo proposito giä negli anni Cinquanta si ö manifestato in Ger-mania un processo di forte italianizzazione. Lo dimostra bene l'acco-
485
glienza trionfale che i beni di consumo italiani hanno trovato in Germa-nia:la moda (in Germania esisteva perfino il termine.Italienmode,); i filmdel cinema italiano,legati a nomi di noti registi come Federico Fellini, edi grandi star come Sofia Loren (26); il design, soprattutto nel settoredei mobili (27) e la famosa Vespa (28).
I successi maggiori li ha raccolti perö la cucina italiana (29). Lapizza ela pasta ebbero giä nei primi anni Cinquanta i loro entusiasticiammiratori. La gelateria italiana divenne a poco a poco, per cosi dire,un luogo magico per la gioventü tedesca del dopoguerra. Quanta im-portanza essa abbia avuto per niolti come luogo di incontro, si puö de-durre dal fatto che nell'Haus der Deutschen Gescbicbte di Bonn ö stataallestita, in esposizione, un'interu gelateria italiana (30).
Dall'altraparte, anche gli italiani assunsero abitudini di vita tedesche.I lavoratori delle fornaci tornati dallaBaviera, ad esempio, introdusserolabirra nel Friuli. L'effetto indesiderato fu perö la diffusione dell'alcolismo.Proprio in questa regione si diffusero anche altre abitudini tedesche. Al-meno secondo le osservazioni della popolazione locale gli emigrati, tor-nati in ltalia, pulivano le loro case come si usava in quell'epoca in Ger-mania (31).
Ormai non ö piü possibile concepirelavita quotidiana tedesca sen-za elementi italiani. Il cappuccino italiano si puö ordinare in Germaniaquasi dappertutto (32). Nella sola cittä di Monaco esistono oggi nonmeno di 600 ristoranti ltalian| Sard senz'altro corretto parlare in questocontesto non solo di una crescente omogeneizzazione delle culture na-zionali, ma anche dei primordi di una cultura europea di consumo (3il.
Queste vicende non avevano perö un andamento semplice, linea-re e consensuale. Il crescente intrecciarsi economico, sociale e cultura-le trovö anche ostacoli e resistenze. A proposito dell'accordo del1,955 isindacati tedeschi temettero ad esempio una maggiore concorrenza sulmercato del lavoro. E le autoritä statali paventarono delle infiltrazioni co-muniste ad opera dei lavoratori italiani (34).i per questo motivo che cer-carrano di influenzare I'opinione degli immigrati italiani attraverso i me-dia alorc diretti (35).
L'anticomunismo tedesco era talmente forte da spingere KonradAdenauer a ctiticare addirittura i film di Don Camillo che godevano an-che in Germania di grande popolaritä (36). Secondo il primo Bundes-kanzler essi .minimizzavano" pericolosamente il comunismo. In ultimaanalisi, siala ttaduzione tedesca di Giovanni Guareschi sial'adattamen-to cinematografico erano "opera dei comunisti, (37). Adenauer dimen-ticö, perö, che la tradtzione tedesca era di Alfons Dalma, un noto gior-nalista di destra che aveva contatti stretti con il giovane Franz-losef Strauß,allora ministro nel governo Adenauer.
I pregiudizi dei tedeschi nei confronti degli italiani erano fortementeradicati nella cultura quotidiana. Dopo il23 maggio 191.5 e l'8 settem-bre 7943, tanti tedeschi accusavano gli italiani di essere "traditori,. Su que-
486
7iIl
I
,t
.
II
1
1
iiaIItt
+
\
t!
1
i
I
I
ti
rFit3
lsto sfondo anche i costumi degli italiani divennero il bersaglio di risen-timenti. Ancora negli anni Sessanta non pochi tedeschi chiamarono i la-voratori italiani "Spaghetti-Fresser, (mangiaspa ghetti) (38).
Anche da parte italiana esistevano delle riserve, ben comprensibilia caüsa dei crimini di guerra commessi dai nazisti inltalia. Molti italianinon credevano che i tedeschi fossero cambiati dopo il1,945.I film ita-liani sulla Seconda gueffa mondiale lo dimostrano molte bene in quan-to proponevano di continuo l'immagine del cattivo tedesco - uno ste-reotipo che fu strumentalizzato anche nell'arena politica come abbiamovisto nel 2OO3 dtrante la discussione al Parlamento europeo tra SilvioBerlusconi e il deputato tedesco Martin Schultz. Il che si spiega certa-mente con la paura, fortemente radicata, di un futuro che avrebbe por-tato alla superioritä economica, politica e culturale dei tedeschi nei con-fronti dell'Italia.
Verso la fine degli anni Sessanta, le riserve dei tedeschi contro gliitaliani cominciarono ad attenuarsi. Ciö dipende da un lato dal ricambiogenerazionale (39). D'altro lato questi processi vanno ricollegati al co-siddetto mutamento dei valori che si ö manifestato in tutte le societä oc-cidentali apafüre degli anni Sessanta (40). Valoritradizionali, come adesempio l'obbedienza, persero granpafie della loro incidenza rispetto aicosiddetti valori dello sviluppo personale. A questi ultimi apparteneva inparticolare la capacitä. di godersi la vita (47). Da sempre i tedeschi ave-vano attribuito agli italianitale capacltä, definendola perö .pigrizia,. Mol-ti tedeschi invece cominciarono ora afarsiun'immagine decisamente po-sitiva degli italiani e del loro supposto stile di vita. Secondo loro gli ita'liani sapevano vivere nel modo giusto, trascorrendo ad esempio una bel-la e tranquilla serata in famiglia e gustandosi una cena opulenta. A que-sto si riferiva chiparlava di .stile di vita italiano" (42). Secondo alcuni son-daggi l'Italia ö ormai avanzata tra i paesi europei piü amati dai tedeschi:il paese si trova alterzo posto dopo IaSvizzera e l'Austria (43).
Gli italiani di oggi non parlano meno euforicamente delle loro va-canze trascorse in Germania. I racconti dell'Oktoberfest, o le descrizionidel castello di Neuschuanstein somigliano a quelli dei tedeschi che ne-gli anni Cinquanta scoprivano , e imparavano ad amare,le spiagge diRimini e di Riccione. Sembra dunque che le Yacanze e i consumiabbia-no fortemente influenzato la formazione delle mentalitä e delle opinio-ni(44). Sarebbe del resto paradossale apostrofare gliitaliani ancora co-ffre "mzngiaspaghetti", ora che i tedeschi afnafto questa pastasciutta qua-si quanto la apprezzano gli ltaliani.
Certo: tutto ciö non basta per arrivare ad un'approfondita com-prensione reciproca. Continuerä a rimanete necessario il lavoro di me-diazione dei rispettivi istituti di cultura. Come scrive Lutz Klinkhammer,sarebbe inoltre .opportuna una stfategia di scambi rivolta agli studentidelle scuole primarie e secondarie e agli studenti universitari, ai lettori,agli insegnanti e docenti, agli operatori specializzati nei settori dell'eco-
487
nomia e agli esperti ministeriali" (4r. Affinch6 questi contaffi umani di-retti, non limitati soltanto a pochi giorni ma sostenuti da un processo diapprendimento sul piano professionale e umano, possano aiutare ad eli-minare le ombre del passato e rafforzare la comprensione reciproca inun'Europa unita.
(traduzione di Gerhard Kuck)PATRICK BERNHARD
Note
(1) Per la lettenturz sulla storia delle migrazioni durante il medioevo si veda: U. Ist.+u, Fremdeaus dem Norden. Transalpine Zuwand,erer im spätmittelaheilichen ltalien, Tübingen 2OO5, pp.8-9.
(2) In una prospettiva molto ampia: Migration in Europa. Histortscbe EnhDicklung, aktuelle Trendsund politiscbe Realetionen, a cura di H. FASSMANN, Frankfuft et al. 1996, pp.119-138.
(3) F. HsrNs, Italicln Migrants in Germany. A statistical oueruieu and a researcb bibliograpbicalnote, in "Studi Emigrazione.. International iournal of migration studies 42 (2OO), pp. 227-244; M. BAUMET-srER, .Italien. Ankommen, um zurückzukehren? Italienische Arbeitsmigranten im Nachkriegsbayern,, inBayern nxitten in Europa. Vom Fdbmittelalter bß ins 20. Jabrbundert, a cura di A. SCHMID e K. WETGAND,München 2005. pp. 402-41.8.
(4) R. Dar F,q,sgno, Transalpini. Italienßcbe Arbeitsoanderung nach Süddeutscbland. im Kaßer-reich 187O-191§ Osnabrück, Rasch, 1996; U. BnnNenor, AEetti d.ell'emigr.tzione italiana nell'Imltero Ger-manico tra Otto e Nouecento, in .Le relazioni tra l'ltalia e la Germania". Numero speciale del "Veltro" nelcinquantennale dell'accordo per l'emigrazione italiana in Germania del 1955. Roma 2005, pp. 349-356.
(5) K. J. Blroz, Sozialbßturtscbe Migrationsforscbung. Gesammelte Aufsätze, a cuta di M. Bom-mes e J. Oltmer, Göttingen 2004 e U. Hnnrrnr, Geschicbte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saiso-narbeiter, Zuangsarbeiter, Gastarbeiter, Flücbtlinge, München 2001.
(6) Questo aspetto viene spesso trascurato dalla storiografia che pone l'accento quasi esclusiva-mente sulle migrazioni di manodopera non qualificata. Si veda ad esempio: I'ernigrazione tra ltalia e Ger-nxania,a cura diJ. Petersen, Bari, Roma, 1993.
(7) P. Bnmurano, L'Italia nel piatto. Per una storia della gastrononüa e cucina italiane in Ger-mania nel XX secolo, in ltaliani in Gerrnanfui tra Ottocento e Nouecento. Spostamenti, rapporti, immagini,inJluenze, a cura di G. ConNI e C. Dnnen, Bologna 2006, pp. 263-287; si veda anche il prospetto "Kurzerhistorischer Rückblick auf die Entwicklung des Eiskonditorenhandwerks" di Uniteis Germania, in pos-sesso dell'autore.
(8) Si veda ad esempio la crilica di S. BAflEMTE, Le capacitA imprenditoriali degli italiani eruigra-ti in Germania nel secondo dopoguerra: un ca.so deuiante, in "Memoria e Ricerca, 18 (2005), pp.723-1,34.
(9) Dal punto di vista tedesco: J. Orlr,tan (a cura di), Migration steuern und uentalten. Deutscb-land uom späten 19. Jabrbundert bis zur Gegenutat't, Göttingen 2003.
(10) B. MeNrBrLt, .Carnerati d.el lauoro". I lauoratori italiani emigrati nel Terzo Reicb nel periododell'Asse 1938-1943, Firenze, La Nuova llalia, 1))2; C. Bnmlam, S. BoLoGNA, B. MeNrsrn, Proletarier d.er.Acbse,. Sozialgescbicbte der italienßcben Fremdarbeiter in NS-Deutscbland 1937 bis 1943,Berlin 1997.
(11) G. HeumnueNN, Gli internati ,nilitari italiani in Germania 1943-1945,Bo1ogna 2004.(12) Per l'accordo si veda anche M. Fuzorx, SoJabre Anwerbeuertrag zloischen Deutscbland und
Italien - Italienische Gastarbeiter und Unternebmer in Bayern und Müncben, in http://w"ww.muen-chen. info/stalm-stat/themen/wirtschaft/berichte,/berichte_2005lmb05030 1.pdf
(13) F. Romno, Emigrazione e integrazione europea,1,945-1973, Roma 1991.(14) Si veda soprattutto lo studio di Y. Rrrxnn, "Ein Stück Heimatfindet man ja immer'. Die ita-
lieniscbe Einutand.erung in die Bundesrepublik, Essen 2O03.(15) Finora perö la storiografia contemporanea tedesca ha solo scarsamente integrato la storia
della migrazione nella storia generale del )O( secolo. Si veda la critica di M. G. EscH/P. G. Potrxus Zeit-gescbichte und Migrationsforscbung: Eine Einfübru.ng, in.Zeithistorische Forschungen/Studies in Con-temporary History,, Online-Ausgabe,2 (200)H.3,http://www.zeithistorische-forschungen.del1,61,26041-Esch-Poutrus-3-2005. Per un tentativo piü recente si veda: 50 Jabre Bundesrqublik - 5O Jabre Einwan-
4BB
I
1ii.*
1
a
rr
:
n
b
1
III'
i
E
F
F
r
t)r
rrif
t:FI
deru.ngsland. Nacbkriegsgescbicbte ak Migrationsgescbicbte, a cttra diJ. Morre , R. OHUGER e A. voN Oswer-o,
Frankfurt am Main 2000.(16) Sulle ricerche in proposito si veda: C. S. MATER, Tbe Marcball Plan and tbe Diuision of Euro-
pe, in "Jovt,|lal of Cold War Studies, 7 (2005), pp. 168-174.(17) J.-D. SrErNERr. Migration und Politik. Westdeutscbland- Europa- Übersee 1945-196 l.
Osnabrück 1995.(18) La Germania concluse simili accordi con la Spagna e la Grecia nel 1960, con la Turchia nel
1.961., con il Marocco nel 1963, con il Portogall o nel 1964, con la Tunisia nel 1965 e con la Jugoslavia nel1968. Per l'accordo con la Turchia siveda l'eccellente studio di K. Hur:w, "NöcbstesJabr kebren uirzurück...,.Die Gescbicbte d.er türkiscbsn "Gastarbeiter" in der Bundesrepublik, Göttingen, §(r'allstein Verlag,2005.
(19) Y Acrcm,rerN, Der.ecbte, Flücbtling aus der DDR 1945-1961, Osnabrück, Verlag Rasch 1995;
M.-L. REcKER, Gescbicbte der Bundesrepublik Deutschland,2a ed., München 2005, in particolare pp.43-47.(20) Perl'Italia:V.CesmoNovo,L'industriaitali.anadall'ottocentoaoggr,Milano1980,pp.275ss;
M. BolrEscnr, Poueri nxa belli - i nogrt anni cinquanta, Milano, Mondadori, 1995/1997 .
(21) D. Dnuenco, -Per una storia economica dell'emigrazione italiana,, in Tendenze dell'emigra-zione italiana: ied, oggi, a cura di A. DELL'OREFICE, Genöve 1978, pp.2l-56.
(22) M. Furoes., Deutscb-italienßcbe Wi?tscbaftsbeziebungen. Kontinuitäten und Brücbe 1936-1 957, Frankfurt am Main et al., 2003.
(23) La storia del turismo tedesco in Italia dopo i11945 rimane ancora tutta da scrivere. Finora esi-
stono soltanto gli studi di C. Pagenstecher che si limita, perö, a presentare una storia visuale del fenome-no: Der bundesdeußcbe Tourismus. Ansätze zu einer Visual History: Llrlaubsprospekte, Reisertihrer, Fo-tcmlben,1950-1990,Hamburg 2003. In italiano lo stesso: .L'immagine dell'Italia nella pubblicitä tedesca deldopoguerra. Il Lago di Garda e la Riviera Adriatica nelle brochure del tour operator,, in Storta del turi-srno,
^ cuta di A. BrnmNo, Roma e Mllano 2004, pp. 1,05-136. Comunque, all'universitä di Göttingen Till
Manning ha appena irriziato la sua tesi di dottorato sulla storia del turismo tedesco inltalia.(24) A. FeRRrrn, Iln uiaggio lungo un secolo. Per una stoia del turtsmo italiano in Germania,
19OO-2OOO, in .Italiani in Germania tra Ottocento e Novecento,, cit., pp. 521-544.(25) K.H. Jeneuscu e M. Grtzx, Zerbrochener Spiegel. Deutscbe Gescbicbten im 2O. Jabrbundert,
München 2005, in pafticolare il capitolo 7 "Eine Gesellschaft in Bewegung; Mobilität und Migration,.(26) Sulla storia delle star del cinema italiano in Germania durante il fascismo e negli anni Cin-
quanta si veda fra poco la tesi di dottorato di Antie Dechert dell'Universitä di Bologna.(27) A. BeNcrnr, .Il design italiano in Germania o la metodica di un moderno transfer culturale,,
in ltaliani in Germania tra Ottocento e Nouecento, cit., pp.385-391.(28) T. BneNor, Centaur, Venus or Centauress - Gendering tbe Vespa scooter in ltaly in the
194Os-196Os, in T. BoncsRSsN e A.B. MeunsnrH (a cura di), Fabrikkens Stecl, Bilde og Idö. (The Locus, Ima-ge and Idea ofthe Factory) No. 5 i Skriftserie fra forskningsprosjektet "Fabrikken,, NTNU, Trondheim 2002.
(29) Per la letteratura recente sul consumo di prodotti italiani in una prospettiva europea sivedaP. BnnNneno, Espo?'tare I'Italia. Nuoui studi sulla §orta del consumo transnazionale nel Nouecento. In'troduzione, in "Italia Contemporanea, 241, (.2OOr, pp. 509-513.
(30) A. SnnrcN, Eisdiele. .komm mit nacb ltalien ...b, a ctrra della Haus der Geschichte der Bun-desrepublik Deutschland, Bonn 1998.
(31) K. GerrrNctn, .Gli stagionali italiani in Baviera prima della Grande guera,, in ltaliani in Ger-
rna.nia tra Ottocento e Nouecento, cit., pp.99-115.(32) U. SptrxrnueNrv, .Lifesryle und Kaffee. Kaffeebars als Trendprodukt derJahrtausendwende,,
in Am litnit. KafJeegenuss als Grenzerfabrung, ^
cura di E. Dletnrcn e R. RossFELD, Znrich2002,pp. 106-119.
G3) H. KAELBLE, "Europäische Besonderheiten des Massenkonsums 1950-1990" in EuropäiscbeKonsumgescbicbte. Zur Geselkcbafts- und Kulturgescbicbte des Konsums (18. bis 2O, Jabrbundert), a
cura di H. srncnrst, H KAELBLE e J' Kocre, Frankfurt am Main 1"997 , pp' 169-1'96; cross-cultural consump-tion: Global Markets, Local Realities, a cura di D. Hovns, London e New York 1996; A. Arlour.i,t, Moder-nitA in poluere. Dim.ensioni culturali della globalizzazione, Roma 2001. Di prossima pubblicazione,Consuming Cultures, Global Perspectiues: Historical Trajectories, Transnational fuchanges, a cura di F.
TREMMANN e J. BRE\üER, Oxford e New York.(34) Y. ruar<nn, Südlände\ Ostagenten oder Westeuropäer? Die Polrtik der Bundesregienr.ng und
das Bild der italieniscben Gastarbeiter 1955-197O,in"Archiv ftir Sozialgeschichte,, 40 (2000), pp.231-258.(35) R. SArA, .Ga.starbeiteßendungen, und "Ga.starbeitetzeitscbrifien, in d.er Bundxrepublik (1960-
1979 - ein Spiegel internationaler Spa.nnungen, in .Zeithistorische Forschungen/Studies in Contempo-rary History,, Online-Ausgabe, 2 (2OO), H. 3, http://v/ww.zeithistorische-forschungen.de/16126041'-Sala-3-2005.
(3O f. funer, Die Rezeption uon Don Camillo und Peryone irn deutschsPrachigen Raum. EineÜbersetzungsanalyse.Tesidilatrea presso l'Universitä di Graz l999.Fra poco anche: T. LNorNssncnn, Fllrnim Kalten Krieg - Kalter Krteg im Film: Studien zum deutscb-französßcben Vergleich. Per l'Italia; M.Cs.
TrunnnrNr, Don Camillo e Pryone o I'omogeneizzazione del pubblico, in.Italienisch,. Zeitschrift für ita-lienische Sprache und Literatur del novembre 1982.
489
(37) Cosi K. AonNeusR in un colloquio del30 mano 1954 con il gruppo parlamenare democristiano:Die CDU/csu-Fraktion im Deutschen Bundestag. sitzungsprotokollelsij-tiSZ,a cura di H. Hnmrurvrn,1'.Hbd. 1'953-1955,Düsseldorf2003,Doc.45.RingrazioilmiocollegaTimGeigerperquestaindicazione.
G8) P' BBnxueno, Die Pizza arn Rbein, Zur ltalienßienrng an dewsinä Küibe und Gastrono-mie im 2O. Jabrbund.ert, in "Forum Loccum, 24 (2OOr, pp. 61f f . Ma anche nella Svizzera questa parolaera conosciua:J. Thnvan, .Italienische "Makkaroni-Essen" in dei Schweiz. Migration von Arbeiiskraftön undkulinarische Traditionen,, ifi Essen und kulturelle ldentität. Europcikcbe pärcpektiuen, a cura di H. J. Tru-TEBERc et al, Berlin 1.997,pp.473-497.
- _ (39) Si veda per esempio; A. kurnr, Anbunft im westen. ßsay zur Erfolgsgescbicbte der Bundes-
republik. Frankfurt am Main 19», pp.t81-189; Detnokratßi.erung und geseilscttifilicber AuJbnrcb. oiesecbzigerlabre aß Wendezeit der Bundesrepublik, a cura di trl. nnrsr,l. Peurus-e K. Trrer, paderborn2003, pp L2-1'3; Generationswecbsel und bistorßcber wand.el, a cura di Ä. ScHULz e G. GnanNrn, München2003. Sulla teoria del concetto di generazione nella storiografia contemporanea: B. §hlsnnoo, Generationund Generationalitöt in der Neueren Gescbicbte, in "Aus Politik und Zäitgeschichte" 8 (2005j, pp.3-9.
(40) In italiano: R- INcI-rrunt, Ia rfunluzione silenziasa, Uilano 19-83. Per la Germania, H. Krecrs,wertori'entierungen im wandel. Rückblick, Gegenuartsanafise, prognosen, Frankfurt am Marit 19g5.
.(41) E. PIEHL, "Langeweile ein Schicksal? Verbesserung der Gbens- und Arbeitsbedingungen,, inAllensbacberJabrbucb der Demoskopie 1978-1883. a cura di E. NEu.r-E-NEUMANN e E.p. Nruuerri, UIrr.h..,1983, p. )ooil; All.ensbacberJabrbuch der Demoskopie 1993-1Dl a cura di E. Nruur-Nnulunr.l e E.p. Nru_uemr, München 1997, p. 632.
(42) rrtenista dell'autore al tesrimone peter M. (nato nel 1949) I'11..12004 a Haimhausenso Monaco.
pres-
(43) AllensbacberJabrbucb der Demoskopie 1998-2002, a cura di E. NEULLE-NEUMANN e E.p.NEUMANN, München 2002, p.1001,.
(44) D. Hornorn, Cultures in Contact. World. Migrations in tbe Second Millenium, Durham 2002.(45) RiJlessioni sull'immagine dei tedercbi in Itaiia dopo il 1945, in.Le relazioni tra l'Italia e la Ger-
mania,. Numero speciale del .Veltro,, cit., pp. 140-14& qui: 14g.
ii
!
.?
e
*
1
490
i
?
!7
I)rE
i
i
t?k"ri.
!ItF
t
rI
tI
tLt,
IF
ttt
F
III
i
iIt
iI
- L'accordo, stipulato nel dicembre 1955 tra. la Repubblica Federale di Germania el'Italia sul reclutamento di lauoratori italiani, costituisce un importa.nte rnornento per irapporti ffa i due paesi nello scorso secolo. Da una parte esso costitui il punto di partenza perl'ultima grande ondata rnigratoria dall'Italia uerso la Genxania. Sotto il segno dell'incipiente
miracolo economico i cosiddeni "Gastarbeiter" lauorauano soprattutto nell'industria e nelle
miniere, contribuendo cosi non poco alla ricostruzione della Germania occidentale e
dell'Italia. Dall'altra parte tale mouimento tt.igratorio di milioni di persone, a cuicorrispondeuano i flussi turtsilci tedescbi uerso I'Italia, portö nei due paesi a complessi e
stratificati processi d.i ffasformazione socioculturale. Non da ultimo attrauerso il cinema, lamod.a e la gastronomia si innescö una dinamica di crescente riauuicinamento tra i due paesi.
The agreement stipulated betüeen tbe Federal Republic of Germany and ltaly indecember 1955 regarding tbe recruitment of ltalian uorkus, bas been a.n ifitportafi startingpoint for tbe relations betueen tbe tuo countrtes in last century. On the one band, itrepresented tbe beginning of latest migratory waue from ltaly towar^ Germany. Anticipatingtbe economic miracle, tbe so called "Gastarbeiter" were mo§ly employed in industries andmines, contributing to tbe recon§ntction of western Germany and ltaly. On tbe otber band,
tbß migratory rnouernenet of millions of people, including a Jlou of Gerrnan tourßts to ltaly,
implicated cornplex and stratified processes of sociocultural transformation. Among tbe most
important a.rees tbat nudged tbe tuo countries closer togetber utere cinema, fasbion andgastrononty.
491














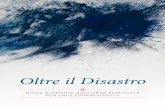




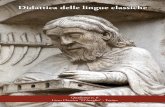









![Monni, S. (2013) “ Oltre il velo di Maya: il ruolo delle idee e delle Istituzioni” [in Italian].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63225731050768990e0fd043/monni-s-2013-oltre-il-velo-di-maya-il-ruolo-delle-idee-e-delle-istituzioni.jpg)

