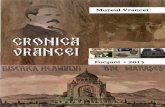Attività Parlamentare del Senatore, Legislature XIV e XV, 2001-2008
La Musicoterapia Olofonica applicata in psichiatria: attività riabilitativa su un caso di psicosi...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La Musicoterapia Olofonica applicata in psichiatria: attività riabilitativa su un caso di psicosi...
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “ROMA TRE”
Facoltà di Scienze della Formazione
Elaborato Master in
“LE ARTITERAPIE:
METODI E TECNICHE D’INTERVENTO”
Corso di Perfezionamento in Musicoterapia
La Musicoterapia Olofonica applicata in psichiatria:
attività riabilitativa su un caso di psicosi cronica
Specializzando
Vito Barillari
Matr. n. 454156
ANNO ACCADEMICO 2011-2012
Capitolo secondo
Le psicosi
2.1. Cosa e quali sono i disturbi psicotici?
Per psicosi, in generale, si intende un gruppo eterogeneo e vario di disturbi mentali che comportano alterazioni del pensiero, della perce-zione e degli stati emotivi, anomalie e cambiamenti comportamentali, con conseguente distorta o errata rappresentazione della realtà, altera-zione della personalità, e una forte sofferenza psichica. Queste patologie sono caratterizzate da una disintegrazione dell’io ed una diminuzione della capacità critica della realtà, quindi conducono alla parziale o totale perdita dei legami sociali e dell’abilità lavorativa.
Tale malattia purtroppo è piuttosto frequente e diffusa, soprattutto nei giovani1, insorge spesso in età adolescenziale (tra i 18 e i 25 anni cir-ca), e si manifesta sotto diversi aspetti, talvolta in modo non immedia-tamente riconoscibile, con crisi ripetute nel tempo; le crisi possono anche non presentare una stabilizzazione dei sintomi principali, ma lasciano, tuttavia, dei limiti alla persona.
I sintomi più caratteristici che si presentano si possono raggruppare insieme, distinguendo i cosiddetti sintomi positivi da quelli negativi2: i primi comprendono deliri, allucinazioni, catatonia e agitazione; i sintomi negativi, invece, comportano l’impoverimento ideo-affettivo e motorio, l’isolamento ed il ritiro sociale, dunque comprendono apatia, abulia, a-naffettività, passività ed inattività. C’è poi la disorganizzazione cogniti-va e la confusione delle funzioni mentali, con alterazioni del linguaggio e del ragionamento, caotico ed illogico. In alcuni casi, ad esempio, i sog-getti presentano difficoltà ad esprimere dei ragionamenti in modo orga-nizzato e comprensibile, e questo aumenta il senso d’estraneità dall’interlocutore oppure favorisce la diffidenza o il criticismo da parte degli altri. Le funzioni mentali relative alla vita di tutti i giorni diventa-no confuse o non seguono una successione logica. L’individuo si espri-
1 La Federazione Mondiale per la Salute Mentale [World Federation for Mental
Health] ha calcolato che nel mondo attualmente soffrono di questa patologia circa
24 milioni di persone. 2 World Federation for Mental Health, Learning about schizophrenia, An Interna-
tional Awareness Packet from the World Federation for Mental Health, 2008, pp. 3-
5.
Capitolo secondo 4
me con frasi poco chiare o che non hanno alcun senso ed ha difficoltà a concentrarsi, a seguire una conversazione o a ricordarsi le cose.
I sintomi e la durata della malattia in genere differiscono da un indi-viduo all'altro e potrebbero cambiare col tempo. Esistono vari tipi di di-sturbi psicotici, identificabili prevalentemente con il criterio sintomato-logico. Una prima categoria diagnostica sono i disturbi schizofrenici propriamente detti, nelle forme di schizofrenia paranoide (deliri e allu-cinazioni a carattere persecutorio; sintomi dissociativi); schizofrenia di-sorganizzata (disorganizzazione dell’eloquio, degli affetti e dei compor-tamenti); schizofrenia catatonica (disturbi psicomotori, negativismo, ste-reotipie verbali e/o motorie); schizofrenia residuale (sintomi negativi come, ad esempio, impoverimento motorio, affettivo e volizionale).
La schizofrenia (termine coniato da Eugen Bleuler) o demenza preco-ce (dementia praecox) è una malattia psicotica eterogenea a decorso lento e progressivo, nella quale i sintomi o i cambiamenti comportamentali per-durano da un periodo di circa sei mesi; se i sintomi durano da meno di sei mesi si parla di disturbo schizofreniforme. Bleuler individua alcuni sintomi caratteristici della schizofrenia (la dissociazione ideica, il dete-rioramento dell’affettività, l’ambivalenza, l’autismo ed i disturbi della volontà), che distingue dai cosiddetti sintomi “accessori” (disturbi per-cettivi, deliri, disturbi della personalità, catatonia, disturbi della memo-ria)3.
Quando il disturbo schizofrenico presenta contemporaneamente sin-tomi emotivi, come episodi di mania o di depressione o misti, allora siamo di fronte al disturbo schizoaffettivo. Il disturbo delirante è, invece, caratterizzato da manifestazioni d’alterazione ideativa di tipo delirante con vari temi di pensiero (grandiosità, gelosia, erotomania, persecutorie-tà, somatizzazioni) non accompagnate da altri sintomi dei disturbi schi-zofrenici.
Questa è stata la nosografia classica della patologia in uso sino alla metà circa del 1900, allorquando le maggiori scuole di psichiatria a livel-lo mondiale, dopo importanti e significativi studi, riuscirono a standar-dizzare a livello internazionale una precisa linea di condotta nel definire i criteri diagnostici per le psicosi, con la prima uscita, nel 1952, del ma-nuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, meglio noto con la si-gla DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), a cura
3 E. BLEULER, Dementia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien, Leipzig, Deuticke,
1911 [ed. ita. a cura di J. VENNEMANN e A. SCHIACCHITANO, Roma, La Nuova
Italia Scientifica, 1985].
Le psicosi 5
dell’American Psychiatric Association (APA), giunto ormai alla quarta edi-zione, revisionata ed aggiornata (DSM-IV TR)4, attualmente in vigore e in uso dai principali medici, psicologi e psichiatri di tutto il mondo. Per il 2013, in più, è già stata annunciata la pubblicazione della quinta edi-zione di questo testo fondamentale (DSM V), con i cambiamenti e le in-tegrazioni approvate dalla fondazione APA il 1 dicembre 2012.
2.1.1. Cause e diagnosi
Le psicosi sono causate da una serie di fattori biologici, spesso intrec-ciati fra loro, che creano una vulnerabilità individuale variabile da per-sona a persona. I primi sintomi spesso emergono come reazione a ten-sioni emotive, abuso di droghe o di alcool, cambiamenti sociali. Riguar-do al manifestarsi del primo episodio di psicosi le cause sono partico-larmente poco chiare e possono dipendere da molteplici fattori. È quindi necessario che il paziente si sottoponga ad una visita completa per e-scludere che ci siano problemi di carattere medico e per poter stilare una diagnosi il più precisa possibile. Per diagnosi si intende l'identificazione di una malattia in base ai sintomi. La diagnosi dipende dall'origine della malattia e dalla durata dei sintomi.
Riguardo alle psicosi in generale, i fattori di rischio favorenti la malat-tia possono essere fattori predisponenti, quali fattori genetici o ambien-tali, la storia e condizione familiare, complicazioni perinatali e ostetriche o infezioni, abuso di sostanze stupefacenti o di alcool; oppure aspetti demografici e fattori concomitanti, quali l’età, il sesso, la razza, la classe sociale e lo stato civile; fattori precipitanti, quali eventi vitali stressanti o condizioni legate allo sviluppo.
2.1.2. Differenti tipi di cura
Gli interventi più appropriati ed efficaci sono di tipo farmacologico, psicoterapeutico, riabilitativo e psicoeducazionale, sia per l’individuo che per i suoi familiari, dunque si tratta di promuovere un approccio multidisciplinare integrato.
Un trattamento ritenuto spesso necessario è sicuramente quello far-macologico, mediante la somministrazione – sempre e solo da parte di medici specialisti – dei neurolettici maggiori che agiscono soprattutto sui
4 AA.VV., DSM-IV TR. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Milano,
Masson, 2001.
Capitolo secondo 6
sintomi allucinatori, deliranti e comportamentali, riducendo l’angoscia e le reazioni aggressive. Esistono farmaci propriamente adibiti alla cura della sintomatologia delle psicosi. Gli antipsicotici comprendono farmaci tradizionali quali l’aloperidolo, la perfenazina, la clorpromazina, di pro-vata efficacia clinica. Nell’ultimo decennio sono comparsi nuovi antipsi-cotici proposti ai pazienti nel tentativo di mantenere una buona efficacia clinica ma al contempo di ridurre alcuni effetti collaterali di particolare dannosità dei farmaci tradizionali (es. parkinsonismo). Gli antipsicostici atipici sono la clozapina, l’olanzapina, il risperidone, la quetiapina, l’aripiprazolo, l’amisulpiride e sono comunemente utilizzati in queste forme di disturbi, hanno un migliore profilo di tollerabilità e minori ef-fetti collaterali, inoltre possono favorire l’inizio dei trattamenti psicote-rapeutici ove intrapresi.
La cura attraverso i farmaci, tuttavia, ha dei limiti nel favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza della realtà e non pro-muove le relazioni con gli altri, ma soprattutto non considera il lato psi-cologico del soggetto. Inoltre la cura farmacologica pur focalizzandosi sull’eliminazione dei sintomi può causare effetti collaterali, come l’aumento di peso corporeo, disfunzioni sessuali o il rischio di diabete.
In associazione alla terapia farmacologica il più delle volte è indicata come indispensabile la psicoterapia. Infine, la stabilizzazione delle psi-cosi richiede degli interventi specifici di tipo riabilitativo e psicoeduca-zionale, mirati sulle diverse aree del funzionamento psichico, lavorativo e di relazione.
Un trattamento diffuso è quello cognitivo-comportamentale, che ha lo scopo di permettere la comprensione dei sintomi e di superarli, affinché sia raggiunta un’adeguata qualità della vita5. L’intervento cognitivo è specifico sui sintomi positivi e mira al loro riconoscimento, padroneg-giamento e distanziamento critico dai sintomi. La capacità di essere con-sapevoli della propria attività mentale e di quella altrui (metacognizio-ne) può essere variamente danneggiata nelle psicosi; questo vuol dire
5 B. E. WEXLER, M. D. BELL, Cognitive remediation and vocational rehabilitation for
schizophrenia, in «Schizophrenia Bulletin», 31, 2005, pp. 931-941; C. DEMILY, N.
FRANCK, Cognitive remediation: a promising tool for the treatment of schizophrenia, in
«Expert Review in Neurotherapeutics», 8, 2008, pp. 1029-1036; S. R. McGURK, A
meta-analysis of cognitive remediation in schizophrenia, in «American Journal of Psy-
chiatry», 164, 2008, pp. 1791-1802; S. T. WYKE, V. HUDDY, Cognitive remediation for
schizophrenia: it is even more complicated, in «Current Opinion in Psychiatry», 22 (2),
2009, pp. 161-167.
Le psicosi 7
che i pazienti possono avere delle difficoltà nel calcolare tutta una serie di operazioni mentali, tra cui riconoscere i propri contenuti mentali, dif-ferenziarli per sapere se sono prodotti dalla realtà o dalla fantasia, inte-grarli in opportune teorie psicologiche o cogliere il pensiero di un’altra persona. L’acquisizione di buone competenze metacognitive può aiutare l’individuo nel riconoscimento e nel padroneggiamento dei sintomi psi-cotici, può, inoltre, permettere di superare le difficoltà nelle relazioni con le altre persone, portando ad un aumento delle abilità interpersonali o di condivisione psicologica con gli altri.
La terapia si articola in varie fasi. In un primo momento avviene la valutazione diagnostica e la presa in carico, durante la quale il paziente espone le proprie problematiche e il terapeuta può concordare e fornire, attraverso il cosiddetto contratto terapeutico, spiegazioni sulle modalità d’intervento. Successivamente la cura, che viene sempre adattata alla sintomatologia ed al vissuto del paziente, mira a facilitare una rielabora-zione dell’esperienza psicotica; favorire la definizione e quindi la spie-gazione di un modello condiviso del disturbo, in modo tale che il sog-getto possa arrivare a dare un senso ai problemi e a comprendere il si-gnificato dei sintomi; potenziare le abilità metacognitive; favorire l’acquisizione di strategie efficaci di fronteggiamento dei sintomi psico-tici, la formulazione di ipotesi alternative alle convinzioni deliranti, la spiegazione e la comprensione del significato delle “voci”.
L’approccio cognitivo-comportamentale prevede, inoltre, un tipo di trattamento particolare, il Social skills training, volto a migliorare le com-petenze sociali ed interpersonali dei pazienti psicotici. Le abilità sociali di queste persone sono, infatti, spesso deficitarie e sono un fattore di mantenimento dell’isolamento sociale. Con questo tipo di intervento si ha l’opportunità di valutare le abilità sociali di ogni singolo soggetto e di intraprendere specifici programmi su una, o più, delle abilità mancanti o disfunzionali. La persona affetta da psicosi può, ad esempio, presentare un’incapacità a percepire correttamente le situazioni sociali, oppure può non sapere affrontare e risolvere alcuni problemi che si presentano nel vivere con gli altri quotidianamente. Il programma prevede un attività di gruppo con terapeuti appositamente formati all’insegnamento delle abilità sociali, capaci di aiutare le persone affette da psicosi nell’apprendimento delle stesse abilità. Tali attività, sviluppatesi negli Stati Uniti negli anni settanta e condotte in istituzioni come cliniche ed ospedali psichiatrici, ora vengono avviate in strutture pubbliche o priva-te e costituiscono parte integrante del programma terapeutico delle psi-cosi. Gli studi di efficacia riferiscono che le persone che hanno acquisito
Capitolo secondo 8
le abilità sociali tendono a mantenerle nel tempo ed a esercitarle in con-testi diversi da quello in cui originariamente le avevano apprese.
2.2. La musicoterapia con pazienti psicotici
Che la musicoterapia, fra i vari settori di applicazione, sia efficace con i pazienti psicotici è risaputo6. Basti ricordare, tra l’altro, fra i primi me-dici psichiatri ad aver sperimentato l’intervento musicoterapico nelle di-verse forme di psicosi, un pioniere della disciplina come Rolando Omar Benenzon, considerato unanimemente uno dei massimi esperti a livello mondiale. Il modello teorico di Benenzon7, dal carattere psicodinamico e volto principalmente alla relazione, applicato alle psicosi8, tuttavia, ba-sandosi sul concetto che il paziente, caratterizzato da una propria Identi-tà Sonora (ISO), è prima di tutto un individuo che soffre e non una ma-lattia, non dà particolare risalto alla diagnosi.
La musica con i suoi effetti benefici sull’organismo umano e sulla psi-che aiuta ad alleviare l’ansia e la depressione, nonché riduce positiva-mente i sintomi negativi, migliorando l’efficacia delle cure ed il contatto interpersonale9. Le tecniche d’intervento utilizzate con i pazienti psicoti-ci possono essere sia la musicoterapia attiva che quella ricettiva; quest’ultima tuttavia, in base alla nostra esperienza diretta, da preferirsi in determinati casi specifici, come quello trattato in questo studio su un
6 Fra gli studi più recenti, si vedano almeno N. TALWAR, M. J. CRAWFORD, A.
MARATOS, U. NUR, O. McDERMOTT, S. PROCTER, Music therapy for in-patients
with schizophrenia: Exploratory randomised controlled trial, in «British Journal of Psy-chiatry», 189, 2006, pp. 405-409; C. GOLD, Music therapy improves symptoms in
adults hospitalised with schizophrenia, in «Evidence-Based Mental Health», 10 (3),
2007, 77; K. MÖSSLER, X. CHEN, T. O. HELDAL, C. GOLD, Music therapy for people
with schizophrenia and schizophrenia-like disorders (Review), The Cochrane Collabora-
tion, The Cochrane Library, Chichester (UK), John Wiley & Sons, Ltd., 2013. 7 R. O. BENENZON, Manuale di musicoterapia, Roma, Borla, 19983. 8 A. FRANCOMANO, M. G. CARLONE, M. DAZZO, D. LA BARBERA, Un mo-
dello di musicoterapia nelle psicosi schizofreniche: possibilità di impiego della musicoterapia
nella riabilitazione psichiatrica, in «Psichiatria e Psicoterapia», 30/4, 2011, pp. 277-299. 9 G. ULRICH, T. HOUTMANS, C. GOLD, The Additional Therapeutic Effect of
Group Music Therapy for Schizophrenic Patients: a Randomized Study, in «Acta Psychiat-
rica Scandinavica», 116 (5), 2007, pp. 362-370; W. TANG, X. YAO, Z. ZHENG, Reha-
bilitative effect of music therapy for residual schizophrenia: A one-month randomised con-
trolled trial in Shanghai, in «British Journal of Psychiatry», 165 (Suppl. 24), 1994, pp.
38-44.
Le psicosi 9
individuo affetto da psicosi cronica. I soggetti, durante le sedute, posso-no esternare la propria gioia o il proprio dolore, o rabbia; possono utiliz-zare gli strumenti musicali o il proprio corpo per comunicare, attribuen-do ai gesti, alle parole o ai suoni, un valore simbolico.
I sintomi psicotici comportano spesso, fra l’altro, la perdita della ca-pacità di comunicare con le parole. Il paziente tende a ritirarsi in spazi regressivi, lontano da esperienze frustranti, rifugiandosi in uno spazio pre-oggettuale più gratificante10. Il ritiro in sé, da alcuni chiamato “ritiro narcisistico”, determina il distanziamento dal mondo, dalla realtà ed an-che dal corpo, tanto che anche la mimica, la produzione verbale e la po-stura assumono aspetti dissociativi. Ad esempio, il paziente concentrato sul delirio può avere uno sguardo assente o reazioni decontestualizzate di tipo impulsivo o esplosivo. Questa è una delle caratteristiche più im-portanti che suggeriscono l’utilità della musicoterapia come tecnica ba-sata principalmente sulla sintonizzazione degli affetti e sul rispecchia-mento empatico per entrare in relazione con il mondo delle psicosi, con lo scopo fondamentale di aiutare i pazienti a superare la condizione di isolamento e aumentare l’autostima, stimolando e facilitando le condotte espressive, regolando e favorendo la libera espressione delle emozioni, acquisendo una maggiore consapevolezza di sé e quindi migliorando il rapporto con gli altri11.
Accanto alle psicosi dello spettro schizofrenico esistono le cosiddette psicosi bipolari e depressive, le quali non compromettono tanto la sfera cognitiva quanto quella affettiva. L’intervento musicoterapico in queste patologie è stato per molto tempo controverso, ed alcuni autori ne hanno sconsigliato l’applicazione nelle crisi maniacali. Per questi pazienti viene usata soprattutto la musicoterapia improvvisativa o interattiva12, che permette di dare loro la possibilità di sviluppare al massimo le capacità creative e di aumentare l’autostima. Nel corso delle sedute i soggetti hanno modo così di relazionarsi con il musicoterapeuta, stabilendo un contatto con il mondo esterno ed interno, e di elaborare le proprie emo-zioni e vissuti.
10 D. LA BARBERA, A. FRANCOMANO, C. LA CASCIA, Cento fiori nel giardino.
Apporti teorici, interventi terapeutici e nuove prospettive nella riabilitazione psico-sociale,
Milano, Franco Angeli, 2007. 11 M. J. SILVERMAN, The Influence of Music on the Symptoms of Psychosis: A Meta-
Analysis, in «Journal of Music Therapy», 40 (1), 2003, pp. 27-40. 12 J. ALVIN, Music Therapy, London, Hutchinson, 19752 [trad. in italiano, Terapia
musicale, Roma, Armando, 19862].
Capitolo secondo 10
Nell’ambito della riabilitazione psichiatrica la musicoterapia rientra, nel campo delle artiterapie, fra le attività cosiddette di secondo livello, in quanto tecnica espressiva che opera nel contesto non verbale, con l’obiettivo di aprire e riattivare forme di comunicazione attraverso il suono, percepire e comunicare le proprie sensazioni, liberare le proprie emozioni. Essa è attualmente inclusa nelle linee guida pubblicate dal Na-tional Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)13, come terapia be-nefica per i soggetti affetti da schizofrenia, con rilevanti effetti a medio e lungo termine basati sull’evidente e significativa riduzione dei sintomi negativi.
Oggi le artiterapie sono riconosciute a livello internazionale come trattamenti ormai indispensabili nella cura e nel quasi completo recupe-ro psicofisico degli individui affetti da schizofrenia, tanto da essere se-riamente valutate come appunto attività fondamentali e non più sempli-cemente “terapie complementari” alla farmacoterapia14. L’arteterapeuta funge da tramite fra l’ambiente esterno ed il soggetto, aiuta i pazienti a tirare fuori ed esprimere al meglio i propri sentimenti e mostrare gli stati d’animo, ad affrontare e combattere meglio la malattia, stimolati da un senso di assoluta libertà, benessere e sollievo. L’augurio dunque, in que-sto senso, è che anche in Italia possa prender piede l’idea di integrare obbligatoriamente nei piani terapeutici dei pazienti psicotici, il tratta-mento con le artiterapie, e con la musicoterapia in particolare.
13 National Collaborating Centre for Mental Health, Schizophrenia. The NICE
Guidelines on Core Interventions in the Treatment and Management of Schizophrenia in
Adults in Primary and Secondary Care (Updated Edition), National Clinical Guideline
Number 82, London, The British Psychological Society & The Royal College of Psy-
chiatrists, 2010, 251-257. 14 M. J. CRAWFORD, S. PATTERSON, Arts therapies for people with schizophrenia:
an emerging evidence base, in «Evidence-Based Mental Health», 10 (3), 2007, pp. 69-70.
Grafici
E m o z i o n i d e l t i r o c i n a n t e
0
1
2
3
4
5
6
Seduta
1
Seduta
3
Seduta
5
Seduta
7
Seduta
9
Seduta
11
Seduta
13
Seduta
15
Media
Rilassato
Teso
Sorpreso
Incuriosito
Impaurito
Concentrato
Soddisfatto
V e r i f i c a u t e n t e
0
1
2
3
4
5
6
Seduta
1
Seduta
3
Seduta
5
Seduta
7
Seduta
9
Seduta
11
Seduta
13
Seduta
15
Media
Ascolta le proposte del conduttore
Collabora alle proposte del conduttore
Propone idee
Rispetta i turni
Rievoca ricordi
Si addormenta
Abbandona il setting
Rispetta le regole del setting
Verbalizza le sensazioni e le emozioni
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Seduta
1
Seduta
3
Seduta
5
Seduta
7
Seduta
9
Seduta
11
Seduta
13
Seduta
15
Media
R e l a z i o n e d e l l' u t e n t e c o n g l i o p e r a t o r i Cordiale
Diffidente
Scettico
Scontroso-aggressivo
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Seduta
1
Seduta
3
Seduta
5
Seduta
7
Seduta
9
Seduta
11
Seduta
13
Seduta
15
Media
S t a t o d' a n i m o d e l l' u t e n t e d o p o l a s e d u t a Depresso
Triste
Nervoso
Felice
Rilassato
Risollevato