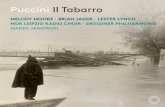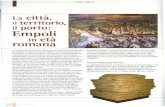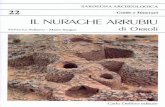Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza nel...
Transcript of Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza nel...
ESTRATTO ISSN 1123-3036
Mucchi Editore
Il dirittodell’economia
rivista quadrimestraledi dottrina, giurisprudenza e documentazione
in collegamento con laUnione Italiana Camere di Commercio
e con laAssociazione Bancaria Italiana
Promossa da
Università di BolognaFacoltà di Economia e Commercio;
Giurisprudenza
Università Cattolica di MilanoFacoltà di Giurisprudenza; Economia;
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
Università CommercialeLuigi Bocconi di Milano
Università di Modena e Reggio EmiliaFacoltà di Economia; Giurisprudenza
Università di CamerinoFacoltà di Giurisprudenza
Università di ParmaFacoltà di Giurisprudenza
Università Statale di MilanoFacoltà di Giurisprudenza
Università di VeneziaFacoltà di Economia e Commercio
vol. 28, n. 86 (1-2015)
Il dirittodell’economia
rivista quadrimestraledi dottrina, giurisprudenza e documentazione
in collegamento con laUnione Italiana Camere di Commercio
e con laAssociazione Bancaria Italiana
Promossa da
Università di BolognaFacoltà di Economia e Commercio;
Giurisprudenza
Università Cattolica di MilanoFacoltà di Giurisprudenza; Economia;
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
Università CommercialeLuigi Bocconi di Milano
Università di Modena e Reggio EmiliaFacoltà di Economia; Giurisprudenza
Università di CamerinoFacoltà di Giurisprudenza
Università di ParmaFacoltà di Giurisprudenza
Università Statale di MilanoFacoltà di Giurisprudenza
Università di VeneziaFacoltà di Economia e Commercio
vol. 28, n. 86 (1-2015)
Mucchi Editore
issn 1123-3036
Direttore Responsabile: Prof. Fabrizio Fracchia - università Commerciale L. Bocconi di Milano, Via Röentgen, 1 - 20136 - Milano - tel. 02.583.652.25
La rivista «Il diritto dell’economia», fondata e diretta dal 1954 al 1987 da Mario Longo, ha ripreso le pubblicazioni a partire dal 1987 su iniziativa di Elio Casetta e Gustavo Vignocchi
issn 1123-3036
© STEM Mucchi Editore, via Emilia est, 1741, 41122, [email protected]@pec.mucchieditore.itwww.mucchieditore.itfacebook.com/mucchieditoretwitter.com/mucchieditorepinterest.com/mucchieditore
Pubblicità inferiore al 45 %Grafi ca e impaginazione, STEM Mucchi Editore (Mo). Stampa, Editografi ca (Bo)Finito di stampare nel mese di dicembre del 2014
La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d’Autore, modifi cata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l’archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest’opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere eff ettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso diff erente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifi ca autorizzazione rilasciata dall’editore o dagli aventi diritto.
con un contributo diIl presente fascicolo è stato pubblicato
La pubblicazione di articoli e contributi proposti alla rivista è subordinata alla seguente procedura:
• Il lavoro (almeno 20.000 battute) è sottoposto a un esame preliminare da parte della direzione (o di un suo componente delegato), per rilevare la sua attinenza alle caratteristiche ed ai temi propri della rivista, nonché l’eventuale presenza di evidenti e grossolane carenze sotto il profilo scientifico.
• Il successivo referaggio consiste nella sottoposizione del lavoro alla valutazione di due professori ordinari esperti nella materia, italiani o stranieri, scelti dalla direzione nell’ambito di un comitato di referees o, in casi eccezionali, inerenti alla specificità dell'argomento trattato, all’esterno dello stesso.
• Il sistema di referaggio è quello c.d. doppio cieco (double blind peer review): lo scritto è inviato ai due revisori in forma anonima. All’autore non sono rivelati i nomi dei revisori. I revisori sono vincolati a tenere segreto il loro operato e si impegnano a non divulgare l’opera e le relative informazioni e valutazioni, che sono strettamente confidenziali: l’accettazione preventiva di questo vincolo e di questo impegno è precondizione per assumere il compito di referaggio.
• I nomi dei revisori consultati per la valutazione dei lavori pubblicati dalla rivista nel corso dell’anno sono pubblicati in apposito elenco nell’ultimo fascicolo dell’annata senza riferimento ai lavori valutati.
• I revisori invieranno alla direzione (o al componente delegato), la proposta finale, che può essere di: accettazione dello scritto per la pubblicazione (eventualmente con un lavoro di editing); accettazione subordinata a modifiche migliorative, sommariamente indicate dal revisore (in questi casi lo scritto è restituito all’autore per le modifiche da apportare); non accettazione dello scritto per la pubblicazione.
• I revisori, nel pieno rispetto delle opinioni degli autori e a prescindere dalla condivisione del merito delle tesi da essi sostenute, dovranno tenere in specifica considerazione l’originalità e l’utilità pratica delle idee espresse nel lavoro, nonché la conoscenza delle fonti pertinenti, la consapevolezza culturale, la consistenza critica del percorso argomentativo e la correttezza formale.
• La direzione della rivista (o il componente delegato) ha la responsabilità ultima della decisione di pubblicazione o meno del contributo (in particolare quando si tratti di relazioni di convegni o seminari), ferma restando la esclusiva responsabilità dell’autore per il suo contenuto e le opinioni in esso manifestate.
The publication of articles and contributions in the journal is dependent upon compliance with the following procedure:
• The work (of at least 20,000 characters) is subject to a preliminary examination on the part of the editors or their delegate to assess its relevance to the journal’s characteristics and themes, as well as the possible presence of evident and glaring shortcomings of a scientific nature.
• The subsequent peer review involves submitting the work for review by two full professors (Italian or foreign) who are experts in the relevant field, selected by the editors or their delegate from among a committee of referees or exceptionally from outside the committee, depending on the particular expertise required in relation to the subject matter of the work.
• The peer review system is the so-called double blind peer review method: the text is sent to two reviewers in anonymous form. The author is not told the names of the reviewers. The reviewers are obliged to keep their task confidential and undertake not to divulge the work or the information and evaluations contained in it (being considered strictly confidential); prior acceptance of this obligation and of this undertaking is a necessary condition for accepting the task of carrying out a peer review.
• The names of the referees consulted for assessment of works to be published by the journal during the year are disclosed in a special list in the last issue of the year, without reference to the works reviewed.
• The referees shall send the editors or their delegate the final proposal, which may be: acceptance of the work for publication (possibility after editing); acceptance subject to improvements, indicated in summary form by the referee (in these cases the work shall be sent back to the author in order to make the necessary changes); not to accept the work for publication.
• Referees must also bear in mind the originality and practicality of the ideas expressed in the work, as well as the cultural awareness and critical constancy of the line of argument.
• The journal’s editors is ultimately responsible for the decision whether to publish the proposed contribution or not (in particular when it comes to papers presented at conferences or seminars), without prejudice to the author’s responsibility for the contents of the work and for the opinions expressed within it.
Norme per la preparazione degli originali destinati alla rivista «Il diritto dell’economia»
L’originale, completo di testo e note (e/o breve nota finale di riferimenti essenziali), deve essere inviato (in formato .doc o .rtf ) per e-mail all’indirizzo del direttore responsabile ([email protected]).I riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali devono essere conformi alle indicazioni riportate qui sotto ed aggiornati, per quanto possibile, al momento dell’invio alla Direzione.All’originale deve essere allegato un breve riassunto di 20 righe al massimo, in italiano e in inglese (compreso il titolo), che potrà essere utilizzato a discrezione della Direzione.Il testo deve essere corretto e completo di titolo e sommario, deve essere suddiviso in paragrafi numerati progressivamente e deve indicare per ogni paragrafo il titolo (da riportare nel sommario con il numero del paragrafo), con gli stessi caratteri (maiuscolo, maiuscoletto, corsivo) utilizzati dalla rivista. Anche al fine di evitare ritardi nella pubblicazione dei contributi si raccomanda agli AA. la massima cura nella redazione e consegna degli originali in conformità alle presenti indicazioni. Non sono consentite modifiche o nuove versioni dei contributi inviati. La correzione delle bozze avviene di norma in via redazionale.
Nella redazione del testo (e delle note) sono da seguire, di norma, i seguenti criteri:- evitare di usare, nel testo, abbreviazioni (ad es., è da scrivere: Corte costituzionale, anziché Corte cost.,
pubblica amministrazione, anziché p.a. ecc.) o acronimi, in specie se inusuali (es. FB in luogo di fondazioni bancarie; AGC, in luogo di autorità per le garanzie delle comunicazioni, ecc.); nel caso di uso di acronimi (soprattutto se non di uso corrente), è sempre bene riportare (almeno la prima volta) anche il testo intero corrispondente: ad es., istituto monetario europeo (IME) etc.;
- per le parole straniere usare il corsivo; - per i nomi degli AA. usare il maiuscoletto con l’iniziale del nome precedente quella del cognome (es. M.
Nigro);- per le date (anche dei testi normativi) è da scrivere per lettera il mese, ed in modo completo l’anno di
riferimento (es., 16 aprile 1998, anziché 16.4.98; n. 605 del 2000, anziché 605/00);- per i testi normativi, valgono di norma le seguenti abbreviazioni: l. (per legge); d.l.; d.lgs.; t.u.; d.P.R.;
d.p.c.m.; d.m.; cod. civ., cod. pen. (ecc.); Cost..; c. (per comma o commi); numero va abbreviato con n., anziché con n°.
In ogni caso, occorre seguire un criterio di uniformità nel testo e nelle note: - le note devono essere numerate progressivamente (in corrispondenza del richiamo nel testo);- deve essere usato il corsivo per il titolo dell’opera citata, nonché per la rivista (abbreviata) o il volume in
cui essa è riportato, secondo gli esempi seguenti:
Per le citazioni di dottrina:E. Casetta, Brevi considerazioni sul c.d. diritto amministrativo dell’economia, in Dir. econ., 1955, 339 ss.;F. Merusi, M. Passaro, Autorità indipendenti, in Enc. dir., VI, Agg., Milano, 2002, 143 ss.;S. Cassese, Le basi costituzionali, in Id. (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Dir. amm. gen., I, Milano, 2003, 273 ss.;F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana, Padova, 1996.
Per le opere collettanee:Aa.Vv., Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, Bologna, 1999; oppureE. Paliero, A. Travi, La sanzione amministrativa, Milano, 1989.Per le citazioni successive alla prima, ad es.: E. Casetta, op. cit., 340; oppure (in caso di più opere dello stesso A.: E. Casetta, Brevi considerazioni, cit., 340.
Per le citazioni di giurisprudenza:Cons. Stato, Ad. plen., 1 aprile 2000, n. 1, in Cons. Stato, 2000, I, 301 ss.;Corte cost., 15 gennaio 1999, n. 12, in Foro it., 1999, I, 267 ss.;Cass., SS.uu., 12 marzo 1998, n. 128, in Giur. it., 1999, I, 2, 315 ss.;
Per le abbreviazioni degli altri collegi, ovvero delle riviste e dei periodici, si può fare riferimento, ad es., all’elenco del repertorio generale del Foro italiano o della Giurisprudenza italiana, sempre secondo criteri di uniformità.Lo stesso vale per le altre abbreviazioni delle parole più correnti (es.: v., op. cit., cfr., pp., ss., ecc.).
Sono da indicare in calce al contributo in formato cartaceo o nella mail di accompagnamento: Cognome, nome, qualifica accademica (con l’indicazione della Facoltà e/o del Dipartimento e della università di appartenenza) e/o la qualifica professionale; indirizzo (di abitazione e di ufficio), completo di codice postale e numero di telefono; numero di fax e/o recapito di posta elettronica.
Le opinioni espresse nei contributi pubblicati impegnano i soli Autori. La Direzione non assume alcuna responsabilità nemmeno per eventuali errori od omissioni nella correzione delle bozze o per smarrimento degli originali (che, comunque, non vengono restituiti agli Autori).
CoNDIzIoNI DI ABBoNAMENTo (3 numeri):Abbonamento annuoItalia € 114,00; Estero € 164,00; Digitale € 98,00Cartaceo + Digitale (Italia) € 136,00; Cartaceo + Digitale (Estero) € 185,00Fascicolo cartaceo€ 39,00 (iva inclusa, spedizione esclusa)Fascicolo digitale€ 34,00 (iva inclusa)
Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per cambio di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all’amministrazione presso la Casa editrice:
© STEM Mucchi Editore s.r.l.Via Emilia est, 1741 - 41122 - Modena. Tel. 059.37.40.94 - Fax 059.28.26.28e-mail: [email protected]; web: www.mucchieditore.it
L’abbonamento decorre dal 1 gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell’annata, com-presi quelli già pubblicati. Il pagamento deve essere effettuato direttamente all’editore sul c/c po-stale n. 11051414, a ricevimento fattura (valido solo per enti e società), mediante carta di credito (sottoscrivendo l’abbonamento on line all’indirizzo www.mucchieditore.it, oppure precisando numero, scadenza e data di nascita). Al fine di assicurare la continuità nell’invio dei fascicoli, gli abbonamenti si intendono rinnovati per l’anno successivo. La disdetta dell’abbonamento va ef-fettuata tramite raccomandata a/r alla sede della Casa editrice entro il 31 dicembre dell’annata in corso. I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, dietro rimessa dell’importo (prezzo di copertina del fascicolo in oggetto). Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell’anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l’acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della stessa rivista. Per l’acquisto di singoli fascicoli della rivista consultare il catalogo on line all’indirizzo www.mucchieditore.it. Il cliente ha la facoltà di rece-dere da eventuali ordini unicamente mediante l’invio di una lettera raccomandata a/r alla sede della Casa editrice, fax o e-mail (seguiti da una raccomandata a/r) entro le successive 48 ore atte a consentire l’identificazione del cliente e dell’ordine revocato (merce, data, luogo, etc.). La revoca dell’ordine deve essere spedita entro e non oltre il 10° giorno successivo alla data di sottoscrizione.
Indice n. 86 (1-2015)
Articoli e sAggiMarcello Clarich, Autorizzazioni e concessioni: presidi dell’interesse pubbli-co o barriere all’accesso al mercato? ������������������������������������������������������������ pag� 9
Filippo Salvia, La difficile coesistenza tra usi e tutela dell’ambiente costiero ��� » 23
Paola Piras, Il buon andamento nella pubblica amministrazione tra etica pubblica e corruzione: la novella del nemico immortale ������������������������������� » 35
Emiliano Frediani, Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile ��������� » 49
seZioNe Di Diritto iNterNAZioNAleUnione Europea �����������������������������������������������������������������������������������������Altre organizzazioni internazionali ��������������������������������������������������������������
»»
8187
Articoli e sAggiGiovanni Barozzi Reggiani, La Giurisprudenza amministrativa e l’evoluzio-ne del diritto antitrust italiano: il Caso Coop - Esselunga ���������������������������� » 91
Pasquale Pantalone, Città metropolitane e riordino degli enti di area vasta: forse è la volta buona? ���������������������������������������������������������������������������������� » 121
Stefano Vaccari, Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (ne-cessaria) tutela della riservatezza nel d�lgs� 33/2013 ������������������������������������� » 151
Note sUi collABorAtori �������������������������������������������������������������� » 179
«Il diritto dell’economia», vol. 28, n. 86 (1-2015), pp. 151-178
Articoli e Saggi
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza nel d.lgs. 33/2013*
Stefano Vaccari
Sommario: 1. Premessa. − 2. I limiti alla trasparenza contenuti nell’art. 4 del d.lgs. 33/2013. − 3. Problematiche aperte e possibili soluzioni. − 3.1. (Segue): la libera indicizzazione e rintracciabilità mediante motori di ricerca web dei dati personali pubblicati. − 3.2. (Segue): il (libero?) riutilizzo dei dati personali pubblicati. − 3.3. (Segue): questioni sulla durata della pubblicazione e sulla conservazione post scaden-za dei dati personali pubblicati. − 4. Conclusioni.
1. Premessa.
Il nuovo d.lgs. 33/20131 reca una serie di disposizioni per il riordi-no della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza2 e dif-
* Il presente lavoro rappresenta uno sviluppo dell’intervento svolto all’incontro del Grup-po San Martino dedicato al tema «La visibilità del potere. Gli obblighi di trasparenza tra pubblicità, accesso e open data», tenutosi il 10-12 aprile 2014 presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurispru-denza dell’Università degli studi di Palermo.
1 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-cità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», adottato dal governo sulla base della delega conferitagli dall’art. 1, commi 35 e 36, della l. 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pub-blica amministrazione» (c.d. «legge anticorruzione»).
2 Sulla differenza di significato tra i termini «pubblicità» e «trasparenza», spesso usati impro-priamente come endiadi o quali espressioni tra loro fungibili, si rimanda alle considerazioni di P. Marsocci, Gli obblighi di diffusione delle informazioni e il d.lgs. 33/2013 nell’interpretazione del modello costituzionale di amministrazione, in Istituzioni del federalismo, 2013, III/IV, 688 ss. In par-ticolare l’Autrice sottolinea come l’attività di «pubblicizzare» alluda ad un’operazione di tipo statico consistente nella mera esteriorizzazione di un complesso di conoscenze e di informazioni sulla base di obblighi di fonte legale. Viceversa, il concetto di «trasparenza» non è sinonimo della mera osten-sione al pubblico dei dati informativi, bensì consiste in un quid pluris, come momento dinami-
Stefano Vaccari152
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nell’inten-to, ben chiarito dall’art. 1 del decreto cit.3, di aumentare la c.d. «trasparen-
co, legato alla chiarezza, alla comprensibilità e all’intelligibilità delle informazioni precedentemen-te pubblicate. V’è dunque un rapporto da mezzo a fine, ove mezzo è la pubblicità la quale, quando possiede determinate caratteristiche che consentono la comprensibilità del dato, raggiunge il fine rappresentato dalla trasparenza. Nello stesso senso cfr. P. Canaparo, La via italiana alla trasparen-za pubblica: il diritto di informazione indifferenziato e il ruolo proattivo delle pubbliche amministra-zioni, in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 2014, IV, 42. Per completezza si riporta anche la chiara riflessione sul punto di G. Arena, M. Bombardelli, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa. Saggi ordinati in sistema, Napoli, 2006, 411: «La pubblicità è fondamen-tale, ma è solo il passaggio intermedio per uscire dal segreto e arrivare alla trasparenza. Il segreto è infatti non conoscibilità, non conoscenza e quindi non comprensione. La pubblicità è conoscibili-tà, ma non necessariamente conoscenza. La trasparenza è insieme conoscenza e comprensione. Una informazione pubblica è un’informazione conoscibile, ovvero è una potenziale fonte di conoscenza; ma affinché si abbia il passaggio dalla pubblicità alla trasparenza è necessario il passaggio dalla cono-scibilità alla conoscenza vera e propria, su cui può a sua volta fondarsi la comprensione. Pertanto assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa vuol dire assicurare la conoscenza reale, vera, di tale attività, quella che consente la comprensione e di conseguenza anche il controllo. Se l’attività è segreta non può essere conosciuta; se è pubblica, è conoscibile, ma non è detto sia anche conosciuta né che sia anche compresa. Solo quando si realizzano queste due ultime condizioni si ha veramente la trasparenza di quell’attività amministrativa e, dunque, la possibilità di un controllo sull’esercizio del potere che quell’attività comporta». Per un ulteriore approfondimento sul tema si rinvia al con-tributo di M. Occhiena, I principi di pubblicità e trasparenza, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi di diritto amministrativo, Milano, 2011, 143 ss.
3 Art. 1, comma 1, d.lgs. cit. Principio generale di trasparenza: «La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche ammi-nistrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istitu-zionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche». Per un breve excursus diacronico sullo sviluppo norma-tivo del principio di trasparenza all’interno del nostro ordinamento si deve partire, innanzitutto, dal-la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ove, seppur nella versione originaria veniva fatto richiamo al solo principio di pubblicità, con la riforma apportata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrati-va», viene fatta per la prima volta espressa menzione al principio di trasparenza all’interno dell’art. 1 che rubrica, per l’appunto, «Principi generali dell’attività amministrativa». Successivamente il princi-pio di trasparenza, dopo essere stato richiamato in numerose leggi settoriali, ha trovato un primo ten-tativo definitorio con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» (c.d. «Decreto Brunetta»). Ivi, infatti, all’art. 11 così viene definita la tra-sparenza: «La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pub-blicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risor-se per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valuta-zione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 153
za»4 amministrativa declinata come accessibilità totale delle informazioni inerenti all’organizzazione e all’attività degli apparati amministrativi da pubblicarsi sui siti istituzionali5 delle varie p.a. rientranti nell’ambito di applicazione del decreto6.
[…]». Tale definizione, ripresa poi dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzio-ne e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» (c.d. «legge anti-corruzione»), si ritrova ampliata nell’art. 1, cui supra, del d.lgs. oggetto di studio nel presente lavoro.
4 La bibliografia sulla c.d. «trasparenza amministrativa» è amplissima. Si rinvia, ex multis, a E. Carloni, L’amministrazione aperta. Regole, strumenti, limiti dell’open government, Rimini, 2014; A. Bonomo, Informazione e pubbliche amministrazioni. Dall’accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni, Bari, 2012; F. Manganaro, Evoluzione del principio di trasparenza amministrati-va, in AA. VV., Scritti in memoria di Roberto Marrama, Napoli, 2010, 3 ss.; E. Carloni, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa, in Dir. pubbl., 2009, III, 779 ss.; F. Merloni (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, 2008; G. Arena, Trasparenza amministrativa (voce), in S. Cassese (diretto da), Diz. dir. pubbl., vol. VI, Milano, 2006; G. Are-na, Trasparenza amministrativa (voce), in Enc. Giur. Treccani, XXXI, Roma, 1995, 1 ss; F. Cara-mazza, Dal principio di segretezza al principio di trasparenza: profili di una riforma, in Riv. trim. dir. pub., 1995, 941 ss.; R. Chieppa, La trasparenza come regola della pubblica amministrazione, in Dir. econ., 1994, 613 ss.; G. Arena, Trasparenza amministrativa e democrazia, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1992, XCVII-XCVIII, 25 ss.; G. Arena, La trasparenza amministrativa ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in G. Arena (a cura di), L’accesso ai documenti amministrativi, Bologna, 1991, 25 ss.; G. Abbamonte, La funzione amministrativa tra riservatezza e trasparenza. Introduzione al tema, in AA. VV., L’amministrazione pubblica tra riservatezza e traspa-renza. Atti del XXXV Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione – Varenna 1989, Milano, 1991, 13 ss.; R. Marrama, La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organiz-zazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 1989, 416 ss.; R. Villata, La traspa-renza dell’azione amministrativa, in Dir. proc. amm., 1987, V, 528 ss.
5 Art. 2, comma 2, d.lgs. cit. Oggetto: «Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati con-cernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazio-ne […]». Circa la crescente importanza dei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, qua-li canali privilegiati per la diffusione delle informazioni sulla gestione amministrativa e quale inter-faccia primaria con il cittadino, si vedano gli interventi legislativi aventi ad oggetto proprio le defi-nizioni strutturali e contenutistiche dei siti web delle p.a. In particolare, cfr. l. 9 gennaio 2004, n. 4, «Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ma, soprat-tutto, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale». Sui requisiti, normativa-mente indicati, cui deve corrispondere un sito istituzionale di un’amministrazione pubblica, si rin-via al testo dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 82/2005 (la cui rubrica è, per l’appunto, «Caratteristiche dei siti»): «Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte del-le persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità».
6 Art. 11, d.lgs. cit. Ambito soggettivo di applicazione: «Ai fini del presente decreto per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell’arti-
Stefano Vaccari154
Attraverso tale forma di attuazione della «visibilità del potere»7 e dell’ammi-
colo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione prov-vedono all’attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti».
7 Quest’idea di realizzo di una «total disclosure» circa un’ampia gamma di dati ed informazioni concernenti i più svariati profili della gestione della «cosa pubblica» trae spunto, quale modello di rife-rimento, dal sistema creato in terra statunitense dal «Freedom of information act» (c.d. «FOIA») del 4 luglio 1966 (e, in seguito, oggetto di numerosi emendamenti, tra cui il c.d. «Government in the Sunshi-ne Act» del 1976). Vd. sul punto, espliciter, la Relazione illustrativa al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ove, nel commento all’art. 3 del decreto (cui infra), si afferma che il modello d’ispirazio-ne è «[…] quello dei Freedom of Information Acts di derivazione statunitense, che garantisce l’accessi-bilità per chiunque lo richieda di qualsiasi documento o dato inerente all’attività di un’amministrazio-ne pubblica, con le sole eccezioni previste dalla legge». Il FOIA, nel suo nucleo essenziale, impone alle amministrazioni pubbliche una serie di regole concernenti l’accesso totale (o parziale) ai vari documen-ti classificati (visti come proprietà collettiva e del singolo che attraverso il diritto di accesso fa valere una posizione equiparabile ad un diritto reale su un bene di tipo immateriale) al fine di consentire a chiun-que la visione totale, e dunque la comprensione, sull’operato del Governo federale. Lo schema di origi-ne statunitense, ideato durante il mandato del presidente Lyndon B. Johnson, è stato via via esportato in numerosi altri Stati che hanno ritenuto di adeguare le proprie legislazioni a tale paradigma, essenzia-le per un sistema che intenda abbracciare politiche di «open government», al fine di incrementare il pro-prio livello di «accountability» e di democraticità nel rapporto con i governati. L’Italia, nella sua opera di creazione, a mezzo del decreto de qua, di un simil-modello ha, tuttavia, ideato un impianto che si potrebbe definire come «FOIA italiano» in quanto, seppur ispirandosi nell’humus culturale di sfondo, come detto supra, al FOIA statunitense, tuttavia diverge da quest’ultimo per un aspetto essenziale che denota un ribaltamento prospettico. Infatti, mentre nel FOIA originario il sistema è elaborato a parti-re dalla posizione giuridica soggettiva esprimibile come «diritto soggettivo alla conoscibilità» per farne derivare un diritto del cittadino alla visione del dato in possesso alle varie P.A. di tipo onnicompren-sivo (ovvero, un regime di accesso c.d. «open to all» riguardante qualsiasi informazione detenuta dal-le autorità pubbliche, interpretando l’eccezione di riservatezza, le c.d. «exceptions», in senso restrittivo con presunzione a favore della disclosure) nel sistema italiano, viceversa, la chiave di partenza è il dato legislativo che fonda specifici obblighi di ostensione di dati, informazioni e documenti sui siti istitu-zionali delle amministrazioni pubbliche fondando il diritto alla conoscenza che nasce, perciò, già limi-tato all’origine dal dato legislativo e, perciò, esiste ed è conseguentemente coercibile solo ove vi sia una disposizione normativa fondante un esplicito obbligo di pubblicazione (cfr., a supporto, il dato testua-le dell’art. 3, del d.lgs. 33/2013 ove si dispone che «[t]utti i documenti, le informazioni e i dati ogget-to di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7». Nonostante la divergenza dall’archetipo del FOIA statunitense, saluta con favore il nuovo impianto normativo R. Garofoli, Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190, il decreto trasparenza e le politiche necessarie, in www.giustizia-amministrativa.it, 2013, par. 3.1., affermando che «[p]ure non trattandosi di un sistema normativo riconducibile al Freedom of information act statunitense, si è al cospetto di un sistema fortemente innovativo, in grado di “costringere” le amministrazione ad assicurare la pubblicità che la legge prescrive». Sottolinea, invece, le diversità strutturali tra il sistema FOIA e l’impianto di cui al d.lgs. 33/2013 E. Carloni, L’amministrazione aperta…, op. cit., 256. L’Autore, ivi, afferma che «[n]el sistema del freedom of information, vi è un canale di comunicazione tra diritto di accesso e pubblicità,
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 155
nistrazione aperta si cerca di perseguire lo scopo di promuovere la partecipazio-ne e la «demarchia»8 dei cittadini nell’ottica di favorire forme diffuse di control-lo9 sull’esercizio delle funzioni istituzionali e sulle modalità di utilizzo delle risor-se pubbliche, facendo acquisire alla trasparenza un carattere di servizio10 rispetto
che consente anche di valorizzare dinamiche bottom up (dal basso): i dati più frequentemente oggetto di richieste di accesso ai sensi del Foia vengono pubblicati in apposite “reading rooms”(on line, in base al Foia). Nel sistema italiano, “bipolare”, accesso ai documenti e accessibilità totale sono in un rappor-to di incomunicabilità, e le dinamiche di pubblicazione sono rimesse unicamente a scelte del legisla-tore, con un processo top down». Sul sistema FOIA statunitense si rimanda, in dottrina, quantomeno al saggio di E. Carloni, La qualità delle informazioni diffuse dalle amministrazioni negli Stati Uniti, in Giorn. dir. amm., 2002, 1232 ss., nonché al contributo di G. Arena, La “Legge sul diritto alla informa-zione” e la pubblicità degli atti dell’Amministrazione negli Stati Uniti, in Pol. dir., 1978, 279. Vd. anche, per completezza, l’indagine comparatistica sui vari modelli (svedese, americano, inglese, francese, spa-gnolo, tedesco) di diffusione dell’informazione amministrativa contenuta nello studio monografico di A. Bonomo, Informazione e pubbliche amministrazioni…, op. cit., in part. 83 ss.
8 Il concetto di «demarchia» o «democrazia partecipativa» allude ad un modello di ammini-strazione paritaria e condivisa con il cittadino al quale, nell’esercizio della funzione amministrativa, viene conferito il ruolo di co-amministrante dotato di posizioni di libertà attiva nei confronti del-la p.a. detentrice del potere d’impero con la quale dialoga all’interno di un mutato rapporto con i pubblici poteri caratterizzato in senso collaborativo più che conflittuale. Per una lettura di questo «nuovo» rapporto tra amministrazione pubblica, cittadini e società si vedano, tra tutti, F. Benvenu-ti, Disegno della Amministrazione Italiana. Linee positive e prospettive, Padova, 1996; F. Benvenuti, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994; F. Benvenuti, Per un diritto amministrativo paritario, in AA.VV., Studi in memoria di Enrico Guicciardi, Padova, 1975; F. Sait-ta, Il procedimento amministrativo «paritario» nel pensiero di Feliciano Benvenuti, in Amministrare, 2011, 457 ss.; U. Allegretti, L’amministrazione dall’attuazione costituzionale alla democrazia par-tecipativa, Milano, 2009; G. Pastori, Feliciano Benvenuti e il diritto amministrativo del nuovo seco-lo, in Jus, II-III, 2008, 323 ss.; F. Merusi, Diritti fondamentali e amministrazione (o della «demar-chia» secondo Feliciano Benvenuti), in Dir. amm., 2006, 543 ss.; U. Allegretti, Amministrazione pubblica e Costituzione, Padova, 1996; G. Berti, La responsabilità pubblica, Padova, 1994; G. Are-na, Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi parlamentari, 1997, 29 ss.
9 Con ciò superando il tradizionale limite del diritto di accesso come configurato dall’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella versione modificata dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, laddove prevede che «[n]on sono ammissibili istanze di accesso preordi-nate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni». Si potrebbe dire, con espressioni mutuate dalle teorizzazioni di F. Merloni, Trasparenza delle istituzioni e principio democratico, in F. Merloni (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, 2008, 9 ss., che si sta assistendo al passaggio da un tipo di accesso soggettivamente delimitato, c.d. «erga partes», ad uno di tipo «potenzialmente generale» o «erga omnes». Tuttavia, la nuova possibilità di un controllo sui dati, informazioni e documenti messi a disposizione dalle amministrazioni di tipo diretto, este-so, immediato e anche, in alcuni casi, spinto da motivazioni di mera curiosità, può ingenerare alcu-ne problematiche, in particolare certi profili di attrito con alcune posizioni di riservatezza dei citta-dini i cui dati sensibili possono essere coinvolti nelle pubblicazioni soggette ad obbligo nel nuovo decreto. Sul punto, amplius, cfr. i paragrafi successivi del presente lavoro.
10 Circa il volto «finalistico» e «servente» che la trasparenza sembra oggi assumere, in parti-colare nel decreto cit., si veda F. Patroni Griffi, La trasparenza della pubblica amministrazione tra
Stefano Vaccari156
a principi e finalità primarie dell’ordinamento (si veda il comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 33/201311) quali il principio democratico12, l’imparzialità, il buon anda-
accessibilità totale e riservatezza, in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 2013, VIII, 2. Interessante la sottolineatura di una duplice declinazione che il principio di trasparenza sembra assumere all’interno dell’impianto normativo delineato dal d.lgs. 33/2013 operata da M. Bombardelli, Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza, in Istituzioni del federalismo, III-IV, 2013, 657 ss. L’Autore mostra come da un lato gli obblighi di pubblicazione imposti dal decreto fungano da argine e presidio garantistico contro ogni rischio di corruzione e di «maladministration» contribuendo ad alimentare, dunque, una forma di «sospetto» verso l’amministrazione; dall’altro lato gli stessi obblighi sono serventi ad un’apertura dell’amministrazione verso il cittadino nell’ottica dell’incremento partecipativo, della realizzazio-ne dei bisogni della collettività e di una rinnovata fiducia della cittadinanza con le istituzioni. Così, infatti, chiaramente l’Autore, in op. cit., pag. 661 ss.: «Da queste previsioni emerge molto nitida la declinazione duplice del principio […]. È evidente infatti come la trasparenza venga innanzitut-to riferita agli importanti obiettivi del contrasto della corruzione e della valutazione dei dipenden-ti pubblici, confermando in questo senso l’impostazione adottata dall’art. 11 del d.lgs. 150/2009 e dall’art. 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 835. Ma queste non sono le uniche finalità attribuite alla trasparenza, perché la stessa viene poi ricondotta anche al piano dell’amministrazione attiva, come principio rivolto a migliorare il rapporto fra amministrazione e cittadini, a porre le basi per un dia-logo più consapevole fra essi e a creare quindi le condizioni per una partecipazione più significati-va, idonea a realizzare un’amministrazione al contempo più efficiente ed efficace nel raggiungere i risultati che le sono richiesti e più aperta e più capace di coinvolgere le risorse partecipative del-la società nella soluzione dei problemi di interesse generale». Sulla c.d. «maladministration», quale uno dei due versanti cui pare orientata la normativa in questione (si ricordi che il d.lgs. 33/2013 è stato attuato in attuazione della delega contenuta nella c.d. «legge anti-corruzione»), cfr. V. Cerul-li Irelli, Etica pubblica e disciplina delle funzioni amministrative, in F. Merloni, L. Vandelli (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Firenze, 2010, 92 ss.; L. Van-delli (a cura di), Etica pubblica e buona amministrazione. Quale ruolo per i controlli?, Milano, 2009; B.G. Mattarella, Le regole dell’onestà. Etica, politica, amministrazione, Bologna, 2007; S. Casse-se, «Maladministration» e rimedi, in Foro it., 1996, VI, 243 ss.; M. D’Alberti, R. Finocchi (a cura di), Corruzione e sistema istituzionale, Bologna, 1994.
11 Art. 1, comma 2, d.lgs. cit.: «La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino».
12 Circa il rapporto tra funzione informativa e controllo democratico, il richiamo va agli stu-di di G. Arena, Trasparenza amministrativa e democrazia, in G. Berti, G.C. de Martin (a cura di), Gli istituti di democrazia amministrativa, Milano, 1996, 17 ss.; G. Arena, Le diverse finalità della trasparenza amministrativa, in F. Merloni (a cura di), La trasparenza amministrativa, Mila-no, 2008, 29 ss. Da ultimo, per un’approfondita analisi delle varie teorie e dei principi costituzio-nali sottesi al paradigma della c.d. «amministrazione aperta» vd. E. Carloni, L’amministrazione aperta…, op. cit., 43 ss.
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 157
mento, l’efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, la responsabilità e l’integrità e la lealtà nel servizio alla nazione.
Tuttavia, tutti i nuovi obblighi di pubblicazione sui siti internet istituziona-li di documenti, informazioni e dati, così come previsti dai vari capi del decreto cit.13, i quali concernono ogni settore e ambito dell’organizzazione e dell’attivi-tà delle pubbliche amministrazioni, non hanno condotto ad un’assolutizzazione14
13 Si elencano, per completezza descrittiva e per una miglior comprensione delle categorie generali soggette ad obblighi pubblicitari, i vari capi del decreto, comprendenti a loro volta dispo-sizioni minuziose e di dettaglio, in cui si sotto-articola il testo normativo: obblighi di pubblicazio-ne concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni (capo II), obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche (capo III), obblighi di pubblicazione in set-tori speciali (capo IV). Per un’esegesi e un commento analitico dei vari articoli del decreto, cfr. B. Ponti (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Rimini, 2013.
14 A favore di un corretto bilanciamento tra esigenze di trasparenza, da un lato, ed esigenze di riservatezza, dall’altro (contro ogni tentativo di assolutizzazione di tipo monodirezionale del solo valore di trasparenza) si era già espresso, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, il Garante per la protezione dei dati personali. Quest’ultimo, infatti, nella Relazione annuale del 2009, del 30 giugno 2010, aveva affermato che «[s]i tratta di un principio (aggiungiamo: quello di trasparenza) finalizzato a rovesciare il tradizionale rapporto tra amministrazione e cittadini, finora caratterizzato dalla separatezza e dal segreto, solo moderatamente corretti dal diritto di accesso agli atti e dalla par-tecipazione ai procedimenti. […] Per la sua ampiezza e pervasività tale principio si pone in naturale tensione con quello della riservatezza e mette in discussione alcuni cardini della protezione dei dati: lo stretto collegamento tra la finalità che si persegue con la diffusione del dato; l’individuazione di chi abbia diritto a conoscerlo; per quanto tempo debba essere diffuso; quando debba essere cancel-lato. Tutti aspetti che perdono efficacia di fronte a una trasparenza considerata una finalità in sé. È evidente peraltro che non è possibile affermare a cuor leggero che l’amministrazione debba mettere on line tutte le informazioni di cui è in possesso, o che per ogni tipo di informazione debbano vale-re le stesse regole. In questo modo si renderebbe concreto il rischio di un controllo globale di tutti su tutti. Il risultato sarebbe una società nella quale non vi è più riservatezza alcuna e ciascuno, solo perché è entrato in rapporto con la Pubblica Amministrazione, deve accettare la conoscibilità tota-le delle informazioni che lo riguardano. Non vi sarebbe più difesa alcuna dei dati sensibili, né dife-sa possibile della dignità di chi ha chiesto e ricevuto un sussidio, un sostegno alla sua disabilità, una risposta a uno stato di necessità o il riconoscimento di un titolo preferenziale legato alle sue condi-zioni economiche, sociali, di salute. Una società mostruosa, quella casa di vetro che è stata sempre il sogno di ogni dittatura e di ogni concezione basata sul totale prevalere dell’interesse della collettività rispetto ad ogni spazio di libertà e di autonomia del singolo. Un incubo, destinato a diventare anco-ra più orrido se non si mettesse alcun limite all’accessibilità ai dati messi in rete da parte dei moto-ri di ricerca. Questi, infatti, li decontestualizzano dai siti delle amministrazioni facendoli diventa-re parti di biografie artificiali e spesso artificiose, costruite sulla base di criteri ignoti ai più». Nello stesso senso, vd. anche le successive Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011, ove si osserva che «[a] fronte della messa a disposizione on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l’albo pretorio on line), occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il rispetto dei principi di quali-tà ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line. Va tenuto presente,
Stefano Vaccari158
del principio di trasparenza, in quanto lo stesso decreto legislativo, tra le disposi-zioni in tema di principi generali, dopo aver enunciato la finalità primaria e l’og-getto del decreto anzidetti (cfr. artt. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013), pone una serie di limiti al fine di tener conto di altri principi di rango primario che devono essere bilanciati ed equilibrati con la trasparenza, in particolare nell’intento di fornire un’adeguata protezione ai dati personali che possono essere inclusi in tutti quegli atti soggetti a pubblicazione ex lege in base alla nuova normativa15.
Ci si riferisce all’importante disposizione generale, contenuta nel capo del decreto dedicato ai principi generali (Capo I) e, pertanto, valevole per l’intero articolato del testo normativo, di cui all’art. 4, che reca come rubrica, per l’ap-punto, «limiti alla trasparenza».
In tale articolo il legislatore delegato ha cercato di compiere un ragionevole contemperamento tra valori di rango costituzionale, tra il favor per la trasparen-za (nella sua accezione di «openness» dell’amministrazione alla visibilità completa del suo operato e alla sua strutturazione come «casa di vetro»16) e la garanzia della riservatezza e della protezione dei dati personali.
La fissazione di limiti normativi a presidio di certe sfere inviolabili della per-sona umana è stata pensata proprio in quanto ben chiara risulta al Governo l’e-levata mole di rischi che possono verificarsi nel caso di diffusione via web, come previsto in più disposizioni del decreto citato, di dati personali: modalità questa
inoltre, che la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano ulteriormente quando la diffu-sione dei dati e la loro messa a disposizione avvenga on line». Contra, in particolare sotto il partico-lare profilo del carattere di «alibi» e di ostacolo alla trasparenza che il limite della riservatezza tende ad assumere in alcuni casi, cfr. E. Carloni, L’amministrazione aperta…, op. cit., 96.
15 Per un’analisi, in chiave generale, dei limiti (in particolare, le esigenze di segreto e di riser-vatezza) che incontra il principio di «trasparenza» nella sua implementazione all’interno dell’ordi-namento, con considerazione dei principali argomenti contro il c.d. «open government», cfr. E. Car-loni, L’amministrazione aperta…, op. cit., 77 ss. L’Autore, infatti, in chiave critica sottolinea come l’apertura del sistema a condizioni di conoscibilità dell’azione dei pubblici poteri si scontra con una serie di limiti che giustificano la permanenza di «aree di opacità» sulla base di confini che, in alcuni casi appaiono come giustificati, in altri, invece, nascondono un loro utilizzo di tipo «strumentale» funzionale ad ingiustificate esigenze di riserbo che, per tale via, ribaltano lo schema logico tra tra-sparenza (regola) e riservatezza/segreto (eccezione).
16 Ci si riferisce alla celebre espressione coniata, per esemplificare il concetto di trasparen-za che dovrebbe informare l’agire delle p.a. (in luogo della passata segretezza) da F. Turati. In part., «Atti del Parlamento italiano», Camera dei deputati, sessione 1904-1908, n. 22962, 17 giu-gno 1908, ove l’Onorevole espresse tale metafora con le seguenti parole: «Dove un superiore, pub-blico interesse non imponga un segreto momentaneo, la casa dell’amministrazione dovrebbe esse-re di vetro […]».
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 159
che, come noto, rappresenta la forma più invasiva per la diffusione di dati riguar-danti la sfera privata e personale delle persone.
2. I limiti alla trasparenza contenuti nell’art. 4 del d.lgs. 33/2013.
Per meglio comprendere le disposizioni dell’art. 4 del d.lgs. 33/2013, occor-re tuttavia primariamente considerare come il legislatore abbia inteso effettua-re una «summa divisio» tra due differenti modalità di pubblicazione di dati: una obbligatoria ed una facoltativa.
Quanto alla prima, alla pubblicazione c.d. obbligatoria, si prevede al primo comma dell’art. 4 cit.17 che, ove vi siano obblighi di pubblicazione (di fonte lega-le o regolamentare)18 inerenti a dati personali, quest’ultimi comportano la diffu-sione dei dati stessi sui siti internet istituzionali delle p.a. ed il loro trattamento secondo modalità che ne consentano l’indicizzazione e la rintracciabilità trami-te motori di ricerca web unitamente al loro possibile riutilizzo disponendo, per quest’ultimo, tanto un espresso rinvio all’art. 7 del d.lgs. 33/2013 (disposizione appositamente dedicata al tema del riutilizzo dei dati, cui infra), quanto il rispet-to dei principi in materia di trattamento dei dati personali.
In un’ottica garantista, inoltre, tale primo comma dell’art. 4 esclude espres-samente dagli anzidetti obblighi di pubblicazione e di libero riutilizzo (visti dal decreto come strumento operativo per declinare in concreto il valore della traspa-
17 Art. 4, comma 1, d.lgs. cit. Limiti alla trasparenza: «Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consen-tono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali».
18 Tali obblighi normativi di pubblicazione corrispondono, nella visione di F. Merloni, La funzione di informazione pubblica nella società dell’informazione, in F. Merloni (a cura di), L’infor-mazione delle pubbliche amministrazioni, Rimini, 2002, 69 ss. al versante c.d. «interventista» e atti-vo della funzione amministrativa di informazione, al cui opposto si situa, viceversa, la posizione c.d. «astensionista» ove l’amministrazione si situa sul versante passivo di un’eventuale richiesta di acces-so. In linea con questa visione, A. Bonomo, Il Codice della trasparenza e il nuovo regime di cono-scibilità dei dati pubblici, in Istituzioni del federalismo, III-IV 2013, 727, vede il realizzarsi, a mez-zo del cambio prospettico attivato dal d.lgs. 33/2013, del passaggio da un regime di «accessibilità» dei dati pubblici (non pubblicati ma acquisibili a richiesta dell’interessato che trae legittimazione da un diritto di accesso a «titolarità ristretta») ad un regime di «disponibilità» ove i dati in possesso delle varie p.a. debbono ex ante essere messi a disposizione della collettività a prescindere da espli-cite iniziative del cittadino (salvo il versante patologico dell’inottemperanza agli obblighi normati-vi di pubblicazione). Sull’argomento vd. anche A. Bonomo, Informazione e pubbliche amministra-zioni…, op. cit.
Stefano Vaccari160
renza) i dati personali di tipo sensibile e giudiziario19 così come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del d.lgs. 196/2003 (c.d. «Codice della privacy»)20.
Pertanto, si può dire che il legislatore preveda, in base alla citata esclusio-ne espressa contenuta nell’art. 4, comma 1 (il quale a sua volta rinvia alle defi-nizioni del Codice della privacy), una preclusione tout court alla pubblicazione e alla diffusione generalizzata sui siti web delle p.a. dei dati personali qualificabi-li come sensibili e giudiziari, secondo le nuove modalità di «openness» e di «open data» previste dal d.lgs. 33/2013 che consentono il libero accesso a chiunque sen-za previa identificazione, senza lasciare quindi margine alcuno di discrezionalità alle amministrazioni che si troveranno ad adempiere agli obblighi di pubblicazio-ne discendenti dal decreto, ritenendo ex se sproporzionata un’ostensione di tale specie di dati rispetto alla primaria finalità di trasparenza cui è improntata la nor-mativa che si sta analizzando.
Viceversa, per quanto attiene alla generalità dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, si ridefinisce l’equilibrio tra trasparenza e tutela del-la privacy con uno spiccato favor per la prima, in quanto si consente la diffusio-ne degli stessi in formato di tipo aperto21, la loro possibile rintracciabilità a mezzo
19 Per quanto attiene, in particolare, ai dati c.d. super-sensibili, vi è un’ulteriore esplicita pre-sa in considerazione di essi da parte del comma 6 dell’art. 4 del decreto cit. ove si mantengono fermi i limiti relativi alla diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
20 D.lgs. 30 giugno 2003, n.196. Codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 4, comma 1: «[…] d) – dati sensibili – i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sin-dacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) – dati giudiziari – i dati per-sonali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzio-ni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale […]».
21 Art. 7, comma 1, d.lgs. 33/2013. Dati aperti e riutilizzo: «I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 […]». Per dati pubblicati in formato aperto s’intende, ai sensi di quanto disposto dall’art. 68, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, una forma di pubblicazione on line di dati che pre-senti le seguenti caratteristiche: «[…] a) un formato di dati reso pubblico, documentato esaustiva-mente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termi-ni di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comu-nicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lette-ra a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 161
di ogni motore di ricerca web e il loro ampio e (quasi) libero riutilizzo, attraverso l’eliminazione di ogni barriera protettiva di tipo preventivo mantenendo fermi, tuttavia, come è stato osservato22, tutti i meccanismi di tutela di tipo c.d. succes-sivo onde reprimere ogni forma di abuso che ne possa seguire.
Tuttavia, si deve sin da subito rilevare come, in accoglimento delle osser-vazioni del «Garante per la protezione dei dati personali» (di seguito, breviter, anche «Garante della privacy») rese sullo schema di decreto23, nella versione fina-
e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private […]». Sul duplice sco-po perseguito dal legislatore attraverso la previsione di una pubblicazione sui siti istituzionali delle varie p.a. dei dati, documenti e informazioni in formato «open data» si veda quanto sostenuto da P. Canaparo, La via italiana alla trasparenza pubblica…, op. cit., 41. L’Autore, ivi, ritiene che il legi-slatore, attraverso l’opzione normativa per tale formato di pubblicazione di tipo aperto, da un lato cerchi di garantire la c.d. «interoperabilità», ovvero una permanenza temporale nel lungo periodo di accesso ai dati senza problematiche legate a caratteristiche tecniche e/o di privativa legale; dall’altro lato tenti un percorso pro-concorrenziale connesso al riutilizzo delle informazioni pubblicate sen-za che vi sia un unico detentore del controllo su di esse con poteri inibitori verso altri possibili uti-lizzatori. Sull’importanza della scelta legislativa di applicare il regime degli «open data» al comples-so informativo da pubblicarsi sui siti istituzionali delle varie amministrazione vd. anche B. Ponti, Il codice della trasparenza amministrativa…, op. cit. Tale opzione per il regime degli «open data», ad avviso dell’Autore, «[…] consolida un nucleo “duro”, non comprimibile, di informazioni dif-fuse e rese disponibili in formato aperto, contribuendo così in modo significativo alla diffusione di questo approccio culturale (prima ancora che tecnologico o giuridico), anche semplicemente per-ché costringe tutte le amministrazioni a fare i conti con questo “paradigma” (nella necessità di dare applicazione alla previsione normativa). Inoltre, proietta la stessa trasparenza amministrativa verso un nuovo paradigma, nel quale quest’ultima non è sempre, e solo, “prodotta” dalle amministrazio-ni (e direttamente fruita dai cittadini), ma sempre di più va configurandosi come frutto della elabo-razione delle informazioni e dei dati resi disponibili dalle p.a., posta in essere da soggetti terzi (asso-ciazioni non profit, istituzioni di ricerca, media, gli stessi partiti e movimenti politici, etc.), che si pongo come mediatori della trasparenza tra istituzioni e cittadini».
22 Ci si riferisce a B. Ponti, Il codice della trasparenza amministrativa: non solo riordino, ma ridefinizione complessiva del regime della trasparenza amministrativa on-line, in www.neldiritto.it, 2, ove si afferma che l’aver rimodulato l’equilibrio con la tutela della riservatezza/privacy «[…] non significa che per i dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) oggetto di pubblicazione obbligatoria venga meno ogni forma di tutela. La ridefinizione dell’equilibrio consiste nella circo-stanza che perdono peso, ma solo per questi dati, i meccanismi di tutela preventiva, mentre resta-no immutati (e pienamente applicabili) i meccanismi di tutela successiva (a protezione dagli abusi eventualmente perpetrati nell’utilizzo dei dati diffusi). Un riequilibrio che corrisponde alla volontà di rendere più facilmente accessibili, fruibili e riutilizzabili i dati rilevanti (che l’ordinamento giudi-ca rilevanti, facendone oggetto di pubblicazione obbligatoria) ai fini della trasparenza».
23 Garante per la protezione dei dati personali, «Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a.», n. 49/2013, parte I, punto n. 2: «Il diritto alla prote-zione dei dati personali trova il suo pieno ed effettivo riconoscimento solo se sono rispettati tutti i principi e le regole alla base delle garanzie previste dalla normativa comunitaria e dal Codice a tutela dell'individuo, della sua riservatezza e della sua dignità. Fra questi assumono particolare importan-za il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi infor-
Stefano Vaccari162
le dell’art. 4 vi sia stato un innesto di un comma ulteriore, dedicato sempre ai casi di pubblicazione c.d. obbligatoria, che sembra aprire una breccia garantista e contrastare, in chiave di bilanciamento, quanto appena detto circa la totale aper-tura preventiva ai dati personali da pubblicare obbligatoriamente sui siti web isti-tuzionali.
Ci si riferisce al comma 4 dello stesso art. 4 del d.lgs. 33/201324, ove, al fine di assicurare un maggior rispetto da parte dell’intero impianto normativo dei principi comunitari e nazionali in materia di tutela della privacy, si dispone che, anche ove norme di legge o di regolamento stabiliscano obblighi di pubblicazione di dati e documenti, le p.a. debbano provvedere a non rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari25, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
Il rispetto dei suddetti principi di pertinenza e d’indispensabilità, che sem-brano richiamare surrettiziamente le disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 lett. d) del Codice della privacy26, è stato inserito al fine apposito di ridurre al minimo l’uti-lizzo dei dati personali e far sì che questo utilizzo, ove consentito, non risulti in
mativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice), il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali e quello di indispensabilità del trattamento di dati sensibili e giudiziari, tutti di derivazione comunitaria (artt. 3, 11, comma 1, lett. d), e 22, comma 3, del Codice; art. 6 direttiva 96/45/CE). Tali principi devono trovare appli-cazione anche in presenza di norme di legge e di regolamento che impongano la pubblicazione di atti o documenti. In tal caso, deve essere rimessa alla cura dell’amministrazione la selezione, all’in-terno dell’atto o documento in via di pubblicazione, dei dati personali da oscurare o comunque da espungere. […] Lo schema di decreto sembra tener conto di tali esigenze (art. 4, comma 4), ma con una formulazione che lascia qualche dubbio interpretativo circa la obbligatorietà della selezio-ne preventiva dei dati personali da sottrarre alla pubblicazione. Si ritiene necessario, pertanto, inte-grare il medesimo articolo 4 con una disposizione che richiami l’applicazione doverosa dei predetti principi nei termini appena descritti […]».
24 Art. 4, comma 4, d.lgs. cit.: «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelli-gibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle spe-cifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».
25 Con riguardo al richiamo specifico, ivi presente, ai dati personali sensibili e giudiziari si può, forse, mostrare una contraddizione testuale rispetto alla preclusione anzidetta di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. cit., ove viene già eccettuata espressamente (e in via generalizzata) quest’ulti-ma species di dati personali dagli obblighi di pubblicazione e diffusione sui siti web delle p.a., senza che si debba effettuare previamente alcuna valutazione di pertinenza e/o indispensabilità circa l’o-stensione di tali dati.
26 Art. 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Principio di necessità nel trattamento dei dati: «I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità per-seguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od oppor-tune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità».
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 163
eccedenza rispetto alle finalità della raccolta e del trattamento dei dati, il tutto in linea con un più generale principio di proporzionalità che sembra dover governa-re ogni ipotesi di trattamento dei dati personali.
Pertanto, le amministrazioni, nel momento in cui si attiveranno per dare applicazione concreta ai nuovi obblighi di pubblicazione inseriti nel d.lgs. 33/2013, si troveranno a dover tenere in debita considerazione, per effetto del combinato disposto tra l’art. 4, primo comma, e il successivo comma 4 dello stes-so articolo, tanto l’obbligo di pubblicazione dei dati personali e il connesso favor per la trasparenza (comma 1), quanto il rispetto dei suddetti principi di pertinen-za, non eccedenza e indispensabilità (comma 4), ovvero a realizzare una pondera-zione a carattere discrezionale nel momento in cui ci si accosta alla selezione dei dati da pubblicare o, viceversa, da espungere ed oscurare al fine di realizzare un equo contemperamento tra principi di pari importanza quali quello di trasparen-za dell’azione amministrativa e quello di tutela della privacy degli individui.
Quanto al secondo tipo di pubblicazione prevista dall’art. 4 del d.lgs. 33/2013, ovvero quella qualificabile come «facoltativa», ravvisabile nel com-ma 3 del predetto articolo27, si può notare come il decreto abbia facoltizzato le pubbliche amministrazioni a disporre (nei propri siti istituzionali) pubblicazioni aggiuntive, cioè ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione ex lege obbli-gatoria (quelle appena analizzate più sopra trattando del primo comma dello stes-so articolo), obbligandole, al contempo, all’oscuramento mediante anonimizza-zione di ogni dato personale ivi contenuto.
Mediante una formulazione di tal fatta, perciò, non si lascia residuare, in capo alle amministrazioni, alcun margine di discrezionalità circa la valutazione di pertinenza, o meno, dei dati personali presenti negli atti o documenti, che s’in-tendono pubblicare in via aggiuntiva, rispetto alla finalità di trasparenza (come nel caso della pubblicazione c.d. «obbligatoria») ma, viceversa, si vieta ipso iure ogni ostensione di quest’ultimi.
Tale scelta di anonimizzazione completa dei dati personali nei casi di pub-blicazione facoltativa, rispondente sicuramente ad un’attenzione forte per la pro-tezione delle sfere di riservatezza dei cittadini, è stata inserita dal Governo, nel testo finale del decreto, in accoglimento delle osservazioni esposte dal Garante
Art. 11, d.lgs. cit. Modalità di trattamento e requisiti dei dati: «I dati personali oggetto di trattamento sono: […] lett. d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati».
27 Art. 4, comma 3, d.lgs. 33/2013: «Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pub-blicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamen-to, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, proceden-do alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti».
Stefano Vaccari164
della privacy nel parere reso sullo schema di atto normativo28, nel quale è stata for-temente ribadita la necessità di una previsione di obbligo, e non (come differente-mente disposto nella proposta iniziale) di mera facoltatività, di anonimizzazione di ogni dato personale presente in questa specie di pubblicazione avente carattere libero, id est, rimesso a scelta discrezionale delle singole amministrazioni.
Infatti, qualora un tale oscuramento dei dati personali pubblicati secon-do libera scelta di ogni p.a. non fosse stata imposta dal legislatore, bensì rimes-sa alla discrezionalità delle varie amministrazioni, ne sarebbe derivata conseguen-zialmente, secondo il Garante per la protezione dei dati personali, una protezio-ne dei dati personali affetta da possibile disomogeneità, risultato sicuramente non auspicabile in una visione di uniforme protezione dei diritti individuali su tutto il territorio nazionale: il che rende, sicuramente, maggiormente coerente con l’ordi-namento e il sistema di protezione dei dati personali l’opzione normativa da ulti-mo positivizzata nel d.lgs. 33/2013.
3. Problematiche aperte e possibili soluzioni.
La normativa contenuta nel nuovo d.lgs. 33/2013, nonostante tutto il siste-ma appena descritto di limiti alla trasparenza, così come escogitato dal legislatore attraverso le disposizioni contenute nell’art. 4, sembra, tuttavia, lasciar residua-re una serie di previsioni che appaiono fonte di rischi, nel senso di una maggior possibilità di recare un grave vulnus alla riservatezza e alla protezione dei dati per-sonali dei cittadini, e che debbono, perciò, essere analizzate e valutate al fine di comprendere se sia possibile, in via interpretativa, una loro riconduzione a siste-
28 Garante per la protezione dei dati personali, «Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a.», n. 49/2013, parte I, punto n.1: «Al riguardo, lo stes-so articolo 4, comma 3, prevede che la pubblicazione di informazioni che le pubbliche ammini-strazioni non hanno l’obbligo di pubblicare avvenga – anche ricorrendo a forme di anonimizzazio-ne in presenza di dati personali. La formulazione della norma suscita tuttavia perplessità in quan-to sembra costituire un’autorizzazione permanente alla diffusione da parte di un soggetto pubblico di dati personali anche in assenza della previsione legislativa o regolamentare di cui all’articolo 19, comma 3, del Codice. Pertanto, la norma in questione deve essere modificata prevedendo la salva-guardia della predetta disposizione e prescrivendo come necessaria, e non meramente facoltativa, l’anonimizzazione in presenza di dati personali. Il comma 3 dell’articolo 4 potrebbe, pertanto, esse-re sostituito dal seguente: – Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblica-re ai sensi del presente decreto, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giu-gno 2003, n. 196».
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 165
ma, oppure se tale sforzo esegetico lasci spazio, unicamente, a prospettive di rifor-ma de jure condendo.
Il riferimento va, in particolare, a tre aspetti: alla previsione sulla libera indi-cizzazione e rintracciabilità mediante motori di ricerca dei dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria, alla possibilità di un loro libero riutilizzo e, infine, all’ambigua disciplina sulla durata delle pubblicazioni.
3.1. (Segue): la libera indicizzazione e rintracciabilità mediante motori di ricerca web dei dati personali pubblicati.
Procedendo per ordine, va considerato primariamente che l’art. 4, comma primo, del d.lgs. 33/201329, nel disporre che il trattamento dei dati personali sog-getti ad obblighi di pubblicazione avvenga secondo modalità che ne consentano l’indicizzazione e la rintracciabilità mediante i motori di ricerca web30, rischia di cagionare, per tale via, una forte decontestualizzazione di questi dati, una volta che siano stati estrapolati dai siti istituzionali delle amministrazioni e riordinati secondo criteri non conoscibili ex ante dall’utenza, con apparente contrasto, dun-que, rispetto al principio, ribadito fortemente anche in ambito sovranazionale31,
29 Art. 4, comma 1, d.lgs. 33/2013: «[…] nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web […]».
30 Tra l’altro, ai sensi del comma 9 del d.lgs. 33/2013, senza che le amministrazioni coinvol-te possano «[…] disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”».
31 La materia della protezione dei dati personali è stata oggetto di particolare attenzione in ambito sovranazionale, in particolare nella giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte di Giu-stizia dell’Unione Europea. Si osserva che, nel contesto C.E.D.U., la protezione dei dati personali viene collegata alla disposizione dell’art. 8 dedicata al diritto al rispetto della vita privata e familia-re da interpretarsi, tuttavia, in combinato disposto con la Convenzione del Consiglio d’Europa n. 108 del 28 gennaio 1981 (ideata dal Consiglio d’Europa in un momento iniziale quando si ritene-va insufficiente, per la finalità di tutela in analisi, il solo art. 8 C.E.D.U.) sulla «[…] protezione del-le persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale». Sulla stretta relazio-ne sussistente tra art. 8 C.E.D.U. e tutela dei dati personali cfr., ex multis, Corte E.D.U., Leander c. Svezia del 26 marzo 1987; Z. c. Finlandia del 25 febbraio 1997; Amman c. Svezia del 16 febbra-io 2000. Per un’analisi dei principali orientamenti, in tema di protezione dei dati personali, emer-si nella giurisprudenza della Corte E.D.U. si rinvia, quantomeno, a S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, in part. 315 ss. Con riferimento, invece, al versante del dirit-to comunitario (oggi: diritto dell’Unione Europea), il percorso di evoluzione progressiva da una c.d. timida «data protection» ad un compiuto diritto fondamentale alla protezione dei dati perso-nali prende l’avvio da una serie di direttive originate da esigenze di armonizzazione delle differenti discipline statali. Ci si riferisce ai seguenti atti di diritto derivato: direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla «[…] tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
Stefano Vaccari166
di proporzionalità nel trattamento dei dati personali rispetto alla finalità da per-seguire, in questo caso l’apertura alla trasparenza dell’azione dei soggetti pubblici.
Infatti, cercando di porre l’accento sull’importanza del richiamo, contenu-to nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 33/201332, alla disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e ai principi costituzionali che si pongono quali limiti esterni ad un assolutizzazione del principio di trasparenza esigendo un opportuno equilibrio tra i vari valori/principi presenti, si può rilevare come il c.d. Codice della privacy, nel titolo riguardante le regole generali valevoli per ogni for-ma di trattamento dati, preveda, all’art. 11, lett. b)33, per l’utilizzo dei dati perso-nali, il principio forte di «finalità»34 e di compatibilità con gli scopi della raccolta, nel caso di specie quindi con la finalità primaria della trasparenza.
nonché alla libera circolazione di tali dati»; direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997 sul «[…] trat-tamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni»; diret-tiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 relativa al «[…] trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche»; direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva «[…] 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche […]»; direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009 recante modifica delle «[…] direttive 2002/21/CE che istituisce un qua-dro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettro-nica». Inoltre, si pone l’accento sul fatto che diversi diritti, ricavati in via giurisprudenziale dall’art. 8 C.E.D.U. cit., sono stati oggetto di una specifica disciplina inserita in puntuali disposizioni del-la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 – adottata il 12 dicem-bre 2007 – (c.d. «Carta di Nizza»). In part., l’art. 8 della C.D.F.U.E., dedicato appositamente alla protezione dei dati di carattere personale, statuisce che «[o]gni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il princi-pio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fon-damento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’auto-rità indipendente». La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che si è occupa-ta di questioni attinenti alla materia della protezione dei dati personali, da tempo, ha aderito ad un orientamento che tende a mutuare l’interpretazione elaborata dalla Corte E.D.U. facendo, altresì, espresso richiamo, nelle proprie sentenze, proprio all’art. 8 C.E.D.U. (vd., tra tutte, C.G. 20 mag-gio 2003, C-465/00 e C-138-139/01, Rechnungshof e Österreichischer Rundfunk).
32 Art. 1, comma 2, d.lgs. cit.: «La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia […] di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzio-nali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’uti-lizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione».
33 Art. 11, comma 1, d.lgs. 196/2003: «I dati personali oggetto di trattamento sono […] lett. b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi».
34 La valorizzazione del principio di «finalità», onde giustificare le ingerenze determinate dal-la raccolta e dalla memorizzazione dei dati personali, è sostenuta costantemente anche dalla Cor-te E.D.U. (vd., da ultimo, Shimovolos c. Russia del 21 giugno 2011, § 58-71), la quale afferma che
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 167
Poiché, tuttavia, l’art. 4, comma primo, appare chiaro nel disporre testual-mente la libera rintracciabilità dei dati personali oggetto di pubblicazione obbli-gatoria mediante tutti i motori di ricerca web, e con ciò rendendo estranee le amministrazioni ad ogni possibilità di governo e di controllo circa l’esattezza, l’aggiornamento e il monitoraggio dei dati pubblicati una volta che questi si tro-vino a transitare, a mezzo dei motori di ricerca, nei vari spazi del web, non sem-bra che vi sia alcuna possibilità di rendere compatibile tale norma con gli anzi-detti principi, a tutela della riservatezza e della privacy degli individui, di finalità e compatibilità allo scopo.
Non sembra, pertanto, possibile superare tale impasse, come suggerito da più parti35, tra cui l’autorevole voce del Garante della privacy36, se non a mezzo di una modifica diretta di tale disposizione in un senso che favorisca una rintraccia-bilità dei dati personali, ove presenti, soltanto mediante motori di ricerca interni ai siti istituzionali, i quali, in questo modo, potrebbero consentire accessi, sempre liberi, ma maggiormente selettivi37 e coerenti con le finalità sottese alla pubblica-zione; ciò nel pieno rispetto dei principi (accennati più sopra) nazionali e comu-nitari in materia di trattamento dei dati personali.
le legislazioni nazionali debbano delineare: le finalità, i destinatari potenziali della raccolta dei dati, le circostanze che giustifichino tale raccolta, i dati e/o le categorie di dati per i quali è vietata e/o ammessa la memorizzazione, le modalità procedurali della raccolta e della conservazione, l’identità dei soggetti autorizzati a consultare i dati archiviati ed, infine, la durata della conservazione dei dati.
35 Ci si riferisce, in particolare, a L. Califano, Il bilanciamento tra trasparenza e privacy nel d.lgs. 33/2013, XXX Assemblea Anzi, Firenze, 24 ottobre 2013.
36 Garante per la protezione dei dati personali, «Parere del Garante su uno schema di decre-to legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a.», n. 49/2013, parte I, punto n. 4: «Al riguardo, l’Au-torità richiama l’attenzione del Governo sulla opportunità di rendere rintracciabili i dati oggetto di pubblicazione solo con motori di ricerca interni ai siti, posto che un obbligo indifferenziato e ampio, come quello previsto dalla norma, appare contrario al principio di proporzionalità nel trat-tamento dei dati personali rispetto alle specifiche finalità di trasparenza di volta in volta persegui-te (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice), e incide negativamente sull’esigenza di avere dati esatti, aggiornati e contestualizzati. In proposito si rammenta che nelle Linee guida citate il Garante ha ritenuto preferibile le funzionalità di ricerca interne ai siti in quanto assicurano accessi maggior-mente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione, garantendo nel contempo la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposi-zione del pubblico».
37 Per questa via si riuscirebbe anche ad ovviare ad un problema di reperimento di tipo «casuale» dei dati pubblicati via web o ad una loro ricerca ispirata unicamente da mera curiosità che finisca per creare, più che vera trasparenza dell’agire dei pubblici poteri, una sorta di c.d. «voyeuri-smo amministrativo». Tale ultima suggestiva espressione è stata ideata, per descrivere in chiave cri-tica il fenomeno, da M. Bombardelli, Fra sospetto e partecipazione…, op. cit., 670. Parla, invece, di conoscenza dell’azione pubblica «curiosity oriented» P. Canaparo, La via italiana alla trasparen-za pubblica…, op. cit., 44.
Stefano Vaccari168
3.2. (Segue): il (libero?) riutilizzo dei dati personali pubblicati.
In secondo luogo, va considerata la previsione contenuta nell’art. 7 del d.lgs. 33/201338 circa la possibilità di un riutilizzo dei documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, totalmen-te libero, ovvero senza alcuna restrizione salvo l’obbligo di citarne la fonte, rispet-tare l’integrità del contenuto e rinviare per il resto al rispetto dei d.lgss. 36/2006, 82/2005 e 196/200339.
Tale disposto è stato ideato, nelle intenzioni del Governo, quali traspaio-no anche dalla relazione illustrativa al decreto, per attivare un’economia legata ai dati pubblicati in formato aperto e liberamente rielaborabili da chiunque, gra-zie ai quali le imprese e ogni cittadino privato avranno a disposizione un’ampia mole di dati pubblici che potranno utilizzare al fine di «realizzare servizi a valore aggiunto e per migliorare la qualità della vita dei cittadini»40.
Tuttavia, il mero rinvio, ivi contenuto, ai decreti in materia di utilizzo di dati personali41 appare di per sé assai generico, vista anche l’intenzione, palesa-ta dal Governo nella relazione illustrativa al decreto, di consentire un riutilizzo generalizzante e diffuso dei dati pubblicati, e non sufficiente (si veda anche quan-to avanzato dal Garante della privacy nel parere reso in via consultiva42) a garan-tire il rispetto dei principi sulla privacy che rischiano di esser lesi da un riutilizzo
38 Art. 7, d.lgs. 33/2013. Dati aperti e riutilizzo: «I documenti, le informazioni e i dati ogget-to di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’arti-colo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diver-se dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità».
39 D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36. Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutiliz-zo di documenti nel settore pubblico; d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell’amministrazione digitale; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.
40 Relazione illustrativa al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Commento all’art. 3.
41 Cfr. nota n. 39.42 Garante per la protezione dei dati personali, «Parere del Garante su uno schema di decre-
to legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparen-za e diffusione di informazioni da parte delle p.a.», n. 49/2013, parte I, punto n. 6: «[…] ai sensi del Codice, in base al principio di finalità, i dati personali possono essere riutilizzati solo in termini di compatibilità con gli scopi originari. La preoccupazione che tale principio finalistico non sia tenuto nella dovuta considerazione dall’odierno decreto è avvalorata dalla Relazione illustrativa nella quale si specifica che – la trasparenza consente […] di attivare anche un’economia legata a dati pubblica-ti in formato aperto e rielaborabili. Le aziende e i privati potranno, infatti, utilizzare i dati pubblici per realizzare servizi a valore aggiunto e per migliorare la qualità della vita dei cittadini».
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 169
smodato e senza freni o limiti dei dati personali resi pubblici e liberamente dispo-nibili in formato aperto sui siti web delle varie p.a.
Si deve tuttavia tener conto di altre norme in materia e dei richiami conte-nuti nella parte generale del d.lgs. 33/2013 che consentono di meglio precisare i principi che devono reggere il riutilizzo dei dati personali pubblicati, arginando, conseguentemente, ogni possibile lettura estremistica di quel libero riutilizzo dei documenti, informazioni e dati, visto come corollario di un nuovo «diritto alla conoscibilità», positivizzato dall’art. 3 del medesimo d.lgs. cit.43, che segna il pas-saggio da un «need to know» (situazione riferibile all’accesso tradizionale di cui alla l. 241/1990, ove va dimostrato l’interesse particolare a fondamento della pretesa) ad un «right to know»44, quale vero e proprio diritto soggettivo alla conoscenza e alla fruizione dei dati, ma del quale, tuttavia, vanno necessariamente tratteggiati e limitati i contorni per quanto attiene ai dati personali.
In primo luogo va sottolineato come, a livello comunitario, nella Diretti-va 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (con riferimento alla promozione della concorrenza e all’incremento dell’economia mediante la cir-colazione del capitale informativo detenuto dalle varie amministrazioni) non sia previsto alcun obbligo per gli Stati membri di diffusione tout court di ogni dato
43 Art. 3, d.lgs. 33/2013. Pubblicità e diritto alla conoscibilità: «Tutti i documenti, le infor-mazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubbli-ci e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sen-si dell’articolo 7».
44 Ci si riferisce a quanto osservato da B. Ponti «Il codice della trasparenza amministrati-va…», op. cit., 1: «Agli obblighi di pubblicazione corrisponde dunque non un need to know (una conoscenza utile al sofddisfacimento di un interesse, di un bisogno particolare), ma un vero right to know. Un diritto conseguentemente assistito da un meccanismo di implementazione (in caso di inadempimento dell’obbligo di pubblicazione) attivabile da chiunque, quasi nella forma dell’azio-ne popolare». Nello stesso senso F. Patroni Griffi, «La trasparenza della pubblica amministrazio-ne…», op. cit., 6. Sulla configurazione di questo nuovo diritto soggettivo alla conoscibilità dell’at-tività e dell’organizzazione amministrativa come «sociale» e/o «civico», quale proprium di ogni cit-tadino «uti cives», cfr. C. Cudia, Il diritto alla conoscibilità, in B. Ponti (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Rimini, 2013, 57 ss. Più in generale sul nuovo istituto del c.d. «accesso civico» vd. anche M. Magri, Diritto alla trasparenza e tutela giurisdiziona-le, in Istituzioni del Federalismo, 2013, II, 28 ss.; M. Savino, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2013, VIII-IX, 795 ss.; P. Canaparo, Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: i nuovi confini della trasparenza pubblica e il diritto alla conoscibilità dell’azio-ne amministrativa, in Giustamm.it, 2013, IV, 27 ss. Per una comprensione, in chiave diacronica, dell’evoluzione delle singole ipotesi di c.d. «accesso generalizzato» (quale forma giuridica anticipa-trice dell’odierno accesso civico) sparse e frammentate all’interno dell’ordinamento (in particola-re, nella legislazione ambientale, nell’ordinamento degli enti locali, nelle amministrazioni regiona-li e per particolari categorie di soggetti), cfr. A. Bonomo, Informazione e pubbliche amministrazio-ni…, op. cit., 223 ss.
Stefano Vaccari170
in possesso delle varie p.a. interne, bensì si preveda espressamente, al consideran-do n. 9 che «[l]a presente direttiva non prescrive l’obbligo di consentire il riutiliz-zo di documenti. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all’ente pubblico interessato […]» e, al considerando n. 21, che «la pre-sente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali».
Quanto alla trasposizione interna della direttiva anzidetta, da parte del d.lgs. 36/200645 in materia di riutilizzo dei documenti nel settore pubblico, si deve notare come, pur nell’intento, palesato dall’art. 1 di tale decreto, di «[…] rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicuri-no condizioni eque, adeguate e non discriminatorie», all’art. 4 dello stesso, a chia-re lettere si dispone che «sono fatte salve: a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 […]».
Passando, invece, al testo del d.lgs. 33/2013, si tratta di valorizzare, per ciò che attiene al riutilizzo dei dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria, più che la locuzione, di cui all’art. 7 del d.lgs. 33/2013, «riutilizzabili […] sen-za ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l’in-tegrità», la quale sembra imprimere un forte favor46 per una riutilizzabilità libe-ra e senza vincolo alcuno, la norma dell’art. 4, comma 1, dello stesso d.lgs. cit. secondo cui il riutilizzo (dei dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria) deve essere effettuato «[…]ai sensi dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trat-tamento dei dati personali», e quella dell’art. 7, comma 1, del decreto cit., ove si consente, quanto alle modalità, un riutilizzo «[…] ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 […]». E va tenuto conto, infine, della clausola generale dell’art. 1, comma 2, dello stesso decreto secondo cui il principio gene-rale di trasparenza va attuato nel rispetto «[…] delle disposizioni in materia […] di protezione dei dati personali».
Visto il riferimento ai principi e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, contenuto nelle varie norme sopracitate, quale limite che deve essere rispettato anche nella fattispecie che si sta analizzando, concernente il riuti-lizzo dei dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria, si tratta di consen-tire tale riutilizzo unicamente secondo forme rispettose di un principio cardine sulla protezione dei dati personali, che trova sicura applicazione nel caso di specie,
45 Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Attuazione della direttiva 2003/98/CE relati-va al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
46 In linea anche con quanto appena detto circa le intenzioni del governo, palesate nella rela-zione illustrativa al decreto, per una riutilizzabilità libera che consenta l’avvio di un’economia lega-ta ai dati pubblicati dalle p.a.
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 171
ovvero il principio (di genesi europea) di finalità, il quale comporta che ogni for-ma di riutilizzo, per ulteriori operazioni, di dati personali (anche legittimamente raccolti) debba avvenire sempre secondo modalità che consentano un trattamen-to unicamente per scopi analoghi a quelli che ne hanno giustificato la raccolta e la registrazione (vd. art. 11, comma 1, lett. b) del d.lgs. 196/200347)48.
In questo modo il riutilizzo dei dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sarà sempre libero ma avverrà unicamente in forme coerenti allo sco-po della raccolta, di modo che siano evitati (una volta che sia esclusa la possibili-tà per chiunque di rimaneggiarli senza controllo) effetti manipolativi sui dati che possano frustrare lo stesso senso della trasparenza, nella sua idea di veridicità del-le informazioni pubblicate.
Quale addenda finale, ove non fosse sufficiente una forte sottolineatura in via interpretativa del principio di finalità (quale principio rientrante nel nove-ro dei principi in materia di protezione dei dati personali, più volte richiamati, in via generica, dal d.lgs. 33/2013), nel riutilizzo dei dati personali pubblicati, si potrebbe suggerire49, in chiave de jure condendo, di esplicitare positivamente tale
47 Art. 11, comma 1, d.lgs. 196/2003: «I dati personali oggetto di trattamento sono […] lett. b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi».
48 Si vuole richiamare, a completezza e a conforto di quanto appena sostenuto, un estrat-to del parere del Garante europeo della protezione dei dati del 13 aprile 2012 circa una possibi-le modifica della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico: «Il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico contenenti dati personali può arrecare notevo-li benefici, ma comporta anche rischi considerevoli per la protezione dei dati personali. Alla luce di tali rischi, il GEPD raccomanda che la proposta definisca più chiaramente in quali situazioni e fat-te salve quali salvaguardie le informazioni contenenti dati personali possono dovere essere messe a disposizione per il riutilizzo. In particolare, la proposta deve: […] – ove necessario, considerando i rischi per la protezione dei dati personali, imporre a chi chiede il riutilizzo di dimostrare (attra-verso una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati o mediante altre modalità) che eventuali rischi per la protezione dei dati personali vengano adeguatamente presi in considerazione e che chi chiede il riutilizzo tratterà i dati in conformità della legislazione applicabile in materia di protezio-ne dei dati – chiarire che il riutilizzo può essere subordinato allo scopo per cui viene effettuato, in deroga alla regola generale che autorizza il riutilizzo per fini commerciali e non commerciali […]».
49 Suggerimento espresso anche dal Garante per la protezione dei dati personali, in «Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a.», n. 49/2013, parte I, punto n. 6: «In conclusione, il mero rinvio presente nello schema all’osservanza delle – disposi-zioni di protezione dei dati personali – (cfr. art. 1, comma 2 dello schema) non appare sufficiente a garantire il rispetto del principio di finalità, dovendo la disciplina che si intende introdurre essa stessa incorporare i principi di protezione dei dati personali contenuti nella direttiva 95/46 nonché nella direttiva 2003/98. Si ritiene necessario, pertanto, integrare l’articolo 7 con il seguente com-ma o con altro di analogo tenore: “In caso di pubblicazione di dati personali, il loro utilizzo in altre operazioni di trattamento è consentito solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 giu-
Stefano Vaccari172
principio all’interno del testo dell’art. 7 del d.lgs. 33/2013 in luogo di un gene-rico (e, forse, non chiaro) rinvio ai decreti 36/2006, 82/2005 e 196/2003 nella loro interezza.
3.3. (Segue): questioni sulla durata della pubblicazione e sulla conservazione post sca-denza dei dati personali pubblicati.
Da ultimo va considerata la disciplina sulla durata dell’obbligo di pubbli-cazione e sulla conservazione dei dati alla scadenza del termine, contenuta negli artt. 8 e 9 del d.lgs. 33/2013.
L’art. 8 citato50, infatti, stabilisce che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e fintanto che gli atti pubblicati producano i loro effet-ti, con le uniche eccezioni dei «diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali» e dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 451.
Il decreto prevede, pertanto, una durata dell’obbligo di pubblicazione che, siccome fissata in un termine unico e generalizzato di cinque anni per tutti i dati, sembra presentare profili di contrasto con un principio cardine in materia di pro-tezione dei dati personali, ovvero il principio di proporzionalità, il quale è ricava-
gno 2003, n. 196, e comunque nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003”».
50 Art. 8, d.lgs. 33/2013. Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione: «I documen-ti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pub-blicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pub-blicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblica-ti per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4».
51 In particolare l’art. 14, comma 2, si riferisce agli «obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico» e dispone che «[l]e pubbliche amministrazioni pub-blicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situa-zione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato […]». Men-tre l’art. 15, comma 4, si riferisce agli «obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza», e dispone che «[l]e pubbliche amministrazioni pub-blicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni suc-cessivi alla cessazione dell’incarico».
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 173
bile dal disposto dell’art. 11, comma 1, lett. e), del d.lgs. 196/2003 ove si dispo-ne che i dati personali oggetto di trattamento siano «conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamen-te trattati».
Dato che a nulla può valere l’espressa eccezione, disposta dallo stesso art. 8 del d.lgs. 33/2013, riguardo ai «[…] diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali» in quanto il Codice della privacy non contiene alcuna disposizione che faccia riferimento a tali diversi termini, si dovrà interpretare tale assunto normativo nel senso che, a mezzo di esso, si è inteso pre-vedere la possibilità, anzi la necessità di derogare allo standardizzato, valevole in via generale e residuale, termine unico di cinque anni, e di modulare il termine di pubblicazione in senso conforme ai principi che informano la normativa in mate-ria di trattamento dei dati personali.
Tale normativa, in punto di durata di pubblicazione, dispone unicamente che, in omaggio al già accennato principio di proporzionalità, i dati siano con-servati per un periodo di tempo proporzionato52, id est coerente e non superiore a quello necessario per assolvere alla finalità della raccolta, pubblicazione o tratta-mento dei dati, con ciò richiedendo una differenziazione di tali termini in ragio-ne delle peculiarità delle singole tipologie di dati.
Qualora un tale approccio ermeneutico dell’art. 8 del d.lgs. 33/2013 non fosse possibile, sarebbe allora il legislatore stesso a dover rimodulare il testo della norma mediante l’inserimento di una previsione di termini differenziata per cate-goria tipologica di dati e secondo le diverse finalità specifiche e individualizzate della pubblicazione dei dati previsti dal decreto53, ciò in linea anche con il conte-
52 L’importanza del rispetto del canone di proporzionalità nella raccolta e nella conservazio-ne dei dati personali è ribadita anche dalla costante giurisprudenza della Corte E.D.U. In part. vd. Corte E.D.U. Leander c. Svezia del 26 marzo 1987, § 48, ove si afferma che la raccolta e/o conser-vazione di dati personali da parte delle autorità nazionali rappresenta un’ingerenza nella sfera pri-vata degli individui giustificabile, ex art. 8, par. 2, C.E.D.U., unicamente laddove quest’ultima sia legale, motivata da obiettivi legittimi e, soprattutto, necessaria oltreché proporzionata. Nello stes-so senso vd., anche, Corte di giustizia dell’Unione Europea, Michael Schwarz c. Stadt Bochum del 17 ottobre 2013, ove si ammettono limitazioni al diritto alla protezione dei dati personali (di cui all’art. 8 C.D.F.U.E.) purché «[…] tali limitazioni siano previste dalla legge e rispettino il contenu-to essenziale di detti diritti e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».
53 Nello stesso senso, Garante per la protezione dei dati personali, «Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblici-tà, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a.», n. 49/2013, parte I, punto n. 7: «[…] Si rimette quindi al Governo la valutazione circa una rimodulazione della norma con l’indicazione
Stefano Vaccari174
nuto della legge delega n. 190/2012, nella quale, al comma 35 dell’art. 1, si pre-vede (tra i vari criteri direttivi), alla lettera g), l’«individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria».
Vi è poi un secondo problema: quid iuris una volta scaduto il termine di pubblicazione, ovvero quale sarà la sorte, in tal caso, dei dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle p.a.?
Sul punto, l’art. 9, comma 2, del d.lgs. 33/201354 dispone che, una vol-ta scaduti i termini di durata degli obblighi di pubblicazione ex art. 8, comma 3 cit., i documenti, le informazioni e i dati pubblicati siano comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio dei vari siti istituziona-li debitamente segnalate e dunque, di fatto, resi disponibili alla fruizione libera di chiunque in modo permanente.
Tuttavia una disponibilità perpetua dei dati personali pubblicati via web, in quanto semplicemente trasferiti ad altra sezione dei siti istituzionali ma mai defi-nitivamente cancellati, sembra vanificare e contraddire la stessa ratio di una pub-blicazione temporanea dei dati personali sui siti web delle p.a., la quale appare, invece, dallo stesso art. 8 del d.lgs. 33/2013 ove, per l’appunto, si prevede un ter-mine per l’obbligo di pubblicazione (i cinque anni sopracitati).
Pertanto, tale permanenza de facto perpetua dei dati personali pubblicati sui siti istituzionali, tra l’altro rintracciabili ex art. 4 del d.lgs. 33/2013 a mezzo di ogni motore di ricerca web, pare presentare il rischio immanente di una cristallizzazione dei dati caricati e di una conseguente lesione, date le difficoltà intrinseche di can-cellazione postuma, del «diritto di oblio» quale garanzia propria di ogni persona.
Il diritto di oblio55, infatti, per consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria, spetta in capo ad ogni soggetto e richiede che sia evitata ogni forma
di termini differenziati, in ragione delle categorie di dati e delle specifiche finalità della pubblicazio-ne (cfr. criterio di delega sub. lettera g) […]».
54 Art. 9, d.lgs. 33/2013. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti. Comma 2: «Alla sca-denza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 8, comma 3, i docu-menti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all’articolo 6, all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnala-te nell’ambito della sezione – Amministrazione trasparente. I documenti possono essere trasferi-ti all’interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 3».
55 Per un approfondimento sul diritto di oblio, dalla sua creazione giurisprudenziale ai vari profili ricostruttivi dell’istituto, si veda F. Mangano, Diritto all’oblio, in Giurisprudenza di meri-to, n. 12/2012, 2621 ss. Cfr., anche, G. Finocchiaro, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, IV-V, 591 ss.; S. Peron, Il diritto all’oblio nell’era dell’informazione “online”, in Responsabilità civile e previdenza, 2014, IV, 1177 ss.; M. Bassini, O. Pollicino, Conciliare diritto all’oblio e la libertà di informazione nell’era digitale.
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 175
di immobilizzazione sine die56 di informazioni passate che lo riguardino, le qua-li, magari, potrebbero anche non essere più corrispondenti al vero, il tutto senza alcuna possibilità di controllo, verifica o potere di cancellazione.
Per superare tale impasse in via interpretativa e, dunque, favorire una conser-vazione dei dati che sia al contempo rispettosa dei principi in materia di protezio-ne dei dati personali si deve tener conto dell’inciso, contenuto nello stesso art. 9, comma 2, che stabilisce che i dati «sono comunque conservati […], con le moda-lità di cui all’articolo 6» e quindi dell’art. 6 che disciplina le modalità di conser-vazione dei dati (traslati nelle apposite sezioni di archivio dei siti web) riferendo-si ai principi sulla qualità delle informazioni57, disponendo l’obbligo per le p.a. di garantire certi profili di qualità delle informazioni riportate sui siti istituzionali e, in particolare, per quanto qui rileva, che ne vengano assicurati «il costante aggior-namento» e la «tempestività».
Va ricordato poi che l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 33/2013, a conferma di tale approccio ricostruttivo, dispone che «[i] documenti contenenti altre informa-
Passato e futuro della protezione dei dati personali nell’Unione Europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2014, II, 640 ss.; M.C. Daga, Diritto all’oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all’i-dentità personale, in Danno e responsabilità, 2014, III, 274 ss.
56 L’ipotesi di una conservazione a tempo indeterminato di dati personali è stata ritenuta, altresì, da parte della Corte E.D.U., contraria all’art. 8 C.E.D.U. Infatti, in alcune sentenze (cfr., ex multis, W. c. Paesi Bassi del 20 gennaio 2009; S. e Marper c. Regno Unito del 4 dicembre 2008) la Corte di Strasburgo ha dichiarato il carattere illegittimo, sproporzionato e lesivo della riservatez-za delle persone, secondo l’interpretazione consolidata dell’art. 8 C.E.D.U., delle legislazioni nazio-nali che consentano la creazione di database e/o banche del D.N.A. per la conservazione temporal-mente illimitata di profili genetici, impronte digitali, appartenenti a persone indagate e, in seguito, assolte da ogni responsabilità penale elevata a loro carico.
57 Art. 6, d.lgs. 33/2013. Qualità delle informazioni: «Le pubbliche amministrazioni garan-tiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pub-blicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completez-za, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessi-bilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7. L’esigenza di assi-curare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’o-messa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti». Sul rapporto inver-samente proporzionale sussistente fra trasparenza e quantità di dati pubblicati, nonché sull’im-portanza assunta dai profili qualitativi dell’offerta informativa cfr. E. Carloni, La “casa di vetro” e le riforme…, op. cit., 806, ove viene ideato il concetto di «opacità per confusione» per alludere al potenziale distorsivo insito nell’eccesso di informazioni pubblicate online che rischia di cagionare, per tale via, effetti di disorientamento sul cittadino-utente. In senso adesivo vd. anche P. Canapa-ro, La via italiana alla trasparenza pubblica…, op. cit., 58. Radicalizzando tale assunto, certa dot-trina è giunta ad affermare la regola del «less is better» come emerge, chiaramente, dalle argomen-tazioni sul punto di G. Napolitano, L’attività informativa della pubblica amministrazione: ‘less is better’, in F. Manganaro, A. Romano Tassone (a cura di), I nuovi diritti di cittadinanza: il dirit-to d’informazione, Torino, 2005.
Stefano Vaccari176
zioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigen-te sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presen-te decreto».
Dal combinato disposto dell’art. 9, comma 2, nel suo espresso rinvio alla anzidetta disposizione dell’art. 6, e di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del-lo stesso decreto, si riesce a evincere l’obbligo conseguente della conservazione postuma dei dati personali pubblicati da parte delle amministrazioni attraverso interventi che siano tempestivi e mantengano i dati disponibili sempre aggiornati e rispondenti ai canoni positivizzati di qualità dell’informazione (a garanzia della perenne rispondenza al vero dei dati personali diffusi).
Inoltre, per assicurare il giusto contemperamento tra trasparenza e tutela della riservatezza, gli obblighi di garanzia qualitativa delle informazioni pubbli-cate, ricomprendenti il dovere di tempestivo aggiornamento, possono trovare un «enforcement» dal corretto svolgimento dei compiti di controllo attribuiti, in base all’art. 43 del d.lgs. 33/2013, alla nuova figura organizzativa del c.d. «Responsa-bile per la trasparenza»58, il quale dovrà svolgere «[…] stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pub-blicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chia-rezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate […]»59.
Tale soggetto, pertanto, allorché riscontri nell’espletamento delle sue nuo-ve funzioni un vulnus quanto al difetto di rispetto del dovere di aggiornamento costante delle informazioni pubblicate e conservate negli archivi web dei siti isti-tuzionali, dovrà segnalare «[…] all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione […]»60, oltre ad un ulteriore dovere di comuni-cazione all’ufficio di disciplina affinché venga attivato un eventuale procedimen-to disciplinare: il che, potrà aver effetto di deterrenza e di stimolo per l’adempi-mento pronto e tempestivo da parte delle p.a. dei propri obblighi in tema di pub-blicazione.
Qualora tali obblighi imposti alle amministrazioni non appaiano sufficien-ti e si voglia intervenire direttamente sulla norma, in chiave de jure condendo, si dovrebbe optare per una modifica di quest’assetto sulla conservazione dei dati
58 Il «Responsabile della trasparenza», all’interno delle varie amministrazioni, dovrebbe coincidere, per espressa disposizione del comma 1, dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013, con il sogget-to qualificato come «Responsabile per la prevenzione della corruzione» dall’art. 1, comma 7, del-la l. 190/2012 che si troverà, dunque, di fatto a dover svolgere un cumulo di funzioni previste dai due testi normativi.
59 Cfr. Art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013.60 Ibidem.
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 177
personali, dopo la scadenza del termine di pubblicazione obbligatoria, secondo disposizioni che impongano la cancellazione di questi dati, quale prima via più radicale61, o, quantomeno, accessi selettivi e mirati, rispettosi cioè del principio di finalità e proporzionalità che deve sempre sorreggere la conservazione dei dati personali, alla luce dei principi, più volte esposti nella presente trattazione, ricava-bili dall’impianto normativo del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy).
4. Conclusioni.
Si è visto, dunque, in questo breve percorso ricostruttivo, come nella versio-ne finale del d.lgs. 33/2013 si siano fatti enormi passi in avanti nel temperamento di ogni aprioristica assolutizzazione del valore di trasparenza e nella affermazione dell’esigenza di un’imprescindibile e necessaria conciliazione con i diritti connessi alla tutela della privacy e della riservatezza, i quali, rivestendo il carattere di dirit-ti fondamentali della persona ed espressione della dignità personale, non possono soffrire compressioni e violazioni ingiustificate e/o sproporzionate.
Tuttavia permangono alcuni aspetti dell’attuale versione del decreto che sembrano far prevalere ingiustificatamente la tutela della trasparenza sulla tute-la della riservatezza e che vanno superati in via interpretativa (come si è cercato di fare nel corso dell’analisi compiuta) o de jure condendo, al fine di realizzare un miglior e più ragionevole punto di equilibrio tra le due opposte istanze.
Ciò, in quanto, per usare una metafora suggestiva62, l’amministrazione deve essere vista sì come una «casa di vetro» ma i suoi abitanti all’interno devono comunque rimanere vestiti e non totalmente nudi allo sguardo di chiunque.
61 Opzione in linea con quanto disposto, per un caso specifico, dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ove, in tema di «obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indi-rizzo politico», al comma 2 si dispone che «[…] decorso il termine di pubblicazione ai sensi del pre-sente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferi-ti nelle sezioni di archivio».
62 Metafora ripresa da L. Califano, Il bilanciamento tra trasparenza…, op cit., 2.
This paper seeks to make an analysis of and comment on – from a critical point of view – the legislative limits imposed by leg. Dec. 33/2013, which aims to strike an appropriate balance between the principle aim (and primary motive behind the legislation) of increasing ad-ministrative transparency and the simul-taneous (and necessary) call for appro-priate protection of personal data that may be contained within deeds/docu-ments subject to compulsory publica-tion, as per the law on the institution-al websites of the Public Administra-tion. In particular, the Author intends to demonstrate how the rules regarding protection and the limits of transparen-cy contained in the cited legislation are insufficient for this purpose since they seem to leave a series of risks/dangers for confidentiality and the protection of cit-izens’ personal data. These problem areas have been grouped together in the fol-lowing issues, examined separately: first-ly, the free indexation and traceability of published personal data through internet search engines; secondly, the possible (free) reuse of such data and, finally, the duration of the publication, as well as the post expiry storage of such person-al data. For each of these critical areas, an attempt is made in the reconstructive part of the paper to consider whether there is scope for their solution by inter-pretative means through systematic rec-onciliation, or whether such an exegeti-cal effort implies that the only option is ultimately de jure condendo reform.
Stefano Vaccari
Il presente lavoro si propone di offri-re un’analisi e un commento – in chia-ve critica – dei limiti normativi appo-sti dal d.lgs. 33/2013 al fine di realizza-re un opportuno bilanciamento tra la primaria finalità (ispiratrice del decre-to) d’incremento della trasparenza am-ministrativa e la compresente (e necessa-ria) esigenza di adeguata protezione dei dati personali che possono essere coin-volti all’interno degli atti/documen-ti soggetti a pubblicazione obbligatoria ex lege sui siti istituzionali delle P.A. In particolare, l’Autore intende dimostrare come le regole di protezione ed i limiti alla trasparenza contenuti nel d.lgs. cit. siano insufficienti a tale scopo in quan-to sembrano residuare una serie di ri-schi/pericoli per la riservatezza e la pro-tezione dei dati personali dei cittadini. Tali criticità sono state raggruppate nel-le seguenti questioni, esaminate sepa-ratamente: in primo luogo, la libera in-dicizzazione e rintracciabilità mediante motori di ricerca web dei dati persona-li pubblicati; in secondo luogo, il possi-bile (libero) riutilizzo di essi ed, infine, da ultimo, la durata della pubblicazio-ne nonché la conservazione post scaden-za degli stessi dati personali. Nella parte ricostruttiva si è cercato di valutare, per ognuno di questi profili critici, se vi sia margine per una loro risoluzione in via interpretativa mediante riconduzione a sistema, oppure, se tale sforzo esegetico lasci spazio, unicamente, a prospettive di riforma de jure condendo.
Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza nel D.lgs. 33/2013 - The difficult balance between favouring transparency and the (necessary) protection of confidentiality in Leg. Dec. 33/2013
Riassunto - Abstract
Comitato di direzione
Carlos Botassi (Università de La Plata - Argentina)Elio Casetta † (Università di Torino)Andrea Comba (Università di Torino)Giacinto della Cananea (Università Tor Vergata - Roma) Vittorio Gasparini Casari (Università di Modena e Reggio Emilia)Daniel Farber (University of Berkeley)Guido Greco (Università Statale - Milano)Estanislao Garcia Arana (Università di Granada - Spagna)Neville Harris (University of Manchester)Michel Prieur (Université de Limoges)
Direttore responsabile
Fabrizio Fracchia (Università L. Bocconi - Milano)
Comitato scientifico
Laura Ammannati (Università Statale - Milano)Sandro Amorosino (Università La Sapienza - Roma)Mario Bertolissi (Università di Padova)Cristina Campiglio (Università di Pavia)Giovanni Cordini (Università di Pavia)Marco Dugato (Università di Bologna)Denis Galligan (University of Oxford)Marco Gestri (Università di Modena e Reggio Emilia)Francesco Marani (Università di Modena e Reggio Emilia)Anna Marzanati (Università Bicocca - Milano)Giuseppe Morbidelli (Università La Sapienza - Roma)Fabio Merusi (Università di Pisa)Giorgio Pastori (Università Cattolica Sacro Cuore - Milano)Giuseppe Pericu (Università degli Studi di Milano)Ornella Porchia (Università di Torino)Pierluigi Portaluri (Università di Lecce)Margherita Ramajoli (Università degli Studi Milano - Bicocca)Giuseppe Restuccia (Università di Messina)Franco Gaetano Scoca (Università La Sapienza - Roma)Antonello Tancredi (Università di Palermo)
Comitato di redazione
Miriam Allena (pres.)Giovanni Barozzi ReggianiLorenzo CaruccioAnnalaura GiannelliGiuseppe La RosaAlberto MarcovecchioPasquale PantaloneMariacristina SantiniScilla Vernile