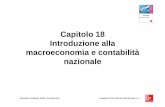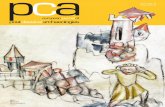El Purgatorio de San Patricio en Irlanda. Edición crítica del Ms. BNM 1872321
Gli argomenti esterni per la pubblicazione dell'Inferno e del Purgatorio
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Gli argomenti esterni per la pubblicazione dell'Inferno e del Purgatorio
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
In una precedente nota si è mostrato come, con ragionevoleverosimiglianza, sia da credere che il canto XIX dell’Inferno abbia vistola luce non prima del 1312, subendo una lieve modifica, relativamente alpreannuncio della morte di Clemente V, intorno alla metà del 1314, pocoprima di licenziare la cantica1. Cantica che, nella sua interezza, videla luce nel secondo semestre di quell’anno. Le conclusioni di quellostudio si fondano sull’analisi del pontificato del Papa guasco che,sebbene controverso fin dall’inizio, si risolse irrimediabilmente innegativo, secondo Dante, solo dopo il Concilio di Vienne (1311-‘12).Questa convinzione poggia in maniera incontrovertibile su altri testidanteschi (l’Epistola V, databile con certezza al settembre-ottobre 1310,e, con minor sicurezza, l’Epistola VII, dell’aprile 1311). Essi testimonianoche ancora a quell’altezza vi era piena disponibilità da parte del poetaad un’ingente apertura di credito verso Clemente V. Su tali basi è statolecito concludere per una data intorno al 1312 per la stesura originariadel canto: tanto radicale è la condanna di cui quel pontefice è fattooggetto, da risultare anacronistico anticiparla, come vorrebbe lacommunis opinio, al 1306-‘07, epoca in cui il neoeletto Bertrand du Got nonaveva avuto neppure il tempo materiale per compiere quelle nefande azioniche Dante gl’imputava, come e più di Papi degeneri del calibro di NiccolòIII e, soprattutto, Bonifacio VIII2.1 G. INDIZIO, La profezia di Niccolò e i tempi della stesura del canto XIX dell’«Inferno», «StudiDanteschi», LXVII, 2002, pp. 73-97.2 A fronte di tali argomentazioni, si possono registrare quelle contrarie che,nei decenni, sono state messe innanzi dai dantologi: Parodi, seguito da Egidi,Torraca, Sapegno, Vallone e Folena, fino ai recenti Fenzi (2005), Casadei (2011)e Scott (2011), parlò di profezia ante eventum. Ciascuno s’industriò poi a rendereplausibile un simile azzardo. Ci fu chi (Torraca, molto seguito tra i moderni)parlò delle malcerte condizioni di salute del pontefice, tali da non rendererischiosa la profezia di una morte precoce: «di un uomo ridotto in quello statoDante poteva facilmente prevedere imminente la morte anche prima del 1313»; cit.in G. VANDELLI, Ancora su la datazione della D.C., «Studi Danteschi», XV, 1931, p. 43-63,p. 52; chi (Vallone, senza seguito) invocò una sorta di pathos irrinunciabile delpoema: «[Queste allusioni ad eventi futuri sono nient’altro che] predizioni,allusioni che dicono di Dante non una realtà vista passata, ma una sua speranza,un suo augurio. Se noi sapessimo vita opere e miracoli di ogni vicenda [...] laCommedia perderebbe quella trepidazione ansiosa che tutta la percorre»; A.VALLONE, Studi sulla D. C., Firenze, Olschki, 1955, p. 9; chi (Sapegno, Reggio) siappellò all’episodio del battezzatorio il quale, ritenuto un’infrazionenarrativa riferita al presente reale, fu collocato opportunamente intorno al1301, ancorando ad esso il tempo di stesura del canto (cfr. i relativi commentialla Commedia, e relative note al verso). Peraltro, se tutti spiegano come Dantepoté azzardare una simile profezia, nessuno spiega perché vi si spinse,
1
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
Considerando che il canto XIX rappresenta, dal punto di vista interno,la punta cronologicamente più avanzata dell’Inferno, è indubbio, per chiscrive, che la sola altra via per fissare termini ragionevoli allaconclusione e pubblicazione della prima (e della seconda) cantica, siaun’analisi organica dei cosiddetti «argomenti esterni», ossia di queirichiami a versi della Commedia ricavabili da testi e opere nondantesche. Può suscitare stupore che, nel plurisecolare fiorire di studidanteschi, non sia stata compiuta un’esplorazione sistematica di taliargomenti. Per quanto non manchino ricerche su specifici aspetti, si devenotare che una complessiva ed esauriente ricognizione ad oggi, salvoerrore, manca. Né è facile comprendere perché la maggioranza deglistudiosi abbia tradizionalmente preferito interessarsi solo ad alcuniargomenti, i quali, per di più, non hanno tardato a rivelarsi talvoltadel tutto secondari. Peraltro, fintanto che il quadro si mantieneincompleto e frammentario, fondato su argomenti controversi (ad esempiol’argomento cd. «barberiniano») o addirittura fragili (come l’argomento«useppiano»), si libera spazio per opinioni ed interpretazioni chealtrimenti non avrebbero mai potuto avere corso. Ma non è tutto. Non sipuò tacere che argomenti di importanza capitale, come l’«ugurgieriano-lanciano» ed il «martiniano», siano stati quasi completamente ignoratidalla dantologia maggiore, ovvero riconfigurati in modo talvoltastrumentale. Di tutto questo si renderà conto nel corso dell’esposizione,dedicata ad avviare una prima parziale esplorazione degli argomentiesterni.
L’ARGOMENTO BARBERINIANOIl primo, e più esplorato, argomento esterno per datare la
pubblicazione della prima cantica è il celebre «argomento barberiniano»,oggetto, come si è anticipato, di una nutrita bibliografia3. Nei suoi
rischiando un terribile nonsense in caso di vaticinio errato (ricordiamo cheClemente V muore nel 1314 e che molti sostenitori della communis opinio ipotizzanol’Inferno pubblicato tra il 1308 ed il 1313). Infine, vi fu chi (Petrocchi),abbandonando l’illazione di una profezia autentica, preferì pensare ad unritocco di 7-8 anni posteriore all’originaria stesura, che fu comunque mantenutaal 1306-‘07. Illustrativo di tale tesi, più recentemente si è espresso conautorevolezza A. CASADEI, Questioni di cronologia dantesca: da «Paradiso» XVIII a «Purgatorio»XXXIII, «L’Alighieri», XXXVIII, 2011, pp. 123-41, con discussione dellabibliografia precedente.3 In ordine cronologico, se ne sono occupati: A. THOMAS, Francesco da Barberino et lalitterature provençale en Italie, Parigi 1883; M. SCHERILLO, Alcuni capitoli della biografia di Dante,Torino, Loescher, 1896; G. MELODIA, Dante e Francesco da Barberino, «GiornaleDantesco», IV, 1897, pp. 1-3; R. ORTIZ, Le imitazioni dantesche e la questione cronologicanelle opere di Francesco da Barberino, «Atti della R. Accademia di Architettura Lettere e
2
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
termini essenziali, l’argomento può essere così sintetizzato: in unachiosa di commento ad una sua opera, i Documenti d’Amore, Francesco daBarberino, notaio valdelsano coetaneo di Dante, richiama, a latere di unriferimento alle Declamazioni di Seneca, il grande poeta latino Virgilio.Soggiunge che, a tale riguardo, non può tacere di un’opera di tal DanteAlighieri, la quale tratta: «attraverso molte vicende» (Vallone), di coseinfernali e che al grande autore latino ed alla sua opera si mostrapalesemente debitrice. Non è stato difficile per gli studiosi, a partireda Antoine Thomas (1883) e Michele Scherillo (1896), identificare inquesta chiosa un riferimento alla prima cantica della Commedia. Tuttavia,sul tempo della chiosa e sulla porzione di Inferno effettivamenteconosciuta dal notaio valdelsano, gli studiosi si sono divisi. Le ipotesipiù autorevoli, fondate su una disamina strutturale dei testi ancor oggisono tre:
Belle Arti di Napoli», XXIII, 1904, poi in ID., Francesco da Barberino e la letteraturadidattica neolatina, Roma, Signorelli, 1948, pp. 25-83; F. TORRACA, Quando scrisse Dante?,«La Tribuna», 12 dicembre 1912, p. 3; R. CRISTIANI, La questione cronologica nelle opere dimesser Francesco da Barberino, «Raccolta di studi di storia e critica dedicata aFrancesco Flamini da’ suoi discepoli», Pisa, Mariotti, 1918, pp. 3-21; F. EGIDI,L’argomento barberiniano per la datazione della «Divina Commedia», «Studi Romanzi», XIX, 1928,pp. 135-62, studio fondamentale per l’analisi del testo e delle fasi dicomposizione; G. VANDELLI, L’argomento barberiniano e la data della «Commedia», «StudiDanteschi», XIII, 1928, pp. 5-29, studio di notevole valore per la collocazionestorica di alcuni riferimenti presenti nelle chiose barberiniane; F. EGIDI, Per ladatazione della «Divina Commedia», «La Rassegna», XXXVII, 1929, pp. 250-5; G. VANDELLI,Ancora su la datazione, cit.; A. VALLONE, Studi sulla «Divina Commedia», Firenze, Olschki,1955; G. PETROCCHI, Intorno alla pubblicazione dell’«Inferno» e del «Purgatorio», «Convivium», VI,1957, pp. 652-69; A. QUAGLIO, Sulla cronologia e il testo della «Divina Commedia», «Cultura eScuola», XIII-XIV, 1965, pp. 241-53; G. FOLENA, La tradizione delle opere di Dante Alighieri,in Atti del Congresso Internazionale di Studi Danteschi, 2 voll., Firenze, Sansoni, 1966, I, pp.1-78; T. BARON, La conoscenza della «Divina Commedia» prima del 1315, Ferrara, LibreriaAriosto, 1965; C. HARDIE, The date of the «Comedy» and the «Argomento Barberiniano», «DanteStudies», LXXXVI, 1968, pp. 1-16, recensito da F. MAZZONI, «Studi Danteschi», L,1973, pp. 243-4; C. F. GOFFIS, voce Francesco da Barberino, in Enciclopedia Dantesca, 6voll., Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1970-’78 (= ED), III, p. 23;G. PADOAN, Il lungo cammino del «poema sacro», Firenze, Olschki, 1993. La nota di E.FENZI, Ancora a proposito dell'argomento barberiniano (una possibile eco del Purgatorio nei «Documentid'amore» di Francesco da Barberino, «Tenzone. Revista de la Asociación Complutense deDantología», VI, 2005, pp. 97-119, prende posizione contro il presentecontributo. A destituirla di fondamento è dedicato G. INDIZIO, L’argomentobarberiniano: dossier di un’attribuzione, «Studi Danteschi», LXXII, 2007, pp. 283-97.Regressivo rispetto ai pur esili argomenti proposti per la profezia ante eventumil recente contributo di J. A. SCOTT, Dante ha rivisto il testo dell’«Inferno» nel 1314?, «StudiDanteschi», LXXVI, 2011, 115-28
3
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
a)l’ipotesi di Francesco Egidi, moderno editore dei Documenti4, per ilquale l’Inferno e il Purgatorio erano a conoscenza di Francesco daBarberino, che scriverebbe nei primi mesi del 1313. Egidi ritieneche l’intero commento ai Documenti sia stato concluso entro l’estatedel 1313, poiché verso la sua fine (c. 94) si citerebbe Arrigo VIIcome ancora vivente. Se, quindi, Da Barberino mostra di conoscerel’Inferno (e il Purgatorio), ne consegue che la pubblicazione avesseluogo intorno alla metà circa del 1313: da qui, tra l’altro,l’obbligo di ritenere che la famosa ‘profezia di Niccolò’, rivoltaad un evento dell’aprile 1314, sia autentica, e che il riferimentodel canto XXIII del Purgatorio non sia associabile, come sembra, allabattaglia di Montecatini (sul punto si tornerà nel seguito);
b)l’ipotesi di Giuseppe Vandelli, per il quale Da Barberino scrive ilcommento entro i primi mesi del 1314, in ogni caso primadell’aprile, visto che Francesco citerebbe, ad un certo punto delsuo commento (c. 91), Clemente V ancora regnante. Vandelli credeperaltro che la profezia di Niccolò sia post eventum, pertanto sivincola a credere che a quell’altezza (primi mesi del ’14) fossepubblicato – e che quindi Francesco conoscesse – solo un primogruppo di canti, mentre il canto XIX e i seguenti erano per alloradi là da venire;
c)l’ipotesi di Giorgio Petrocchi, per il quale Da Barberino protrassela stesura del suo commento ai Documenti fino al secondo semestre 1314o, al limite, entro i primi mesi del 1315 (è assolutamente cogente,come vedremo, il termine ante quem del 28 aprile 1315), ma, quantoall’Inferno, solo per sentito dire, non avendone materialmente lettoneppure un verso.
In ciascuna delle tre tesi, come si mostrerà, vi sono elementi diincongruenza tali da giustificare un supplemento d’indagine. In primoluogo, per dirimere la questione barberiniana è necessario svilupparel’analisi su due piani: la biografia di Francesco, onde dedurne i terminidi composizione dell’opera e del relativo commento; la sequenza dellechiose apposte dall’autore ai suoi Documenti d’Amore, in particolare quelledirettamente o indirettamente riguardanti l’Inferno, al fine di precisarnela cronologia.
Francesco nasce a Barberino di Valdelsa, nella pieve di S. Piero inBossolo, nell’agosto 1264, figlio del notaio Neri (il nonno, Ranuccio,4 FRANCESCO DA BARBERINO, Documenti d'Amore secondo i manoscritti originali, 4 voll., a cura diF. Egidi, Roma, Società Filologica Romana, 1905-‘27 (rist. anast. Milano, Arché,1982).
4
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
era anch’egli notaio)5. Da adolescente studiò a Firenze, per spostarsipoi a Bologna (1285 ca.), al fine d’intraprendere gli studi superiori didiritto. Esercitò la professione notarile dapprima a Bologna (1292-‘96),con soste documentate a Imola (1293) e Napoli (1294)6, al servizio delvescovo Sinibaldo de’ Miliotti; poi a Firenze, al servizio di duevescovi, Francesco Monaldeschi (1297-1301), con almeno una sosta nellaRoma bonifaciana (1298), e infine Lottieri della Tosa (1301-‘03). Nel1304 diversi indizi lasciano credere che abbia lasciato la Toscana,portandosi in Veneto. Le maggiori probabilità sono per Padova come sedestabile, alla cui Università Francesco riprese gli studi in legge invista della laurea in diritto canonico e civile. Da Padova si portò perun certo periodo a Treviso, a cavallo tra il 1307 ed il 1308, dove forse– ma la prova manca – fu familiare del despota fiorentino Corso Donati, cheallora, per pochi mesi, vi esercitò le funzioni di Podestà7. Francescodové a quel tempo portarsi per un periodo non breve a Venezia, altrimentinon si spiegherebbe il delicatissimo incarico affidatogli dallaRepubblica di S. Marco, sul principio del 1309, di accompagnare, inqualità di esperto di leggi, l’ambasceria in partenza per Avignone,composta da Giovanni Zen, Delfino Delfini e Piero Quirini (vi sisarebbero aggiunti nell’agosto 1311 Francesco Dandolo e Carlo Quirini).Venezia aveva invaso Ferrara a fine 1308 ed era pertanto incorsa nellascomunica (27 marzo 1309) e nell’interdetto (aprile 1309). La Chiesavantava diritti su quella città, rimasta senza signore alla morte di AzzoVIII d’Este (31 gennaio 1308). Per ottenere il ritiro dei provvedimentipapali era cruciale aprire tempestivamente una trattativa diplomatica,appunto quella cui partecipò Francesco da Barberino. Per sua esplicitaammissione sappiamo che, credendo inizialmente di dovervisi fermare perun bimestre, erano sopravvenute novità (cioè la scomunica el’interdetto), ragion per cui dovette prolungare la sua permanenza «perannos iiiior et tres menses» (c. 94), con ciò portandoci fino all’incircaalla primavera del 1313, con somma verosimiglianza intorno all’aprile. 5 I materiali consultati per la biografia di Francesco da Barberino si trovanoin: A. THOMAS, Francesco da Barberino, cit.; F. MAZZONI, Per Francesco da Barberino,«Miscellanea Storica della Valdelsa», LXX, 1964, pp. 173-98; M. PRANDI, Vincenzo diBeauvais e Francesco da Barberino, «Italia Medioevale e Umanistica», XIX, 1976, pp.133-61. Cfr. altresì C. GUIMBARD, Recherches sur la vie publique de Francesco da Barberino,«Revue des Etudes Italiennes», XXVII, 1982, pp. 5-39. Lo studio meglio informatoè C. C. CALZOLAI, Messer Francesco da Barberino nel VII centenario della nascita, Barberino diVal d’Elsa-Firenze, ICAT, 1964. 6 Sullo scorcio del 1294 Francesco è a Napoli, dove poté vedere Celestino V,alla vigilia del «gran rifiuto».7 Cfr. G. BISCARO, Francesco da Barberino al seguito di Corso Donati, «Nuovi StudiMedievali», I, 1924, pp. 255-62.
5
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
La situazione diplomatica giunge ad una prima cruciale svolta tra iltardo 1312 e il gennaio 1313, allorché Clemente V scrive al doge ed alMaggior Consiglio veneziano (26 gennaio 1313) preannunziando l’imminentepromulgazione della bolla di accordo, che sarà poi la Decet sedis del 17febbraio 13138. Lo stesso 26 gennaio il papa promulga la bolla Adperpetuam rei memoriam, con cui si annullano gli impedimenti su figli enipoti di veneziani, fino alla quarta generazione, ad accedere agliuffici ed alle dignità attribuite dalla Chiesa, revocando altresì lecancellazioni di benefici già detenuti da veneziani, inflitte conl’interdetto. Una conciliazione, peraltro, che Venezia paga a caroprezzo; infatti, per ottenere la revoca delle sanzioni e riprendersil’egemonia sui traffici adriatici la Repubblica di S. Marco sborseràufficialmente due rate da 25.000 fiorini d’oro, rispettivamente entro il15 settembre 1313 ed il 15 marzo 13149. Francesco Dandolo, il capo-delegazione, lascia Avignone poco tempo dopo l’emanazione della Decetsedis, lo ritroviamo infatti il 12 maggio tenere una relazione solennesullo stato delle trattative diplomatiche dinanzi al doge ed al MaggiorConsiglio. Lo stesso Francesco da Barberino tra la fine del 1312 e gliinizi dell’anno successivo comunica al doge veneziano Giovanni Soranzo(insediatosi nell’infuriare della controversia il 13 luglio 1312)l’imminente pubblicazione della bolla Decet sedis di Clemente V10.
Dall’esperienza avignonese Francesco riportò anche un risultato,diremmo, privato: con la data del 29 marzo 1313 la Cancelleria pontificiagli rilascia l’autorizzazione a sostenere l’esame dottorale in utroque iurepresso una sede episcopale di sua scelta, tra Firenze, Padova e Bologna(i tre centri della sua formazione giuridica). È doveroso ritenere, comefanno gli studiosi più avveduti, che solo al ricevimento di così altecommendatizie Da Barberino facesse ritorno in Italia, anche perché dovevafare i conti con la fama di collaborazionista di Arrigo VII piovutaglisul capo all’indomani della lettera che egli inviò nel 1311 al monarca(il che gli precludeva momentaneamente la Toscana, in gran parteantimperialista). Fatto sta che una lettera-citazione della Cancelleriaimperiale del 30 maggio 1313, contenente un’intimazione a presentarsi al8 Il 16 settembre 1312 Venezia annuncia la sopraggiunta riconciliazione colpapa; il 7 ottobre i Legati pontifici danno licenza a tutte le città diriprendere il traffico con la Serenissima.9 Dal 15 marzo 1314, pagata la seconda rata della multa, Venezia poté ritenersiliberata dalle sanzioni, riaprendo ufficialmente i canali diplomatici, rimastiinterrotti dal momento della scomunica (1309).10 Gli eventi citati sono ottimamente ricapitolati da G. PADOAN, Il lungo cammino,cit.. Fondamentale G. SORANZO, La guerra fra Venezia e la S. Sede per il dominio di Ferrara: 1308-1313, Città di Castello, S. Lapi, 1905.
6
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
campo pisano di Arrigo entro il 24 giugno, lo indica al primo posto comeresidente a Venezia11. Ciò vuol dire che Francesco, lasciata Avignonenell’aprile del 1313, era rientrato in Italia e, precisamente, si erariportato nella città da cui era partito più di un quadriennio prima:Venezia. In laguna Francesco dové trattenersi diverso tempo finché, il 28aprile 1315, è, sulla fede di documenti, in Firenze, addottorato sottol’egida del vescovo Antonio dell’Orso12. Altrettanto sicuro è che l’8agosto 1313 Francesco sia ancora a Venezia: in quella data infattirilascia procura a Piero di Giovanni da Friena, affinché portiall’attenzione del vescovo fiorentino le commendatizie pontificie e siprendano gli accordi per la determinazione dell’esame. Si può quindidedurre, con somma verosimiglianza, che Francesco si portasse da Veneziaa Firenze e vi sostenesse l’esame nel corso del 1314. Ai suoi successivispostamenti siamo poco interessati ai fini danteschi, per cui litralasceremo.
Dato per fermo l’itinerario di Francesco, in particolare la sua sicurapermanenza oltralpe fino al marzo-aprile 1313, procediamo ad un’analisistringata della struttura coronologico-compositiva dei Documenti d’Amore ead una radiografia essenziale delle chiose d’interesse dantesco. A talescopo seguiremo da vicino l’ordine in cui testo e chiose ci sono offertedal manoscritto Barb. Vat. 4076 (ms. A)13. Il manoscritto A ci presentaun’ordinata struttura quadripartita: testo volgare, testo latino, chioselatine e miniature. Fin da un’analisi superficiale, emerge un lampantesquilibrio tra testo e chiose, tanto da suscitare l’impressione che ilprimo e le seconde siano nati in maniera sostanzialmente indipendente.Tale impressione viene confermata da un’analisi più minuta. In unafondamentale chiosa Francesco ci informa di aver iniziato il testo deiDocumenti (corrispondente al moderno «regole» o «insegnamenti») poco
11 Il testo è riportato da F. NOVATI, Francesco da Barberino e Arrigo VII, «ArchivioStorico Italiano», XIX, 1887, pp. 380-2.12 C. SOCCI, Alcune notizie riguardanti Francesco da Barberino, «Miscellanea Storica dellaValdelsa», XV, 1907, pp. 33-6. Si osservi che, nell’explicit ai Documenti d’Amore,Francesco si dichiara ancora scolaro di diritto, ciò obbliga a ritenere chel’opera vedesse la conclusione entro la fine del 1314 o, al limite, ai primi del1315.13 D. GOLDIN, Testo e immagine nei Documenti d’Amore di Francesco da Barberino, «Quadernid’Italianistica», I, 1980, pp. 125-38. Per un aggiornamento circa lecontestazioni in merito all’autografia del manoscritto barberiniano, indisaccordo con quanto stabilito da Egidi, cfr. P. SUPINO MARTINI, Per la tradizionemanoscritta dei Documenti d’Amore di Francesco da Barberino, «Studi Medievali», XXXVII,1996, pp. 945-54. Vale osservare che seppure il ms. non sia autografo, fu certoesemplato sotto la diretta e scrupolosa supervisione dell’autore; il tema èperaltro irrilevante per i temi qui esaminati.
7
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
avanti la sua partenza per la Francia, dove, non avendo portato con sé iquaderni dell’altra opera che aveva in gran parte composto, il Reggimentoe costumi di donna, si risolse a continuarlo fino a compimento (Doc. Am., I,pp. 33-4). Un’ulteriore chiosa ci assicura che il testo dei Documenti fueffettivamente terminato in Provenza (Doc. Am., III, p. 224). Si concludequindi che Francesco compose il testo dei Documenti all’incirca tra il1308 ed il 1310-‘11, allorché avviò la stesura delle chiose latine. Inrealtà, è facile constatare che la parte realmente impegnativa dell’operaè proprio quella delle chiose, alle quali risulta che Francesco lavorasseper ben 16 anni (Doc. Am., I, pp. 262-3). Poiché l’opera fu sicuramentecompiuta entro il 1314 circa, è elementare dedurre che quel lavoro fosseiniziato al più tardi intorno al 1299, con ciò confermando in pienol’ipotesi che Francesco avesse concepito in origine un’opera di generetrattatistico-didascalico, indipendente dai Documenti.
La deduzione più naturale è che questi ultimi furono ad un certo puntopoco più che l’appiglio per sfoderare la vasta, sebbene non tutta diprima mano e ben digerita, erudizione classicizzante dell’autore,affidata non ad un ponderoso trattato enciclopedico, ma ad una piùattraente opera poetica in volgare: «E non si può negare ch’egli non siastato in questo geniale»14. Tale ipotesi viene ampiamente confermata, tral’altro, da una chiosa in cui l’autore stesso, constatando la vistosasproporzione della chiosa rispetto al testo sottoposto a commento, eperfino lo scarso legame reciproco, se ne scusa (Doc. Am., I, p. 65):
È questa la materia [scil. delle chiose] che, già pronta, egli venivaassegnando alle varie parti ed ai varj documenti via via che preparava il testo,errando anche – fortunatamente! – una volta, così che, confessando l’errore, ciha senza volere illuminato su tutta la sua opera15.
In conclusione, nelle chiose confluiscono cospicui materiali giàpredisposti dall’autore, originariamente destinati ad una compilazione acarattere enciclopedico. Francesco se ne serve ad abundantiam nel commentoai Documenti, inserendovi, ove se ne presenti l’opportunità, sezioni dicommento testuale e quelle lezioni di attualità, apprese stando mundo, chefrattanto veniva maturando (Doc. Am., II, p. 60). Proprio questisporadici riferimenti all’attualità ci consentono di seguirecronologicamente lo svilupparsi della stesura delle chiose. Ciò, comevedremo, è elemento di capitale importanza poiché, assodato che ad uncerto punto Da Barberino fa riferimento alla prima cantica (tralasciamo
14 F. EGIDI, L’argomento, cit., p. 153.15 Ivi, pp. 154-5.
8
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
per ora se a tutta, a parte o ad alcunché di essa), la data delle chioseci consentirà di datare la prima menzione e quindi la prima diffusionedella cantica medesima:
1. c. 38c: «Dicas cum secum habuerit rationem. Isto vocabulo sepius utitur,secundum quod fertur, Romanorum Rex dominus Henricus qui modo est. Dum dealiquibus fertur ei quod gentem habeant se maiorem, respondet: “Et nosDeum, quia iustitiam habemus nobiscum”. Et certe in pluribus, quasimiraculosa res sit, eum magna prosperitas commitatur».
La chiosa ci riporta al periodo avignonese di Francesco, dopo ladiscesa di Arrigo VII in Italia, il quale è citato quale Re dei Romani –qualifica che perse il 29 giugno 1312 allorché cinse la coronad’Imperatore –; ed è giovato dalla sorte in pluribus, il che non si poté piùdire nel corso del 1312, contestualmente al rivoltarglisi contro deiComuni italici e, soprattutto, alla brusca inversione di rotta diClemente V, istigato da Filippo il Bello di Francia. Siamo quindi, consomma verosimiglianza, nel 1311 o, al massimo, ai primi del 1312;
2. c. 43: istam XLII regulam glosabimus cum novitatibus Bononiensium
dominarum, cum simus in earum civitate ad presens.
La chiosa ci riporta a qualche tempo dopo il marzo 1313: Francesco è aBologna, è quindi rientrato in Italia e fa tappa nella città emiliana.Con matematica certezza siamo, al più presto, tra aprile e i primi dimaggio del 1313: ricordiamo che il 30 maggio è citato dalla Cancelleriaimperiale quale residente veneziano;
3. c. 50b: Una pars istius regule habet exemplum in Tuscia et maxime incivitate Florentie; ad quam cum venisset Teotonici pauci numero, sciveruntFlorentini et alii stare ad duram et se in periculo belli non ponere quiadubius est eventuus belli. Sicque tenentes rem in longum iuvit eos mora:et capud illorum mortuum est, et [Florentini] tenuerunt terram suam.Quidam rudes dicebant: Ecce magna verecundia Florentini non bellarehabentis longe numero gentem majorem! Sapientum vero dictum contrarium,morto dicto capite, comprobatum est. Alia pars regule habet exemplum inLucanis qui sciverunt male confidere et male custodire suam civitatem.
La prima parte della chiosa, in perfetta coerenza e successione con lachiosa precedente, ci porta dopo l’ottobre 1312, visto che viene dato pertrascorso l’assedio arrighiano a Firenze. Senza dubbio siamo anche dopoil 24 agosto 1313, visto che viene citata la morte di Arrigo, avvenuta in
9
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
quella data. Infine, a norma della seconda parte della chiosa, che citala presa di Lucca da parte dei pisani guidati da Uguccione dellaFaggiuola, siamo dopo il 14 giugno 1314. Rifiutandosi di spostare lacronologia delle chiose ad un tempo successivo alla morte di Arrigo VII,Egidi, seguito oggi da pochi epigoni, ha contestato duramente chel’assedio teutonico di Firenze citato da Francesco Da Barberino fossequello arrighiano, ritenendo inaccettabile il riferimento ai «Teotonicipauci numero» e che, di conseguenza, la morte del capo degli assediantifosse quella di Arrigo. L’infondatezza della contestazione emerge conevidenza (oltre che dal movente, l’amor di tesi) dalla natura dellecontrodeduzioni offerte. Egidi si limita ad assicurarci che a sfogliareben bene i vari episodi bellici della storia fiorentina di quegli anni,altro accaduto similare, che egli peraltro ignora e si astienedall’indicare, sarebbe stato rintracciato. Giustamente Giorgio Petrocchiribatte: «Fatto si è che episodi del genere, e poi così precisamentedescritti, non vi sono»16.
Parimenti irricevibili le argomentazioni di Vandelli, volte a riferirela seconda parte della chiosa ad alcuni episodi bellici minori (quello diPontetetto, di 8 mesi prima) della guerra pisano-lucchese, tantoesplicito è il riferimento alla presa di Lucca: «Lucanis qui sciveruntmale confidere et male custodire suam civitatem», e Pontetetto non èprecisamente la «suam civitatem» dei lucchesi. Siamo con certezza nelsecondo semestre 1314;
4. c. 63b: quia sumus in civitate sua Mantuana ex casu istam partemglosantes.
La chiosa ci porta nel mezzo della questione dantesca. Da essasappiamo che Francesco è in viaggio e si trova a Mantova. Sono due leoccasioni sicure in cui egli si mosse da e per Venezia, e poté quindisoggiornare a Mantova: la prima, verso l’aprile-maggio 1313, provenienteda Avignone e diretto in laguna; la seconda, uscente da Venezia perdirigersi a Firenze, cosa che fece nel corso del 1314. Visto che, invirtù della chiosa precedente è trascorso il giugno 1314 è da credere cheFrancesco sostasse a Mantova (presumibilmente proveniente da Venezia ediretto a Firenze), alla metà del 1314;
5. c. 63c: Hunc [scil. Virgilium] Dante Arigherij in quodam suo opere quoddicitur Comedia et de infernalibus inter cetera multa tractat, commendatprotinus ut magistrum; et certe, si quis illud opus bene conspiciat,
16 G. PETROCCHI, Itinerari danteschi, Roma-Bari, Laterza, 19942, p. 66.10
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
videre poterit ipsum Dantem super ipsum Virgilium vel longo temporestuduisse, vel in parvo tempore plurimum profecisse.
La chiosa è decisiva per attestare se e in che misura, a quell’altezzacronologica (secondo semestre 1314), Francesco conoscesse l’Inferno.Secondo Petrocchi, Francesco mentre scrive non ne ha presente neppure ilprimo canto:
Si potrebbe [...] giungere a restringere la cognizione diretta che Francescoha della Commedia, soltanto al primo canto [...]. Ma nemmeno questo è possibile.Francesco cade in una lampante contraddizione, che non avrebbe potuto commetterese in grado di leggere o se avesse letto il primo canto [...]. Francescodichiara a tutte lettere di non essere in grado di giudicare se l’apprendimentodell’opera virgiliana da parte di Dante sia frutto di un lungo studio opiuttosto di una sollecita conquista [...]. Se egli avesse letto anche solo ilcanto proemiale [...] avrebbe risolto da sé il dubbio17.
Si tratta di una conclusione molto gradita agli studiosi poiché lasciale mani talmente libere in fatto di cronologia che non ha esitato asposarla anche chi, come Giorgio Padoan, ha idee affatto diverse, anziopposte a Petrocchi, in tema di composizione e divulgazione dell’Inferno18.Tuttavia, c’è un forte indizio che Francesco avesse letto almeno qualcheverso della prima cantica ed è la citazione testuale dei versi in cuiDante saluta Virgilio quale suo maestro (vv. 85-7). Come poteva Francescoessere così calzante se non aveva, come vorrebbe Petrocchi, che poche evaghe idee su di un’opera in corso di pubblicazione? In quel caso avrebbepotuto solo mantenersi su un piano generico, mai ripetere verbatimespressioni di cui solo un lettore, e sia pure sommario e distratto,poteva essere a conoscenza. Molto più sensata la deduzione di Vandelli:
[Mentre scrive la chiosa, Francesco parla dell’Inferno come d’opera che, almenoparzialmente, potesse essere da tutti consultata e che quindi dovesse essere giàpubblicata, come risulta dall’]avverbio protinus unito alla frase hunc [...]commendat ut magistrum: con tale avverbio si accenna a una commendatio di Virgiliocome maestro, la quale s’incontra subito al principio della Commedia [...].Altrettanto evidente poi a me pare che Francesco citasse a memoria: se, mentrescrive le parole che stiamo considerando, avesse avuto sotto gli occhi il primocanto [...] non avrebbe messa innanzi l’ipotesi del parvum tempus, giacché non
17 Ivi, p. 70.18 Petrocchi, com’è noto, ritiene la prima cantica scritta nel 1304-‘08 eritoccata nel 1313-‘14, con pubblicazione integrale nel secondo semestre del1314; Padoan che la prima cantica sia stata scritta nel 1306-‘14 e pubblicataper gruppi di canti nel corso della novennale stesura.
11
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
gli sarebbe sfuggita la frase della terzina precedente al verso ora ricordato“Vagliami il lungo studio” con quel che segue19.
Sul punto si tornerà conclusivamente nel seguito.
6. c. 91c: Dum essem in Curia tempore istius domini Clementis in cameracamerarii sui, dominus Petrus de Columna Sancte Romane Ecclesiecardinalis20.
La chiosa ci mette davanti un problema di cronologia interna dellechiose. Infatti, alla lettera il testo parla di «questo Clemente», ossiadi un Clemente che si potrebbe credere ancora regnante. Poiché Clementemorì il 20 aprile 1314, ne risulterebbe una sfasatura con la datazioneben più tarda delle chiose precedenti. Basti ricordare che la chiosavista al punto 3. ci aveva portati già oltre il 14 giugno di quell’anno.È questa la chiosa che Vandelli ritiene determinante per la datazione delcommento. Se, egli argomenta, quasi al termine dell’opera Clemente èancora vivente, vuol dire che Francesco scrive la chiosa infernale benprima dell’aprile 1314. Ma poiché l’Inferno reca in sé un riferimento allamorte proprio di Clemente, occorre credere ad una pubblicazione parzialedella cantica, laddove gli ultimi canti, almeno dal XIX in avanti, eranoancora di là da venire. Le varie congetture di Vandelli sarebbero daaccogliere solo ove fossimo certi che per Francesco iste significhinecessariamente colui che è, mentre ille starebbe per colui che non è più: il chenon è, come ha mostrato Petrocchi citando opportunamente la chiosa a c.97b, dove il valdelsano scrive ille venetus riferito a Marco Polo, allora(1314) vivo e vegeto. Non è tutto. Come si è detto, per ammettere la tesidi Vandelli bisognerebbe anche cambiare i connotati alla chiosa a c. 50b.Ora, tralasciando che il riferimento del notaio valdelsano èespressamente alla conquista della città di Lucca (ripetiamo, «Lucanisqui sciverunt male confidere et male custodire suam civitatem»), c’è danotare un’ulteriore incongruenza: Francesco sta enumerando vicende legateall’attualità, alla ricerca di fatti concludenti che suggellino lasolenne lezione ch’egli vuol impartire ai suoi lettori, i.e. la bontà
19 G. VANDELLI, Per la datazione, cit., p. 8.20 La chiosa continua come segue: «loquebatur ei in favorem quorundamexpediendorum inter cetera dicens ipsi procurabunt quod usque ad certum tempusfiet talis provisio camere. Ille camerarius respondit de dabo non curo pluspresens laudo futuro plus valet hoc tribuo quam tribuenda duo. Illa dieinfirmatus est et infra X dies cum toto auro suo decessit et forsitan minusbene. Unde Roma rapit mercas bursas exaurit et arcas ut tibi iam parcas fugePapas et patriarcas. Namque sunt ibi plures quam celi sidera fures».
12
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
della tattica del temporeggiamento in tempo di guerra. È perciò lampantecome egli non potesse riferirsi ad un episodio minore, quale quello diPontetetto (novembre 1313), per il semplice motivo che esso, del tuttointerlocutorio, non possedeva minimamente quel valore didascalico di cuil’autore abbisognava ai suoi fini. In più, espressioni come «dum essem» esoprattutto «tempore» (perché dire «al tempo di questo Clemente» sequesto tempo era ancora in corso?) lasciano chiaramente intendere unriferimento indefinito al recente passato circa il pontificatoclementino.
In breve, con il massimo di concessione possibile, possiamo ammettereche la chiosa a c. 91c non provi di per sé sola né che al tempo Clementefosse vivo, né che fosse morto. La deduzione più probabile si ottieneinserendola nella complessiva sequenza delle chiose. Posta com’è ad unlivello così basso (agli oltre 9/10 di un commento concluso nel secondosemestre 1314), dopo altre chiose riferentisi a fatti del giugno 1314, invia di probabilità concludiamo che Clemente presumibilmente non fosseallora più in vita.
7. c. 94: In quadam epistula quam vice Romane Corone ad Augustum formavi,dicitur circa finem: ‘Et erimus omnes in sedibus nostris nec erit invidiain minori neque superbia in maiori’. Quam epistolam si videre volueris,utilem videbis metaphoram.
La chiosa ci pone davanti una situazione identica a quella appenavista per la chiosa precedente. Secondo il ragionamento di Egidi,Francesco citando Arrigo VII semplicemente come «Augusto», l’intenderebbecome ancora regnante, ossia in un modo che aveva ragion d’essere fino al24 agosto 1313. Di qui la sua convinzione che il commento latino fosseterminato tra la primavera e l’estate di quell’anno. È superfluo citarele argomentazioni egidiane per retrodatare i riferimenti ad eventistorici molto più tardi, desumibili dalle chiose precedenti (assedio diFirenze e guerra pisano-lucchese). Appare ad ogni modo discutibilecomprovare le proprie tesi appellandosi ad eventi storici di cui siconfessa l’ignoranza, finendo col chiedere agli oppositori la prova delleproprie deduzioni. A ben vedere, inoltre, dal contesto del discorsosappiamo che Francesco sta riferendosi ad un evento passato, cioè al suoinvio di una lettera ad Arrigo, datata 1311. Francesco potrebbe intenderesemplicemente che al tempo di quella lettera Arrigo era Augusto, il che sarebbeperfettamente esatto. Inoltre se la c. 94, come vorrebbe Egidi, fossedella primavera-estate del 1313, ricordando che quando Francesco scrivela c. 43 è a Bologna (si trova cioè in Italia: siamo quindi non prima
13
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
dell’aprile-maggio 1313), ciò porterebbe alla conclusione per cui ben 52carte delle chiose – quasi i 6/10 dell’intera opera – sarebbero statescritte nel giro di 2 mesi! Il che è un assurdo evidente, visto che le 99carte delle chiose assorbirono l’autore per circa quattro anni, dal1310-‘11 al 1314 inoltrato.
Teniamo poi presente che, a rigor di termini, la semplicedenominazione di Augusto sarebbe da riferire ad un tempo anteriore non al24 agosto 1313 ma al giugno 1312, poiché Romanorum rex semper Augustus è laformula con cui il lussemburghese accompagnò il proprio nome negli attiufficiali fino al 29 giugno 1312. Dopo di allora egli vi apposel’appellativo di Imperator. Francesco, come dimostrano la sua lettera del1311 (in cui si rivolge a «domino Henrico [...] Romanorum regi dignissimoet semper Augusto») e la stessa chiosa a c. 38c (dove parla di «RomanorumRex dominus Henricus»), ha molto ben presente il valore formale di taliappellativi, sicché se avesse voluto parlare dell’Imperatore regnante,avrebbe apposto il dovuto titolo di Imperator. Se non l’ha fatto vi sonodue sole spiegazioni: o sta scrivendo quando Arrigo non era ancoraImperatore, cioè prima del giugno 1312, il che è irricevibile poiché lachiosa in questione fu scritta sicuramente in Italia, pertanto post marzo1313, quando Arrigo era Imperatore da quasi un anno; oppure, come si èdetto, Da Barberino sta parlando di chi era Augusto al momento in cui gliaveva inviato la famosa lettera del 1311, di cui intende parlare. Il checoincide ad unguem con la realtà storica. Non solo. Posto che Francescoscrive sicuramente in un periodo in cui Arrigo – vivo o morto non importa– ha già ricevuto la corona imperiale, l’omissione del titolo è perfinosintomatica: egli, che si era improvvidamente esposto con la lettera del1311 (ma a quel tempo Arrigo si muoveva con l’appoggio della Chiesa), dal1312 veleggiava lontano dalle ormai malsicure sponde imperialiste, sicchési possono facilmente comprendere i motivi della sua reticenza.
14
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
L’ARGOMENTO UGURGIERIANO-LANCIANOIl secondo argomento esterno per fissare la pubblicazione dell’Inferno
(e del Purgatorio), di grande importanza sebbene meno esplorato daglistudiosi, lo si può dire «argomento ugurgieriano-lanciano» poiché lecitazioni, tra loro collegate, si trovano in opere, cioè ivolgarizzamenti dell’Eneide di Ciampolo degli Ugurgieri, letterato senesedi secondo piano, e Andrea Lancia, notaio e letterato fiorentino un temporitenuto, a torto, autore dell’Ottimo commento (1334 ca.) e di numerosivolgarizzamenti21. Tra i pochi sicuri, il volgarizzamento lanceodell’Eneide, per il quale ci serviremo delle osservazioni di GianfrancoFolena22; per quello ugurgieriano seguiremo il contributo di Giulia21 Dantista di primo piano nella Firenze medio trecentesca, Andrea Lancia è notoagli studiosi di letteratura delle origini per i sui volgarizzamenti, molti deiquali attribuitigli senza fondamento: «Il primo [volgarizzamento] dovette esserequello […] delle Epistulae morales ad Lucilium di Seneca […]. [Di alcuni anniposteriore] la più compiuta versione dell’Eneide»; L. AZZETTA, medaglione AndreaLancia, in Censimento dei Commenti danteschi. 1. I Commenti di tradizione manoscritta (fino al 1480), 2voll., Roma, Salerno, 2011, I, pp. 19-35, p. 21 (fondamentale).22 La Istoria di Eneas volgarizzata per Angilu di Capua, Palermo, Mori, 1956. Ilvolgarizzamento virgiliano fu eseguito da Lancia a partire dalla riduzione difrate Anastasio minorita, su commissione del ricco mercante, e sodaleboccacciano, Coppo di Borghese Migliorato Domenichi, cfr. P. FANFANI, Compilazionedella Eneide di Virgilio fatta volgare per Ser Andrea Lancia Notaro Fiorentino, «Etruria», I,1851-‘52, pp. 162-88, 221-52, 296-318, 497-508, 625-32, 745-60; ID., Scritti inediti.Una lettera di Andrea Lancia e due favole di Esopo, ivi, pp. 103-6; P. COLOMB DE BATINES, AndreaLancia, scrittore fiorentino del Trecento, ivi, pp. 18-27; L. BENCINI, Intorno alle opere d’AndreaLancia scrittor fiorentino del secolo XIV, Lezione detta alla Società Colombaria, ivi, pp.140-55; C. MARCHESI, Di alcuni volgarizzamenti toscani in codici fiorentini, «Studi Romanzi», V,1907, pp. 181-4; riporta il II libro C. SEGRE, Volgarizzamenti del Due e Trecento,Torino, Utet, 1953 (successive edizioni, ivi, 1969 e 1980), pp. 569-70; M. T.CASELLA, Il Valerio Massimo in volgare: dal Lancia al Boccaccio, «Italia Medioevale eUmanistica», VI, 1963, pp. 49-136; F. MAZZONI, voce Lancia Andrea, in ED, III, pp.565-6; G. AQUILECCHIA, Dante and the Florentine Chronicles, in ID., Schede di italianistica,Torino, Einaudi, 1976. Le moderne conoscenze sul Lancia sono riprese eradicalmente innovate, con metodo rigorosamente storico e scientifico, dagliormai imprescindibili studi di Luca Azzetta, massimo esperto ed editore delnotaio fiorentino, per cui si vedano almeno L. AZZETTA, Per la biografia di Andrea Lancia:documenti e autografi, «Italia Medioevale e Umanistica», XXXIX, 1996, pp. 121-70;ID., Le chiose alla «Commedia» di Andrea Lancia, l«’Epistola a Cangrande» e altre questioni dantesche,«L’Alighieri », XXI, 2003, pp. 5-76; ID., La tradizione del «Convivio» negli antichi commentialla «Commedia»: Andrea Lancia, l'Ottimo Commento e Pietro Alighieri, «Rivista di StudiDanteschi», V, 2005, pp. 3-34; ID., Nuovi documenti e autografi per la biografia di AndreaLancia, «Italia Medioevale e Umanistica», XLIX, 2008, pp. 345-9; ID., medaglioneAndrea Lancia, cit.. Ad Azzetta dobbiamo l’eccellente edizione degli Ordinamenti,provvisioni e riformagioni del Comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia, 1355-1357, a cura diL. Azzetta, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2001. Lostudioso ha fornito inoltre l’edizione del commento dantesco di Lancia (2 voll.,Roma, Salerno, 2012), un contributo di estremo rilievo nella secolare esegesi
15
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
Valerio23. Nel seguito dell’esposizione vale la seguente tripartizione:dapprima si individueranno i dantismi di maggior rilievo presenti nei duevolgarizzamenti, poi si procederà a datarli, infine se ne fisserà ilrapporto di dipendenza cronologica. Sul primo punto, scrive per ilvolgarizzamento lanceo Folena:
Alla fine del II libro, l’ultimo vano abbraccio di Enea a Creusa è così resodal Lancia, che qui abbandona evidentemente la traccia virgiliana del suocompendio per cogliere l’eco più patetica e possente di Dante, e rinvigorirel’immagine: «Tre volte m’isforzai d’avinghiarle le mani al collo, e altre tantemi tornai con esse indarno al petto». Qui è impossibile pensare a unacoincidenza casuale, a uno svolgimento parallelo sul troppo distante clichévirgiliano [è da richiamare piuttosto] il luogo dantesco dell’incontro conCasella (Purg., II 81)24.
Quanto ai dantismi ugurgieriani, nella descrizione che fa di Cerberoall’altezza del VI libro, Ciampolo scrive:
Cerbero, fiera crudele e diversa, cum tre gole caninamente latra, e tienequesti regni, e orribilemente giace in una spelonca a rincontra al quale,vedendo la prophetessa avere i colli pieni di serpenti, la terra cum piene lepugna la gittò dentro alle bramose canne.
Conclude Giulia Valerio:
Sulla fedele traduzione di Virgilio si innestano, trasportati di peso, iversi 13, 14 e 17 del VI canto dell’Inferno25.
del poema. Degli importanti studi di Saverio Bellomo si tengano almeno presenti,sebbene si inclini ad identificare con poco fondamento Lancia e Ottimo, ID.,Primi appunti sull’Ottimo commento dantesco, «Giornale Storico della LetteraturaItaliana», CLVII, 1980, pp. 369-82 e 532-40. Di Bellomo la importante voce Lancia,Andrea nel suo Dizionario dei commentatori danteschi, Firenze, Olschki, 2004, pp. 304-13.23 G. VALERIO, La cronologia dei primi volgarizzamenti dell’«Eneide» e la diffusione della «Commedia»,«Medioevo e Rinascimento», X, 1985, pp. 3-18. Per Ciampolo ed il suovolgarizzamento cfr. L. GROTTANELLI, Genealogia e storia degli Ugurgieri conti della Berardenga,Siena 1881; A. GOTTI, L’«Eneide» volgarizzata nel buon secolo della lingua da Giampolo di Meo degliUgurgieri senese, Firenze, Le Monnier, 1858; A. PELLEGRINI, L’«Eneide» di Virgilio volgarizzatasecondo un nuovo codice del secolo XIV, «Rivista Abruzzese», XVI, 1901, pp. 120-8, 162-8,341-8, 425-40; A. LUSINI, Il Castellare degli Ugurgieri, «La Diana», XIV, 1939, pp. 286-90; C. SEGRE, Volgarizzamenti, cit., pp. 73-96; G. GORNI, Notizie su Dante, Andrea Lancia el’Ovidio volgare, «Studi Medievali», XXIX, 1988, pp. 761-9.24 La Istoria di Eneas, cit., pp. XXXIII-XXXIV.25 G. VALERIO, La cronologia, cit., p. 16.
16
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
Di importanza capitale il richiamo da parte di Ciampolo ad un versodel Purgatorio:
Spia evidentissima [di echi danteschi] è il virgiliano agnosco ueteris vestigiaflammae tradotto da Ciampolo con l’endecasillabo dantesco (Purg., XXX 48)«conosco i segni dell’antica fiamma»26.
Quando Ciampolo scrive, non solo l’Inferno, ma anche tutto il Purgatorio èdi dominio pubblico.
Il secondo punto dell’analisi concerne l’esame degli elementi utili aduna più precisa datazione dei due volgarizzamenti. Per Andrea Lancia ècogente, come termine ante quem, il 1316, segnato nel codice Laur.Martelli 2, c. 1r, il quale – quasi certamente più tardo – ricopiapresumibilmente l’antigrafo, sicché si dovrà collocare la copia delvolgarizzamento lanceo non più tardi di quell’anno che, secondo lo stilefiorentino, si chiuse il 24 marzo 131727. Sempre attenendoci ai datioggettivi, il testo di Ciampolo è anteriore al 1360, termine fornito dalcodice Maiocchi (oggi Laur. Acquisti e Doni 314) che lo contiene28. Sutali basi, si può concludere che parte del Purgatorio è già diffusa in areatoscana entro il 1316.
A ben più rilevanti conclusioni ci riporta il terzo ed ultimo puntodell’argomento, concernente i rapporti di dipendenza tra il testo lanceoe quello di Ciampolo. Secondo la communis opinio degli studiosi, avvaloratada Folena ma quasi certamente errata, il testo di Lancia era presente aCiampolo mentre questi provvedeva alla stesura del propriovolgarizzamento:
Il Lancia rende Virgilio attraverso un intermediario, la riduzione in prosa[latina] di Anastasio minorita [...]. Più che una riduzione in prosa essa vaconsiderata [...] un centone di brani virgiliani collegati spesso malamente
26 Ivi, pp. 15-6. Per un curioso tentativo di anteporre la prosa di Ciampolo aiversi danteschi cfr. A. BENCI, Volgarizzamenti antichi dell’Eneide di Virgilio: traduzioni di essafatte da Annibal Caro, da Vittorio Alfieri, dal padre Solari, e volgarizzamento nuovo di Michele Leoni,«Antologia», II, 1821, pp. 161-200.27 Scrive Gianfranco Folena, op. cit., p. XXXIII: «Per l’Eneide lancea abbiamo unterminus ad quem che ci pare incontestabile nella data 1316 del codice Martelli».Folena attribuisce all’opera lancea la data del 1314-‘16. Devo alla cortesiadella prof.ssa Rosetta Migliorini Fissi la segnalazione circa la data del 1316,che sarebbe materialmente da riferire non al codice Martelli, ma presumibilmenteall’antigrafo.28 Cfr. G. VALERIO, I volgarizzamenti, cit., p. 7.
17
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
[...]. La traduzione di Ciampolo, posteriore di non molti anni, [ci pare]letterariamente più matura e raffinata29.
In realtà, come emerge dall’esame ben altrimenti diligente esupportato da puntuali riscontri di Giulia Valerio, le cose stannoall’opposto:
Opinione comune [...] è l’anteriorità del compendio del Lancia allatraduzione dell’Ugurgieri [...]. [Invece] la versione del Lancia [...] sipresenta come opera di divulgazione, che procede ora riassumendo, oraaddirittura eliminando descrizioni ed episodi, a volte traducendoscrupolosamente i versi latini, sulla scorta della versione di Ciampolo. Che untesto latino [...] sia stato consultato dal Lancia, oltre alla fedele traduzionedell’Ugurgieri, risulta da alcuni errori presenti nel suo volgarizzamento, chepossono derivare soltanto da lezioni corrotte di un testo latino, o dafraintendimenti di questo [...]. Queste corruzioni denunciano anche la scarsaattendibilità del manoscritto consultato dal Lancia [...]. [Fatto sta che]mentre [...] alcuni fraintendimenti dell’Ugurgieri passano nel testo del Lancia,non si verifica mai il caso contrario, che i frequentissimi errori del Lancia,così gravi da ledere il senso del racconto, lascino tracce nella sorvegliatatraduzione di Ciampolo30.
Dato che Ciampolo precede (e non segue) Lancia, e visto chequest’ultimo scrive entro il 1316-‘17, si dovrà dedurre che Ciampoloscriva entro il 1316, termine ante quem per la pubblicazione del Purgatorio,di tutto il Purgatorio, visto che il letterato senese ne ha presente finoalmeno al XXX canto. Alla conclusione di una pubblicazione integraledella seconda cantica entro i primi mesi del 1316, ci conduce, per viaindipendente, anche il successivo argomento.
29 La Istoria di Eneas, cit., pp. XXXVIII-XXXIX.30 G. VANDELLI, Per la datazione, cit., p. 8.
18
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
L’ARGOMENTO MARTINIANOIl terzo argomento può essere denominato «martiniano» poiché si trova
in un’opera, un dipinto (quello della Maestà), eseguito dal grandepittore senese Simone Martini (1284-1344)31. Nel dipinto, a mo’ di explicit,si trovano inseriti versi di chiara derivazione dantesca. Tali versi, conogni probabilità endecasillabi, componenti una terzina ma parzialmenteilleggibili, seguono lo schema ABA e dicono:
Mille trecento quindici vol[...] / e Delia avia ogni bel fiore spinto / eIuno già gridava: I’ mi rivol[...].
Leggermente più in basso, di dubitosissima ricostruzione, troviamo:«S[...] a man di Symone [...]». Fermo restando il senso, sostanzialmentechiaro, tra le varie proposte le interpolazioni congetturali piùattrattive sono, a parere di chi scrive: a) «volto» per il primo e terzoverso; b) «Siena» e «m’ha (di)pinto» per l’ultimo verso (la cui strutturaendecasillabica resta incerta). Il riferimento a Delia richiama uno degliultimi canti del Purgatorio (XXIX 78):
Conta la suggestione e la pregnanza dell’epiteto classico (usato fra imoderni solo da Dante), che induce probabilmente anche il successivo Iuno, nelquadro di una retorica della perifrasi temporale e stagionale di gusto classico,impensabile senza i precedenti della Commedia32.
In altri versi presenti sullo stesso dipinto – si tratta di due strofedi sette endecasillabi, un’esortazione alla Vergine con relativaresponsio33 – abbondano le citazioni dall’Inferno e dal Purgatorio31 Il contributo più importante sull’argomento, sebbene viziato da una gravesvista sulla data della citazione dantesca, è di F. BRUGNOLO, Le terzine della Maestà diSimone Martini e la prima diffusione della Commedia, «Medioevo e Rinascimento», XII, 1987,pp. 135-54. Cfr. altresì G. MAZZONI, Influssi danteschi alla Maestà di Simone Martini, in ID.,Almae luces, malae cruces, Bologna, Zanichelli, 1939, pp. 333-48; G. CONTINI, SimonMartini gotico intellettuale, in L’opera completa di Simone Martini, a cura di M. C. Gozzoli,Milano, Rizzoli, 1970, pp. 5-8.32 F. BRUGNOLO, Le terzine, cit., p. 150.33 La Vergine rivolta agli angeli: «Li angelichi fiorecti, rose e gigli / ondes’adorna lo celeste prato, / non mi diletta più che i buon’consigli. / Ma talorveggio chi per proprio stato / disprezza me e la mie tera inganna, / e quandoparla peggio è più lodato. / Guardi ciascun cui questo dir condanna!». ResponsioVirginis ad dicta Sanctorum: «Dilecti miei, ponete nelle menti / che li devoti vostriprieghi onesti / come vorrete voi farò contenti. / Ma se i potenti a’ debil’fienmolesti, / gravando loro o con vergogne o danni, / le vostre orazion non son perquesti / né per qualunque la mia terra inganni». La trascrizione qui riportata èquella fissata, da ultimo, da Furio Brugnolo, fededegna rispetto a precedentiversioni.
19
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
(rimarchevole, tra le altre, la corrispondenza tra il «gravando loro ocon vergogne o danni» della responsio, col «tanta vergogna mi gravò lafronte» di Purg., XXX 78), la cui data è ricavabile con sicurezza daltristico sopra citato. Siamo, a norma dell’incipit, dopo il 1315 che, al dilà dei dubbi di lettura, era volto. Ora, in molti Comuni medievali, tracui Firenze e Siena, l’anno cominciava notoriamente non il 1° gennaio mail 25 marzo successivo, giorno dell’incarnazione di Cristo (Pisa seguivalo stesso stile, ma anticipando di 12 mesi esatti). Secondo il calendariomoderno quindi, l’anno 1315 terminò non il 31 dicembre, ma il 24 marzo1316. Non solo. Il tristico ci dice che anche giugno si era già rivolto:siamo cioè nella seconda metà (ovvero alla fine) del mese34. Sappiamoquindi, in perfetta coerenza con l’argomento precedente, che alla metàcirca del 1316 anche il Purgatorio era integralmente pubblicato.
Val la pena riportare, con riguardo alle implicazioni discendentidall’impiego della terzina dantesca quale metro del messaggio religioso ecivile della Maestà, l’intuizione di Gianfranco Contini, per il qualesolo dopo il Dante delle prime due cantiche la terzina acquisisce quellavalenza di schema politico, di «laica celebrazione dei valori supremi,sintesi di civile appunto e sacro»35. Ecco perché l’estensore di queiversi ricorse alla terzina dantesca nell’affresco: rivestire la rampognamoralistica contro le discordie civili che dilaniavano il Comune di Siena(incruditesi proprio nel 1315), – rampogna posta non a caso sotto ilsicuro usbergo della Vergine e dei Santi –, con quella forma metrica che,proprio allora, Dante vi aveva clamorosamente e magistralmenteconsacrato36.
34 Brugnolo accoglie la data del 1315, poiché ritiene (erroneamente) che nelMedioevo in molte città italiche l’anno cominciasse (in stile cd. ab incarnatione)non 3 mesi dopo il 1° gennaio, come quasi ovunque, ma 9 mesi prima. Il chevaleva solo a Pisa ed in pochissimi altri Comuni italici. Secondo lo stilesenese, che seguiva quello fiorentino, il 1315 terminò pertanto il 24 marzo del1316 non del 1315. In un pur pregevole contributo, resta priva di significatol’affermazione di M. M. Donato per cui, riferendosi ai lavori di Brugnolo e diGiulia Valerio (la quale segue a sua volta Brugnolo), si afferma: «Il restauroha chiarito che la risposta della Vergine ai santi va datata entro il 1315»;EAD., Dante nell’arte civica toscana. Parole, temi, ritratti, in Dante e le arti visive, a cura di M. M.Donato, L. Battaglia Ricci, M. Picone, G. Z. Zanichelli, Milano, Unicopli, 2006,pp. 9-42, p. 21. Naturalmente quel «ha chiarito» va preso con beneficiod’inventario. Per l’adesione di Donato ad una ancor meno felice ipotesicronologico-attributiva avanzata da Valerio si veda infra, n. 36.35 G. CONTINI, Simon Martini, cit., p. 5.36 Si deve a Giulia Valerio una singolare ipotesi (EAD., Sull’iscrizione della Maestà diSimone, «Studi Medievali», XXVII, 1986, pp. 147-62): i versi contenenti leparole rivolte dalla Vergine agli angeli sarebbero opera successiva rispettoalla prima strofa (l’esortazione alla Vergine), alla risposta della Vergine ai
20
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
santi ed al tristico finale, del 1316. Per la studiosa la sezione angelicasarebbe consonante, per tematiche e lessico, non solo all’ultima parte delPurgatorio, il che risulta evidente, ma addirittura all’ultima parte del Paradiso(canto XXIII, vv. 70-81 per temi e simboli; vv. 110-1 del XXX per il ricorreredel lemma fioretti). Poggiando la propria tesi su documenti del 1321 che comprovanopagamenti del Comune di Siena a Simone Martini e ad altri collaboratori per unarecente reactatio dell’affresco (deputata parrebbe a ritoccare l’area del trono ele figure degli angeli), Valerio azzarda che al tempo di quella reactatio fuinserita la preghiera della Vergine agli angeli (1320 circa), e pertanto che aquella data anche tutto il Paradiso sarebbe stato di dominio pubblico. In primoluogo si noti il paralogismo cronologico: poiché i versi della Vergine agliangeli derivano dai canti finali del Paradiso, e poiché tali testi sonopubblicati non prima del 1320-’21, essendosi fissata al 1315 la datadell’affresco si conclude che quei versi non vi possano essere coevi, maaggiunti in occasione della successiva reactatio. Naturalmente la data di cui sidiscute non è il 1315, ma il 1316, i versi di cui si tratta non derivano daicanti finali del Paradiso, non è provato che i versi della Vergine agli angelisiano stati inseriti nel 1320-’21. Per dare un’idea dell’illusionismodimostrativo adottato, si pensi che dal verso incipitario «Li angelichifiorecti, rose e gigli» si estraggono i lemmi rose e gigli per ricondurli aiseguenti versi danteschi: «Quivi è la rosa in che ‘l verbo divino / carne sifece; quivi son li gigli (Par., XXIII 73-4)», dove è evidente che la rosa di cuiparla Dante non ha niente a che vedere con il fiore, ma è la rosa mistica deibeati. In realtà è a tutti noto, inclusa Valerio, che il binomio ‘rose e gigli’è di matrice biblica: «et montes immensos […] habentes rosam et lilium»; Ezra,4.2.19; «et quasi flos rosarum […] quasi lilia» (Sirac, 50.8), ecc.. A ben vedere,obliterato l’appiglio inesistente con il canto XXX del Paradiso, la studiosafonda il legame tra la preghiera mariana agli angeli e il XXIII del Paradiso subase tematica (in entrambi i casi ricorre l’incoronazione della Vergine, ma è untopos; e certi passaggi del medesimo canto consuonano con certa simbologiadell’affresco, ma probabilmente per identità di tema). Infine nel 1320-‘21 ilcanto XXIII del Paradiso quasi certamente non era ancora divulgato poiché, comerisulta dalla testimonianza di Boccaccio (non smentita dai protagonisti, i figlidel poeta) e dalle ricostruzioni dei più autorevoli studiosi, l’ultimo gruppo dicanti fu pubblicato postumo in occasione della prima edizione integrale dellaterza cantica. Per completezza d’informazione, il celebre sonetto di GiovanniQuirini, il quale richiede che Cangrande si faccia finalmente carico delprogetto editoriale della Commedia, imprudentemente invocato da Valerio comeriprova di una precoce divulgazione della terza cantica, non solo è
21
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
L’ARGOMENTO USEPPIANOIl quarto ed ultimo argomento, di minore importanza ma molto
divulgato, è l’«argomento useppiano»37. In breve, il notaio Tieri degliUseppi da S. Gimignano, mentre nel primo semestre 1317 si trovava aBologna in servizio del Podestà Niccolò Bandini da Siena, scrive sulrovescio della copertina anteriore di un registro della curia podestarileversi ricavati dai canti III e V dell’Inferno. L’argomento è estremamentefragile e di scarsa rilevanza, in quanto non aggiunge nulla a quanto siagià noto attraverso gli argomenti precedenti. Tuttavia dà un’indicazionesulla prima area, quella bolognese, in cui la Commedia iniziò adiffondersi.
Dall’esame del primo argomento, emerge come le tre più accreditateopinioni in materia si siano rivelate in tutto o in parteinsoddisfacenti. Francesco completa indubitabilmente il suo commento aiDocumenti d’Amore nel secondo semestre 1314 (cita la presa di Lucca),contrariamente a quanto ne dissero Egidi, Vandelli ed altri più recentiespositori. Inoltre, mentre scrive, il valdelsano lascia intendere diessere direttamente a conoscenza della prima cantica, tanto da sentirsiin grado lui stesso di descriverla sommariamente e, sebbene commetta unasvista, di citarne quasi testualmente alcuni versi. Ciò contraddice lasupposizione di chi (Petrocchi) concede al notaio nulla più di una vagaed imprecisa idea sulla trama dell’opera. Tale convinzione è pocoplausibile anche per un’altra ragione: Francesco, in estrema sintesi,esorta a leggere un’opera che tratta di materie di alto contenuto, deinfernalibus, in volgare. Un’opera, egli ci assicura, il cui valore affondale radici in autori del calibro di Virgilio. Non staremo a rifare lastoria letteraria del primo ’300 né dell’antidantismo letterario (e nonsolo) che precocemente vi si sviluppò. Basti pensare che finanche dottial di sopra di ogni sospetto, che per Dante professavano stima ebenevolenza (Giovanni del Virgilio), guardavano proprio all’Inferno (ed alPurgatorio) con imbarazzo, per non dire rigetto, ritenendo indegno per unuomo di cultura rivolgersi al volgo su argomenti dotti e rispolverandoper l’occasione la poco elegante parabola delle perle e dei porci.Ebbene, come poteva Francesco spendere il suo nome su di un’operacronologicamente controverso (non è certo se Dante allora fosse vivo o meno) ma,volentieri ammettendo un Dante vivente, quel sonetto mostra l’esatto contrariodi ciò che la proponente intende mostrare: Dante vivo, il Paradiso non fupubblicato. E, si aggiunga, men che mai a Verona.37 Il primo studio sull’argomento, cui i contributi successivi non hannoapportato nulla di sostanziale, è di G. LIVI, Dante, suoi primi cultori, sua gente inBologna, Bologna, Cappelli, 1918.
22
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
letterariamente molto controversa (e non solo letterariamente, visto chetrattava de infernalibus, cioè di cose su cui la Chiesa avrebbe potuto averedi che sindacare, come puntualmente accadde, giuste le difese bolognesidi Pietro Alighieri), tale da suscitare, come suscitò, gravi remore,esortandone altri alla lettura, senza possederne che poche e vaghe idee?
A ben vedere, le cose andarono presumibilmente così: rientrato inItalia verso la metà del 1313, nel corso del 1314 Francesco da Barberino,mentre porta a termine la sua trilustre fatica letteraria, ha notizia diuna nuova opera, recentissima, di Dante Alighieri. Essendo già da tempoun estimatore di questo autore (Doc. Am., I, 100, dove elenca iprincipali scrittori contemporanei da lui stimati, e dove, insieme aJacopo da Lentini, Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia e Dino Compagni, ècitato appunto Dante), se ne procura copia e molto sommariamente nelegge. La zona di riferimento geografico del notaio, veneto-emiliana, ciassicura della reperibilità dell’opera. Nella chiosa, apposta nel secondosemestre 1314, nota che la materia concerne un argomento elevato econtroverso, de infernalibus, e che la trama si sviluppa tra molte vicende,cetera multa. Il suo gusto per l’erudizione classica gliene fa apprezzarela parte iniziale, intessuta di echi virgiliani, il che gli pare elementodi pregio, tanto da invitare altri ad esaminarla, si quis illud opus beneconspiciat, poiché in ogni caso, vel...vel, che v’abbia studiato a lungoovvero in breve, Dante mostra d’aver messo molto bene a fruttol’insegnamento del grande autore latino, plurimum profecisse. A riprova,esordisce citando quasi testualmente alcuni versi, che denunciano ildebito magistrale: hunc [Virgilium] Dante Arigherij [...] commendat protinus utmagistrum.
Ora, se Francesco fa tutto questo senza aver letto neppure un versodella prima cantica, ciò vuol dire, né più né meno, che ne stamillantando la lettura. Il che è possibile, ma è elementare rifletteresul fatto che si millanta qualcosa, esponendosi evidentemente a qualcherischio, per un motivo: ricavarne prestigio (nella fattispecie, di tipoletterario). Senza andare troppo lontano, è proprio ciò che Da Barberinofa con Virgilio, lasciando intendere ai suoi lettori in vari puntidell’opera una conoscenza che non aveva, come ha ben documentato MariaPrandi. Ma certo non fu millantata la lettura di un poema, quale quellodantesco, così controverso, e per di più per ritrarne prestigioletterario, visto che un tale prestigio l’opera di Dante – redattaall’alba del ’300 in volgare – era ben lungi dal possedere38. 38 Illuminante sulle cautele da adottare, specie in area fiorentina (verso cuimuove Da Barberino al tempo dei fatti), nel maneggiare le opere di Dante – esegnatamente la prima cantica –, l’acuta osservazione di S. BELLOMO, Primi appunti,
23
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
A norma del secondo e terzo argomento, tra la fine del 1315 ed il 1316– ante giugno – anche il Purgatorio è ormai di dominio pubblico. Si opponea tale eventualità la communis opinio, che vuole la seconda cantica scrittanel 1309-‘12, rifiutando quale termine post quem la battaglia diMontecatini (29 agosto 1315), di cui si può scorgere allusione nel cantoXXIII.
Il canto XXIII del Purgatorio, certamente notevolissimo per i temi ivisvolti, ai fini della cronologia rappresenta per la seconda cantica ciòche il canto XIX rappresenta per la prima39. La figura centrale del cantoè, come è noto, Forese Donati [1260 ca.-1296], amico di gioventù diDante, con cui il poeta imbastì una tenzone di genere comico-realisticointorno al 1290-‘9540. La figura di Forese serve al poeta per lanciarecit., p. 381: «Le posizioni politiche di Dante avevano fatto sì che Firenzefosse l’ultima, tra le città di importanza culturale, a riconoscere i meriti delsuo figlio illustre. Ma Firenze [...] ne ricambiò pure l’amore per mezzo diuomini che con lui mantennero amichevoli rapporti, ne apprezzarono l’opera e, inparte, ne recepirono il messaggio. Essi tardarono ad esprimersi probabilmenteperché le diffidenze di carattere politico, che gravavano sulla persona diDante, avrebbero potuto colpire anche loro; la stima tuttavia che gli portavanoe l’impossibilità di manifestarla dovettero essere un ottimo motivo di legametra loro. Non stupisce, per questo, vedere uniti, in un modo o nell’altro, inomi di Andrea Lancia e Giovanni Villani (ed anche di Frescobaldi). Intuiamo,quindi, la presenza di un gruppo fiorentino di cultori della Commedia: la lorostima per l’Alighieri resterà per alcuni anni rinchiusa in un ambito ristretto».Da queste acute osservazioni, si deduce come la citazione di un autore qualeDante negli anni (1314 circa) e nell’area (fiorentina) che, ai finibarberiniani, qui interessano, fosse talmente impegnativa per l’estensore, daindurre seri dubbi circa l’eventualità di una citazione alla leggera invocata daPetrocchi. Quanto alla tesi di una pubblicazione della prima cantica per gruppidi canti, essa si può fondare su altri argomenti, di cui, sulla scia di PaulRenucci, ha fornito notevoli saggi (anche se non sempre ineccepibili) GiorgioPadoan, ma non sul barberiniano, che è troppo tardo per essere probante.Infatti, per provare una pubblicazione per gruppi, dovremmo disporre dicitazioni sincrone del 1305-‘13, il che mette fuori gioco proprio ilbarberiniano.39 Tra i principali interventi sul canto si segnalano: F. NOVATI, Freschi e minii delDugento, Milano, Cogliati, 19252; U. BOSCO, Dante vicino, Caltanissetta-Roma,Sciascia Editore, 1966; A. DEL MONTE, Forese, «Cultura e Scuola», XIII-XIV, 1965,pp. 572-89; A. JENNI, Il canto XXIII del «Purgatorio», in Nuove Letture Dantesche, Firenze, LeMonnier, 1972, pp. 1-32; A. FRUGONI, Il canto XXIII del «Purgatorio», in ID., Incontri nelMedio Evo, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 411-28; P. CUDINI, La tenzone fra Dante e Foresee la «Commedia», «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CLIX, 1982, pp. 1-25; L. AZZETTA, Canti XXIII-XXIV. «Se tu riduci a mente...»: memoria, amicizia e poesia nei canti diForese, in Esperimenti danteschi. Purgatorio 2009, a cura di B. Quadrio, Torino, Marietti,2010, pp. 225-52.40 A parte gli ormai classici studi di Barbi, tuttora imprescindibili, dasegnalare la messa a punto di A. STAEUBLE, La tenzone di Dante con Forese Donati, «LettureClassensi», XXV, 1995, pp. 151-70.
24
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
una dura invettiva contro le donne fiorentine, stigmatizzate qualiesempio di corruzione dei costumi, irrefrenate anche dinanzi alle piùinsistite reprimende comunali ed ecclesiastiche. In cosa affondi leradici questa condanna di Dante verso le sue concittadine non si è potutoaccertare con precisione. Fatto sta che nella parte topica del suodiscorso, Forese (cioè Dante) fa una di quelle profezie che tantoimportano ai fini della cronologia:
Ma se le svergognate fosser certe / di quel che ’l ciel veloce loroammanna, / già per urlare avrian le bocche aperte; / ché, se l’antiveder qui nonm’inganna, / prima fien triste che le guance impeli / colui che mo si consolacon nanna (Purg., XXIII 106-11).
Siamo di fronte ad una predizione molto circostanziata e la presenzadel computo quasi esatto degli anni la assegna chiaramente al genere deivaticini post eventum. Si parla di un evento luttuoso che turberà le donnefiorentine in un tempo in cui sta per impelare le guance colui che oggi(cioè nell’anno 1300) è ancora in fasce. Siamo quindi, a un di presso,negli anni intorno al 1314-‘15. Riassumendo la communis opinio deglistudiosi e le loro remore, Giovanni Reggio, con occhio ben fermo allatesi preconcetta della stesura del Purgatorio nel 1309-‘12, scrive:
Tenendo conto che la visione, e quindi la profezia, è immaginata nel 1300 el’età della pubertà è intorno ai 15 anni, si deve ritenere che press’a pocoDante pensasse l’avverarsi di questa profezia prima del 1315 o verso quegl’anni[…]. C’è chi riferisce l’accenno alla sconfitta di Montecatini nel 1315, ma unasemplice sconfitta come quella, non giustificherebbe l’urlo di orrore delledonne; e la data della battaglia è troppo tarda rispetto alla presumibilecomposizione del canto. C’è poi chi ha pensato alla discesa di Arrigo VII(1310-‘12) o alla strage (1303) di Fulcieri da Calboli (cfr. canto XIV) o l’annoseguente, al crollo del ponte della Carraia, con la morte di molti cittadini.Altri, più indeterminatamente, pensa ad alluvioni o carestie […]. Delle varieproposte, l’unica plausibile può essere quella della discesa di Arrigo VII […].Si può quindi pensare e azzardare l’ipotesi che, essendo questa parte delPurgatorio scritta in questo torno di tempo […] la profezia del canto rispecchi lostesso stato d’animo che ha dettato l’epistola [agli scelleratissimi fiorentini,datata 31 marzo 1311, presaga di gravi catastrofi contro i fiorentini che siopponevano al lussemburghese]. Può anche darsi addirittura che la profezia nonsia che l’atteggiamento fiducioso del poeta nella Giustizia divina e nel suoinesorabile, imprevedibile, ma sicuro intervento41.
41 DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di U. Bosco-G. Reggio, Firenze, LeMonnier, 1979, nota al verso.
25
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
Questo saggio di critica è stato riportato quasi per intero poiché è asuo modo esemplare. Nella prima parte si fornisce un nugolo di soluzioni,instillando nel lettore l’impressione che si sia di fronte ad una materiamolto controversa. In realtà, ci si accorge ben presto che solo alcunedelle soluzioni proposte sono plausibili: perché vengono citati i casi diFulcieri da Calboli o della tragedia del ponte alla Carraia?42 Comefarebbe ad impelare le guance nel 1303-‘04 chi è appena nato nel 1300?Non solo. Giunti al vaglio delle soluzioni, si presceglie quella chemeglio si adatta, ma non alla lettera del testo, quanto piuttosto alla«presumibile data di composizione» della cantica, realizzandoun’inversione metodologica ragguardevole: non è la lettera del testo chesi tiene ferma, ma la data presunta (?) di composizione del canto: tuttociò che è o che sembra in contrasto, viene scartato. Dispositivo, come siè avuto modo di notare, piuttosto divulgato43.
42 Sulle implicazioni cronologiche dell’impelare le guance, di diverso parere èAlberto Casadei: «il “prima […] che le guance impeli” (v. 110) inducechiaramente a pensare al periodo della fine dell’infanzia, e quindi piuttosto,partendo dal 1300, il 1311-‘12»; A. CASADEI, Questioni di cronologia dantesca, cit., p.127. Parrebbe doversi intendere che l’infanzia per un neonato del 1300terminasse ad 11-12 anni, mostrando questi la barba subito dopo. Secondo Isidorodi Siviglia, Etymologiae, XI II 2-8: «De Aetatibus Hominum. Gradus aetatis sex sunt:infantia, pueritia, adolescentia, iuventus, gravitas atque senectus. Prima aetasinfantia est pueri nascentis ad lucem, quae porrigitur in septem annis. Secundaaetas pueritia, id est pura et necdum ad generandum apta, tendens usque ad quartumdecimum annum.Tertia adolescentia ad gignendum adulta, quae porrigitur usque ad viginti octoannos». In termini medioevali l’infanzia terminava a 7 anni, col che concludiamoche Dante intendeva riferirsi alla fine della pubertà (secunda aetas), nella fasedi trapasso all’adolescenza, età in cui effettivamente si cominciaprogressivamente ad impelare le guance. Nessun dubbio che il poeta volesseriferirsi ad un tempo futuro tra i 14 e i 15 anni dal momento in cuivirtualmente scrive (1300).43 Si legga M. MARTI, Studi su Dante, Galatina, Congedo, 1984, p. 147: «Questi dati[scil. offerti dalla profezia] ci portano agli anni fra il 1311 e il 1313, cioèpressappoco al tempo dell’inoltrata composizione del Purgatorio e forse anchedella sua conclusione, che gli ultimi studi di Giorgio Petrocchi fisserebberointorno al 1312. Se così fosse, gli avvenimenti fiorentini e toscani del 1315,che potrebbero anche, in qualche misura, corrispondere a ‘quel che il cielveloce ammanna’, sarebbero sensibilmente al di là dei limiti cronologici segnatidai versi come noi li abbiamo interpretati, e quindi da scartare come bersaglidell’allusione dantesca. Niente dunque Montecatini (1315) [...] piuttostoespressione dello stato d’animo di Dante nei mesi della speranzosa discesa diArrigo VII». Tralasciando l’imperizia della citazione di Marti (è notorio chePetrocchi lascia aperto il varco a modifiche, per il Purgatorio, fino al 1315: eper Petrocchi quella profezia si riferisce a Montecatini!), non si sa comegiudicare un simile modo di argomentare, sviluppato con molta compiacenza versole proprie interpretazioni, ma poca sensibilità storica.
26
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
La parte finale del citato intervento è eloquente. Visto che ilriferimento in esame stride con la presumibile data di composizione deltesto, ecco la immancabile lectio facilior di un poeta e di un’opera fuoridall’attualità e, in ultima analisi, dalla storia. Il poeta non starebberiferendosi ad un evento preciso, anche se sembra, ma starebbe dando vocead uno stato d’animo, un’aspettativa e, pertanto, è inutile procedere astoricizzare. La conclusione, intenzionale, è che anche il canto XXIIIdel Purgatorio, che pure sembra utile per la datazione, viene ammutolito.
Esaurito il discorso sul metodo, entriamo nel merito. La battaglia diMontecatini viene [rectius: deve] essere scartata postulando che il cantorichiede un evento di elevata magnitudo, mentre essa sarebbe stata solouna «semplice sconfitta». Ebbene, eccone la ricostruzione storica, cosìcome ce la forniscono i cronisti contemporanei ed il massimo studioso diFirenze medievale, Robert Davidsohn. Nell’estate del 1315 Uguccione dellaFaggiuola, signore di Pisa e Lucca, procedeva imperterrito nell’offensivaantifiorentina. Il faggiolano piombò in Val di Nievole il 10 agosto,provocando Firenze allo scontro aperto. La battaglia campale tra le forzepisano-lucchesi e quelle fiorentine si svolse il 29 agosto, nella pianasenese di Montecatini. Dopo un durissimo combattimento l’esercito diUguccione prevalse e travolse le truppe avversarie, di cui consumòun’ecatombe. Le cifre più accreditate parlano di migliaia tra morti eprigionieri. Molti i nomi illustri tra i caduti: Pietro di Eboli,fratello di re Roberto d’Angiò, annegato nelle paludi di Fucecchio;Carlotto d’Angiò, figlio di un altro fratello del re di Napoli, Filippo;Carlo Guidi di Battifolle, figlio di quel Guido che nel 1311 avevaospitato Dante al castello casentinese di Poppi. Si era consumata quelgiorno una delle giornate più sanguinose della storia di Firenze, ed èinvidiabile la nonchalance con cui i vulgatori danteschi della «semplicesconfitta» si concedano di obliterare tutte le fonti coeve.
Un importante e ben condotto studio di Carla Monti (2010)44, procedendoalla riedizione della lettera scritta di pugno da Uguccione dellaFaggiola agli influentissimi capi ghibellini genovesi, Bernabò Doria eGherardo Spinola, consente di ampliare e sistematizzare l’imponenteconsesso di fonti coeve o di poco successive che danno grande eco alladisfatta di Montecatini: tra i cronisti l’Anonimo pisano, il seneseAgnolo di Tura, il fiorentino Giovanni Villani, i padovani Guglielmo eAlberico Cortusi, il domenicano pisano Ranieri Granchi, il samminiateseGiovanni di Lemmo da Comugnori, il fiorentino Marchionne di CoppoStefani, gli anonimi compilatori delle Storie Pistoresi, del Chronicon Estense,44 C. M. MONTI, Uguggione (sic) della Faggiola, la battaglia di Montecatini e la «Commedia» di Dante,«Rivista di Studi Danteschi», X, 2010, pp. 127-59.
27
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
del Chrionicon Mutinense, degli Annales Arretini, il reggiano Pietro dellaGazzata; tra gli storiografi e letterati ricordiamo il padovano AlbertinoMussato, il vicentino Ferreto Ferreti, l’aretino fiorentinizzato LeonardoBruni, il fiorentino Coluccio Salutati, l’aretino Domenico Bandini. Tracostoro, teste il forlivese Biondo Flavio, dovremmo ricomprendere a buondiritto Pellegrino Clavi, epistolarum magister di Scarpetta Ordelaffi a Forlìe perciò contemporaneo dei fatti. Giunti all’ambito della poesia volgare,citiamo il Lamento della Regina Maria, i serventesi pisani su Montecatini, lerime di Pietro dei Faitinelli. Più di tutti desta però interesse illamento di Folgòre da San Gimignano, Così faceste voi o guerra o pace, checombacia in modo assai significativo con la descrizione dantesca:
Non vi ricorda di Montecatini, / come le mogli e le madri dolenti /fanvedovaggio per gli ghibellini? (vv. 9-11)45.
Con i commentatori danteschi si apre uno scorcio oltremodointeressante per collegare la profezia purgatoriale di Forese con ladisfatta fiorentina di Montecatini: Guido da Pisa, Benvenuto da Imola,dubitativamente Andrea Lancia. Il frate carmelitano e il notaiofiorentino si spingono anche oltre e attribuiscono i versi danteschi diInf., XXXIII 22-4 (recanti un vago accenno ad altri che, dopo Ugolino e isuoi congiunti, saranno accolti entro la macabra Torre della fame a Pisa)alla folla di prigionieri che vi saranno stipati proprio a seguito diMontecatini:
La battaglia di Montecatini ebbe uno straordinario impatto su Firenze e sututte le città coinvolte, fu costantemente ricordata nelle cronache e nellestorie cittadine in volgare e in latino ed ebbe grande risonanza anche a livelloitaliano [tanto che] prima ancora che Uguccione scrivesse la sua lettera, il 1°settembre 1315, un membro della famiglia Doria, Niccolò, già informava reGiacomo II d’Aragona degli esiti della battaglia [cosa che pochi giorni dopofaranno anche Cristiano Spinola e Bernabò Visconti]. La sconfitta di Montecatinifu per Firenze una vera tragedia: non vi fu battaglia in quegli anni che megliosi attagliasse alle parole di Dante […]. Essa avvenne in una data dall’altovalore simbolico, il 29 agosto, festa della decollazione di S. GiovanniBattista, patrono di Firenze […]. Tale fu l’impatto […] che da allora la festapatronale fu spostata al 24 giugno, ricorrenza della natività del Battista,perché non coincidesse con quel giorno. Di contro il 29 agosto fu celebrato aPisa per quasi un secolo […]. Le ipotesi di chi vede nelle parole di Forese una
45 Pur ritenendo probabile una genesi indipendente dei testi di Dante e Folgore,Monti scrive: «Se qui vi è un’eco dei versi danteschi bisognerà riconoscere cheFolgòre ne ha svelato l’implicito riferimento storico»; ivi, p. 158.
28
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
profezia post eventum di questa battaglia andranno allora riprese in serissimaconsiderazione46.
Di fronte alla tragica ecatombe di Montecatini le altre ipotesi messeinnanzi si rivelano poco o nulla significative. Tralasciamo subitoFulcieri e la caduta del ponte alla Carraia, per elementari motivi diragionevolezza. Resta l’ipotesi di Arrigo VII il quale, tra il 1311 ed il1312, tenne effettivamente Firenze sotto pressione. Ma, come noto, sitrattò di una pressione meramente politica. Dal punto di vista militareil lussemburghese aveva una forza risibile per Firenze. Quando cercò diassediarla, nell’autunno 1312, non riuscì a circondarne le mura neppureper metà (e non è Francesco Da Barberino, un testimone contemporaneo, aparlare guarda caso di: «Teotonici pauci numero»?). A titolo conclusivosi ricordi che Dante stesso, che pure parteggiava con dedizione assolutaper l’astro arrighiano, non volle aggregarsi alla sfortunata impresacontro Firenze; e ciò fece certo per reverenza verso la patria, forseanche per averne intuito l’infelice destino (del resto le oculatedefezioni furono numerose, si pensi a quasi tutti i rami della potenteprosapia comitale dei Guidi). A ben giudicare, come poté Dante attribuirevalore apocalittico nel suo poema a tale evento se all’atto pratico eglistesso nutriva dei dubbi e, in definitiva, come riferisce in modofededegno Leonardo Bruni, «non vi volle essere»? Si dirà, ma fu reverenzaverso la patria a trattenerlo non la preconizzazione del fallimento:sarà, ma dov’era la reverenza verso la patria nelle coeve Epistole VI eVII? Lettere talmente lesive della riverita città da compromettervi sinedie il rientro del poeta a condizioni onorevoli47.
A chi riguardi con attenzione gli eventi storici di cui si tratta, nonsfuggirà neppure che Firenze profuse quantità di fiorini per organizzarela fronda antiarrighiana, ma non versò una stilla di sangue per opporsiall’Imperatore, per cui difficilmente questi avrebbe potuto provocare
46 Ivi, pp. 148-56. Non persuasivo A. CASADEI, Questioni di cronologia dantesca, cit.:«Sebbene si possa pensare [che il riferimento di Forese sia] in rapportoall’unica, grave sconfitta dei fiorentini prima della morte di Dante, labattaglia di Montecatini del 29 agosto 1315, è del tutto più economico pensare auna profezia analoga a quella dell’epistola [VI], probabile sino a quando leforze di Arrigo erano cospicue e l’assalto contro Firenze poteva sembrareimminente, tanto da essere caldeggiato nell’epistola [VII] all’Imperatore,datata 17 aprile 1311. La minaccia si attaglia quindi perfettamente a quelperiodo»; p. 129.47 E non si dimentichi che Firenze stessa rese indirettamente merito al poetadella sua presa di distanze, come prova il noto documento fiorentino del 7 marzo1313 in cui, tra i nuovi condannati per la infelice impresa arrighiana (ben476), manca proprio il nome di Dante.
29
GLI ARGOMENTI ESTERNI PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INFERNO E DEL PURGATORIO
l’allucinato urlo di terrore di cui parla il canto. A voler esseresottili poi, non si capirebbe perché, se fosse stato Arrigol’apocalittico distruttore di Firenze, se ne sarebbero dovute atterrirele sole donne, laddove l’urlo delle fiorentine si adatta come un guantoalla disfatta di Montecatini, suscitato come fu dalla tragica perdita deiloro uomini, di quanti, padri, mariti o fratelli, vi persero la vita.Infine, arrischiare una simile profezia a giochi ancora aperti(1311-‘12), correndo l’alea di una sonora smentita (e così sarebbe stato,infatti), tale da gettare il ridicolo su un canto che vede Dantepersonalmente così coinvolto e partecipe, pare irricevibile.
In conclusione, considerando congiuntamente le risultanze del cantoXXIII con quanto ci dicono in modo irrefutabile il secondo e terzoargomento qui analizzati, possiamo dedurre che la seconda cantica vide laluce, con somma verosimiglianza, tra la fine del 1315 ed i primi del1316.
30