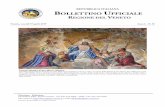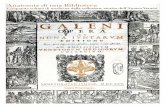«Navigatio Sancti Brendani»: volgarizzamento veneziano del ms. Paris, BnF, it. 1708
Dal volgarizzamento al rifacimento. Un Purgatorio veneto
Transcript of Dal volgarizzamento al rifacimento. Un Purgatorio veneto
Lingue testi cultureL’eredità di Folena vent’anni dopo
Atti del XL Convegno Interuniversitario(Bressanone, 12-15 luglio 2012)
a cura di Ivano Paccagnella e Elisa Gregori
Questo volume è stato stampato con il contributodel Dipartimento di Studi linguistici e letterari
dell’Università degli Studi di Padova
ISBN 88-6058-047-1© 2014 Esedra editrice s.r.l.via Palestro, 8 - 35138 PadovaTel e fax 049/723602e-mail: [email protected]
INDICE
Furio Brugnolo, Ivano Paccagnella, Gianfelice Peron Premessa IX
Pier Vincenzo Mengaldo PerGianfrancoFolena,vent’annidopo 1
Lorenzo Renzi Folenanotoemenonoto 5
Sandra CovinoImaestridiFolenaelastoriadellalinguaitalianaoggi 27
Daniela Goldin Folena Iltestocomemediatoretralingueeculture.Latraduzione 49
Fabiana Fusco Unariflessionesullastoriaelaterminologiadellatraduzione 73
Elisa Guadagnini, Giulio Vaccaro Uncontributoallostudiodel«volgarizzareetradurre»:ilprogettoDIVO 91
Sonia Barillari Dalvolgarizzamentoalrifacimento.UnPurgatorioveneto 107
Margherita Lecco“Tradurre”nellaletteraturaanglo-normanna.IlprologodelRoman de Waldef 131
Martina Di FeboTraduzioneetradizione.LetraduzionidegliOtia Imperialia diGervasiodiTilbury 145
Patrizio Tucci «Baillierenfrançoislesartsetlessciencesestunlabeurmoultprofittable».NicoleOresmetraduttoredell’Etica Nicomachea(1370) 159
Michael RyzhikLatraduzionedellepoesieanticheperlaFestadelleCapanne(Hosh’anot)neivolgarizzamentidellibrodipreghiereebraicoingiudeoitaliano 173
Marco Bianchi SulLucreziodiAlessandroMarchetti.Contestoeuropeoeanalisiinternadiunatraduzione 185
Irene Fantappiè «Ilsolve et coagula dellastoria».TraduzioneetradizioneinFortinieFolena 209
Rachele Fassanelli «OliveriusfiliusdominiRolandi».Ladiffusionedell’’onomasticaletterariaromanzanellaPadovadeisecoliXIIeXIII 231
Luciano Morbiato Eroie«pamòi».Ladoppiatracciaonomasticafogazzariana 249
Stefano Saino MetastasioelalezionediRinuccini 261
Bruno CapaciL’impostoremalinconico.EpiloghinonlietineidrammigiocosidiGoldoni 277
Edoardo Buroni Linguaestile«all’ombraamenadelGigliod’or».Il viaggio a ReimsdiRossinieBalochi 295
Alessandro Bampa ItrovatoriinLiguriaePiemonte 313
Michela Scattolini L’imitazionedantescanell’Huon d’Auvergne 331
Kazuaki UraGiovanniQuirini,lettore“sintagmatico”diDante,Rime,LVIIeLXVIII 349
Andrea CecchinatoLavarietàlinguisticanellaproduzionevolgareaPadova 371
Andrea Comboni TestiinpavanoeinveroneserusticonelleantologiediFeliceFeliciano.Proposteperunanuovaedizione 385
Helmut Meter«Immediatezza»e«naturalità»nelNovellinodiMasuccio.Lamisoginiacomeesempio 395
Ivano Paccagnella Lacommedia“cittadina”daRuzanteallaVeniexiana 413
Mirka Zogović «Lelinguedellacommediaelacommediadellelingue».Ilplurilinguismodellecommedieragusee 435
Andrea Battistini L’analisiretoricaapplicataatestiscientificiefilosofici 449
Elisa GregoriFlorideaelealtre.PoetidiFranciainitaliano 463
Gaia Guidolin LetteretraunitalianoinEuropaeuneuropeoinItalia 487
Rossana Melis«Ehvia,cimancherebb’altro».Goldoninellaricezioneottocentesca 515
Mariarosa Giacon Lalinguadelviator.AltrenoteperItaly/Itaca 539
Wolfram Krömer Unapossibilitàdell’autocommento 561
Angelo Pagliardini Esilioeritornonellaletteratura“nazionale”.LuigiMeneghellodall’EuropaaMalo 569
Antonio DanieleRealtàefinzioneinLuigiMeneghello 587
Furio Brugnolo PrimiappuntisullalinguaelostilediFolena 601
Gianfelice PeronFolenanelDuecento.Osservazionisuitemielostile 625
Indicedeinomi 651
Sonia Maura Barillari
DAL VOLGARIZZAMENTO AL RIFACIMENTOUN PURGATORIO VENETO
1. Il Purgatorio di Ludovico di Francia
Al Tractatus de Purgatorio s. Patricii 1 – composto in ambiente cistercen-se2 fra il 1179 e il 11853 – va senza dubbio riconosciuto il merito di ave-re contribuito in maniera determinante all’affermazione, e alla successiva diffusione, della fede in una terza dimensione ultraterrena atta alla lenta purificazione dai peccati commessi in vita. A un simile peso dottrinale corri-spose una commisurata “fortuna”, documentata dagli oltre centocinquanta manoscritti che tramandano il testo e di cui a tutt’oggi non è stata predi-sposta una recensio esaustiva. E se i numerosissimi volgarizzamenti4 possono
1 Si legge in Das Buch vom Espurgatoire S. Patrice der Marie de France und seine Quelle, hrsg. von K. Warnke, Halle/Saale, Max Niemeyer (Bibliotheca Normannica, IX), 1938 [repr.: Genève, Slatkine, 1976], volume che propone a fronte del testo di Marie de France le edizio-ni affiancate – e solo in parte soddisfacenti – delle due versioni in cui ci è giunto il Tractatus: una di lunghezza maggiore (ben rappresentata dal ms. Brit. Mus. Royal 13. B. VIII) che configura il gruppo β, e una più breve (ne fornisce un buon esempio il ms. Brit. Mus. Harley 3846, ff. 134-147) a identificare il gruppo α. In realtà la tipologia dei testi che tramandano il Tractatus è ben più varia e complessa.
2 Presumibilmente nell’abbazia di Saltrey, nella diocesi di Lincoln, in Inghilterra. Già Jacques Le Goff ha sottolineato come proprio la letteratura teologico-spirituale fiorita in am-bito cistercense abbia avuto una parte importante nell’elaborazione concettuale di un “terzo luogo” oltremondano deputato alla purgazione. J. Le Goff, La nascita del Purgatorio, Torino, Einaudi, 1996 [ed. or.: Paris, Gallimard, 1981], p. 222.
3 Più probabilmente verso la fine di questo periodo: ulteriori approfondimenti riguardo alla datazione del Tractatus si possono rinvenire in R. Easting, The date and dedication of the Tractatus de Purgatorii sancti Patricii, in «Speculum», 53, 4, 1978, pp. 778-783.
4 Ce ne sono pervenute sette versioni antico-francesi in versi (tre delle quali presumibil-mente composte in Inghilterra) e numerose in prosa, sette in italiano, una in langue d’oc, una in catalano, due in castigliano, nonché – uscendo dal dominio delle lingue romanze – tra-duzioni in inglese, tedesco, olandese, svedese, polacco, ungherese, ceco, gallese... Va tuttavia detto che alcune di esse operano interventi massicci sul proprio “modello”, a cui si manten-gono fedeli prevalentemente per quanto concerne le tappe del pellegrinaggio oltremondano del protagonista. In merito si veda l’appendice 2 in S. M. Barillari, Il racconto di un viaggio, i viaggi di un racconto. Analisi comparata dei volgarizzamenti di un passo del Tractatus de Purgatorio sancti Patricii, in Medioevo romanzo e orientale. Il viaggio nelle letterature romanze e orientali, a cura di G. Carbonaro, M. Cassarino, E. Creazzo, G. Lalomia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 43- 80, alle pp. 63-72.
SONIA MAURA BARILLARI108
ben documentare l’ampio e duraturo successo di cui godette l’opera al di fuori del milieu in cui era stata formulata, sono i suoi molti e vari rifacimenti a comprovare l’intrinseca vitalità letteraria di una “materia” ancora capace, a dispetto del trascorrere del tempo e del mutare delle condizioni socio-culturali, di sollecitare approcci narrativi inediti.
A tale deriva diegetica vanno senz’altro ricondotte le vicende testuali di una visio latina che rispecchiano, in piccolo, quelle del suo illustre antece-dente, almeno stando a quanto ci lascia intendere la piccola “famiglia” di testimoni che – in forme e idiomi diversi – la conservano:
V: Napoli, Biblioteca Nazionale, Vind. lat. 57, cc. 258-263 (latino, fine del XIV sec.);P: Paris, B.N.F., Lat. Nouv. Acq. 1154, cc. 7r-10v (latino, fine del XIV sec.);C: Venezia, Biblioteca del Museo Correr, 1508 (veneziano, primo quarto del XV sec.); B: Barcelona, Arxiu de la corona d’Arago, Sant Cugat 82, cc. 157r-163v, e 83, c. 126 (catalano, prima metà del XV sec.);Pd: Padova, Bibl. Civica, C.M. 106, cc. 44va-49vb (veneto, metà del XV sec.);N: Napoli, Biblioteca Nazionale, XXII. 39, cc. 84r-89r (latino, fra 1576 e 1625).5
Tutti narrano del viaggio intrapreso da un cavaliere francese, Ludovico, che raggiunge l’Irlanda per affrontare la dura prova del Purgatorio di san Patrizio: dopo essersi sottoposto a un rigoroso digiuno accompagnato da indefesse preghiere, egli è condotto con una piccola imbarcazione sull’iso-la dove, debitamente protetta da una porta chiusa, si trova l’entrata di un
5 V è edito in S. M. Barillari, Il Purgatorio di Ludovico di Sur (Napoli, Biblioteca Nazionale, Vind. lat. 57, cc. 258-263): un testo a cavallo fra Medioevo e Rinascimento, in «Studi medievali» 3a serie (2008), pp. 759-808.; P in M. Voigt, Beiträge zur Geschichte der Visionenliteratur im Mit-telalter, Leipzig, Mayer und Müller, 1924 [repr.: New York, Johnson, 1967]; B in R. Miquely Planas, Llegendes de l’altra vida. Viatges del cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de sant Patrici, Barcelona, F. Girò, 1914; C e Pd sono pubblicati a fronte in D. De Martino, Il viaggio di Lodovico al Purgatorio di san Patrizio, Siena, Betti, 2006, volume che contiene anche una trascrizione – con svariate imprecisioni – di V.
UN PURGATORIO VENETO 109
mondo sotterraneo, e gli è concesso di penetrarvi. Da lì in poi si dispie-ga un racconto la cui fisionomia presenta spiccati tratti di originalità, e dettagli che non hanno riscontro né nelle opere concresciute attorno alla leggenda del Purgatorio di san Patrizio, né nella seppur vasta letteratura visionaria coeva. In particolare, sono tre gli aspetti che, per la loro strava-ganza, stimolano l’attenzione di chi si appresta a leggerlo in qualsivoglia delle sue forme: in primo luogo i demonî tentatori che assillano il pellegri-no lungo tutta la parte iniziale del tragitto assumono qui le sembianze di fascinose donzelle che gli si offrono lusingandolo con la promessa aggiun-tiva di ingenti ricchezze;6 secondariamente, annovera fra i suoi personaggi un enigmatico vegliardo7 preposto a guidare, servendosi di un’altrettanto enigmatica tovaglia d’oro, fino alle soglie del paradiso terrestre quanti aves-sero avuto la ventura di giungere incolumi oltre il pons subtilis; infine, cosa assai curiosa, quest’ultimo vi appare qualificato come multicolore.8
Appare inoltre degno di rilievo il fatto che i quattro testimoni che ci sono giunti integri, ovvero V, P, C e Pd,9 forniscono delle importanti in-
6 Può essere interessante rilevare come il nesso donna-ricchezze associato alle tentazioni a cui è sottoposto chi intraprende il cammino di purgazione compaia in altre due opere aventi quale oggetto il Purgatorio di san Patrizio: la Visio di Peter of Cornwall e la terza delle Visiones Georgii. Si leggono in R. Easting, Peter of Cornwall’s account of st. Patrick’s Purgatory, in «Ana-lecta bollandiana», CXVII, 1979: 397-416, e Visiones Georgii. Visiones quas in purgatorio sancti Patricii vidit Georgius miles de Ungaria a. D. MCCCLIII, hrsg. von L. L. Hammerich, Kobenhavn, Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1930. Sull’argomento si veda S. M. Barillari, Gli infortuni della penitenza. Ovvero, un purgatorio dai dolorosi amplessi, in «L’immagine riflessa» N. S., XIV, 2005, pp. 87-102.
7 In esso si può scorgere, forse, una reminiscenza, se non una citazione, della figura di san Macario Romano che la leggenda – definita «fabulosa» da Victor De Buck che ne ha curato l’edizione negli Acta Sanctorum – dice dimorare ancora in vita nei pressi dell’ingresso del pa-radiso terrestre, senza tuttavia potervi entrare. Anch’egli, come il vecchio canuto incontrato da Ludovico, è caratterizzato da una capigliatura candida «instar lactis [...] aut nivis», che però ne ricopre interamente il corpo «come l’uccello delle penne». Cfr. AA.SS., Octobris, X, pp. 563-574, alle pp. 563 e 569; D. Cavalca, Le vite de’ santi padri, Istituto Editoriale Italiano, 1915, 2 voll., I, pp. 196-212, a p. 203.
8 «Multi coloris» (V), «diversi coloris» (P), «de diverso chollore» (C e Pd). Un attributo che in B è riferito ai serpenti che lo infestano: «e entron de aquel hauia serps de diverses colos» (Miquel y Planas, op. cit., p. 243). Forse all’estensore, o al copista, era sembrato più plausibile che ad essere variopinti fossero degli esseri fantastici appartenenti al bestiario oltremondano anziché il pons subtilis, la cui tradizione – da tempo consolidata – non comprendeva una simile peculiarità. Oppure egli attingeva a una versione del testo in cui l’attributo era effettivamente riferito alle serpi. Va comunque ricordato che l’arcobaleno (il cui modello si lascia intravedere alla base di questa rappresentazione) nella mitologia norrena costituiva il tramite fra il mondo dei mortali e Asgard, residenza celeste degli Asi. In merito si veda S. M. Barillari, Arcobaleni ctonii. Il pons subtilis multicolore di un Purgatorio trecentesco, in Le vie del racconto. Temi antropo-logici, nuclei mitici e rielaborazione letteraria nella narrazione medievale germanica e romanza, a cura di A. Barbieri, P. Mura, G. Panno, Padova, Unipress, 2008, pp. 19-48.
9 B ci è infatti giunto acefalo (per la perdita della carta iniziale) e mutilo delle quattro o cinque carte finali. Per questo e per il cattivo stato di conservazione in cui versa non è age-
SONIA MAURA BARILLARI110
formazioni riguardo alla contestualizzazione storica della vicenda narrata, intanto puntualizzando che essa avuto luogo nel settembre 1358, per la precisione il 17 di settembre, a quanto consta da V e P:
quidam milles nomine Lodoycus de Sur dixit suo proprio ore quod in mille-simo trecentessimo quinquagessimo octavo, inditione undecima, die decimo septimo mense septembri, in partibus Yibernie, in loco qui dicitur Purgatorium sancti Patricij oculis suis vidit infrascripta. (V)10
Anno ergo Domini mccclviij die xvij mensis septembris illuc [scil.: in Purgato-rium sancti Patrici] intrans... (P)11
E poi facendo esplicito riferimento all’incontro con un personaggio noto che sarebbe stato in procinto di entrare nel purgatorium irlandese in conco-mitanza con l’uscita di Ludovico: Galeotto Malatesta l’Ungaro (1327-1372).12
vole risalire alla tipologia del testo alla base del volgarizzamento: mentre struttura frastica, scelta lessicale e assetto contenutistico, deporrebbero a favore di una più stretta parentela con P, altri elementi, quali la presenza di lezioni non corrotte unitamente a una maggiore stringatezza e linearità del dettato, lasciano presupporre una fonte meno viziata da errori di copiatura, e forse collocabile, rispetto a P, a un piano più alto della tradizione. La sua natura frammentaria non consente comunque di farne oggetto di un’analisi comparativa con gli altri testi conservati integralmente.
10 Barillari, Il Purgatorio di Ludovico di Sur, cit., p. 800.11 C. 7r; cfr. Voigt, op. cit., p. 226. Qui e in seguito, di P, C e Pd riporto la mia trascrizione
con il riferimento all’edizione già disponibile. L’indicazione del giorno è omessa in C e Pd: «Et io lì dentro intrai in l’ano del nostro Segnior MCCCLXI del mexe de setenbrio» (C, c. 4r; cfr. De Martino, op. cit., p. 122). Salvo differenti indicazioni qui come oltre si riporta la versione di C, essendo le varianti che si registrano in Pd solo di natura grafico-fonetica.
12 Che il Malatesta si fosse veramente recato al Purgatorio patriciano, e vi avesse esple-tato il rito prescritto, è testimoniato da varie fonti, in primo luogo dalle litterae testimoniales rilasciate a lui e a Niccolò de’ Beccari, suo compagno di viaggio, dalla curia di Edoardo III d’Inghilterra in data 24 di ottobre 1358: «nobilis vir Malatesta Ungarus de Arminio [scil. Arimino] miles, ad praesentiam nostram veniens, mature nobis exposuit quod ipse, nuper a terrae suae descendens laribus, Purgatorium sancti Patricii, infra terram nostram Hiberniae constitutum, in multis corporis sui laboribus peregre visitaret, ac per integrae diei et noctis unius continuatum spatium, ut est moris, clausum manserat in eodem [...] Consimiles literas Regis habet Nicholaus de Beccariis de Ferraria Domicellus, natione Lumbardus, sub eadem data». Cfr. L. Frati, Tradizioni storiche del Purgatorio di San Patrizio, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», XVII, 1891, pp. 46-79, p. 74. Della corretta identificazione di Malatesta da Rimini e Niccolò de’ Beccari si tratta alle pp. 49-50. Al pellegrinaggio irlandese effettuato dall’Ungaro fanno inoltre riferimento un’epistola indirizzata allo stesso Galeotto da Checco Rossi da Meleto il 31 agosto 1360, una Cronaca malatestiana del sec. XIV, la Cronaca di Baldo Branchi (1474 ca.), quella di Gaspare Broglio (1478 ca.), e ancora la ricordano Gambino d’Arezzo (1430 ca. - 1480 ca.), Benedetto da Cesena (inizi XV-1464), Basinio da Parma (1425-1457). Sul viaggio di Galeotto Malatesta al Purgatorio di san Patrizio, e sui motivi che l’avreb-bero indotto a farlo, cfr. S. M. Barillari, La «coppia d’Arimino» fra il Triumphus cupidinis e il Purgatorio di san Patrizio. (Una ballata per Viola Novella dal codice Magliabechiano VII, 1078), cds.
UN PURGATORIO VENETO 111
Tunc vidi portam feream per quam prius intraveram aperire. Et vidi dominum Malatestam Ungarum cum familia magna et cum monacis sancti Patricij in pro-cessionibus euntem qui me primitus accepit. (V)13
Prostratus iacens in terram, aperiens oculos vidi dominum Malatestam Unga-rum de Arimeno. (P)14
Siando chussì trato fuora, io chomenziè uno pocho ad averzer li ochi, e sì viti missier Malatesta Iungaro. (C)15
2. Il Purgatorio di Ludovico di Sur (V) e il Tractatus de Purgatorio s. Patricii
Preliminarmente va ricordato come il Tractatus – e così molti dei suoi “epigoni” – proponga una visione dell’aldilà relativa ai soli siti purgatoriali, suddivisi in purgatorio e giardino edenico, escludendo dalla descrizione offerta tanto i luoghi riservati alla dannazione eterna quanto quelli prepo-sti ad accogliere i beati. Tale bipartizione, che ha un precedente nella Visio Drythelmi, tende a riprodurre la dicotomia inferno-paradiso traducendo in chiave “dinamica” la distinzione agostiniana fra anime non valde bonae e non valde malae, non definitivamente perdute ma neppure già salve. Conseguen-temente, finisce col proporre un’immagine infernalizzata del purgatorio in quanto tale, a cui fa riscontro una figurazione del paradiso terrestre sostan-zialmente similare a quella del suo corrispettivo celeste.
Ma va anche tenuto presente che l’opera in questione ha un’articola-zione complessa,16 di cui l’esperienza visionaria costituisce solo una parte, sebbene importante. Una rilevanza quasi paritetica è attribuita al cerimo-niale prescritto a chi intendesse misurarsi in quell’avventura perigliosa, e un ruolo importante nell’economia del componimento assume per un ver-so la rievocazione degli eventi che resero necessaria l’apertura del varco oltremondano da parte dell’Apostolo d’Irlanda, per l’altro la registrazione di testimonianze successive volte a confermare la perniciosità delle insidie ordite dai demoni ai danni degli umani, anche e soprattutto se in apparen-za irreprensibili.
Per quanto concerne la visio vera e propria, quella di cui è protagoni-sta il miles Owein, l’aspetto maggiormente significativo consta nel fatto che
13 Barillari, Il Purgatorio di Ludovico di Sur, cit., p. 806.14 C. 10v; cfr. Voigt, op. cit., p. 245.15 C. 23r; cfr. De Martino, op. cit., p. 184.16 Questa, in sintesi, la sua scansione interna secondo l’edizione Warnke: I Dedicatio -
II Prologus - III Narratio: a) De Purgatorio S. Patricii, b) De Owein milite, c) De milite in Purgatorio, Homilia I, d) De Owein milite in Paradiso terrestri, Homilia II, e) De milite e Purgatorio reuerso, f) Testimonium Gileberti - IV Epilogus - V Appendix: 1) Testes, 2) Nar-ratiunculae, Epilogus.
SONIA MAURA BARILLARI112
l’esperienza del cavaliere irlandese non sia vissuta “in spirito” – come era toccato ai suoi predecessori – ma col corpo, «corporaliter»,17 ponendo un distinguo fra l’approccio estatico a una dimensione trascendente e quello assolutamente fisico che si sperimenta sull’isola del Lough Derg. E che il libero – e incentivato, per quanto rigidamente regolamento – accesso a quest’ultima rende il rito praticatovi suscettibile di essere ripetuto, come in effetti lo è stato e lo è ancora tutt’oggi: circostanze che incentiveranno non poco il rampollare di visioni in parte autonome a partire dal “ceppo” del Tractatus. Tornerà allora utile sunteggiarne i contenuti, affinché ci possano guidare nel raffronto con i testi qui presi in esame.
Redarguito dal vescovo a cui si era confessato per la gravità dei peccati commessi, Owein formula l’intenzione di espiarli sopportando la penitenza più gravosa, sostenendo cioè il cimento del Purgatorio di San Patrizio. Dopo aver tentato invano di dissuaderlo – così come voleva la prassi – il vescovo lo indirizza al priore dell’abbazia sorta in prossimità di quell’adito: avvertito della rischiosità dell’impresa, e scongiurato di desistere dal suo proponimento, il cavaliere viene alla fine ammesso al rituale di purificazione imposto ai temerari risoluti a sostenere tale prova: un ritiro di quindici giorni in chiesa dedicati al digiuno e alla preghiera. Trascorso questo periodo, di primo mattino, dopo avere ascoltato la messa ed essersi comunicato, ricevuta la benedizione, è ac-compagnato con una solenne processione all’uscio che serra l’entrata del poz-zo. Viene esortato un’ultima volta a rinunciare al suo proposito, poi i battenti sono dischiusi e Owein si addentra nelle cavità ctonie. La porta è richiusa alle sue spalle: se la mattina seguente, quando sarebbe stata riaperta, non lo avesse-ro veduto l’avrebbero ritenuto perduto per sempre. Adesso Owein è solo nelle viscere della terra. Mano a mano che procede viene meno ogni luce naturale e l’oscurità è squarciata solo da un fievole chiarore, seguendo il quale raggiunge una costruzione simile a un chiostro dove è accolto da quindici persone vestite di abiti candidi e fresche di tonsura. Esse lo mettono in guardia sulle blandizie dei demoni di cui presto sarà ostaggio: solo se le disdegnerà e si manterrà saldo nella fede potrà portare a compimento quanto si prefigge. E quando i supplizi inflittigli saranno intollerabili, basterà invocare il nome del Signore che lo li-bererà da ogni patimento. Detto ciò, i messaggeri celesti si allontanano e di lì a poco fa irruzione un drappello di diavoli che, dopo aver provato a farlo recede-re dal suo intento, lo prendono in consegna tormentandolo aspramente. Sotto la loro scorta visita i differenti luoghi di pena dove anch’egli, di volta in volta, soffre le stesse tribolazioni degli spiriti purganti ma sempre ne è affrancato grazie all’invocazione salvifica del nome di Cristo: dapprima tre campi in cui le vittime giacciono inchiodate a terra in posture diverse, atrocemente dilaniate dai diavoli e da altri mostri repellenti, poi un quarto campo dove sono immerse
17 «Corporalibus oculis hec se uidisse et in corpore corporaliter pertulisse dixit». Tractatus de purgatorio sancti Patricii, III xii, 2 α. Cfr. Warnke (hrsg. von), op. cit., p. 146.
UN PURGATORIO VENETO 113
nel metallo fuso oppure arrostite in forni o infilzate sugli spiedi; poi una ruota gigantesca che, girando, affonda tra le fiamme le anime appese ai suoi raggi incandescenti. È in seguito condotto in un edificio fumigante del tutto simile a quelli termali: al suo interno innumerevoli fosse colme di metallo ardente sono predisposte per straziare i peccatori, e il nostro eroe con essi. Appellatosi al san-to nome, e immediatamente soccorso, è trascinato sulla cima di una montagna sferzata da un vento gelido che con raffiche violente lo fa precipitare nel fiume sottostante, fetido e gelato, dalle cui acque riesce miracolosamente a sfuggi-re per essere però minacciato dal successivo tormento, un pozzo infiammato nel quale viene gettato dai demoni torturatori. Superata anche questa prova, non gli resta che oltrepassare un ponte sottilissimo e sdrucciolevole, sospeso sull’abisso infernale brulicante di diavoli. Passo dopo passo avanza sull’infida passerella (che gli riserva la sorpresa inattesa di allargarsi al suo incedere) e, ar-rivato sull’altra sponda, di nuovo solo e finalmente al sicuro, inizia a scorgere in lontananza le mura poderose del paradiso terrestre. Pervenuto nei pressi di un portone, scintillante per le gemme che reca incastonate, lo vede aprirsi davanti a sé e, attraverso di esso, gli si fa innanzi una processione festante, con a capo due arcivescovi, accorsa a dargli il benvenuto. Assieme a loro visita quella che fu la prima dimora dell’uomo e apprende come chiunque non si sia macchiato di colpe tali da essere dannato in perpetuo è destinato a una permanenza in purgatorio la cui durata dipende dai peccati perpetrati e, parimenti, dalle azio-ni misericordiose realizzate in terra in suo suffragio. Una volta completata la purgazione, le anime sono ammesse al Paradiso terrestre dove, in pace e letizia, allietate da dolcissimi aromi e soavi armonie, quotidianamente pasciuti di una vivanda celestiale, attendono di ascendere al Paradiso. Ma ormai per Owein è giunta l’ora di tornare. Seppure a malincuore, ripercorre a ritroso, senza più molestie né timore, la via che lo aveva guidato fin lì; incontra ancora i messi divini che lo spronano ad affrettarsi verso l’uscita: qui lo aspetta il priore che, con una grande processione al seguito, lo riporta in chiesa dove dovrà passare altri quindici giorni in digiuno e preghiera.
A partire da tale “canovaccio”, come si è anticipato, prendono forma e sostanza numerosi Purgatori successivi, fra cui quello di Ludovico di Fran-cia. Iniziamo a prendere in considerazione la versione di V – scritta in un latino nel complesso corretto ma contraddistinto da abitudini grafico-fo-netiche tali da far supporre l’origine veneta del copista18 – che di tutte è la
18 Quali il trattamento del nesso -dj- il cui esito è un’affricata dentale sonora in coreçan-tem (< suff. -idiare), oppure di gj che dà un’affricata dentale sonora in çoia, zallis, zardinos/çardino (dove la palatalizzazione di g dinanzi ad a è segnale della matrice antico-francese dei vocaboli); o ancora le grafie oscillanti di -t- e -d- (cadenis, capud, velud, set), -c- > -g- in cargatis, -n > -m in posizione finale in tan (= tam). In posizione pre- o post-consonantica r è talvolta soggetta a metatesi: chatreda/cathreda, con propagginazione: scorpiaret; si registra un caso di dissimilazione /r/ - /r/ > /l/ - /r/ per albor (= arbor). X è resa s in res (= rex), respesi (= respexi), perspessi (= perspexi). Va infine notato che le consonanti doppie (ad es. vissa est) ricorrono
SONIA MAURA BARILLARI114
più sintetica e, con buona probabilità, la più scevra da inesattezze e frain-tendimenti. Differentemente dalle altre, in essa Ludovico è detto originario di Sur, forma che sembra voler ricalcare la designazione vernacolare della città di Auxerre,19 derivante dall’esito Autessiodurum > Auceurre attestato nel XIV secolo, epoca in cui sarebbe stato realizzato il viaggio, e stilata la relazione ad esso relativa.20
In merito all’articolazione interna del soggetto – circoscritto, come nella maggioranza degli epigoni del Tractatus, alle peregrinazioni ctonie del cavaliere – è interessante notare come l’anonimo estensore intervenga sull’originario impianto contenutistico del testo apportando delle integra-zioni che ne stravolgono in parte l’assetto primitivo, non solo sotto il profilo topografico ma, di conserva, anche e soprattutto sotto quello teoretico-dog-matico. La prima variazione che introduce, tanto più indicativa in quanto comporta una radicale riorganizzazione della geografia oltretombale, con-siste nell’attribuire alle vessazioni inflitte dai demoni – qui travisati in bellis-sime fanciulle – una funzione probatoria anziché purificatrice, quale invece manifestamente possiedono nel purgatorio patriciano. Ciò determina un ripensamento degli spazi incontrati oltre il pons subtilis i quali, derogan-do alla primitiva identificazione col paradiso terrestre, finiscono col con-templare due parti: una prima propriamente purgatoriale – un fiume e un prato di fiori gialli dove albergano spiriti «non habentes aliud boni neque mali», il castello in cui espiano la propria pena un re e una regina inclini, quand’erano al mondo, alla lussuria – all’interno della quale a un «homo totus albus», come si è accennato, forse san Macario Romano, è affidato il compito di accompagnare il visionario,21 stretto alla «toagla de auro» che egli serra nel pugno, fino alle porte di una «civitat[as] murata cum muris de argento», illustrandogli il significato di quanto gli era stato dato di vede-re lungo il suo itinerario. E una seconda più vicina al dettato del Tractatus, dove tuttavia il paese circondato da possenti bastioni rilucenti di gemme si sdoppia in due città, una d’argento e l’altra d’oro, oltre le quali, dal sommo
nel testo latino come nell’appendice volgare tanto scritte per esteso quanto (è il caso di n) raddoppiate dal titulus: non hanno rilevanza fonetica e trovano un corrispettivo antitetico in forme scempie quali notuque (= noctuque), quidam (= quiddam) e ilum (= illum).
19 Dato che lascerebbe ipotizzare una maggiore prossimità di V all’originale, essendo di gran lunga più probabile per un testo latino – quale quello preso a modello da P, o dal suo antigrafo – emendare ope ingenii la voce volgare con il corrispondente latino piuttosto che il contrario.
20 Di un «conte d’Auceurre» parla ancora Christine de Pizan nel suo Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V, portato a termine nel 1404.
21 Va ricordato come nel Tractatus non sia prevista alcuna guida per il pellegrino oltre-mondano, caratteristica che distingue il purgatorio di San Patrizio da tutte le altre visioni pre-cedenti, coeve e posteriori. In merito si veda S. M. Barillari, Il guerriero e l’oltremondo: relitti di percorsi iniziatici nelle visiones cristiane, in «L’immagine riflessa» N. S., XXI, 2012, pp. 115-140.
UN PURGATORIO VENETO 115
di una torre, è concessa a Ludovico la visione di Dio. Presa la strada del ri-torno, questi incontra un’altra volta l’«homo albus» che gli confida «aliqua que nemini revellarem», indi si avvia verso l’uscita dove farà l’incontro con Galeotto Malatesta.
In virtù dei risvolti didascalici e parenetici che ciò assume, merita di es-sere rilevato come tale riorganizzazione della zona situata al di là del fiume impetuoso e bollente sia resa perspicua anche in termini lessicali: il redat-tore, infatti, nel corso della narrazione utilizza il sostantivo purgatorium solo due volte,22 e lo fa riguardo al re e alla regina scampati a punizioni ben più gravi («sed Deus misertus fuit eorum et in Purgatorio nunc sunt dampna-ti») e alle anime dimoranti in uno splendido prato di fiori gialli («iste sunt gentes in isto Purgatorio stantes, non habentes aliud boni nec mali nisi ut vides»), vale a dire per indicare i luoghi che stanno fra il “ponte sottile” e la città argentea, assegnando perciò alle lande prima del ponte un carattere esclusivamente infernale, e delineando così un oltretomba comprensivo di tutte e tre le sue parti costitutive (inferno, purgatorio-paradiso terrestre e paradiso celeste, per quanto quest’ultimo sia soltanto intravisto dal prota-gonista).
A ciò si aggiunga che V riporta in calce una breve “appendice” in volgare (plausibilmente d’area lagunare):23 questa, però – altrimenti da quanto ci si attenderebbe – mostra di non essere finalizzata a fare una sintesi del testo che correda, di cui intende piuttosto proporre un’interpretazione, specifi-cando le tipologie di peccatori puniti prima del pons subtilis relativamente ai quali l’esposizione di Ludovico – in piena sintonia con lo spirito del Tracta-tus 24 – non dà delucidazione alcuna. Essa, in pratica, non assolve a un ruolo riassuntivo, o quantomeno lo fa limitatamente a una sola sezione, quella iniziale, dell’opera, riepilogando le pene ivi evocate («la prima penna del fogo», «la segonda penna sì è quili che sum clavati in terra», «la terça penna è de çente che sum clavati in terra cum el viso en ço», «la quarta penna che è ’n la piaça là ove se rostisse li homini», «la quinta penna de la roda», «la sesta penna che è ’n la pessima fornaxe ardente», «la septima penna soto el ponte») allo scopo di stabilire una relazione con determinati peccati: usura e omicidio, disprezzo verso Dio e i Santi, lussuria, eresia ed avarizia, iniquità
22 Il termine compare tuttavia nell’intitolazione, assente nelle altre versioni: «quidam mil-les nomine Lodoycus de Sur [...] in loco qui dicitur Purgatorium sancti Patricij oculis suis vidit infrascripta». Barillari, Il Purgatorio di Ludovico di Sur, cit., p. 800. Altre due volte sarà utilizzato – lo si vedrà tra breve – nell’appendice volgare.
23 Per quanto la pressione omologante esercitata dalla lingua latina in cui è composto il Purgatorio e la datazione tarda del nostro testimone non consentano di ascriverla con certezza al veneziano.
24 E prima ancora del purgatorio stesso, le cui pene non sono pensate per specifiche categorie di vizi, o di peccatori, essendo ciascuna soltanto una tappa di un percorso di purifi-cazione che deve comprenderle tutte.
SONIA MAURA BARILLARI116
nell’amministrazione pubblica, ecclesiastica e della giustizia, invidia e falsi-tà nei giuramenti, tradimento. Al suo interno il lemma purgatorio fa registra-re due occorrenze: la prima per indicare i territori a cui si accede tramite il pons subtilis («e da questo ponte enançi è Purgatorio, e bene sono di multe e diverse e grandissime penne, e sono de queli che anno maçor penne che no ano quili che sono a l’Inferno per lo tempo che ano a stare, ma pensan-do a la dolçe gloria che sperano de Paradixo pocha doia ge pare avere»), la seconda ai fini di ribadire la stretta contiguità sussistente fra purgatorio e paradiso («et apresso el Purgatorio è el Paradiso celesto, nel qual paradiso chi è dentro vede la gloria divina dove sì è gran deleti e piaçeri che lengua de homo non poria dire»): un asserto che se non può dirsi erroneo in senso assoluto, dal momento che, nell’ottica di un aldilà tripartito, alle pene pur-gatoriali seguono – a tempo debito – le gioie paradisiache, lo è in relazione al testo a cui si riferisce dove il paradiso celeste non viene mai menzionato.
Da tale essenziale disamina emerge dunque in maniera palese come, a questa altezza cronologica, sia stato ormai portato alle estreme conseguen-ze un processo di progressivo misconoscimento della natura purgatoriale della prima parte dell’avventura di Owein a favore di una sua risemantiz-zazione in termini probatori, misconoscimento sicuramente addebitabile alla nuova rappresentazione del purgatorio che andava gradualmente affer-mandosi di pari passo con la diffusione della Commedia dantesca.
L’avventura di Owein nel TracTaTus Gli addenda di V
rito di purificazione (15 giorni)ingresso nel purgatorium e incontro con i fratres albi
i supplizi inflitti alle anime
demoni della tradizione visionaria demoni femminili - 7 penesezione probatoria
pons subtilis
incontro con l’homo albus
fiume dei boni neque mali
il re e la regina puniti - purgatorium
prato dei boni neque mali - purgatorium
iter di 20 miglia - viridarium
l’homo albus lo lascia
incontro con i due vescovi - dentro le mura dell’Eden
sala d’oro e d’argento
città d’argento - viridarium
UN PURGATORIO VENETO 117
città d’oro - viridarium
monte - visione delle porte del paradiso torre - visione di Dio
rivelazione di aliqua secreta
nuovo incontro con l’homo albus
ritorno e uscita dal purgatorium
incontro con Malatesta ‘Ungaro’
appendice che riassume le ‘pene’ della sezione probatoria
3. Il Purgatorio nella versione di P
Rispetto la versione offerta da V, quella di P è, oltre che più ampia, an-che maggiormente particolareggiata, prestando la massima cura a incor-porare dettagli che contribuiscono a infondere nei fatti esposti un deciso appeal immaginifico. Soprattutto si presta a esplicitare le modalità mediante le quali la testimonianza inerente al cimento purgatoriale è stata raccolta e registrata, arricchite da qualche notizia intesa a dare minimali ragguagli sull’identità del protagonista e le ragioni che lo spinsero fino in Irlanda. Innanzi tutto viene a essere sommariamente schizzata la figura dell’autore, che si qualifica come «fratre Tadeo de Gualandis de Pissis indigno fratre mi-nore, lectore Sancte Marie de Arcelli» (7r).25 La curiosità espressa da questi sulla veridicità o meno di quanto si sentiva raccontare sul Purgatorio di san Patrizio e sui suoi visitatori trova piena soddisfazione nel resoconto resogli da un suo occasionale interlocutore, presentato quale
strenuus miles dominus Ludovicus natione Franchus de civitate Ansidiorensi vir [...] non multiloquax sed parcus et verax, mundum spernens, a peccatis se abstinens, oracionibus ieiunijs, vigillijs, perigrinationibus ac multis alijs peni-tentie actibus carnem domans. (7r)26
I moventi che l’avrebero indotto a intraprendere quel viaggio, e a sfidare tali rischi, sono nella sostanza gli stessi che spinsero Owein:
ego [...] plusquam pro posse operam dederam operibus bellicossis, ob quam rem me nunc astiludijs, nunc torniamentis, nunc campalibus, nunc in Galiam, nunc ad Germanos, nunc umquam ad Italicos, quandoque ad diversas alias nationes me transferens exercerem, quatenus copiam efuderam sanguinis chri-
25 Cfr. Voigt, op. cit., p. 227. Fino ad ora non è stato possibile identificare questo perso-naggio.
26 Ivi, pp. 226-227.
SONIA MAURA BARILLARI118
stianorum essemque quam multis alijs vitijs involutus, cepi mecum aliquamtu-lum cogitare non deinceps modo peccatis carnis quam pecculantie deservire, sed perpetrata facinora in Purgatorio Sancti Patritij pariter purgare de quo aliax audiveram.27
Dopo questo breve cappello introduttivo la trama si dipana seguendo da vicino lo schema di V, fatta salva, come si è detto, la tendenza all’amplificazio-ne di alcuni elementi e alla moltiplicazione di particolari non strettamente necessari alla definizione dell’intreccio: i quindici giorni di digiuno rituale, l’ingresso nelle cavità del sottosuolo, il colloquio con i fratres albi, l’irruzione dei demoni femminili, la sezione probatoria comprensiva degli stessi sette tormenti presenti in V, l’attraversamento del ponte sottile, l’incontro con l’homo albus, il fiume dei «peccata leviter purgantes», il re e la regina puniti per la loro lussuria, un prato di triboli dove i gli spiriti «secundum diversa demerita sua diversimode sunt aflicti», un viridarium oltre il quale l’homo al-bus lascia Ludovico, la città d’argento in cui questi è accolto dai due episcopi, un altro viridarium, la città d’oro e la torre dalla cima della quale gode della vista di Dio, la rivelazione di «archana aliqua sub sigilo secreti»,28 il nuovo incontro con l’homo albus e finalmente il ritorno su questa terra «totum de-calvatum, percussum, lividum et flagellatum»29 nel momento stesso in cui Malatesta l’Ungaro si accingeva a varcare l’ingresso del purgatorium.
La differenza più macroscopica è costituita dal fatto che P ingloba all’in-terno del flusso narrativo quella ricapitolazione dei supplizi inferti alle ani-me nella sola contrada esplorata da Ludovico in completa solitudine – in V delegata all’appendice volgare – precisando quali siano i nessi fra colpa e pena immediatamente a ridosso del segmento testuale più direttamente improntato alla lezione del Tractatus che viene così stravolta nei suoi princi-pi dogmatici come nei suoi presupposti teoretici:
per septem singulares transitur penas quas tibi tali ordine explicabo. Prima civi-tas ignita scilicet in qua homicide et usurarij absque ula redemptione miserabi-liter afliguntur et cruciantur qui perpetue interioris ignis voces doloris exterius sic ut audivisti emitunt. Secunda illorum qui scilicet suppremi in terra con-clavantur clavibus quorum per duorum palmorum longitudo est periuriorum atque crudelium quia Dei et sanctorum postergata omni reverentia blasfeman-tium. Tertia clavatorum scilicet cum clavis eiusdem longitudinis ut suppremi fatie versus cellum est adulterantium, fornicatorum, luxurie viventium ac vir-gines deflorantium. Quarta est illorum scilicet qui in calderia buliuntur platea asantur et ponuntur in fereo iuxta ignem, hereticorum, paganorum, perverso-rum infidelium. Talibus namque, ut avari fuerunt, argentum aurumque lique-
27 Ivi, pp. 227-228.28 C. 10v; ivi, p. 244. In V tali rivelazioni gli vengono fatte dall’homo albus.29 C. 10v; ivi, p. 245.
UN PURGATORIO VENETO 119
factum datur in guture mersum et prout vacabant libidini buliuntur in calderia plena pice. Quinta rote altitudinis ad celum et profunditatis ad abissum est tirampnorum et aliorum dominorum iniuste dominantium quomodocomque ac iudicum advocatorum cuiuscomque generis iniuste advocantium et iudi-cantium ac etiam clericorum iura ecclesiastica iniuste possidentium atque bona qui temporalibus lucris vacant offitijs et non lucris. Tale – inquid – ut vidisti super rotam proitiuntur et elevantur ad celum et rapidissime ad inferos inter-minabiliter demerguntur et postea escha insatiabilis maligni Luciferi preparan-tur. Sesta illorum scilicet qui in pesima fomace ardentissime conburuntur est periuriorum et invidorum. Septima est illorum qui in flumine sub ponte sunt, scilicet omnium predictorum ac illorum qui fuerunt de divina misericordia de-sperati. (9v)30
Sempre in direzione di una maggiore fluidità espositiva va senza dubbio la netta distinzione fra le voci narranti: quella di fra Taddeo che introduce
30 Ivi, pp. 240-241. Si confronti tale sintesi illustrativa con quella apposta in calce a V: «la prima penna del fogo sì è homini stadi al mondo usurari e homicidiarij, e sta cum gram pene di fogo ardando e cum grandisimi cridi. La segonda penna sì è quili che sum clavati in terra cum clodi boienti de duy palmi l’uno per la schina e cum el viso in terra, sì è stati homini crudele sença amore né pietà de nesuno cristiano, e desprisiando Dio, e santi. La terça penna è de çente che sum clavati in terra cum el viso en ço cum clodi de duy palmi l’uno per che y sum stati al mondo homini e femene luxuriosi, e falsati li matrimonij, e de pulçelle donçelle sença raxone. La quarta penna che è ’n la piaça là ove se rostisse li homini, e femene boiono en caldere e cum spidi de ferro, eno stati al mondo homini patarini, e de mala luxuria, e quili che boiono en caldere de pegola, eno stati al mondo homini avari e pieni d’avaricia, e stano in le dicte caldere cum el chavo en ço e cum li pi en su, e alguna hora del die ge colano oro e arçento çoso per la golla. La quinta penna de la roda che per agudi de fogo che tocano le aere e el profundo, è penna data a segnor che segnoreçano en temporale no façando iusta ra-xone, e iudice che dampno iniustamentre le sentencie, e avocati che iniustamentre iudicano, e clerici che no mantiene iustamentre la sancta madre Glexia e mantiene el temporale. E qui-sti, die e note zirando su questa rota, e’ sono danati de profundo cum grandissimi tromenti. La sesta penna che è ’n la pessima fornaxe ardente sì è penna data a homini ch’è stati envi-diosi e che ano fato falsi sacramenti. La septima penna soto el ponte, ch’è profundo, sì sono misi homini stati al mondo traditori, e sono desperati da Dio». E con quella proposta dalle glosse che corredano i margini dello stesso codice, in corrispondenza delle pene descritte: «1ˆ penna que est usurarijs et homicidis deputata. 2ˆ pena que est deputata hominibus crude-libus absque amore et pietatis alienis cristiani despretientibus deum et sanctos. 3ˆ pena que deputata est lusurioxis falsantibus matrimonia et decipientibus domicelas ab raxone. 4ˆ pena est partis binna; de penniis dat primam hereticis patarinis et a Domine luxuriantibus usque in unum magnum puteum Deus excluxive, aliam vere omnibus avaris. 5ˆ pena data dominis dominantibus mundum et advocatis iustitiam nominantis inique que iudicantibus et clericis precepta ecclesie non servantibus temporalia que adtendentibus. 6ˆ pena data invidiosis et falsa iurantibus. 7ˆ pena habet duas partes bis penasque: subtus pontis sunt proditores et desperati a deo secunda vero aliis hominibus maximas penas patientibus qui tum sperant gloriam Dey ». Barillari, Il Purgatorio di Ludovico di Sur, cit., pp. 806-808. Sul rapporto fra la versione di V e l’appendice e le glosse da cui è corredata cfr. S. M. Barillari, Le glosse e l’appendice del Purgatorio di Ludovico di Sur (Napoli, B.N., Vind. lat. 57, cc. 258-263): un caso di contaminazione, in «Studj romanzi» N.S., II, 2007, pp. 127-155.
SONIA MAURA BARILLARI120
la rievocazione dei propri trascorsi da parte di Ludovico, quella di Ludovi-co che narra in prima persona («[Ludovicus] michi per ordinem ennaravit que michi hanc prestiterunt gratiam ut eorum que de dicto Purgatorio au-diveram et legeram fidem confirmarent. Ait ergo: Ego – inquid – plusquam pro posse operam dederam operibus bellicossis...»),31 ancora quella di fra Taddeo che prende idealmente il congedo dalla platea di correligionari ai quali si era rivolto: «ista autem, pater mi – inquio domino abati et alijs monacis – que a vobis interogatus vobis per ordinem enaravi...».32 Diversa-mente da quanto accade invece in V dove, dopo aver brevemente riassunto i fatti precedenti all’entrata nel cunicolo ipogeo, la narrazione registra un brusco passaggio dalla terza alla prima persona singolare, che conserverà fino alla fine:
[Ludovicus] cepit sedere et, dicto sedente per spacium medie hore, vissa est unbra una alba et forma humana capiens ipsum per brachium stringens eum fortiter, et dixit ei: «Surge, vade et revertaris, et de dicto dicas id quod petis». Et visum fuit michi ac vidi unum magnum splendorem...33
Sotto il profilo lessicale giova osservare come in P manchi una qualsivo-glia suddivisione, e relativa denominazione, delle parti dell’Aldilà visitate dal protagonista: il vocabolo purgatorium è impiegato di fatto unicamen-te per indicare il sito di purgazione irlandese («cum ipsum [Ludovicum] in Purgatorio sive Puteo Sancti Patritij fuisse [...] plurimi ennararent»),34 e non ricorre mai dopo l’ingresso di Ludovico nel purgatorio stesso. La sola eccezione è costituita dall’uso del participio purgantes a proposito delle anime immerse nelle acque dell’ameno fiumicello che scorre oltre il pons subtilis:35 «isti sunt homines et mulieres qui hic sua peccata leviter, ut causa criminis exposit, purgantes».36
In definitiva si può concludere che in tale versione della visio di Lu-dovico una preminente tensione verso una linearità compositiva mirante alla piana comprensione dei contenuti, e accompagnata da una continua sollecitudine nei confronti di componenti accessorie, non si risolve in un effettivo incremento dell’intelligibilità della materia trattata, e tanto meno degli asserti catechetici che intende propagandare.
31 C. 7r; cfr. Voigt, op. cit., p. 227.32 C. 10v; ivi, p. 245.33 Barillari, Il Purgatorio di Ludovico di Sur, cit., p. 800.34 C. 7r; cfr. Voigt, op. cit., p. 227.35 Spazio che, come si ricorderà, la versione di V identifica col purgatorio.36 C. 9r; cfr. Voigt, op. cit., p. 227.
UN PURGATORIO VENETO 121
L’avventura di Owein nel TracTaTus La versione di P
premessa di Tadeo de Gualandis de Pissis
rito di purificazione (15 giorni)ingresso nel purgatorium e incontro con i fratres albi
i supplizi inflitti alle anime
demoni della tradizione visionaria demoni femminili - 7 pene (= V)sezione probatoria
pons subtilis
incontro con l’homo albus (= V)
fiume dei peccata leviter purgantes (= V)
il re e la regina puniti (= V)
prato di triboli
l’homo albus illustra le pene della sezione probatoria
iter di 20 miglia - viridarium (= V)
l’homo albus lo lascia (= V)
incontro con i due vescovi - dentro le mura dell’Eden
sala d’oro e d’argento (= V)
città d’argento - viridarium (= V)
città d’oro - viridarium (= V)
monte - visione delle porte del paradiso torre - visione di Dio (= V)
rivelazione di archana (= V)
nuovo incontro con l’homo albus (= V)
ritorno e uscita dal purgatorium
incontro con Malatesta Ungaro (= V)
4. Il Purgatorio nelle versioni di C e Pd
Decisamente più complessa è la fisionomia della versione tràdita, con differenze minime,37 da C38 e Pd: dall’impianto portante desunto da un
37 La sola eccezione è rappresentata da un capitolo conclusivo di Pd, assente in C, dove si rammenta l’usanza, enunciata con risolutezza nel Tractatus, a cui si deve l’elaborazione scritta di quanto aveva visto e provato chi fosse entrato nel purgatorio patriciano, e ne avesse fatto ritorno: una testimonianza che, assieme ad altre dello stesso tenore, sarebbe servita da am-
SONIA MAURA BARILLARI122
esemplare assai prossimo a P rampollano e concrescono in modo caotico e disomogeneo episodi di provenienza eteroclita, semplicemente giustappo-sti l’uno all’altro sulla base di associazioni fortuite, e amalgamati in ragione di una sommaria adesione a un immaginario penale ampiamente collauda-to e diffusamente condiviso.
Come negli altri testimoni, passato da Avignone in Irlanda ed espletati il riti prescritti, Ludovico entra nella fovea e si addentra per un cunicolo fino a raggiungere la sala in cui lo attendono i «munexi bianchi»: grazie al loro conforto è pronto a fronteggiare i diavoli «in forma de donzele» e le tribolazioni patite dai peccatori che vengono divorati dal fuoco, inchiodati a terra in varie posture, scaraventati in un pozzo ribollente. A questo punto, però, il narratore abbandona il tracciato delineato dal proprio modello e inserisce una nuova tappa sulla strada che conduce il visionario a un livello di coscienza superiore: un bosco all’interno del quale una moltitudine di religiosi è conficcata a terra col capo all’ingiù mentre altri sono eviden-temente costretti entro le piante e gli arbusti, se basta spezzare un ramo perché se ne levi un lamento straziante. Un bosco teatro di una caccia in-fernale condotta da demoni a cavallo di orribili dragoni che sguinzagliano le loro cagne rabbiose all’inseguimento di povere anime disperate.
All’uscita da quella macchia tenebrosa gli scenari tornano ad essere quelli previsti dal Tractatus – la “classica” ruota provvista di uncini taglienti e una grande fornace ardente e fumigante – ma subito dopo ancora l’auto-re se ne allontana, intentando nuove vie dall’indiscutibile impatto emotivo: Giuda incatenato a due impervie montagne, un ponte aggettante su un fiume abitato da belve crudeli, un lago di pece incandescente in cui sono immersi i lussuriosi, le città infuocate di Sodoma e Gomorra riservate ai sodomiti, una radura dove avari ed usurai sono costretti a trascinare im-mani sacchi ricolmi d’oro e d’argento, la valle degli iracondi, squartati dai loro aguzzini, la città che ospita i superbi, vestiti di ricchi abiti dalle fodere arroventate, una valle oscura nella quale vengono arrostiti i golosi, il prato delle donne infanticide e dedite alla lussuria, un cimitero e un altro ponte che ci riporta fra i fondali noti della versione di P, discostandosene solo per gremire il prato irto di triboli di peccatori impiccati e trafitti da spiedi acu-minati, e introdurre le figure di Enoch ed Elia nei pressi dell’albero della conoscenza.
Si comincerà col constatare come una così sostanziosa ed eclettica “far-citura” renda necessaria, per conferire un’adeguata coerenza alla scansione spaziale dell’universo ultraterreno, la presenza di un altro ponte – nondi-
monimento, o da viatico, per quanti avessero in futuro voluto sfidarne le insidie col proposito di emendarsi dal peccato.
38 Si tenga presente che la versione di C è conservata in un codice che contiene solo que-sto testo ed è interamente illustrato.
UN PURGATORIO VENETO 123
meno avallata dall’autorevole antecedente della Visio Tnugdali 39 – con l’esi-to di riorganizzare i luoghi attraversati dal visionario in base a una logica quadripartita: un settore probatorio, sommariamente ispirato al Tractatus, in cui le dame diaboliche cercano di indurre in tentazione il penitente,40 un primo ponte multicolore, un settore infernale, un secondo ponte, un settore propriamente purgatoriale, dai contorni nel complesso vaghi e poco organici, il paradiso terrestre articolato secondo la successione città argentea-città dorata, anch’esso a grandi linee ispirato al Tractatus, il para-diso celeste soltanto intravisto.
Affisando lo sguardo sulla cospicua interpolazione frapposta a dividere e distinguere i due domini di cui era originariamente composto l’aldilà descritto dalla fonte di questi volgarizzamenti “gemelli”, e prima ancora dal Tractatus, sconvolgendone, quindi rifondandone struttura e significati, ci si accorgerà come essa sia la risultante di un assemblaggio di materia-li preesistenti, autentici blocchi erratici estrapolati da tradizioni fra loro indipendenti benché limitrofe, dotati di un’autonomia semantica tale da sollecitare nei lettori un recupero memoriale in grado di radicare tale ine-dita declinazione di un motivo alquanto diffuso nell’alveo rassicurante di conoscenze assodate e ampiamente condivise.
Né ci si stupirà, stante la precoce ricezione e assimilazione della Comme-dia di Dante in area veneta, che proprio da questa, e nella fattispecie dalla prima cantica, derivino gli spunti più consistenti per assegnare ai brani con-fezionati ex novo una caratterizzazione che fosse al tempo stesso congrua, incisiva e confacente alle aspettative dei destinatari. Così la boscaglia in cui sono confinati i religiosi non osservanti dei voti professati evoca ambienta-zione e situazioni della selva dei suicidi di Inf. XIII, contaminandole con un’aperta citazione al castigo comminato ai simoniaci di Inf. XIX:
io me troviè in uno oribelle prato in nel qual era uno grandisimo boscho da uno de llati, et erano tuti pechatori nelli qual erano la mazor parte frati et preti,
39 In cui, appunto, i “ponti sottili” sono due nessuno dei quali costituisce – come avviene invece nel Tractatus – il tramite che conduce alla salvezza, rappresentando essi semplicemente due dei tanti supplizi a cui sono soggette le anime in relazione ai peccati commessi, in un caso predisposto a punire (o a mettere alla prova) ladri e razziatori, nell’altro i superbi. Il “debito” contratto dal Purgatorio di Ludovico di Francia (in tutte le sue versioni) con la Visio Tnugdali – piuttosto che con il Tractatus – per quanto concerne la raffigurazione del pons subtilis è del resto abbastanza scoperto: ne è spia l’incontro del protagonista, giunto ormai a metà della campata, con un personaggio che gli viene incontro a cavallo, in cui è possibile ravvisare una citazione della «vacca indomita» trascinata dal protagonista oltre il ponte. Visio Tnugdali. Lateinisch und altdeutsch, hrsg. von A. Wagner, Erlangen, Verlag von Andreas Deichert, 1882, pp. 20-22.
40 Una palese incoerenza rispetto all’organicità di tale quadripartizione è rappresentata dalla presenza di uno spazio dai caratteri inequivocabilmente infernali prima del primo pon-te: il bosco dei religiosi che hanno disatteso i voti professati.
SONIA MAURA BARILLARI124
i qual era piantati chol chapo in zoxo giemenndo e llementandosse molto di-gando: «Guai, guai!». Et aldando mi quelli lamenti, io ne prexi una rama et sì la schavaziè, et ella gità sangue et chomenzame a dire: «O chavaliero, perché me fa’ tu despiaxere? Qualle fortuna t’à menato qui a farme despiaxere? Io som anima passata, et sì fui al mondo relligioxo et sì nom observiè quello io aveva proferto a Dio. Et però mi et tuti questi albori che tu vedi semo stati relligioxi, e persone che à promesso a Dio et nonn à observado la promissiom, et semo morti in queli pechati et senza chonfesarsse. Et però la iustizia de Dio n’à messi in questa pena». Et, chusì stagando, aldì uno grandisimo romor de chazatori. Et guardai et viti vegnir una grandenisima quantità de anime, le qual vegniva chazade da chize negre rabiose, chon molti demonii a chavalo su dragoni teri-belli che vegniva morsegando et squarzando le suo’ charne et l’ossa. (c. 7v)41
E il lago di pece bollente dove sono immersi i lussuriosi mostra innega-bili analogie quello della bolgia dei barattieri di Inf. XXI:
e dentro quel lago iera pieno d’anime che andava suxo e zoso per lo dito fuo-go e pegolla segondo chomo feva el boior. Et llà sì stava infiniti demonii chon ranpini. Et quando le anime vegniva de sopra subito li diti demonii li dava de quelli ranpini. (c. 11r)42
Similmente, le infanticide rammentano gli ipocriti di Inf. XXXIII, come loro condannate a indossare «riche vestimente e fodrade de pionbo pesan-te» (c. 14r). E i superbi fondono in sé la memoria degli indovini di Inf. XX e del notissimo aneddoto riguardante Serlone di Wilton:43
io entrai in una grande zitade la quale iera piena de anime molto bene vestite de real vestimenti, de pani d’oro et de ariento chom manteli de varo, et eran inperatori, re et segniori tirani. Et altra giente assai, la qual andava molto chon gram soperbia. Et soto li manteli et vestimenti ardeva de fiame de fuogo, et andava su e zioso per ’sta zitade chol vixo volto driedo alle spalle, et quando li era andati a torno a torno per questa piaza che senpre ardeva molti demonii et menistri de demonii sentava su chariege ardente. Et faxevalli vegnir davanti et
41 Cfr. De Martino, op. cit., p. 136.42 Ivi, p. 148. Si tengano comunque presenti le affinità con la Visio Thurkilli: «anime vero
assidue bullitionis intolerabilem cruciatum effugere aliquo modo cupientes a ministris Tarta-reis undique astantibus cum furcis et fuscinulis terreis et candentibus introrsum impelleban-tur». Visio Thurkilli. Relatore, ut videtur, Radulpho de Coggeshall, hrsg. von P. G. Schmidt, Leip-zig, Teubner Verlagsgesellschaft, 1978, p. 28. Per le analogie sussistenti fra la Visio Thurkilli e l’Inferno di Dante rinvio a S. M. Barillari, Considerazioni sulla ipotizzata unitarietà dell’immagi-nario grottesco medievale: analogie e differenze fra la Visio Thurkilli (sec. XIII) e l’Inferno dantesco, in Die kulturellen Beziehungen zwischen Italien und den anderen Ländern Europas im Mittelalter, Greifswald, Reineke-Verlag, 1993, pp. 1-14.
43 Conservato, nella sua versione più antica, nel Liber narrationum de diversis visionibus et miraculis, descrive le circostanze che avrebbero indotto Serlone ad abbandonare la vita mon-dana ed entrare nell’ordine dei Cistercensi.
UN PURGATORIO VENETO 125
chruziavali dandogli gram pene. (c. 13r)44
Altrove il calco è meno scoperto, e l’imitazione meno pedissequa: le città infuocate dei sodomiti rinviano ellitticamente a Dite:
e iera pegolla e solfere che ardeva et là dentro ge n’iera tre zitade grosse chon molta zente che non feva se nom biastemar Dio, e ardeva et arderà in senpi-terno (c. 11v)45
Avari e usurai, prostrati sotto il peso eccessivo delle ricchezze accumula-te, paiono emulare i loro omologhi di Inf. VII:
queste anime chon questo teribelle et spaventoxo chridor vigniva charge e pie-te quaxi chon le boche per tera con sachi d’oro et arzento (c. 12r)46
E gli iracondi conservano una reminiscenza di quelli danteschi, impre-ziosita da un velato rimando ai seminatori di scandalo e di scisma di Inf. XXVIII:
viti molte e assai anime, le qual stava tute squarzade davanti el peti. Et chi se strangollava l’una et l’altra, et chi se feriva in la golla l’um l’altro. Et biastemava la potenzia devina. Et altri stava destexi per tera chol volto in zoxo, et chove-gnivasse passar per adosso. Et a mam a mano vegniva li demonii chon gran chortelli, et sì li feriva et squartavali et apichava li quarti ai albori. Et niente de meno le teste pur parlava. (c. 12v)47
Stimoli ugualmente produttivi sono tratti da una produzione edificante che, benché datata, non cessava di riverberare le proprie suggestioni su te-sti destinati a un pubblico poco incline a radicali istanze di rinnovamento. Sulla falsariga della Navigatio sancti Brendani è modellato l’episodio dell’in-contro con Giuda:
rivai in uno luogo dove era uno gram mar de fuogo tra do altisime montagnie. Et, tra ’ste do montagnie, in la sumità era ligado uno che pareva in chorpo et in anima, el qual era inchadenato tra la sumità de queste montagnie, e ’l fuogo ardeva infino al ziello. Et da l’altra parte iera uno fiume chorente che sse alzava infino a la bocha de chostui. E llui voiando ber, subito el fiume challava ch’el non podeva ber, ma chridava sì forte che lle montagnie e la vale pareva che retintinasse [...] Et sì domandiè quello che iera in quella pena chi ’l’iera, e se ’l podiava aiutare. Et lui me disse: «Io fui uno de li dodexe appostoli che tradì
44 Cfr. De Martino, op. cit., p. 150.45 Ibidem.46 Ivi, p. 152.47 Ivi, p. 154.
SONIA MAURA BARILLARI126
el mio segnior misser Yhesu Christo. Et però io son chondenado a star senpre in questa pena». (c. 9v)48
Il mostro divoratore nei pressi della ruota è coniato sulla Visio Tnugdali:
entro le qual bestie ne iera una sì granda et tanto spauroxa che, quando io la vidi, io chazi mezo morto e aveva la dita bestia, con ferma zontura del suo chorpo, una bocha oribelle, grandisima, chon denti sì grandi che, segondo che io putì extimar, ’li era longi ben tre palmi, li qual taiava chomo rasori, et iera chadenado de chadene de fero e de fuogo. Et chon le dite boche mangiava et squarzava et devorava le anime. Et tante ne mangiava che per forza el feva poi avomito e gitava, et quello zitamento et avomito poi mangiava da chavo, et chussì interminabille feva senza fine. (c. 8r)49
Quanto ai dannati infilzati su robusti spiedi di ferro e arrostiti, una esu-berante letteratura visionaria, ivi compreso il Tractatus – suggeriva tante e tali variazioni sul tema della cucina infernale50 da rendere impossibile, e inutile, l’individuazione di una fonte specifica. Lo stesso può dirsi per la presenza di Enoch ed Elia vicino all’albero della conoscenza, essendo la credenza che li pone ancora vivi, e fino alla fine dei tempi, nel giardino edenico molto antica, e comune a ebrei e cristiani.51
Vi è infine in C un altro richiamo all’opera dantesca, sia pure ormai, e da tempo, rivelatosi fittizio. Il codice, infatti, si chiude con una illustrazio-ne a piena pagina dell’Incoronazione della Vergine, copia di un particolare dell’affresco realizzato dal Guariento fra il 1365 e il 1368 sulla parete di fondo della sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Venezia,52 e gravemente danneggiato da un incendio nel 1577,53 illustrazione a cui sono soprascritti, a mo’ di exergo, gli stessi versi che erano vergati sotto il trono dalla Vergine nell’affresco veneziano – oggi pressoché illeggibili – e che si
48 Ivi, pp. 142 e 144.49 Ivi, p. 140.50 Che Curtius riconduce alla categoria del küchenhumor. Cfr. E. R. Curtius, Europäische
Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern, Francke, 1948, pp. 432 ss.51 Come rammenta Arturo Graf, molti padri della Chiesa accolgono tale tradizione, se-
guita, tra gli altri, da Fazio degli Uberti e da Federigo Frezzi. Ma non da Dante. A. Graf, Miti, leggende e superstizioni del medio evo, Milano, Paravia 2002 [ed. or.: Torino, Loescher, 1892-1893], pp. 66-67.
52 Il soggetto fu ripetutamente praticato dal Guariento: esso venne realizzato anche per un polittico eseguito nel 1344 per la parrocchiale di Piove di Sacco ed ora appartenente alla collezione del Norton Simon Museum di Pasadena, e nella decorazione commissionatagli da Francesco I da Carrara attorno al 1351 per la tomba di Jacopo II da Carrara posta nel presbi-terio della chiesa di sant’Agostino a Padova, oggi distrutta (il frammento dell’Incoronazione della Vergine è attualmente conservato nella chiesa degli Eremitani).
53 A seguito di ciò, nel 1590, venne ricoperto dalla grande tela del Paradiso di Tintoretto: solo nel 1903 la rimozione del quadro resasi necessaria per procedere al suo restauro rivelò la presenza, sulla parete che questo occupava interamente, dell’affresco sottostante.
UN PURGATORIO VENETO 127
ritenevano essere stati composti da Dante in occasione di una sua visita alla città lagunare in veste di ambasciatore dei signori di Ravenna:54
l’amor che mosse già l’eterno padre per figlia aver de sua deità trina costei che fu del suo fiol poi madre de l’universso qui la fa regina. (c. 24r)55
Benché oggi questa attribuzione sia ritenuta erronea, all’epoca in cui fu redatto il manoscritto era pacificamente accolta come autentica, cor-roborata dalla presenza, nell’affresco del Guariento, di motivi figurativi di chiara derivazione dantesca. E come tale va senz’altro aggiunta al novero dei referenti letterari che contribuirono a rimodulare il componimento su una nuova sintassi contenutistica.
Un ulteriore segnale della convinta e tenacemente perseguita adesione alla lezione di Dante da parte dell’autore del rifacimento attestato da C e Pd è dato dalla pervasiva e massiccia inserzione di riferimenti ora traspa-renti, ora allusivi o coperti, ad accadimenti e personaggi reali: altrimenti da quanto avveniva nel Tractatus – dove sono descritti i tormenti e i gaudi di anime destinate a restare nell’anonimato – questo Purgatorio tardivo non sa affrancarsi del tutto dalle passioni terrene e popola le contrade dell’Oltre-tomba di visi noti, lumeggiando di sfumature municipalistiche un racconto che aspira forse ad acquisire i connotati della visione “politica”,56 sfruttando la visita nell’Altro Mondo come un convincente strumento d’accusa o di
54 Così Francesco Sansovino, nella sua Venetia : «sopra al seggio del prencipe, erano quat-tro versi, composti da Dante Alighieri, poeta fiorentino, ch’esprimevano la pittura del Para-diso, e furono fatti da lui, quando venne oratore a Venetia per li signori di Ravenna, e erano: “l’amor, che mosse già l’eterno Padre / per figlia haver di sua deità trina, / costei, che fu del suo figliuol poi madre, / de l’universo qui la fa regina”». F. Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare, in Venetia, presso Altobello Salicato, 1604 [1581], pp. 233-234.
55 Cfr. De Martino, op. cit., p. 184.56 Uno dei primi testi in cui è possibile riconoscere i tratti distintivi di tale “sottogenere” –
destinato a divenire una vera e propria “moda” letteraria – è la Visio cuiusdam pauperculae mu-lieris (inizi IX sec.) dove si imputa a Ludovico il Pio un coinvolgimento nella morte del nipote Bernardo. Si legge, nell’edizione Hauben con traduzione italiana a fronte, in Visioni dell’Aldilà in Occidente. Fonti, modelli, testi, a cura di M. P. Ciccarese, Firenze, EDB, 1987, pp. 394-399. Lo stesso fa Ramón de Perilhós nel suo Viatge al Purgatori de sant Patrici, viaggio che pretendeva di aver effettuato allo scopo di appurare in quale stato versasse l’anima del suo signore Giovanni I d’Aragona, morto senza aver avuto l’opportunità di confessarsi, anche se è di gran lunga più probabile che egli lo abbia scritto per scagionare se stesso dalle accuse di essere in qualche modo coinvolto in quella morte improvvisa. Per questa ipotesi propende M. de Riquer, Història de la literatura catalana. Part antiga, Barcelona, Ariel, 3 voll., 1964, II, pp. 313-314. Si veda anche M. Di Febo, «Viatge al Purgatori de sant Patrici di Ramón de Perilhós: dalla visione al viaggio», in «La parola del testo», XIII/1, 2010: pp. 21-46. Il Viatge al Purgatori de sant Patrici si può leggere nella vecchia edizione (basata su un solo manoscritto) di A. Vignaux - A. Je-anroy, Voyage au Purgatoire de St. Patrice, Visions de Tundal e de St. Paul, textes languadociens di quinzième siècle, Toulouse, Librairie E. Privat, 1903 [rist.: New York-London 1971].
SONIA MAURA BARILLARI128
difesa di personaggi pubblici e istituzioni. Salvo che se Dante chiama in causa personaggi del calibro di Farinata, Guido da Montefeltro, Ugolino della Gherardesca, Ludovico si riduce a nominare un «abate de san Felixe», il «prior di remiti de Murano», un «falso piovam de sam Marziliam» [...].
La versione di P La versione di C e PD
premessa di Tadeo de Gualandis de Pissisrito di purificazione (15 giorni)
ingresso nel purgatorium e incontro con i fratres albii supplizi inflitti alle anime
demoni femminili - 7 pene (= V)sezione probatoria
demoni femminili
pena del fuoco pena del fuoco
anime inchiodate a terra anime inchiodate a terra
ancora anime inchiodate a terra ancora anime inchiodate a terra
pozzo bollente pozzo bollente
bosco - religiosi piantati col capo in giù – ramo parlante – caccia selvaggia
ruota e mostro divoratore ruota e mostro divoratore
fornace fornace
Giuda incatenato
I ponte
lago di pece infuocata – lussuriosi
lago profondo, città sommerse – sodomiti
prato – avari, usurai
valle – iracondi
città – superbi
valle oscura - golosi
prato - donne infanticide e lussuriose
cimitero
pons subtilisincontro con l’homo albus (= V)
fiume dei peccata leviter purgantes (= V)il re e la regina puniti (= V)
prato di triboli prato di triboli - anime impiccate e arrostite
l’homo albus illustra le pene della sezione probatoria
UN PURGATORIO VENETO 129
iter di 20 miglia - viridarium (= V)
l’albero dell’Eden, Enoch e Elia
l’homo albus lo lascia (= V)incontro con i due vescovi - dentro le mura dell’Eden
sala d’oro e d’argento (= V)città d’argento - viridarium (= V)
città d’oro - viridarium (= V)torre - visione di Dio (= V)rivelazione di archana (= V)
nuovo incontro con l’homo albus (= V)ritorno e uscita dal purgatorium
incontro con Malatesta Ungaro (= V)
5. Conclusioni
La prospettiva comparatistica può dunque aiutarci a comprendere e in-terpretare le discrepanze che emergono dal confronto fra le opere oggetto di queste indagine, la più evidente delle quali è data dalla loro differen-te ampiezza, e fisionomia. Sintetizzando: a fronte di P che si articola asse-condando i principi di una diegesi dalla scansione omogenea e ordinata, estranea alla prolessi quanto all’analessi, proclive agli incrementi come agli approfondimenti esplicativi, V porta avanti un discorso sintetico, essenziale, in apparenza avulso da motivazioni parenetiche, o didattiche. Una carenza a cui è chiamata a ovviare l’“appendice” volgare che non si limita a riassumere quanto è esposto nella narrazione, ma lo arricchisce con elementi aggiunti-vi, riscontrabili sia in P sia in C e Pd. La prosa latina reca inoltre un apparato di glosse marginali, anch’esse in latino, che ne integrano i contenuti con informazioni ricavate dall’“appendice” e assenti nel testo medesimo.
Per contro, C e Pd tendono ad ampliare ulteriormente il racconto, ac-cludendo allusioni e ragguagli riguardanti la realtà locale, dilatando alcuni episodi e inserendone dei nuovi, con l’indubbio risultato di ancorarlo più saldamente allo spazio geografico che ne aveva visto – forse sollecitato – la realizzazione, e così di compiacere il pubblico al quale questo nuovo adatta-mento volgare si rivolgeva. L’intima parentela di entrambi i testimoni – fra loro indipendenti57 – con P, ad ogni buon conto, non lascia dubbi sul modo di procedere adottato da chi aveva allestito il volgarizzamento a cui vero-similmente entrambi si erano rifatti: per addenda e acclusioni di dettagli o brani complementari.
E in effetti questa singolare visione i cui testimoni inequivocabilmente tardivi confermano essere deriva estrema58 di un nucleo diegetico di raro
57 A questo proposito si veda De Martino, op cit., p. 29.58 Posteriore ad essa soltanto quella di Ramón de Perilhós, le cui motivazioni politiche
SONIA MAURA BARILLARI130
vigore, questa narrazione immaginosa, ambientata in un Aldilà dai linea-menti quasi barocchi, pare pervasa da un’irresistibile forza centrifuga di cui è preda e che ne fa una sorta di galassia in lenta, continua espansione. Per orientarci nell’intricata selva di interpolazioni, complementi, chiarimenti, ci sarà utile prendere come punto di riferimento la graduale affermazione dell’idea di purgatorio: se davvero la stesura prima dell’opera era prossima al testo tràdito da V, dovremmo inferire che gli scenarî – fisici e concettuali – in essa tratteggiati rischiavano di apparire inadeguati a petto dell’ormai invalsa consuetudine a dare una rappresentazione complessiva e sequen-ziale dei tre Regni, specie in un’area – quella del settentrione d’Italia – dove il magistero di Dante non aveva tardato a essere accolto e assimilato. In tal senso, P documenterebbe la necessità di trasporre entro gli schemi collaudati di una rigorosa classificazione delle colpe suscettibili di un’irre-missibile condanna quelli che in precedenza potevano essere stati soltanto tormenti inflitti al protagonista (e a chi, come lui, intraprendeva in vita un iter di purgazione) con finalità probatorie e, appunto, espiatorie: di qui l’inserimento del sermone pronunziato dal «reverendus antichus» sull’altra riva del fiume infernale.59
Parimenti, in C e Pd vedremmo riflessa una similare propensione ad adeguare gli assunti della visio all’orizzonte d’attesa, e al bagaglio di cono-scenze, dei fruitori mediante una procedura di aggiustamento – rapsodica, discontinua – che si coglie nel rigoglioso ma disordinato proliferare di epi-sodi frutto, si direbbe, di procedimenti di gemmazione spontanea, poi ag-glutinati in ottemperanza a principi di accumulazione caotica sempre rivolti ad adattare lo svolgimento della trattazione a gusti e interessi non più paghi della semplice, anonima enumerazione e qualificazione di tribolazioni sof-ferte in vista di un riscatto finale. Una procedura agevolata dal potersi con-frontare con una lingua di partenza, il latino di V e P, già profondamente ibridata, sotto il profilo sintattico e semantico, con un volgare in grado di trovare in essa affinità strutturali e culturali tali da consentire una “traduzio-ne” «orizzontale», “infralinguistica”,60 che concede ampi spazi di manovra per conquistare a una materia ormai quasi desueta un nuovo pubblico.
suggeriscono di considerarla un caso a sé nel dossier dei resoconti – reali o fittizi – dei visitatori del purgatorio irlandese.
59 Come si è già rimarcato, non è possibile stabilire l’entità – e ancor prima la presenza – di tale inserto esplicativo in B.
60 La terminologia è mutuata da G. Folena, Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi, 1991, p. 13.