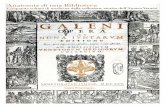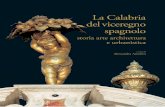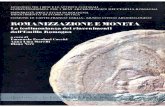Sacrilegi e spazi sacri e profane: Ebrei e cristiani in Polonia d’età moderna
Anticipi di romanizzazione: pianificare, dividere, delimitare gli spazi nel mondo veneto
Transcript of Anticipi di romanizzazione: pianificare, dividere, delimitare gli spazi nel mondo veneto
E. MIGLIARIO
Anticipi di romanizzazione:pianificare, dividere, delimitare gli spazi
nel mondo veneto
estratto da
«Geographia Antiqua»
XIX, 2010
# LEO S. OLSCHKI
GEOGRAPHIA ANTIQUA
rivista di geografia storica
del mondo antico
e di storia della geografia
GEOGRAFIA E POLITICA IN GRECIA E A ROMA
B. VIRGILIO, La corrispondenza del re ellenistico............................................................. 5
A. LARONDE, Les Ptolemees et la Mediterranee .............................................................. 19
P. F. MITTAG, Das Indienbild des Ptolemaios ................................................................ 25
D. MARCOTTE, La mer Erythree et le Sud de l’œkoumene, theme politique dans l’ethnographiehellenistique ............................................................................................................ 39
F. K. MAIER, ,,... zu vertrauten Vorstellungen fuhren‘‘. Die Funktion der Geographie imdidaktischen Geschichtskonzept des Polybios................................................................ 47
S. PANICHI, Lo spazio geografico nella storia dei diadochi (Diodoro XVIII-XX) ................. 65
G. AUJAC, L’urbanisme entre geographie et politique ........................................................ 77
B. DREYER, ‘L’asilo territoriale’ dal periodo tardo-classico fino al dominio degli imperatoriromani ................................................................................................................... 91
E. MIGLIARIO, Anticipi di romanizzazione: pianificare, dividere, delimitare gli spazi nel mondoveneto .................................................................................................................... 99
L. POLVERINI, L’estensione del nome Italia fino alle Alpi e la provincia Gallia Cisalpina...... 115
O. DALLY, Die Grenzen Roms .................................................................................... 123
F. CADIOU, Geographie et pompa triumphalis a Rome ................................................. 141
Saggi
D. MARCOTTE, Le commentaire de Leto a Denys le Periegete retrouve ............................. 151
P. ARNAUD, Notes sur le Stadiasme de la Grande Mer (2): rose des vents, systemesd’orientation et Quellenforschung ........................................................................... 157
F. J. GOMEZ ESPELOSIN, El problema de la credibilidad de los relatos de viaje en la literaturagriega ..................................................................................................................... 163
Note e discussioni
P. JANNI, Ne sappiamo piu degli Antichi? Considerazioni su una ‘notizia’ della stampaquotidiana............................................................................................................... 183
Recensioni e notizie ...................................................................................................... 185
Pubblicazioni ricevute .................................................................................................... 209
Lista dei collaboratori ..................................................................................................... 211
XIX
2010
GEOGRAPHIA ANTIQUArivista di geografia storica
del mondo anticoe di storia della geografia
Direttore responsabileFRANCESCO PRONTERA
Comitato scientificoGERMAINE AUJAC, ANNA MARIA BIRASCHI, GUIDO CLEMENTE, MICHAEL H. CRAWFORD,
ALBRECHT DIHLE, EMILIO GABBA, PATRICK GAUTIER DALCHE,HANS-JOACHIM GEHRKE, PIETRO JANNI, GIANFRANCO MADDOLI, MARICA MILANESI,
FRANCESCO PRONTERA, MIRJO SALVINI, PIERLUIGI TOZZI
Direzione e RedazioneDIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE
Universita degli Studi di Perugia - Via dell’Aquilone 7, 06123 PerugiaTel. 075.585.31.11 - Fax 075.585.31.38 - E-mail: [email protected]
Segreteria di RedazioneLUCIA PALLARACCI, SILVIA PANICHI, ILARIA SERPOLLI
AmministrazioneCASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI
C.P. 66 - 50123 Firenze . Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 Firenze
E-mail: [email protected] . c.c.p. 12.707.501
Tel. (+39) 055.65.30.684 . Fax (+39) 055.65.30.214
2010: ABBONAMENTO ANNUALE - ANNUAL SUBSCRIPTION
ISTITUZIONI - INSTITUTIONS
La quota per le istituzioni e comprensiva dell’accesso on-line alla rivista,
Indirizzo IP e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione dovranno essere inoltrati a [email protected]
Subscription rates for institutions includes on-line access to the journal.
The IP address and requests for information on the activation procedure should be sent to [email protected]
Italia: e 96,00 . Foreign e 116,00
PRIVATI - INDIVIDUALS
solo cartaceo - print version only
Italia: e 74,00 . Foreign e 95,00
Composizione, impaginazione e stampaCDC ARTI GRAFICHE - Citta di Castello
Le opere per recensione vanno spedite a:«Geographia Antiqua» Dipartimento di Scienze Storiche
Universita degli Studi di Perugia - Via dell’Aquilone 7, 06123 Perugia
Articoli e note vengono pubblicati previo giudizio di due studiosi (secondo la procedura peer review),
di cui almeno uno esterno al Comitato scientifico. L’elenco dei revisori verra reso noto ogni due anni.
Pubblicazione periodica - Reg. Cancell. Trib. Perugia n. 35-99 del 22/6/1999
Iva assolta dall’Editore a norma dell’art. 74/DPR 633 del 26/10/72
ISSN 1121-8940
# LEO S. OLSCHKI, Firenze
In copertina: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana. Ms. Laur. San Marco 190, c. 74r.Su concessione del Ministero per i beni culturali e le attivita culturali.E vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
ELVIRA MIGLIARIO
Anticipi di romanizzazione: pianificare, dividere,delimitare gli spazi nel mondo veneto
Del ricco e notevolissimo patrimonio epigrafico latino del Veneto fa parte un piccolodossier di testi confinari assai noti, consistente di quattro iscrizioni (tre incise su cippi e una sudi una parete rocciosa)1 che segnalavano altrettanti punti della linea di confine fra il territoriodi pertinenza di Ateste/Este e quelli di Patavium/Padova e di Vicetia/Vicenza (fig. 1). Si trattadi documenti molto studiati,2 fra i piu antichi del genere, che ne conta complessivamenteassai pochi: infatti, a fronte delle parecchie iscrizioni che segnalano la fissazione di confinia seguito di sentenze autoritative di eta imperiale, emesse dal senato o dall’imperatore stessoper dirimere dispute confinarie sorte sia in Italia sia, soprattutto, nelle province,3 ben piuscarsi sono i documenti di eta repubblicana,4 fra i quali le quattro iscrizioni venete sonotra i piu risalenti, essendo datate agli anni ’40 e ’30 del II secolo a.C.
Le tre iscrizioni da Galzignano (fig. 2), da Teolo e dal Monte Venda recano testi simili, dacui ricaviamo che il proconsole Lucius Caicilius in applicazione di una delibera del senato (exsenati consolto) ordino che venissero fissati (statui iusit) i confini e i relativi termini confinari (ter-minos finisque) fra la comunita di Ateste e quella di Patavium. In base all’identificazione del per-sonaggio citato con Lucio Cecilio Metello Calvo, cos. 142 a.C. e presumibilmente proconsolenell’anno successivo, il provvedimento si daterebbe appunto al 141. La quarta iscrizione, daLobia di Lonigo, ricorda un provvedimento analogo databile al 135 a.C., in quanto attuatoda Sesto Attilio Serrano (Sextus Atilius Saranus), cos. 136 a.C. e proconsole l’anno dopo.
* La genesi di questo lavoro – ripreso e ampliato dietrocortese invito di Francesco Prontera, che qui ringrazio – risalea un intervento al Seminario in onore di Michael Crawford«Incontri di culture nell’Italia antica. La documentazione epi-grafica», organizzato da Maurizio Giangiulio nel novembre2007 presso il Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturalidell’Universita di Trento. Le pagine che seguono devono mol-to alla discussione di allora, e in particolare alle importanti os-servazioni di Anselmo Baroni e di Michael Crawford.
1 CIL I2 2501 = ILLRP 476 = Imagines 202 = SI XV(1997) 14 (da Galzignano: figg. 1-2, nr. 25; ora al Museo Na-zionale Atestino): L . CAICILIVS . Q . F . PRO . COS . TERMINOS /FINISQVE . IVSET . STATVI . EX . SENATI / CONSOLTO . INTER .
PATAVINOS . ATESTINOSQVE; CIL I2 634 = CIL V 2492 = ILS5944 = ILLRP 476 = Imagines 201 a, b (da Teolo: fig. 1, nr. 69;ora al Museo Civico di Padova): L . CAICILIVS . Q . F . / PRO .
COS / TERMINOS / FINISQVE . EX / SENATI . CONSOLTO /
STATVI . IVSIT . INTER / PATAVINOS / ET . ATESTINOS; CILI2 633 = CIL V 2491 = ILS 5944a = ILLRP 476 (dal MonteVenda: fig. 1, nr. 43; ora al Museo Nazionale Atestino): L .
CAICILIVS . Q . F . PRO . COS / TERMINOS . FINISQVE . EX /SENATI . CONSVLTO . STATVI / IOVSIT . INTER . ATESTINOS /ET . PATAVINOS; CIL I2 636 = CIL V 2490 = ILS5945 = ILLRP 477 = Imagines 203 a, b, c (da Lobia di Lonigo:fig. 1, nr. 31; ora al Museo Maffeiano di Verona): SEX . ATILIVS
. M . F . SARANVS . PRO . COS / EX . SENATI . CONSVLTO / IN-
TER . ATESTINOS . ET . VEICETINOS / FINIS . TERMINOSQVE .
STATVI . IVSIT. Per l’analisi paleografica delle iscrizioni, e sul-la duplice redazione del testo di ILLRP 476, BUONOPANE
1992.2 Storia degli studi in BANDELLI 1998a, p. 153.3 Rassegna in BURTON 2000; si veda anche DALLA ROSA
2007.4 Elenco in SCUDERI 1991.
* 99 *
L’orizzonte cronologico in cui questi documenti si collocano e dunque precedente di al-meno quattro decenni alla lex Pompeia de Transpadanis dell’89 a.C., e di almeno cinque all’i-stituzione della provincia di Cisalpina, che l’ipotesi piu generalmente condivisa fa risalire a unprovvedimento sillano.5 Secondo tale opinione prevalente, che qui si segue, ne nel 141 ne nel135 a.C. esisteva ancora una provincia Cisalpina da intendersi quale «distretto amministrativodell’impero romano» – e percio facente parte di un sistema di dominio anche territoriale che sisviluppo compiutamente non prima degli ultimi anni del II secolo a.C.6 – affidato a un go-vernatore con competenze militari, giurisdizionali e fiscali sul territorio a lui affidato.
Tuttavia, pur non esplicandosi in una provincia corrispondente a un distretto territorialeprecisamente delimitato, l’operato in area veneta di ciascuno dei due proconsoli ai quali, apochi anni di distanza l’uno dall’altro, il senato diede mandato di applicare un proprio prov-vedimento puo comunque essere considerato una provincia, in quanto avrebbe potuto costi-tuire la «sfera di attivita»7 assegnata a ciascuno di quei promagistrati; la definizione dei confinifra Ateste e le citta limitrofe comportava infatti, come si dira meglio piu avanti, una serie dioperazioni delicate e complesse che avrebbero richiesto una protratta presenza in loco degliex-consoli a cui ne era stata affidata la responsabilita esecutiva.
In assenza di una provincia del tipo amministrativo-territoriale, l’attivita dei due procon-soli del 141 e del 135 a.C. puo trovare giustificazione solo nel quadro del foedus che legava lecomunita venete a Roma8 almeno dal 225 a.C., l’anno in cui Veneti e Cenomani risultanoavere contribuito con un totale di 20.000 uomini alle forze alleate di Roma.9 Ed e senz’altroin ottemperanza agli obblighi di reciproco soccorso previsti dal foedus medesimo che possonoessere interpretati sia lo sgombero imposto da Roma ai gruppi celtici immigrati in area ve-neta orientale nel 186 a.C.,10 sia l’intervento del proconsole Marco Emilio Lepido chiamatodai Patavini a reprimere una seditio che nel 175-174 a.C. aveva creato fra di loro gravi pro-blemi di ordine pubblico.11
Gli interventi proconsolari miranti alla definizione confinaria di Ateste si inseriscono inun quadro territoriale e in un contesto storico regionale (fig. 3) che entro il primo ventenniodel II secolo a.C. risultarono fortemente marcati da un evento di straordinaria importanzaquale fu nel 181 a.C. la fondazione di Aquileia.12 E difficile valutare appieno l’impattoche la costituzione della grande colonia dovette avere nel mondo veneto: non soltantoper la creazione di un centro urbano che ripeteva moduli edilizio-architettonici di matriceromano-italica, proponendo dunque una forma di urbanizzazione percepita come largamen-te innovativa, ma anche per il sistema delle grandiose operazioni di riorganizzazione del ter-ritorio – misurazione e delimitazione, drenaggio e bonifica... – preliminari alla distribuzioneparcellare (in cui, non va dimenticato, vennero coinvolti anche assegnatari indigeni).13 Nonpare percio irragionevole supporre che il modello urbanistico e territoriale offerto dallacolonia abbia in varia misura influenzato l’evoluzione in senso ‘cittadino’ di diversi centriveneti, accelerando quei processi di ‘autoromanizzazione’ che gia erano in atto in variinsediamenti indigeni, dove l’indagine archeologica sta appunto rivelando i segni diun’urbanizzazione precoce e autoindotta.
5 Si veda da ultimo, in questo stesso fascicolo, L. POLVE-
RINI, L’estensione del nome Italia fino alle Alpi e la provincia GalliaCisalpina. Ha avuto scarso seguito la proposta avanzata da F.Cassola (CASSOLA 1991) di anticipare la data della provincializ-zazione alla meta del II secolo (proprio sulla scorta delle iscri-zioni confinarie atestine lo Studioso riteneva che i due inter-venti proconsolari nel Veneto presupponessero l’istituzionedella provincia).
6 CRAWFORD 1990, spec. pp. 103-109.7 ID., p. 91.8 LURASCHI 1979, pp. 97-98; GABBA 1994 = 1985a,
p. 39.
9 Polyb. II, 24, 7; LURASCHI 1979, pp. 3-22; GABBA
1990, pp. 75-76.10 Liv. XXXIX, 22, 6-7; XXXIX, 45, 6-7; XXXIX, 54,
2-13; XXXIX, 55, 1-6.11 Liv. XLI, 27, 3-4. Su entrambi gli episodi: BUCHI
1993; BANDELLI 2003, pp. 51-53.12 Si veda da ultimo l’importante mise a point in BANDELLI
2003 (con bibliografia precedente).13 GABBA 1990.
ELVIRA MIGLIARIO
* 100 *
Tale appare il caso dei centri egemoni di Padova e di Este, il cui trapasso alla fase pie-namente urbana risulta compiuto proprio nel II secolo a.C., ma anche di altri di minore ri-lievo quali Vicenza, Oderzo e Altino,14 che nel corso dello stesso II secolo conobbero unnotevole sviluppo in direzione dell’urbanizzazione; al punto che nel caso di Altino la strut-tura dell’insediamento post 49 a.C. potra ricalcare quella del centro preromano, in cui gianella prima meta del I secolo era stata attuata la monumentalizzazione del pomerio urbano,15
e forse ancora prima era stato delimitato un auguraculum.16 Quali ulteriori testimonianze diuna riorganizzazione spaziale e di una riqualificazione dei centri anche minori, mediante unprocesso che e stato interpretato nel senso di un adeguamento volontario ai criteri ideologicie ai parametri urbanistici romani, si possono considerare la prima sistemazione dell’area fo-rense di Oderzo, databile almeno agli inizi del I secolo, e comunque a prima dell’89 a.C.; maanche la cerimonia pubblica di probabile definizione confinaria a cui rimanda il deposito vo-tivo degli inizi del I secolo rinvenuto ad Asolo, cosı come l’inauguratio di uno spazio pub-blico avvenuta agli inizi del I secolo a.C. nel foro di Concordia.17
In tutti questi casi, la delimitazione degli spazi pubblici mediante procedure formali diconfinazione sembra costituire una tappa importante nel processo di urbanizzazione dei varicentri e di acquisizione di una consapevole identita ‘civica’ (e non soltanto nel mondo ve-neto: basti ricordare il significato ‘precivico’ della delimitazione del campus «comune agli deie agli uomini» segnalato dalla stele bilingue di Vercelli).18 Dunque, un processo evolutivoverso l’urbanizzazione evidentemente molto avanzato agli inizi del I secolo a.C. ma ricon-ducibile al secolo precedente, ai decenni cruciali durante i quali, sotto la spinta della roma-nizzazione, le strutture insediative e territoriali del mondo veneto furono sottoposte a tra-sformazioni importanti.
A questo proposito, la rappresentazione cartografica del sistema formato dai centri prin-cipali e dalla viabilita maggiore (fig. 4) consente di cogliere immediatamente la centralitastrutturale di una rete viaria che nelle sue principali articolazioni – tutte facenti capo adAquileia – risulta essere stata completata, forse nell’arco di due soli decenni, entro gli anni’30 del II secolo a.C.
La prima strada romana tracciata in direzione di Aquileia attraversava il cuore del mondoveneto, toccando sia Ateste e Patavium sia Altinum, vale a dire i due centri maggiori e piuantichi, la cui crescita ‘protourbana’ risaliva gia al VI-V secolo,19 e il centro lagunare dovesorgeva quello che gia nel VI secolo a.C. era il santuario emporiale interetnico probabilmen-te piu importante della fascia costiera.20 La questione della paternita e dunque della datazionedi questa cosı come di altre successive articolazioni della rete viaria veneta non e ancoracompletamente risolta; qui bastera ricordare che secondo alcuni la piu antica strada tracciatada Roma nel territorio dei Veneti sarebbe stata la via Annia, realizzata nel 153 a.C. da T.Annio Lusco;21 ma se, come altri ipotizzano, il suo primo tratto fosse invece attribuibile aM. Emilio Lepido, esso costituirebbe una via Aemilia ‘veneta’ risalente gia al 175 a.C.22
14 CAPUIS 1998a; MALNATI – TIRELLI – CROCE DA VIL-
LA 1998.15 CRESCI MARRONE – TIRELLI 2007b.16 TIRELLI 1999.17 Oderzo: MALNATI – TIRELLI – CROCE DA VILLA
1998, pp. 444-458; TIRELLI 1999; Asolo: GAMBACURTA
2005; Concordia: MALNATI – TIRELLI – CROCE DA VILLA
1998, pp. 458-462; DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001.18 SI n. s. 19, 2002, nr. 1, pp. 297-300, per cui rimando al
commento ad loc. e a GIORCELLI BERSANI 2002, spec. pp. 61-68;nonche alle interessanti osservazioni di L. MAGANZANI (c. s.).
19 CAPUIS 1998a, pp. 101-102.20 CRESCI MARRONE – TIRELLI 2007b.
21 WISEMAN 1989; sintesi recente della questione inCORRAIN – ZERBINATI 2003, pp. 30-34, e BANDELLI 2007,p. 21.
22 BOSIO 19972, pp. 31-41; la via Annia sarebbe pertantola strada che portava ad Altino e ad Aquileia passando per Pa-dova, ma che partiva da Adria (sul percorso v. da ultimo TOZZI
2009, pp. 34-35, 97-106 con tavv. 41-50), e che avrebbe cosıcostituito la prosecuzione della strada tracciata fra Rimini eAdria da P. Popillio Lenate nel 132 a.C. In tal caso tuttaviala costruzione della via Annia dovrebbe avere seguito, e nonpreceduto, quella della Popillia; di qui la necessita di abbassarnela datazione alla pretura di T. Annio Rufo del 131 a.C. (BOSIO
1970, p. 53 e nota 1; BOSIO 1987, pp. 64-72).
* 101 *
PIANIFICARE, DIVIDERE, DELIMITARE GLI SPAZI NEL MONDO VENETO
Fu comunque grazie a questo percorso stradale che a partire al piu tardi dagli ultimi de-cenni del II secolo a.C. Este, Padova, Altino, e anche Concordia, vennero a trovarsi inseriteall’interno di una linea poleografica che aveva da un lato come estremita le citta della viaAemilia (maior), e dall’altro Aquileia come capolinea (fig. 3). Dal sistema stradale che colle-gava la colonia con i centri veneti deriva la rapida propagazione del modello urbanistico rap-presentato da Aquileia: la citta era il caput pure di un’altra grande strada, la via Postumia (forsecronologicamente posteriore, essendo stata costruita a partire dal 148 a.C., ma destinata adassurgere al ruolo di asse stradale primario del mondo veneto e dell’intera Cisalpina setten-trionale);23 lungo il percorso della Postumia sorgevano Vicetia e Opitergium, poco lontanoAcelum, centri caratterizzati anch’essi, come gia si e detto, dai segni di un’urbanizzazionela cui precocita deve essere ricondotta ancora una volta all’influenza del modello aquileiese.
A sua volta, la poleografia indigena non puo non avere condizionato le forme e le mo-dalita con cui venne realizzata la pianificazione del territorio, di cui la centuriazione di Aqui-leia e la rete della viabilita maggiore costituiscono gli elementi generatori fondamentali; leoperazioni agrimensorie – che dovettero impegnare specialisti numerosi ed esperti – interes-savano d’altronde suoli di comunita alleate, delle cui strutturazioni tradizionali non si potevanon tenere conto. Da una parte infatti l’alleanza coi Veneti doveva prevedere clausole estre-mamente favorevoli a Roma e consentire una liberta d’azione altrove impensabile: si pensi alben diverso caso del foedus con gli Insubri che, secondo un’acuta intuizione,24 verosimilmen-te riservava a loro il territorio a nord del Po, motivo per il quale nel 148 a.C. il ramo occi-dentale della stessa via Postumia da Cremona in avanti fu tracciato interamente a sud del fiu-me. D’altra parte pero si richiedevano altrettanto grandi cautele, poiche vi e motivo dicredere che nel mondo veneto, cosı come altrove, e non solo nella Cisalpina, la riorganiz-zazione territoriale romana tendesse a confermare ove possibile la preesistente situazionepossessoria, pubblica e privata, con l’obiettivo di salvaguardare gli equilibri sociali ed econo-mici tradizionali, senza ledere gli interessi dei ceti superiori, sui quali il rapporto di Romacon gli alleati fondava le proprie basi.25
Il mondo delle consuetudini e delle tradizioni giuridiche dell’Italia preromana, e soprat-tutto della Cisalpina, resta quasi del tutto sconosciuto, sicche si ignora quali fossero le varieforme di possesso dei suoli vigenti a livello locale prima che avesse inizio il processo di uni-formazione al diritto romano che si sarebbe compiuto con la municipalizzazione. L’assenzapressoche completa di fonti da un lato ha determinato un prolungato disinteresse da partedegli storici del diritto antico per la problematica dei molteplici modi preromani di posse-dere,26 dall’altro ha indotto a un’insistenza per alcuni aspetti eccessiva (benche per molti altridel tutto motivata) sulla portata assolutamente innovativa della ristrutturazione territorialeattuata da Roma: quasi che le societa italiche non avessero conosciuto forme protogiuridichedi delimitazione e di attribuzione degli spazi e dei suoli in grado, almeno in alcuni casi, dicostituire una struttura portante che la successiva riorganizzazione romana non necessaria-mente avrebbe obliterato.
La questione merita di essere riconsiderata alla luce di alcune testimonianze epigrafiche invenetico, su cippi di forme e dimensioni varie provenienti da Padova, da Vicenza (fig. 5) e daOderzo. Si tratta di manufatti che possono essere complessivamente considerati come espres-sioni dell’attenzione particolare riservata nel mondo veneto alla delimitazione pubblica deglispazi e dei suoli; pur con tutte le riserve imposte dalla scarsita e dalla casualita dei ritrovamen-ti, e difficile non considerare in qualche modo significativo che, nella totalita del corpus epi-
23 Oltre ai contributi raccolti in Tesori della Postumia, 1998(ivi spec. BANDELLI 1998a, p. 152, con sintesi della storia deglistudi), rimando a TOZZI 1999.
24 GABBA 1994 = 1986, pp. 249-250.25 GABBA 1990, p. 76; GABBA 1994 = 1986, pp. 254-255.26 CAPOGROSSI COLOGNESI 1991, pp. 233-234.
ELVIRA MIGLIARIO
* 102 *
grafico in lingua veneta, le iscrizioni confinarie siano a tutt’oggi le sole di carattere non pri-vato.27
Lungo due facce del cippo Pa 14,28 rinvenuto a Padova in un contesto di reimpiego,corre l’iscrizione
a) entollouki termonb) [...] edios teuters
testo che gli editori interpretano cosı: due o piu soggetti non precisabili (indicati dal lemma[...] edios, mutilo e non altrimenti attestato, ma probabilmente un plurale) posero o eressero anome della comunita (teuters, forma verbale connessa col sostantivo teuta, ‘comunita’) un cip-po terminale (termon) all’interno (entol-) di uno spazio (-louki) confrontabile con il lucus lati-no. E stata ultimamente avanzata anche una diversa proposta interpretativa,29 secondo cui,scomponendo entollouki in due sostantivi (nominativo entollo + genitivo uki), il testo alla li-nea a) risulterebbe entollo uki termon, traducibile come «termine rialto della riunione», men-tre, a seguito dell’integrazione [m]edios, medios teuters (linea b) varrebbe per «assemblea po-polare». Come si vede, pur presentando divergenze notevoli, le due ipotesi di lettura delcippo padovano concordano per quanto riguarda l’ambito semantico dei due lemmi chequi piu interessano, termon e teuters, che rimandano inequivocabilmente a una procedura uf-ficiale di delimitazione di uno spazio pubblico, mediante l’apposizione di un cippo monu-mentale di confine da parte di rappresentanti di una comunita.
Il cippo Vi 230 fu rinvenuto nel 1855 nei dintorni di Vicenza, «in cima a un poggio» suicolli Berici, in un contesto che indusse gia gli scopritori a riconoscervi una pietra terminaleposta a segnalazione di un trivio. In verticale lungo l’intera altezza del cippo corre un’iscri-zione di una sola linea, incisa con un’accuratezza che depone a favore del carattere ufficialeo, semplicemente, dell’importanza attribuita al monumento:
Osts Katusiaios donasto atraes Termonios deivos.
Il testo e quasi interamente interpretabile (il solo lemma atraes resta senza spiegazioniconvincenti): un individuo, Osts Katusiaios, dedico (donasto e verbo dedicatorio) agli DeiTermini (Termonios deivos) un oggetto che dovrebbe essere il cippo stesso. Il dedicante portaquello che all’apparenza e un doppio nome morfologicamente classificabile come veneto, ilcui primo elemento, Osts, potrebbe tuttavia non essere un nome proprio, visto che significa‘straniero’;31 e invece senz’altro un nome personale Katusiaios, ascrivibile pero all’onomasticaceltica, che comprende numerose attestazioni di Katusios/Caturius (dal molto diffuso Ca-tus).32
L’oscurita del lemma atraes non impedisce di attribuire anche in questo caso il cippo el’iscrizione all’ambito di una procedura di confinazione, condotta ritualmente e compiutamediante una dedica alle divinita garanti della sacralita del confine stesso da parte di un in-dividuo recante un nome ‘venetizzato’ benche di probabile origine celtica: uno «straniero»
27 Anche la Tavola di Este, senz’altro il piu notevole do-cumento epigrafico in venetico rinvenuto negli ultimi decenni,potrebbe contenere «una regolamentazione dell’uso del territo-rio, nelle applicazioni di confinazione, distribuzione, sfrutta-mento»: MARINETTI 1999, pp. 413-424 (p. 420).
28 PELLEGRINI – PROSDOCIMI 1967, I, pp. 80, 170-173,364; PROSDOCIMI 1979; PROSDOCIMI 1988, pp. 293-296;per i singoli lemmi, PELLEGRINI – PROSDOCIMI 1967, II, sottole rispettive voci.
29 ZAVARONI 2009.30 PELLEGRINI – PROSDOCIMI 1967, I, pp. 382-387;
PROSDOCIMI 1988, pp. 300-301.31 PELLEGRINI – PROSDOCIMI 1967, II, pp. 148-150; CA-
PUIS 2005, p. 509; per il confronto con il lat. hostis/hospes,
PROSDOCIMI 2009, pp. 135-139. Osts compare anche in un’i-scrizione da Isola Vicentina: MARINETTI 1999, p. 426, nr. 14;MARINETTI 2009, pp. 369-370.
32 PELLEGRINI – PROSDOCIMI 1967, II, p. 115, s.v. Katu-siaios (da confrontare con A. Catusius Severianus, nome di uncivis gallus attestato a Pola da Inscr. It. X. 1, 163); PROSDOCIMI
1988, pp. 404-405. La presenza di basi onomastiche di tipo cel-tico in documenti di lingua e scrittura venetica e bene docu-mentata: MAINARDIS 2001, p. 57; influssi celtici nell’onomasti-ca sono riscontrabili a partire dalla fine del V-inizi del IV secoloa.C. (TOMBOLANI 1985, pp. 61-65), epoca nella quale a livel-lo linguistico-culturale avrebbe iniziato a prodursi «il proces-so di dissoluzione dell’identita veneta»: RUTA SERAFINI 2001,p. 202.
* 103 *
PIANIFICARE, DIVIDERE, DELIMITARE GLI SPAZI NEL MONDO VENETO
appunto, «ospite in patria d’altri»,33 ma apparentemente del tutto integrato nel mondo ve-neto, se non altro a livello linguistico e culturale. Il contesto archeologico del rinvenimentosuggerisce che il cippo fosse stato originariamente collocato a seguito di un rito analogo aquello descritto esplicitamente come arcaico in un noto passo di Siculo Flacco,34 ove il teo-nimo veneto trova un riscontro impressionante in quello latino degli dei Termini:
De condic. agr. 105, 5-19 Thu. (= 141 La.): cum enim terminos disponerent, ipsos quidam lapidesin solidam terram rectos conlocabant proxime ea loca, in quibus fossis factis positura eos erant, etunguento uelaminibusque et coronis eos [c]or[o]nabant. In fossis autem, in quibus eos posituraerant, sacrificio facto hostiaque inmolata atque incensa facibus ardentibus, in fossa cooperti san-guinem instillabant, eoque tura et fruges iactabant. Fauos quoque et uinum aliaque, quibus con-suetudo est Termini[s] sacrum fieri, in fossis adiciebant. Consumptisque igne omnibus dapibus,super calentes reliquias lapides conlocabant atque ita diligenti cura confirmabant. Adiectis enimquibusdam saxorum fragminibus circum calcabant, quo firmius starent. Tale ergo sacrificium do-mini, inter quos fines dirimebantur, faciebant. Nam et si in trifinium, id est in eum locum quemtres possessores adstringebant, si termini ponerentur, omnes tres sacrum faciebant, terminos au-tem conuenientia possessorum confirmabat.
Insieme alle epigrafi confinarie di Padova e di Vicenza pare opportuno considerare duecippi di piccole dimensioni, simili a grossi sassi rastremati all’estremita inferiore, rinvenuti aOderzo durante un saggio di scavo compiuto nel 1982 e pertinenti allo strato sottostante aquello di fondazioni romane di I-II secolo.35 Entrambi i manufatti recano sulla faccia supe-riore due incisioni che si incrociano a formare il segno X, nonche, iscritte in verticale, duelettere in alfabeto venetico, t e, che sono state interpretate come un’abbreviazione di teuta, illemma venetico indicante ‘comunita’ o ‘popolo’, il cui radicale e riconoscibile anche nellaforma verbale teuters dell’iscrizione Pa 14. Il segno X inciso sulla sommita dei cippi ha sug-gerito un confronto con «il decussis della gromatica, ossia il segno formato dall’intersezioneperpendicolare di due linee»36 che veniva utilizzato sia come indicatore dell’orientamentonel contesto di una limitatio, sia come segnale di confine qui agrum intra clausum et extra clau-sum significat.37 Se, come e stato suggerito, i due cippi fossero effettivamente ascrivibili a que-sta seconda categoria, essi attesterebbero che la comunita opitergina aveva provveduto a sud-dividere il territorio di sua pertinenza distinguendovi ufficialmente aree diverse a probabiledifferente destinazione. Anche a Oderzo dunque gia in eta preromana sarebbero esistite for-me ‘pubbliche’ di delimitazione dei suoli, e piu in particolare di confinazione fra l’area im-mediatamente circostante il centro abitato e il territorio a questo piu esterno.
Oltre a testimoniare di una precoce attenzione alla fissazione dei confini e, conseguen-temente, del possesso di conoscenze tecniche sia pure minime che l’operazione richiedeva, ladelimitazione formale degli spazi pubblici segna, come gia si e detto, una tappa importantenel processo di urbanizzazione dei vari centri veneti;38 un processo che presuppone a suavolta sia l’acquisizione di una consapevole identita ‘civica’, sia l’altrettanto consapevole iden-tificazione di una comunita con un territorio riconosciuto come proprio, innanzitutto in re-lazione con quelli delle comunita contermini. Le trasformazioni in senso urbano che in di-versi centri veneti risultano compiute all’inizio del I secolo a.C. non sono pensabili se non in
33 PROSDOCIMI 2009, p. 135; il suffisso femminile -ia delnome Katusiaios segnalerebbe una discendenza matrilineare,forse dichiarata nei casi di paternita non giuridicamente ricono-scibile, come poteva avvenire per i figli di padri schiavi o stra-nieri: PROSDOCIMI 1988, p. 373.
34 VINCI 2004, pp. 204-209, con letteratura, e da ultimoCAMPBELL 2005, p. 311. Sul culto di Termon/Terminus, DUME-
ZIL 1966, pp. 203-206; PICCALUGA 1974, pp. 118-123, 293-325 (sui rituali sacrificali); GONZALES 2005.
35 Od 8a-8b: MARINETTI 1988, pp. 341-343.36 MARINETTI 1988, p. 345; si veda anche CAMPBELL
2000, p. 371, nn. 13-14.37 Term. diagr. 341, 31 La.; cfr. 140, 10 La.; 235, 14 La.;
286 La.38 CAPUIS 2005, p. 510; CRESCI MARRONE – TIRELLI
2007a.
ELVIRA MIGLIARIO
* 104 *
relazione a, e come conseguenza di, una precisa definizione dei rispettivi ambiti territoriali,reciprocamente riconosciuti dalle comunita interessate, sia pure in un ambito di rapporti re-golati da norme protogiuridiche.
E pertanto nel contesto degli equilibri politici esistenti fra i maggiori centri ‘urbani’ ve-neti del II secolo a.C. che bisogna considerare le iscrizioni confinarie atestine. La fissazionedei confini e dunque dell’estensione dei territori di Ateste, Patavium e Vicetia ad opera diemissari di Roma costituı per certi aspetti una novita, in quanto prodotta dalla decisione (av-vertita come incontestabile) di un alleato straniero dominante, mentre non dovette introdur-re elementi particolarmente innovativi negli assetti del territorio: l’attenzione per la delimi-tazione ufficiale degli spazi che risulta cosı risalente e radicata nel mondo veneto lascia infattisupporre che le pertinenze territoriali delle comunita interessate dai provvedimenti del 141-135 a.C. fossero gia in buona parte formalmente definite, e che l’intervento romano abbiasancito – vuoi confermando l’attribuzione di confini tradizionali non necessariamente ogget-to di controversia, vuoi rettificandoli in varia misura – il ripristino o la modifica di un quadroterritoriale sostanzialmente delineato in precedenza.
Nelle iscrizioni confinarie si fa riferimento ad almeno due senatusconsulta attuati per in-tervento proconsolare, senza specificare se si trattava di sentenze arbitrali emesse per dirimereuna controversia sorta a seguito di una disputa – cosı come generalmente avveniva39 – op-pure se il parere vincolante del senato era stato richiesto cautelativamente, da parte di una opiu delle tre comunita, o allo scopo di prevenire un possibile contenzioso,40 o semplicemen-te per motivi di autoaffermazione a livello locale; in ogni caso, per giungere alla fissazionedei confini fra Ateste, Vicetia e Patavium era evidentemente parso opportuno, se non indi-spensabile, ricorrere all’autorita di Roma.
Come gia si e detto, i tre centri erano toccati dall’una o dall’altra delle due piu impor-tanti strade tracciate nel mondo veneto nei decenni successivi alla fondazione di Aquileia:Ateste e Patavium dalla via Annia (o Aemilia-Annia), Vicetia dalla via Postumia. Benche i lororispettivi territori non fossero stati interessati da operazioni di centuriazione,41 la costruzio-ne delle grandi strade, comportando l’individuazione e la delimitazione di zone riservatealla sede stradale e alle aree di rispetto, dovette indirettamente indurre e rendere diffusala necessita di ridefinire o di confermare ufficialmente le confinazioni pubbliche e privateeventualmente preesistenti. A fronte di queste esigenze, mediante il ricorso al senato la co-munita atestina avrebbe potuto ottenere conferma della situazione confinaria in atto scon-giurando il rischio di eventuali contestazioni, e vederla riconosciuta per mezzo di una for-malizzazione autorevolissima che ne avrebbe imposto il rispetto a livello sia regionale siainternazionale.
Inoltre, la definizione ufficiale da parte del senato dell’estensione territoriale precisamen-te attribuita agli Atestini da un lato aveva una potenziale valenza censitaria, in quanto potevacostituire uno strumento utile per valutare le capacita demografiche e patrimoniali in basealle quali erano fissati i contributi imposti dal foedus;42 dall’altro, assumeva anche il significatodi un riconoscimento della situazione vigente a livello locale nell’ottica del diritto pubblicoromano, quasi che Ateste (cosı come, forse, Patavium o Vicetia, i cui territori saranno pure statiperimetrati su vari lati, e non solo al confine con quello atestino) si predisponesse ad acquisire
39 L’esempio piu noto, e cronologicamente piu vicino, eofferto dalla tavola della Polcevera, del 117 a.C. (ILS 5946 =ILLRP 517), dove il senatusconsultum fa esplicito riferimentoal contenzioso per cui le parti in causa, i Genuates e alcune comu-nita dell’entroterra, avevano richiesto l’intervento dirimente delsenato: oltre al classico lavoro di Emilio Sereni (SERENI 1955), sivedano i contributi raccolti in PASTORINO 1995 e, da ultimi,CRAWFORD 2003; MENNELLA 2004; PASQUINUCCI 2004.
40 Cosı CAMPBELL 2005, p. 309.41 Accertate solo in seguito, e in particolare ad Ateste, per
la deduzione di una colonia militare augustea: BUCHI 1993,pp. 52-58.
42 L’arruolamento dei contingenti militari richiesti dai foe-dera richiedeva l’adozione di pratiche di censimento di tipo ro-mano: GABBA 1994 = 1987, p. 46.
* 105 *
PIANIFICARE, DIVIDERE, DELIMITARE GLI SPAZI NEL MONDO VENETO
gli strumenti idonei a tradurre almeno alcuni dei propri ordinamenti tradizionali in quelli diRoma, analogamente a quanto attestato per altre comunita italiche.
E infatti noto che gia nel corso del II secolo a.C. presso diverse citta o gruppi etnici ita-lici, sia alleati sia di diritto latino, aveva preso avvio quello che e stato definito come «ungenerale processo di omogeneizzazione istituzionale e magistratuale»,43 le cui finalita – l’a-deguamento e l’integrazione nel sistema romano perseguiti dalle elites locali – erano conse-guibili innanzitutto tramite l’unificazione normativa. Lo strumento con cui questa pote rea-lizzarsi, in anticipo sui successivi provvedimenti legislativi di concessione della cittadinanza,fu l’istituto del fundus fieri, che prevedeva la facolta di accettare leggi romane, dietro conces-sione di Roma, per le comunita di diritto latino oppure a lei legate da vincoli internaziona-li:44 uno strumento di cui Cicerone in un celebre passo della pro Balbo lascia intendere quan-to l’applicazione fosse frequente e gia da lungo tempo collaudata.45
In pagine importanti, Emilio Gabba ha proposto un’interpretazione dell’origine e delladenominazione dell’istituto che muove dall’etimologia del sintagma fundus fieri, ove fundusmanterrebbe il significato tecnico originario di «unita amministrativo-catastale»: 46 sicche,fundus fieri indicherebbe «precisamente e prioritariamente l’accettazione, da parte di un po-polo alleato di Roma, della catastazione del proprio territorio, come elemento e aspetto fon-damentale della pratica romana del census»;47 cio implicava che, in caso di forme di possessodei suoli regolate da norme consuetudinarie proprie delle varie tradizioni locali, come gene-ralmente avveniva nel mondo italico preromano, il fundus fieri avrebbe trasferito gli assettiproprietari vigenti nel regime romano della proprieta.
Assumendo ipoteticamente che anche gli Atestini si fossero fatti fundi, la formalizzazioneda parte del senato dei confini perimetrali del loro territorio si sarebbe configurata come unatappa prioritaria e imprescindibile del processo di ristrutturazione in senso censitario degliassetti catastali e patrimoniali di una comunita che, forte di un antico foedus con Roma, non-che di assetti politico-economici adeguati e di un buon livello di acculturazione, gia negliultimi decenni del II secolo a.C. mostrava di possedere i prerequisiti necessari all’acquisizionedella cittadinanza romana.48
L’accettazione del fundus fieri da parte di Ateste costituirebbe d’altronde un ulteriore e note-volissimo esempio di quelle tendenze autoromanizzanti, largamente e variamente attestate nelmondo veneto, di cui fornisce manifestazione emblematica lo ‘epigraphic habit’ locale, che finoall’inizio del I secolo a.C. prevede l’uso scrittorio misto venetico-latino,49 progressivamente ab-bandonato nel corso dei decenni successivi a favore dell’adozione esclusiva del latino.
Un analogo utilizzo ‘misto’ di elementi della tradizione culturale locale e di saperi tecnicid’importazione dovette trovare applicazione anche nell’attuazione concreta e nei risvoltioperativi degli interventi proconsolari. E infatti verosimile che la stabilizzazione dei confinifra Ateste, Vicetia e Patavium sia stata condotta a seguito delle complesse procedure di rico-gnizione dello status quo che i testi gromatici prescrivono dettagliatamente: fra queste innan-
43 GABBA 1994 = 1987, ibid.44 ALBANESE 1991, pp. 1195-1196; 1207-1209 (con biblio-
grafia precedente); CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, pp. 162-168.45 Cic., Balb. 20: totum hoc [l’istituto del fundus fieri], iudi-
ces, in ea fuit positum semper ratione atque sententia, ut cum iussissetpopulus Romanus aliquid, si id adscivissent socii populi ac Latini, et siea lex quam nos haberemus, eadem in populo aliquo tamquam in fun-do resedisset, ut tum lege eadem is populus teneretur, non ut de nostroiure aliquid deminueretur, sed illi populi aut iure eo quod a nobis essetconstitutum, aut aliquo commodo aut beneficio uterentur: ALBANESE
1991, pp. 1193 sgg. I luoghi classici di confronto sono Aul.Gell., Noct. Att. XVI, 13, 6, e le ll. 159-163 della Tabula Hera-cleensis (RS 1996, 24, pp. 355-391, con commento ad loc. diM. CRAWFORD e C. NICOLET).
46 GABBA 1994 = 1985, pp. 193-195.47 Ibid., p. 195.48 L’adozione precoce di una diffusa onomastica romana,
l’iscrizione alla tribu Romilia e l’uso del termine fundus per de-signare le proprieta fondiarie (non attestato altrove nel Veneto)hanno indotto M. Crawford a ipotizzare che Ateste avesse otte-nuto il diritto latino gia fra la fine del II e gli inizi del I secoloa.C. e l’optimum ius nel 90-89 a.C.: CRAWFORD 1989; contra,BUCHI 1993, p. 55; LAFFI 2001 = 1999, pp. 306-307.
49 Un esempio particolarmente significativo e l’iscrizionedella nota stele Pa 6 di Ostiala Gallenia, con onomastica vene-tico-latina resa in alfabeto latino: [M’. Galle]ni M’. f. OstialaeGallen/iae equpetars (PELLEGRINI – PROSDOCIMI 1967, I, pp.344-348).
ELVIRA MIGLIARIO
* 106 *
zitutto l’ispezione autoptica da parte degli agrimensori, che erano tenuti a condurre sul postouno studio approfondito delle pratiche locali e della documentazione eventualmente dispo-nibile,50 nonche a consultare le parti direttamente interessate.51 Poiche inoltre, come e espli-citamente attestato da Siculo Flacco,52 qualunque operazione agrimensoria doveva poterriconoscere e rispettare le preesistenti infrastrutture pubbliche (in primis strade e canalizzazio-ni), nonche le aree cimiteriali e gli edifici sacri, si richiedevano la collazione e lo studio ditutte le evidenze documentali disponibili.
Cio implica che le competenze tecnico-giuridiche degli agrimensori che dovettero assi-stere i proconsoli nell’attuazione concreta dei provvedimenti senatori non potevano prescin-dere da una conoscenza precisa e dettagliata del contesto geoambientale e della situazionegiuridico-amministrativa preesistente. Le operazioni di pianificazione territoriale presuppo-nevano una fase decisionale a livello politico che a sua volta si fondava sia sull’acquisizionedei dati geo-topografici, sia sulla padronanza delle norme e delle consuetudini vigenti a li-vello locale: e cio tanto piu nel caso del mondo veneto, dove si doveva tenere conto di unatradizione antica e articolata di forme di organizzazione dello spazio e di delimitazione delterritorio di cui le fonti epigrafiche consentono di intuire la rilevanza e la diffusione.
50 92, 13 Thu.; 81, 7 Thu.; 97, 9-12 Thu.; 77, 15 Thu.;119, 28 Thu.
51 CAMPBELL 2005, pp. 317-318.52 Sic. Flacc., De condic. agr. 121, 18-25 Thu. = 157 La.:
... auctores divisionis assignationisque leges quasdam colonis describunt,ut qui agri delubris sepulchrisve publicisque solis, itinera viae actus am-bitus ductusque aquarum, quae publicis utilitatibus servierint ad idusque tempus, quo agri divisiones fierent, in eadem condicione essent,qua ante fuerant, nec quicquam utilitatibus publicis derogaverunt (da
cfr. con Hygin., De condic. agr. 83, 13-14 Thu. = 120, 12 La.:se ne veda un’analisi esaustiva in CAPOGROSSI COLOGNESI
1999, pp. 19-20); 127, 14-20 Thu. = 162-163 La.: Collegia sa-cerdotum itemque virgines habent agros et territorio quaedam etiam de-terminata et quaedam aliquibus sacris dedicata, in eis etiam lucos, inquibusdam etiam aedes templaque. Quos agros quasve territoriorumformas aliquotiens comperimus extremis finibus comprehensas sine ullamensurali linea, modum tamen inesse scriptum.
* 107 *
PIANIFICARE, DIVIDERE, DELIMITARE GLI SPAZI NEL MONDO VENETO
Bibliografia
ALBANESE 1991 = B. ALBANESE, Osservazioni sull’istituto del fundus fieri e sui municipia fundana, in ID., Scritti giuridici, II, Palermo,
Palumbo 1991, pp. 1189-1214 (= Studi in memoria di G. Donatuti, I, Milano, Cisalpino-La Goliardica 1973, pp. 1-24).BAGGIO BERNARDONI – ZERBINATI 1989 = E. BAGGIO BERNARDONI – E. ZERBINATI, Este, in Misurare la terra. Centuriazione e
coloni nel mondo romano. Il caso veneto, Modena, Panini 1989, pp. 144-148.BANDELLI 1998a = G. BANDELLI, La penetrazione romana e il controllo del territorio, in Tesori della Postumia, 1998, pp. 147-155.BANDELLI 1998b = G. BANDELLI, Il nuovo quadro storico, in Tesori della Postumia, 1998, pp. 156-162.BANDELLI 1999 = G. BANDELLI, Roma e la Venetia orientale dalla guerra gallica (225-222 a.C.) alla guerra sociale (91-87 a.C.), in Vigilia
di romanizzazione 1999, pp. 285-301.BANDELLI 2007 = G. BANDELLI, Considerazioni storiche sull’urbanizzazione cisalpina di eta repubblicana (283-89 a.C.), in Forme e tempi
2007, pp. 15-28.BOSIO 1970 = L. BOSIO, Itinerari e strade della Venetia romana, Padova, CEDAM 1970.BOSIO 1987 = L. BOSIO, Il territorio: la viabilita e il paesaggio agrario, in E. BUCHI (a cura di), Il Veneto nell’eta romana, Verona, Banca
Popolare di Verona 1987, pp. 59-102.BOSIO 19972
= L. BOSIO, Le strade romane della Venetia e dell’Histria, Padova, Esedra 1997 (Editoriale Programma 19911).BUCHI 1993 = E. BUCHI, Venetorum angulus. Este da comunita paleoveneta a colonia romana, Verona, Universita degli Studi di Ve-
rona 1993.BUONOPANE 1992 = A. BUONOPANE, La duplice iscrizione confinaria del Monte Venda (Padova), in L. GASPERINI (a cura di), Rupes
loquentes. Atti del Convegno Internazionale di studio sulle iscrizioni rupestri in eta romana (Roma 13-15 ottobre 1989), Roma,
Istituto Italiano per la Storia antica 1992, pp. 207-223.BURDESE 2006 = A. BURDESE, recensione a VINCI 2004, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 72, 2006, pp. 509-522.BURTON 2000 = G. P. BURTON, The Resolution of Territorial Disputes in the Provinces of the Roman Empire, «Chiron», 30, 2000,
pp. 196-212.CAMPBELL 2000 = B. CAMPBELL, The writings of the Roman land surveyors. Introduction, text, translation and commentary, London, So-
ciety for the Promotion of Roman Studies 2000.CAMPBELL 2005 = B. CAMPBELL, ‘‘Setting up true boundaries’’: land disputes in the Roman Empire, «Mediterraneo Antico», 8, 2005,
pp. 307-343.CAPOGROSSI COLOGNESI 1991 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, I rapporti fondiari fra ordinamenti locali e integrazione giuridica, in PANI
1991, pp. 233-248.CAPOGROSSI COLOGNESI 1999 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Spazio privato e spazio pubblico, in La forma della citta e del territorio.
Atti dell’incontro di studio (Santa Maria Capua Vetere 27-28 novembre 1998) = A.T.T.A. Suppl. V, Roma, «L’Erma» di
Bretschneider 1999, pp. 17-41.CAPOGROSSI COLOGNESI 2000 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della ‘‘civitas Ro-
mana’’, Roma, La Sapienza 2000.CAPOGROSSI COLOGNESI 2001 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Le forme gromatiche del territorio e i vari regimi giuridici dell’ager Ro-
manus e dell’ager colonicus. Il complesso mosaico della romanizzazione italica, in ID. – E. GABBA (a cura di), Gli statuti municipali,
Pavia, IUSS Press 2001, pp. 579-604.CAPUIS 1993 = L. CAPUIS, I Veneti. Societa e cultura di un popolo dell’Italia preromana, Milano, Longanesi 1993.CAPUIS 1998 = L. CAPUIS, I Veneti: territorio, societa, cultura, in Tesori della Postumia 1998, pp. 100-104.CAPUIS 2005 = L. CAPUIS, Per una geografia del sacro nel Veneto preromano, in A. COMELLA – S. MELE (a cura di), Depositi votivi e culti
dell’Italia antica dall’eta arcaica a quella repubblicana. Atti del Convegno (Perugia 1-4 giugno 2000), Bari, Edipuglia 2005,
pp. 507-516.CASSOLA 1991 = F. CASSOLA, La colonizzazione romana della Transpadana, in W. ECK – H. GALSTERER (Hsg.), Die Stadt in Obe-
ritalien und in den nordwestlichen Provinzen des Romisches Reiches (Deutsch-Italienisches Kolloquium im italienischen Kulturinstitut
Koln, 1989), Mainz a. R., von Zabern 1991, pp. 17-44.CORRAIN – ZERBINATI 2003 = C. CORRAIN – E. ZERBINATI, Il sostrato antico: aspetti della viabilita romana e medievale nella fascia
territoriale dell’Adige tra basso Padovano e Polesine, in D. GALLO – F. ROSSETTO (a cura di), Per terre e per acque. Vie di comuni-
cazioni nel Veneto dal Medioevo alla prima eta moderna, Padova, Il Poligrafo 2003, pp. 29-77.CRACCO RUGGINI 1987 = L. CRACCO RUGGINI, Storia totale di una piccola citta: Vicenza romana, in Storia di Vicenza, 1987, pp. 205-
303.CRAWFORD 1989 = M. H. CRAWFORD, Ateste and Rome, «Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichita Classiche», 18, 1989,
pp. 191-200.CRAWFORD 1990 = M. H. CRAWFORD, Origini e sviluppi del sistema provinciale romano, in Storia di Roma, II. L’impero mediterraneo
(1. La repubblica imperiale), a cura di G. CLEMENTE – F. COARELLI – E. GABBA, Torino, Einaudi 1990, pp. 91-121.CRAWFORD 2003 = M. H. CRAWFORD, Language and geography in the Sententia Minuciorum, «Athenaeum», 91, 2003, pp. 204-
210.CRESCI MARRONE – TIRELLI 2007a = G. CRESCI MARRONE – M. TIRELLI, Altino romana: limites e liminarita, in Forme e tempi,
2007, pp. 61-66.CRESCI MARRONE – TIRELLI 2007b = G. CRESCI MARRONE – M. TIRELLI, Che cosa sappiamo (oggi) dell’antica Altino, «Annali
dell’Istituto Veneto», 165, 2007, pp. 543-560.DALLA ROSA 2007 = A. DALLA ROSA, Sulle fonti relative alle dispute confinarie nelle province romane, «ZPE», 160, 2007, pp. 235-246.DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001 = E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, Diventare romani: i pozzetti, l’acciottolato e la pietra di Andetius nel foro
di Iulia Concordia, «Quaderni di Archeologia del Veneto», 17, 2001, pp. 124-141.DUMEZIL 1966 = G. DUMEZIL, La religion romaine archaique, Paris, Payot 1966.FOGOLARI 1987 = G. FOGOLARI (et alii), La fine dell’eta del bronzo e la civilta paleoveneta, in Storia di Vicenza, 1987, pp. 95-119.
ELVIRA MIGLIARIO
* 108 *
FOGOLARI – PROSDOCIMI, 1988 = G. FOGOLARI – A. L. PROSDOCIMI, I Veneti antichi. Lingua e cultura, Padova, Programma1988.
Forme e tempi, 2007 = Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C. – I secolo d.C.). Atti delle Giornate di Studio (To-rino 4-6 maggio 2006), a cura di L. BRECCIAROLI TABORELLI, Firenze, All’insegna del Giglio 2007.
GABBA 1990 = E. GABBA, La conquista della Gallia Cisalpina, in Storia di Roma, II. L’impero mediterraneo (1. La repubblica imperiale), acura di G. CLEMENTE – F. COARELLI – E. GABBA, Torino, Einaudi 1990, pp. 69-77.
GABBA 1994 = E. GABBA, Italia romana, Como, New Press 1994.GABBA 1994 = 1983 = E. GABBA, Strutture sociali e politica romana in Italia nel II sec. a.C., in GABBA 1994, pp. 51-57 [= Les «bour-
geoisies» municipales italiennes aux IIe et Ier siecles av. J.-C. Actes du Colloque (Naples 7-10 dicembre 1981), Paris – Naples,C.N.R.S. Institut Francais de Naples 1983, pp. 41-45].
GABBA 1994 = 1985a = E. GABBA, Aspetti dell’assimilazione delle popolazioni italiche nel II sec. a.C., in GABBA 1994, pp. 34-43[= E. CAMPANILE (a cura di), Lingua e cultura degli Oschi, Pisa, Giardini 1985, pp. 35-46].
GABBA 1994 = 1985b = E. GABBA, Per un’interpretazione storica della centuriazione romana, in GABBA 1994, pp. 177-196 (= «Athe-naeum», 73, 1985, pp. 265-284).
GABBA 1994 = 1986 = E. GABBA, I Romani nell’Insubria: trasformazione adeguamento e sopravvivenza delle strutture socio-economiche gal-liche, in GABBA 1994, pp. 247-256 [= Lombardia tra protostoria e romanita. Atti II Convegno Archeologico Regionale (Como 13-15aprile 1984), Como, New Press 1986, pp. 31-41].
GABBA 1994 = 1987 = E. GABBA, Tendenze all’unificazione normativa nel diritto pubblico tardo-repubblicano, in GABBA 1994, pp. 45-50[= M. SARGENTI – G. LURASCHI (a cura di), La certezza del diritto nell’esperienza giuridica romana. Atti del Convegno (Pavia 26-27aprile 1985), Padova, CEDAM 1987, pp. 169-177].
GABBA 1994 =1991 = E. GABBA, I municipi e l’Italia augustea, in GABBA 1994, pp. 133-143 [= PANI 1991, pp. 69-82].GALSTERER 1991 = H. GALSTERER, Aspetti della romanizzazione nella Cisalpina, «Antichita Alto Adriatiche», 37, 1991, pp. 165-183.GAMBACURTA 1998 = G. GAMBACURTA, Un ritrovamento preromano lungo la Postumia, in Tesori della Postumia, 1998, p. 106.GAMBACURTA 2005 = G. GAMBACURTA, Il bothros di Asolo: una cerimonia pubblica in epoca di romanizzazione, in A. COMELLA –
S. MELE (a cura di), Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’eta arcaica a quella tardorepubblicana, Bari, Edipuglia 2005,pp. 491-505.
GARGOLA 1995 = D. J. GARGOLA, Lands, Laws and Gods. Magistrates & ceremony in the regulation of public lands in republican Rome,Chapel Hill, University of North Carolina 1995.
GIORCELLI BERSANI 2002 = S. GIORCELLI BERSANI, Il laboratorio dell’integrazione. Bilinguismo e confronto multiculturale nell’Italia dellaprima romanita, Torino, Theleme 2002.
GONZALES 2005 = A. GONZALES, Le dieu Terme se tient en gardien a l’entree du monde, in D. CONSO – A. GONZALES – J.-Y. GUIL-
LAUMIN (eds.), Les vocabulaires techniques des arpenteurs romains. Actes du Colloque International (Besancon 19-21 septembre 2002),Besancon, Presses Universitaires de Franche-Comte 2005, pp. 63-69.
LAFFI 2001 = 1999 = U. LAFFI, Osservazioni sul contenuto e sul testo del Fragmentum Atestinum, in ID., Studi di storia romana e didiritto, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2001, pp. 297-324 (= Ciudades privilegiadas en el Occidente romano, a cura diJ. GONZALES, Sevilla, Diputacion de Sevilla y Universitad de Sevilla 1999, pp. 159-176).
Liguri, 2004 = I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo, Catalogo della Mostra (Genova ott. 2004-genn. 2005), a curadi R. C. DE MARINIS – G. SPADEA, Milano, Skira 2004.
LURASCHI 1979 = G. LURASCHI, Foedus ius Latii civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana, Padova, CE-DAM 1979.
MAGANZANI (c. s.) = L. MAGANZANI, Loca sacra e terminatio agrorum nel mondo romano: profili giuridici, in Finem dare. Il confine trasacro, profano e immaginario. A margine della stele bilingue del Museo Leone di Vercelli. Atti del Convegno internazionale (Vercelli 22-24 maggio 2008), c. s.
MAGDELAIN 1962 = A. MAGDELAIN, Cinq jours epagomenes a Rome?, «REL», 40, 1962, pp. 224-227.MAINARDIS 2001 = F. MAINARDIS, Tracce di onomastica celtica nell’epigrafia preromana e romana delle regioni nord-orientali, in I Celti
nell’alto Adriatico (= «Antichita Alto Adriatiche», 48), Trieste, Editreg 2001, pp. 55-69.MALNATI 2002 = L. MALNATI, Monumenti e stele in pietra preromani in Veneto, in AKEO. I tempi della scrittura, Montebelluna, Museo
di Storia naturale e Archeologia 2002, pp. 127-138.MALNATI – TIRELLI – CROCE DA VILLA 1998 = L. MALNATI – M. TIRELLI – P. A. CROCE DA VILLA, Nuovi dati sulla via Postumia
in Veneto, in G. SENA CHIESA – E. A. ARSLAN (a cura di), Optima via. Atti del Convegno internazionale di Studi Postumia. Storiae archeologia di una grande strada romana alle radici dell’Europa (Cremona 13-15 giugno 1996), Cremona, Associazione Promo-zione Iniziative Culturali 1998, pp. 443-464.
MARINETTI 1988 = A. MARINETTI, Nuove testimonianze venetiche da Oderzo (Treviso): elementi per un recupero della confinazione pub-blica, «Quaderni di Archeologia del Veneto», 4, 1988, pp. 341-347.
MARINETTI 1998 = A. MARINETTI, La scrittura e la lingua, in Tesori della Postumia, 1998, p. 105.MARINETTI 1999 = A. MARINETTI, Venetico 1976-1996. Acquisizioni e prospettive, in Protostoria e storia del ‘‘Venetorum angulus’’. Atti
XX Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Portogruaro – Quarto d’Altino – Este – Adria 16-19 ottobre 1996), Pisa, Istituto Na-zionale di Studi Etruschi ed Italici 1999, pp. 391-436.
MARINETTI 2009 = A. MARINETTI, Terminologia istituzionale e formula onomastica in Veneto, in Onomastica, 2009, pp. 357-374.MENNELLA 2004 = G. MENNELLA, La ‘sententia Minuciorum’ e il suo significato politico, in Liguri, 2004, pp. 477-479.Onomastica 2009 = L’onomastica dell’Italia antica. Aspetti linguistici, storici, culturali, tipologici e classificatori. Atti del Convegno (Roma 13-
16 novembre 2002), a cura di P. POCCETTI, CEFR 413, Roma, Ecole Francaise de Rome 2009.Orizzonti del sacro, 2001 = Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi in Altino e nel Veneto orientale. Atti del Convegno (Venezia 1-2
dicembre 1999), a cura di G. CRESCI MARRONE – M. TIRELLI, Roma, Quasar 2001.PANI 1991 = M. PANI (a cura di), Continuita e trasformazioni fra repubblica e principato. Istituzioni, politica, societa, Bari, Edipuglia 1991.PASQUINUCCI 2004 = M. PASQUINUCCI, La ‘sententia Minuciorum’ e la Valpolcevera: territorio, popolamento, ‘terminatio’, in Liguri,
2004, pp. 476-477.
* 109 *
PIANIFICARE, DIVIDERE, DELIMITARE GLI SPAZI NEL MONDO VENETO
PASTORINO 1995 = A. M. PASTORINO (a cura di), La tavola di Polcevera: una sentenza incisa nel bronzo 2100 anni fa, Giornata di studie mostra (Genova 22 gennaio 1995), Genova, Comune di Genova – Museo di archeologia ligure 1995.
PELLEGRINI – PROSDOCIMI 1967 = G. B. PELLEGRINI – A. L. PROSDOCIMI, La lingua venetica, I-II, Padova, Istituto di Glottologiadell’Universita di Padova 1967.
PICCALUGA 1974 = G. PICCALUGA, Terminus. I segni di confine nella religione romana, Roma, Edizioni dell’Ateneo 1974.PROSDOCIMI 1979 = A. L. PROSDOCIMI, L’altra faccia di Pa 14, il senso dell’iscrizione e un nuovo verbo, in Studi in memoria di Carlo
Battisti, Firenze, Istituto di Studi per l’Alto Adige 1979, pp. 279-307.PROSDOCIMI 1988 = A. L. PROSDOCIMI, La lingua, in FOGOLARI – PROSDOCIMI 1988, pp. 211-420, 433-440.PROSDOCIMI 2001 = A. L. PROSDOCIMI, I riti dei Veneti. Appunti sulle fonti, in Orizzonti del sacro, 2001, pp. 5-35.PROSDOCIMI 2009 = A. L. PROSDOCIMI, Note sull’onomastica di Roma e dell’Italia antica, in Onomastica, 2009, pp. 73-151.ROSADA 2006 = G. ROSADA, Le terre dalla frontiera ambigua. Alcune note rileggendo Massimiliano Pavan, «Quaderni di Archeologia del
Veneto», 22, 2006, pp. 257-264.RS 1996 = Roman Statutes, M. H. CRAWFORD ed., I-II, BICS 64, London, Institute of Classical Studies/University of London
1996.RUTA SERAFINI 2001 = A. RUTA SERAFINI, Il celtismo in area veneta: nuovi dati, in S. VITRI – F. ORIOLO (a cura di), I Celti in
Carnia e nell’arco alpino centroorientale. Atti della Giornata di Studio (Tolmezzo 30 aprile 1999), Trieste, Comunita Montana dellaCarnia 2001, pp. 197-210.
SCUDERI 1991 = R. SCUDERI, Decreti del senato per controversie di confine in eta repubblicana, «Athenaeum», 79, 1991, pp. 371-415.SERENI 1955 = E. SERENI, Comunita rurali nell’Italia antica, Roma, Rinascita 1955.SHERK 1974 = R. K. SHERK, Roman Geographical Exploration and Military Maps, in ANRW II. 1, Berlin – New York, De Gruyter
1974, pp. 534-562.Storia di Vicenza, 1987 = Storia di Vicenza. Il territorio, la preistoria, l’eta romana, a cura di A. BROGLIO – L. CRACCO RUGGINI,
Vicenza, Neri Pozza 1987.Tesori della Postumia, 1998 = Tesori della Postumia. I: Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell’Europa; II:
Percorsi tra archeologia e storia, Milano, Electa 1998.TIRELLI 1999 = M. TIRELLI, La romanizzazione ad Altino e nel Veneto orientale: pianificazione territoriale e interventi urbanistici, in Vigilia
di romanizzazione, 1999, pp. 5-31.TOMBOLANI 1985 = M. TOMBOLANI, Altino preromana, in Altino preromana e romana, a cura di B. M. SCARFI – M. TOMBOLANI,
Quarto d’Altino, Biblioteca comunale 1985, pp. 51-68.TOZZI 1987 = P. TOZZI, Lettura topografica del territorio, in Storia di Vicenza, 1987, pp. 131-144.TOZZI 1999 = P. TOZZI, La via Postumia, Varzi (PV), Guardamagna 1999.TOZZI 2009 = P. TOZZI, I Paesaggi della Memoria, Pavia, Cardano 2009.Vigilia di romanizzazione, 1999 = Vigilia di romanizzazione. Altino e il Veneto orientale tra II e I sec. a.C. Atti del Convegno (Venezia 2-3
dicembre 1997), Roma, Quasar 1999.VINCI 2004 = M. VINCI, Fines regere. Il regolamento dei confini dall’eta arcaica a Giustiniano, Milano, Giuffre 2004.WISEMAN 1989 = T. P. WISEMAN, La via Annia: dogma e ipotesi, «Athenaeum», 67, 1989, pp. 417-426.ZACCARIA 1999 = C. ZACCARIA, Documenti epigrafici di eta repubblicana nell’area d’influenza aquileiese, in Vigilia di romanizzazione,
1999, pp. 193-210.ZAVARONI 2009 = A. ZAVARONI, Il luogo dell’assemblea: un cippo venetico ed un cippo etrusco a confronto, «Latomus», 68, 2009, pp. 5-
15.
ELVIRA MIGLIARIO
* 110 *
Fig. 1 – Il territorio di Ateste: n. 25 = Galzignano; n. 69 = Teolo; n. 43 = Monte Venda; n. 31 = Lobia di Lonigo (da BASSIGNANO 1997).
Fig. 2 – Il cippo di Galzignano (da BAGGIO BERNARDONI – ZERBINATI 1989).