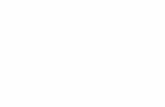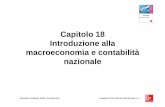«Non perdere il proprio mondo». Argomenti dei giudici e matrimonio «same-sex», tra Corte di...
Transcript of «Non perdere il proprio mondo». Argomenti dei giudici e matrimonio «same-sex», tra Corte di...
«Non perdere il proprio mondo».Argomenti dei giudici e matrimonio «same-sex», tra Corte di Strasburgo e Corte costituzionale
Giorgio Repetto*
SOMMARIO: 1. Corte europea dei diritti dell’uomo e family rights: dalla gerarchia deimodelli alle prime aperture. – 2. La sentenza Schalk e Kopf c. Austria: il caso e ladecisione. – 3. Nel prisma della comparazione. Interpretazione evolutiva … – 4. …e margine d’apprezzamento: le differenze con l’approccio scelto dalla Corte costitu-zionale. – 5. Le risorse di un incompletely theorized agreement.
1. Non sono state poche, negli ultimi anni, le occasioni in cui laCorte europea dei diritti dell’uomo ha dato prova di un certo judicialactivism in tema di diritto di famiglia. Come è noto, fino a pochi annifa, la Corte è stata ferma nel ribadire che, nel quadro dei diritti dellaConvenzione europea che più direttamente riguardano i rapporti fami-liari (in primo luogo gli artt. 8 e 12), alla “famiglia tradizionale” do-veva riconoscersi una posizione privilegiata: solo in parte scalfita, inrelazione all’art. 8, dal peso tradizionalmente attribuito a legami ulte-riori rispetto a quelli tra coniugi e tra questi e i figli legittimi (filia-zione naturale, adozione, rapporti di ascendenza o discendenza), men-tre ben più rigida e difensiva è stata la lettura dell’art. 12, inteso qualefondamento necessario ed imprescindibile della famiglia tradizionale1.
La cristallizzazione di un simile modello, pur con tutte le sue va-rianti e le sue linee evolutive, ha fatto leva principalmente sulla tuteladi aspetti legati alla dimensione privata della vita di coppia e dei le-gami familiari. Più che optare, in altre parole, per una strategia di ri-conoscimento incentrata su un ideale pubblicistico, communitarian, difamiglia, la Corte ha ripetutamente assegnato un ruolo privilegiato aquegli aspetti suscettibili di alterare l’equilibrio all’interno della fa-miglia: basti pensare al peso attribuito al principio di non discrimi-nazione2 o alla sempre più evidente centralità del principio del bestinterest of the child (nei casi di adozione3 o di disconoscimento di pa-ternità4).
525
* Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurispru-denza dell’Università di Perugia.
1 Per un quadro riepilogativo v. ora G. Ferrando, Matrimonio e famiglia: la giu-risprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e i suoi riflessi sul diritto in-terno, in G. Iudica e G. Alpa (a cura di), Costituzione europea e interpretazione dellaCostituzione italiana, Napoli, 2006, 131.
2 Evidentemente a partire dal celebre caso Marckx c. Belgio, dec. del 13.6.1979,n. ric. 6833/74.
3 Dec. del 28.6.2007, Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, n. ric. 76240/01.4 Dec. del 24.11.2005, Shofman c. Russia, ric. n. 74826/01, in part. § 41., ma v.
anche decc. del 20.12.2007, Phinikaridou c. Cipro, ric. n. 23890/02 (§§58-59) e del6.7.2010, Backlund c. Svezia, ric. n. 36498/05.
Si è trattato, per certi aspetti, di un orientamento interpretativonon privo di ragioni, ma che sicuramente ha portato con sé un atteg-giamento estremamente difensivo nei confronti di tutte quelle situa-zioni che faticavano ad essere incluse all’interno della nozione di vitafamiliare di cui all’art. 8 CEDU, tra cui in primo luogo quelle relativea soggetti portatori di identità sessuali minoritarie come gli omoses-suali. Se per i transessuali, infatti, si è determinata a partire dal casoGoodwin5 una significativa apertura sul fronte del godimento dei di-ritti attinenti alla famiglia, primo fra tutti quello di contrarre matrimo-nio, per gli omosessuali, pur non mancando alcuni passi avanti sul ter-reno della non discriminazione6, il fronte dei diritti familiari è rimastoper lungo tempo inaccessibile, come dimostrano i casi Mata Estevez c.Spagna in tema di diritti previdenziali7 e Fretté c. Francia in relazioneal diritto di adozione del single omosessuale8.
Negli ultimi anni, come detto, si è tuttavia assistito ad una certaevoluzione della giurisprudenza di Strasburgo. È innanzi tutto signifi-cativo che, a distanza di pochi anni dal caso Fretté, la Corte sia tornatasul problema del diritto per il single omosessuale di adottare in E.B. c.Francia9, superando nettamente il proprio precedente orientamento edichiarando la contrarietà all’art. 8 cit. di una legislazione che, pur ri-conoscendo ai singles la possibilità di adottare, veniva applicata dalleautorità amministrative nel senso di escludere una simile eventualitàallorché il richiedente fosse omosessuale. Ad una simile apertura,certo rilevante ma priva di ricadute di principio – perché la sentenzaaggancia pur sempre la violazione allo specifico contesto di prove-nienza, dimostrando così le virtù mimetiche della non discrimina-zione10 –, si è infine aggiunta un’indicazione più generale sull’articola-zione delle strutture familiari: in un recente caso sulla fecondazioneeterologa, infatti, la Corte ha dimostrato una inusuale attitudine a ri-
526
5 Sent. dell’11.7.2002, n. ric. 28957/95.6 Come ad esempio nei casi Karner c. Austria, dec. del 24.7.2003, n. ric.
40016/98 e Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo, dec. del 21.12.1999, n. ric.33290/96.
7 Dec. del 10.5.2001, n. ric. 56501/01.8 Dec. del 26.2.2002, n. ric. 36515/97.9 Dec. del 22.1.2008, n. ric. 43546/02.10 Per “virtù mimetiche” intendo la capacità della non discriminazione di ope-
rare, sotto le vesti di un medesimo principio, sia come strumento dalle alte valenzeinclusive, con il quale l’interprete ha a disposizione un’infrastruttura argomenta-tiva per pronunciarsi sulle qualità di un certo fatto («il divieto di matrimonio omo-sessuale è discriminatorio perché lesivo della dignità delle coppie omosessuali»),sia come strumento che mette in moto un giudizio comparativo, tramite il qualel’interprete, accostando due o più soluzioni analoghe, si concentra sulla misura-zione quantitativa delle somiglianze e delle differenze («il matrimonio omosessualeè discriminatorio perché riserva alle coppie omosessuali un trattamento deteriorerispetto alle coppie eterosessuali»): su questi itinerari, oltre a quanto si dirà infrain nt. 23, v. S. Niccolai, Principio di pari dignità sociale e giudizio di costituzionalità.Appunti per una ricerca, in corso di stampa in Studi in onore di Alessandro Pace.
marcare la differenza rispetto al passato, consolidando l’abbandono diuna visuale gerarchica dei modelli familiari e, soprattutto, della vinco-latività del paradigma biologico nei rapporti di filiazione11.
È in uno scenario del genere, pertanto, che si può leggere la re-cente sentenza Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010 (n. ric.30141/04), con cui la Corte si è espressamente pronunciata per laprima volta sul matrimonio omosessuale, vagliando in particolare lalegittimità ai sensi degli artt. 8, 12 e 14 CEDU della legislazione au-striaca che non prevede una simile possibilità. La Corte, vale la penaanticiparlo subito, non riscontra una violazione della Convenzione, maciò nonostante la pronuncia merita grande attenzione perché mostra,sulla scia dei precedenti appena citati, una importante apertura neiconfronti delle istanze delle coppie omosessuali12. Un’apertura che in-vece non pare possibile riscontrare, malgrado un esito apparente-mente simile, nella recente e più nota sentenza della Corte costituzio-nale n. 138 del 2010, la cui analisi, alla luce degli argomenti addottidai giudici europei, restituisce un quadro di argomentazioni più evi-dentemente legato ad un’immagine rigida e tradizionalista dei dirittidei conviventi dello stesso sesso.
2. I ricorrenti, maschi adulti di cittadinanza austriaca, si sono vistiopporre alla loro richiesta di matrimonio un rifiuto da parte delle auto-rità nazionali, fondato sul chiaro tenore dell’art. 44 del codice civile au-striaco del 1812, che riserva il matrimonio a persone di sesso opposto.La Corte costituzionale austriaca, chiamata nel 2003 a giudicare dellalegittimità di questo articolo, ha statuito che né ai sensi delle norme co-stituzionali in tema di uguaglianza, né ai sensi degli artt. 8 e 12 dellaCEDU (che in Austria, è bene precisarlo, ha rango costituzionale), essopoteva ritenersi incostituzionale, data la radicata e, allo stato, incontro-vertibile strutturazione eterosessuale del vincolo matrimoniale, noncontraddetta in alcun modo dai parametri costituzionali invocati.
I ricorrenti, a questo punto, si rivolgono alla Corte di Strasburgo,lamentando la violazione degli artt. 8, 12 e 14 della CEDU e insistendo
527
11 Dec. del 1°.4.2010, S.H. e altri c. Austria, n. ric. 57813/00, ove al § 81 silegge: «… unusual family relations in a broad sense are well known to the legalorders of the Contracting States. Family relations which do not follow the typicalparent-child relationship based on a direct biological link, are nothing new and havealready existed in the past, since the institution of adoption, which creates a familyrelationship between persons which is not based on descent but on contract, for thepurpose of supplementing or replacing biological family relations. From this matter ofcommon knowledge the Court would conclude that there are no insurmountableobstacles to bringing family relations which would result from a successful use of theartificial procreation techniques at issue into the general framework of family law andother related fields of law».
12 Peraltro, al momento di licenziare le bozze, è pendente dinnanzi allaGrande Camera della Corte una richiesta di rinvio presentata ai sensi dell’art. 43CEDU.
per l’accoglimento del loro ricorso anche dopo che in Austria, nel gen-naio 2010, è entrata in vigore la legge sulle unioni registrate (Eingetra-gene Partnerschafts-Gesetz12), che attribuisce alle coppie omosessuali (esolo ad esse, non essendo queste unioni accessibili agli eterosessuali)uno status in larga parte affine al matrimonio.
Rimanendo per ora al profilo legato alla violazione dell’art. 12, laCorte ricorda come, a partire dal caso Goodwin, essa ha precisato chela diversità biologica dei partners non costituisce più una condizioneimprescindibile per potersi sposare, dato che al matrimonio possonoaccedere anche persone di genere opposto (opposite gender), sia essoquello riscontrato alla nascita o quello acquisito a seguito di opera-zione di mutamento di sesso. Il punto, però, è che un simile orienta-mento non appare, agli occhi della Corte (§§ 52 ss.), pacificamente ap-plicabile al caso degli omosessuali. Mentre per i transessuali, infatti,l’abbandono del paradigma biologico non importa necessariamente unabbandono della struttura eterosessuale del vincolo matrimoniale, fon-data semmai sull’opposite gender e non più sull’opposite sex, la coinci-denza piena tra il sex e il gender degli aspiranti coniugi dello stessosesso rende impercorribile la strada già battuta per i transessuali: vistala loro indisponibilità a ricoprire, se non più i ruoli biologici, almenoquelli sociali dei partners di una coppia sposata, gli omosessuali met-tono in discussione più in profondità dei transessuali – questo presup-pone il ragionamento della Corte – l’intima natura del legame matri-moniale.
D’altra parte, la riprova dell’impossibilità di estendere la dottrinaGoodwin al caso di specie si ha in due pronunce della Corte di Stra-sburgo, poco note, del 2005, in cui sono stati dichiarati inammissibilii ricorsi con cui due coppie di coniugi inglesi facevano valere l’illegit-timità della legge nazionale che li obbligava a divorziare nel caso incui uno dei due coniugi, di sesso ovviamente opposto a quello dell’al-tro, si fosse sottoposto ad un’operazione di mutamento di sesso, chel’avrebbe reso dello stesso gender dell’altro coniuge (anche se, eviden-temente, non ne avrebbe alterato il sesso biologico). In questo caso, laCorte affermò che l’impossibilità di proseguire il matrimonio apparivanon irragionevole perché, tra l’altro, all’art. 12 CEDU non poteva attri-buirsi un significato diverso da quello di consentire l’unione solamentetra un uomo e una donna, e quindi una situazione come quella dei ri-correnti, assimilata dai giudici europei (non senza problemi) adun’unione same-sex, è stata ritenuta estranea all’ambito di applica-zione dell’art. 12, finendo così per rientrare nel margine d’apprezza-mento statale, inteso peraltro in termini particolarmente ampi13.
528
12 In BGBl., I, Nr. 135/2009.13 Il riferimento è alle decc. del 28.11.2006, Parry c. Regno Unito, n. ric.
42971/05, e R. e F. c. Regno Unito, n. ric. 35748/05.
La Corte ha scelto quindi di non fare leva solamente sulla giuri-sprudenza aperta da Goodwin, andando piuttosto al cuore del pro-blema, e cioè l’ambito di applicazione dell’art. 12 (§§ 54 e ss.). Ad unprimo livello, la Corte prende atto dell’inequivocabile tenore letteraledell’art. 12, pur senza concludere che esso sia di per sé inapplicabilealle coppie omosessuali: rinviando all’art. 9 della Carta di Nizza, checome noto non insiste sulla differenza di sesso tra i coniugi, i giudicidi Strasburgo affermano significativamente che «the Court would nolonger consider that the right to marry enshrined in Article 12 must in allcircumstances be limited to marriage between two persons of the oppo-site sex. Consequently, it cannot be said that Article 12 is inapplicable tothe applicants’ complaint» (§ 61). La portata di una simile interpreta-zione, rafforzata dai mutamenti cui sono andati incontro, negli ultimisessant’anni, il concetto e il ruolo sociale del legame matrimoniale,non è tuttavia sufficiente per arrivare ad una dichiarazione di incom-patibilità della normativa nazionale, perché, ad avviso della Corte, lelegislazioni dei paesi membri della Convenzione sono ancora troppodiverse tra loro per consentire ad essa l’elaborazione di uno standarddi tutela comune14. In presenza di connotazioni sociali e culturali pro-fonde del matrimonio, che possono variare anche sensibilmente dauna società ad un’altra, la Corte ribadisce di non poter imporre il pro-prio orientamento sulle diverse valutazioni effettuate dagli stati mem-bri, con la conseguenza che la normativa austriaca viene ritenuta unalegittima manifestazione del margine d’apprezzamento che in questamateria spetta agli stati membri.
Un discorso solo in parte diverso vale per l’art. 8 CEDU, invocatodai ricorrenti congiuntamente all’art. 14 per rimarcare la portata di-scriminatoria del divieto loro imposto in rapporto alle coppie eteroses-suali. Anche qui la constatazione della crescente considerazione, a li-vello nazionale, per le rivendicazioni omosessuali spinge la Corte a su-perare la propria precedente giurisprudenza, che relegava i rapportitra conviventi dello stesso sesso nel solo ambito della vita privata dicui all’art. 8 cit., ma non in quello della vita familiare15, anche se que-sto non spinge i giudici a ravvisare una violazione degli articoli in que-stione, perché la riscontrata evoluzione non è ancora ritenuta espres-sione di un common ground tra i diversi ordinamenti nazionali.
529
14 La sentenza ricorda, a seguito di un’indagine comparativa (§§ 24 ss.), chesolo sei stati membri della CEDU (Belgio, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna eSvezia) su quarantasette riconoscono, in questo momento, la legittimità del matri-monio omosessuale.
15 Dec. cit., § 94: «In view of this evolution the Court considers it artificial tomaintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-sex couplecannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8. Consequently the relationshipof the applicants, a cohabiting same-sex couple living in a stable de facto partnership,falls within the notion of “family life”, just as the relationship of a different-sexcouple in the same situation would».
3. I punti salienti della pronuncia, quelli che alimentano le speranzema al tempo stesso sembrano suscitare anche le maggiori perplessità,sono evidentemente legati all’inquadramento delle pretese delle coppieomosessuali all’interno dell’ambito d’applicazione dei diritti in que-stione, ma senza che questo sia stato sufficiente a determinare una di-chiarazione di incompatibilità della normativa nazionale con la Con-venzione. In questo e nel prossimo paragrafo, quindi, cercherò di ap-profondire separatamente questi due aspetti della sentenza indiscussione, legati rispettivamente alla peculiare interpretazione evo-lutiva delle norme della Convenzione e al margine d’apprezzamento,sostenendo che essi, contrariamente all’esito cui è giunta la sentenza,restituiscono un’argomentazione tutt’altro che ostile ai diritti dellecoppie omosessuali, che ha anzi il merito di avviare un percorso di ri-conoscimento tutto sommato coerente e compatibile con il grado dipluralismo esistente tra i paesi membri della Convenzione. Nel farquesto, cercherò anche di mettere in luce come la Corte costituzionale,pur essendosi cimentata nella sent. n. 138 cit. con un quadro di pro-blemi per certi versi affine, soprattutto in relazione agli spazi e ai li-miti dell’interpretazione evolutiva e al rapporto con la discrezionalitàdel legislatore, abbia scelto un itinerario argomentativo molto diverso,perché tutto incentrato sulla strutturale incapacità del discorso giuri-sdizionale di prospettare una lettura trasformativa dei diritti familiaridegli omosessuali.
Innanzi tutto, si è visto come l’estensione della portata degli artt.8 e 12 CEDU alle coppie omosessuali rappresentasse un esito difficil-mente prevedibile16: sia perché, per quanto riguarda il primo articolo,non mancavano i precedenti in senso contrario (da Karner a MataEstevez), ma anche e soprattutto, in relazione all’art. 12, in presenza diun impedimento letterale difficile da superare – il riferimento esplicitoall’uomo e alla donna come parti del matrimonio –, che deve essereperaltro ritenuto ben più stringente di quanto sia nel diritto interno sesi considera che la CEDU è un trattato internazionale e, come tale, adessa si applicano canoni interpretativi particolarmente rispettosi delsignificato letterale e, in subordine, della volontà degli autori del trat-tato17.
Ora, l’aspetto interessante di questa sentenza, anche perchéespressivo del più generale atteggiamento della Corte europea nei con-fronti di controversie attinenti all’identità sessuale, è la scelta del per-
530
16 V. ad esempio M. Lamarche, Les homosexuels devant la Cour européenne desdroits de l’homme, in O. Dubos e J.-P. Marguenaud, Sexe, sexualité et droits europé-enns: enjeux politiques et scientifiques des libertés individuelles, Paris, 2008, 47.
17 Secondo quanto previsto dall’art. 32 della Convenzione di Vienna sul dirittodei trattati, su cui infatti si sofferma criticamente l’opinione separata dei giudiciMalinverni e Kovler. Sulla specificità del canone interpretativo della volontà degliautori del trattato per la CEDU v. G. Letsas, A Theory of Interpretation of the ECHR,Oxford, 2007, 58.
corso interpretativo necessario per ribaltare, almeno in parte, l’orien-tamento consolidato. La mia impressione è che l’argomento letterale equello legato al rispetto dei propri precedenti rivestano, in questa sen-tenza ma più in generale nella giurisprudenza europea, una connota-zione peculiare e molto meno “strutturata” rispetto a quanto avvieneper i giudici (costituzionali e/o di legittimità) nazionali, e soprattuttorimangano subordinati all’argomento fondato sulla comparazione giu-ridica18. Ciò contribuisce ad orientare l’interpretazione delle relativegaranzie verso un’evoluzione dei loro significati, ricercata sulla base diquanto avviene a livello nazionale e internazionale, più che non al solorispetto della lettera della Convenzione stessa o dei precedenti dellaCorte.
Difficile immaginare, in base a quanto si è detto, la parziale aper-tura alle coppie omosessuali sul fronte della libertà di matrimoniosenza il decisivo apporto prestato dall’art. 9 della Carta di Nizza. Ri-spetto ad un testo chiaro, come deve ritenersi quello dell’art. 12 CEDU,la Corte infatti sceglie di non fermarsi alla lettera, ma neanche mostradi volersi avventurare su un terreno rigidamente interpretivista o co-struttivista, come avrebbe potuto fare superando il vincolo letterale, adesempio, limitandosi a constatare il mutamento dei significati socialidel matrimonio e dei legami familiari (compito tutt’altro che semplicee, per una Corte sovranazionale, foriero di conseguenze non necessa-riamente auspicabili). Al contrario, il ricorso alla Carta di Nizza costi-tuisce uno strumento di eterointegrazione dei significati della normaconvenzionale che, senza predeterminare l’esito sostanziale della que-stione (se cioè vi sia o meno una violazione della norma CEDU)19, con-sente alla Corte intanto di estendere la portata della garanzia, deter-minando così una Rechtsfortbildung che, anche se priva di contenuticoncreti nell’immediato, resta strategicamente rilevante perché “sinto-nizza” i contenuti della Convenzione sugli sviluppi che si registranonell’area europea. Avendo attratto le pretese dei ricorrenti nell’ambitodi applicazione degli articoli della Convenzione, infatti, la Corte riba-disce la propria competenza a tornare in futuro sull’argomento e a ve-rificare se, col tempo, non si sia creata una convergenza di soluzioniche le permetta di elaborare uno standard comune20: a partire da que-
531
18 Per spunti in questa direzione v. R. Bernhardt, Rechtsfortbildung durch denEuropäischen Gerichtshof für Menschenrechte, in Breitenmoser, Ehrenzeller, Sas-sòli, Stoffel, Wagner Pfeifer (eds.), Human Rights, Democracy and the Rule of Law,Liber amicorum Luzius Wildhaber, Zürich-St. Gallen, 2007, 91.
19 Perché, come noto, l’art. 9 cit. prevede che «Il diritto di sposarsi e il dirittodi costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne discipli-nano l’esercizio» e le Spiegazioni alla Carta precisano che «L’articolo non vieta néimpone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stessosesso».
20 Un approccio del genere rivela significative analogie con la formazionetopica, ispirata allo Juristenrecht, dei principi di giudizio: per tutti v. J. Esser,
sta pronuncia, in altre parole, non è più possibile ritenere che gli statimembri siano del tutto liberi in questa materia, perché il loro margined’apprezzamento è ora vincolato all’evoluzione futura delle disciplinenazionali.
Sul terreno dell’art. 8 CEDU, invece, il percorso evolutivo è direttoa superare un numero non irrilevante di precedenti nei quali la stessaCorte, come visto, aveva espressamente escluso le coppie same-sex dalnovero delle relazioni rientranti nella “vita familiare”, inquadrando laloro situazione piuttosto all’interno della più generica nozione di “vitaprivata”21. Anche su questo frangente, la difficoltà di ricostruire unanozione unitaria di vita familiare, destinata ad imporsi in contesti na-zionali anche molto differenziati, è sdrammatizzata grazie all’impiegodell’argomento comparativo: in assenza di indicazioni univoche all’in-terno del sistema CEDU (testo della Convenzione e/o precedenti), l’ar-bitrarietà della distinzione è dimostrata non solamente dalla rapidaevoluzione delle social attitudes verso le coppie omosessuali che si è re-gistrata in diversi stati membri negli anni duemila, ma anche da al-cune recenti direttive comunitarie, che annoverano i soggetti contra-enti di un’unione registrata tra i soggetti titolari di diritti riconosciutiai membri della famiglia22.
532
Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 3. Aufl., Tü-bingen, 1970, 342.
21 Per un caso ulteriore rispetto a quelli dianzi citati, v. Commissione EDU,dec. del 9.10.1989, C. e L. M. c. Regno Unito, n. ric. 14753/89.
22 Come nel caso dell’art. 4 del direttiva 2003/86/CE in tema di ricongiungi-mento familiare o dell’art. 2 della direttiva 2004/738/CE in materia di libertà di cir-colazione e soggiorno, richiamate espressamente ai §§ 26 e 93 della dec. in com-mento. Un simile atteggiamento, che da un lato estende la portata del diritto ga-rantito ma dall’altro ne condiziona le sorti alla convergenza progressiva dellenormative nazionali, indica non solo il tentativo di superare in modo non arbitra-rio i vincoli letterali della Convenzione, ma è anche espressivo della convergenzache, quanto ai diritti familiari della coppie omosessuali, viene maturando da qual-che anno tra ambito CEDU e diritto comunitario. In entrambi i sistemi, infatti, siassiste ad un comune disegno di inquadramento delle diversità nazionali per il tra-mite di soluzioni giurisprudenziali che, rinunciando a veicolare un’idea guida“forte” destinata ad imporsi sui diversi sistemi nazionali, valorizzano gli istituti giàpresenti a livello nazionale, orientandone l’interpretazione e l’applicazione in unadirezione non discriminatoria per le persone omosessuali. Si pensi solamente, perfare due esempi, al già citato caso E. B. c. Francia e al caso Maruko della Corte digiustizia europea (sent. del 1°.4.2008, C-267/06). Nel primo caso facendo leva suuna lettura non discriminatoria della norma del Code civil che consente ai single diadottare indipendentemente dal loro orientamento sessuale, nel secondo casocolpendo la normativa tedesca che ometteva di parificare a tutti gli effetti i dirittipensionistici delle parti omosessuali di un’unione registrata ai coniugi, le due Cortieuropee hanno dimostrato di voler costruire i diritti familiari delle persone omo-sessuali senza imporre una visione unica agli stati nazionali, ma piuttosto interve-nendo su quei contesti nazionali nei quali il mancato godimento del diritto rappre-senta, più che altro, un’incompleta attuazione di premesse di politica del diritto giàpresenti nell’ordinamento. Su questo orientamento, sia consentito un rinvio a G.Repetto, Discrimination Against Homosexuals and ‘Integration by Reasonableness’:
Pare tutt’altro che inutile sottolineare, a questo punto, come un si-mile approccio, mutatis mutandis, sia molto diverso da quello seguitodalla Corte costituzionale italiana nella citata sent. n. 138 del 2010. Inquella sentenza, prendendo in esame la doglianza relativa agli artt. 3 e29 Cost., la Corte ha ribadito che quest’ultimo articolo non può essereinterpretato in modo tale da applicarsi anche alle unioni tra personedello stesso sesso, non solo perché il tenore letterale di esso lo esclude,ma anche e soprattutto perché i costituenti intesero riferirsi con quellanorma alla nozione di matrimonio accolta dal codice civile e non an-che (difficile stupirsene …) al matrimonio omosessuale. Lo spazio cheil giudice delle leggi assegna ad una lettura evolutiva delle garanzie co-stituzionali, seppure non è ristretto ad una cristallizzazione dei con-cetti di famiglia e matrimonio, è tuttavia perimetrato in modo moltochiaro dalla circostanza che qualsiasi interpretazione dell’art. 29 cit.«non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma,modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problema-tiche non considerati in alcun modo quando fu emanata» (punto 9.Cons. in dir.). Ed un’interpretazione dell’art. 29 che non facesse della(potenziale) finalità procreativa il dato imprescindibile del legame ma-trimoniale sarebbe inevitabilmente frutto di un’operazione creativa,«perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o diabbandonare una mera prassi interpretativa» (ibid.).
Partendo da premesse originaliste23, quindi, l’argomentazionedella Corte costituzionale non poteva far altro che arrivare ad esclu-dere le coppie omosessuali dall’ambito di applicazione degli artt. 3 e29 Cost.24: ed anche senza voler arrivare ad un allargamento forzosodell’ambito di applicabilità della norma costituzionale in questione, lamodulazione di un intervento “di principio” da parte della Corte costi-tuzionale sarebbe in astratto ben stata compatibile con una letturaevolutiva dell’art. 29 Cost. che, senza pretendere di delinearne in posi-tivo i contenuti, avrebbe portato almeno a rimuovere gli ostacoli aduna legislazione di favore: ostacoli che la Corte di Strasburgo pare
533
Suggestions from the Maruko Case, in S. Niccolai e I. Ruggiu (eds.), Dignity inChange. Exploring the Constitutional Potential of EU Gender and Anti-Discrimina-tion Law, Firenze, 2010, 137 ss.
23 Su cui, in generale, v. F. Giuffrè e I. Nicotra (a cura di), Lavori preparatoried original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, 2008.
24 Cfr. sul punto I. Massa Pinto e C. Tripodina, Sul come per la Corte costitu-zionale le «unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimo-nio». Ovvero tecniche argomentative impiegate per motivare la sentenza 138/2010, inArchivio di diritto e storia costituzionali (www.dircost.unito.it), 12, le quali rilevanocome il ricorso all’original intent sveli, più in profondità, che «la corte considera ilparadigma eterosessuale del matrimonio come un dato sociale, un dato storico,una istituzione, diritto non scritto, un dato normativo oggettivo, propriamente epienamente positivo, con il quale l’interprete costituzionale e il legislatore … de-vono confrontarsi». La Corte costituzionale ha peraltro implicitamente ribaditol’impianto della sent. n. 138 con la recente ordinanza n. 276 del 2010.
aver rimosso (sebbene per ora solo in linea di principio) e che per lanostra Corte ancora coincidono con l’impossibilità di svincolare l’im-magine costituzionale della famiglia e del matrimonio dalla finalitàprocreativa. Allo stesso modo, non stupisce che dell’art. 12 CEDU e,soprattutto, dell’art. 9 della Carta di Nizza venga data nella sentenzaitaliana una lettura estremamente difensiva, attenta a enfatizzare glispazi di discrezionalità che questi articoli lasciano agli stati più chenon le aperture nei confronti di nuovi modelli di relazione, che almenol’art. 9 chiaramente delinea. Da questo punto di vista, pare piuttostoche la sentenza Schalk e Kopf prenda idealmente le mosse da dove l’ar-gomentazione del nostro giudice di costituzionalità aveva scelto di in-terrompersi: il testo dell’articolo di riferimento è chiaro, l’intenzione dichi quel testo lo scrisse ancora di più, ma ciò non toglie che esso vadainserito in un contesto interpretativo più ampio, fondato comparativa-mente, nel quale i suoi significati possono essere aggiornati nel ri-spetto di un consenso in via di definizione a livello europeo.
Lo stesso richiamo, da parte dell’art. 9 della Carta di Nizza, aglispazi di discrezionalità affidati agli stati membri è considerato dallaCorte di Strasburgo certamente un ostacolo alla definizione di unostandard comune, ma non per questo la sua portata è stata ritenutaneutrale rispetto alla qualità degli interessi in gioco, come se la con-cessione di questi spazi potesse costituire il pretesto per ritenere che lerivendicazioni delle coppie omosessuali debbano restare in tutto e pertutto estranee al quadro dei valori che alimentano le garanzie dellaConvenzione25. Ed anzi, da questa prospettiva, l’impressione è chequesta sentenza possa contribuire a ricalibrare il significato delle ga-ranzie contenute nelle due carte, favorendo, quanto alla libertà di ma-trimonio, un progressivo avvicinamento tra le diverse premesse cuiesse rispettivamente si ispirano26.
4. Le aperture alle istanze delle coppie same-sex di cui si è parlatofino ad adesso non hanno tuttavia contribuito, nella sentenza Schalk eKopf, a decidere l’esito concreto della controversia perché, in relazionesia alla libertà di matrimonio che al rispetto della vita familiare, laCorte europea ha stabilito, come detto, che l’assenza di un consenso difondo tra le legislazioni europee sul matrimonio omosessuale impedi-
534
25 È su questo terreno che, auspicabilmente, si potranno muovere gli sviluppifuturi della giurisprudenza costituzionale, soprattutto dopo che, a partire dallesentt. nn. 311 e 317 del 2009, la Corte costituzionale ha fatto proprio un disegno diintegrazione tra livello sovranazionale e livello nazionale per cui «il confronto tratutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere ef-fettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo svi-luppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto imedesimi diritti» (punto 7. Cons. in dir.).
26 E su cui ha richiamato l’attenzione G. Ferrando, Le relazioni familiari nellaCarta dei diritti dell’Unione europea, in «Pol. dir.», 2003, 351.
sce ad essa di fissare uno standard di tutela comune, con l’effetto che isingoli stati possono intervenire liberamente, fintanto che non siforma questa convergenza, nell’ambito del loro margine d’apprezza-mento.
È probabilmente inutile tornare sulle critiche cui è stato sottopo-sto in generale questo istituto: non contemplato dalla CEDU e oggettotalvolta di applicazioni discutibili, ma pur sempre espressione diun’esigenza di articolazione degli standards di tutela inevitabile in unimpianto pluralista di tutela dei diritti fondamentali27. Più interes-sante, piuttosto, è capire se e come può giustificarsi il ricorso al mar-gine d’apprezzamento in una controversia, come quella di specie, nellaquale ci si potrebbe aspettare da una corte dei diritti come quella diStrasburgo un atteggiamento risolutamente contromaggioritario:pronto anche ad andare contro la maggioranza dei paesi membri, sequesto volesse dire dare tutela ad un diritto protetto dalla Conven-zione28.
Innanzi tutto, è da considerare che al margine d’apprezzamento laCorte non ricorre sempre nello stesso modo, ma modulando i suoi cri-teri interpretativi, primo fra tutti la ricerca di un consenso tra le legi-slazioni dei paesi membri, sulla base delle circostanze concrete dellacontroversia e della natura del diritto rivendicato. Soprattutto in rela-zione ai diritti connessi all’identità sessuale, non sono mancati casi neiquali, ad esempio, la necessità di un vero e proprio consenso tra le le-gislazioni europee è passato in secondo piano rispetto alla gravitàdella violazione subita dai ricorrenti, come ad esempio nel celebrecaso Dudgeon, nel quale la Corte era chiamata a giudicare della con-formità all’art. 8 CEDU della legislazione nordirlandese che puniva pe-nalmente i rapporti omosessuali tra adulti consenzienti29. Altre volte,invece, la Corte si è dimostrata sin troppo rigida nel richiedere la for-mazione di un quadro uniforme di principi a livello nazionale prima didichiarare l’illegittimità di una prassi nazionale restrittiva, anche se
535
27 Nella sterminata letteratura sull’argomento, richiamo almeno E. Kastanas,Unité et diversité: notions autonomes et marge d’appréciation des États dans la juri-sprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 1996 e N. Krisch,The Open Architecture of European Human Rights Law, in «Modern Law Review»,2008, 183 ss.
28 Sui termini del problema, nella prospettiva dei diritti all’identità sessuale, v.L.R. Helfer, Consensus, Coherence and the European Convention on Human Rights,in 26 «Cornell International Law Journal», 141 (1993), nonché, se si vuole, G. Re-petto, I diritti all’identità sessuale e il ruolo della morale pubblica, in A. Vespaziani(a cura di), Diritti fondamentali europei, Torino, 2009, 91.
29 Ciò non esclude che il contraltare ad una lettura coraggiosa dell’omoses-sualità segnata dal prisma della comparazione giuridica sia stato il suo ripiega-mento sui soli aspetti legati alla privacy e sulla dimensione privata dell’identità ses-suale: S. Millins, Homosexual Rights and Wrongs Under the European Conventionon Human Rights: A Question of Privacy or Equality?, in B.S. Jackson e D. McGol-drick (eds.), Legal Visions of the New Europe, Dordrecht, 1993, 231-234.
questa era comunque minoritaria in Europa: emblematica, da questopunto di vista, è la giurisprudenza sul rapporto tra libertà di espres-sione e morale religiosa (nei casi sul proselitismo, sulla blasfemia esulla comunicazione commerciale)30, ma anche, per restare a temi piùvicini, la resistenza che per sedici anni la Corte ha opposto nel ricono-scere i diritti dei transessuali nel Regno Unito, nonostante che nelcorso degli anni ’90 sempre più paesi in Europa convergessero sul ri-conoscimento dell’identità successiva all’operazione di mutamento disesso31.
Questo dimostra come il criterio di operatività del margine d’ap-prezzamento non possa essere ridotto sempre alla ricerca di un “mi-nimo comune denominatore” tra le diverse prassi nazionali, poichél’intensità e la direzione della ricerca comparativa intrapresa dallaCorte dipendono, in ultima istanza, dall’intensità della violazione sullasfera privata dei ricorrenti (tanto più intensa e attinente ad una sferaintima della propria personalità è la violazione del diritto, come inDudgeon, tanto meno esigente sarà la ricerca di un common groundsulla materia) e dalla natura del diritto invocato (l’imposizione aglistati di un obbligo positivo di tutela richiede il più delle volte un sup-porto comparativo più completo rispetto alla garanzia di uno spazio dilibertà dagli interventi statali).
Un quadro del genere, del resto, è indicativo di orientamenti dimassima e non può essere formalizzato in una precisa doctrine giuri-sprudenziale32. Non mancano infatti casi nei quali la Corte ha ancheradicalmente mutato nel corso del tempo l’inquadramento di una certarivendicazione, determinando così un diverso modo di operare delconsensus standard e impostando su nuove basi il senso e il ruolo dellasua azione di tutela nei confronti delle scelte nazionali. Ad esempio,dopo che, a partire dal caso Rees del 1986 e per tutti gli anni ’90, laCorte aveva inquadrato il diritto dei transessuali ad ottenere il ricono-scimento della loro nuova identità come una rivendicazione non rien-trante nella sfera più intima della propria personalità e, soprattutto,condizionata da un obbligo dello stato di riconoscimento in positivo
536
30 Su cui v. P.-F. Docquir, La Cour européenne des droits de l’homme sacrifie-t-elle la liberté d’expression pour protéger les sensibilités religieuses?, in «Revue trime-stri elle des droits de l’homme», 2006, 847.
31 Un’attenta trattazione sul punto è quella di A. McHarg, Reconciling HumanRights and the Public Interest: Conceptual Problems and Doctrinal Uncertainty in theJurisprudence of the European Court of Human Rights, in «Modern Law Review»,1999, 690.
32 M. de Blois, The Fundamental Freedom of the European Court of HumanRights, in R. Lawson and M. de Blois (eds.), The Dynamics of the Protection of Hu-man Rights in Europe. Essays in Honour of Henry G. Schermers, vol. III, Dordrecht,1994, 57 s., secondo il quale «Interpretation methods do not function as a straightjacket for the Court, which restricts its freedom of movement. They are more like lei-sure clothing, making it easy for the Court to move around and seek its own way».
del nuovo status, in Goodwin la prospettiva cambia: la Corte ammetteche l’assenza di un riconoscimento interferisce con un aspetto impor-tante dell’identità personale (§ 77) e, sulla scorta di ciò, che la rilut-tanza degli stati ad operare questo riconoscimento non è più sosteni-bile (§ 90). Da questa inversione di prospettiva è scaturita anche unadiversa declinazione del consensus inquiry presupposto dal margined’apprezzamento: «The Court … attaches less importance to the lack ofevidence of a common European approach to the resolution of the legaland practical problems posed, than to the clear and uncontested evidenceof a continuing international trend in favour not only of increased socialacceptance of transsexuals but of legal recognition of the new sexualidentity of post-operative transsexuals» (§ 85). Non è più necessario, inaltre parole, un vero e proprio consenso per poter restringere l’ambitodiscrezionale degli stati, perché è sufficiente la constatazione di unaprogressiva convergenza delle legislazioni nazionali per consentire allaCorte l’individuazione di uno standard comune.
L’esito della sentenza Schalk e Kopf, quindi, non equivale ad unrinvio incondizionato alla discrezionalità statale, ma piuttosto sispiega alla luce del fatto che la garanzia del matrimonio omosessualeviene vista dalla Corte come una positive obligation che grava suglistati e che spetta ad essi disciplinare fintanto che sarà solo una mino-ranza di essi a contemplarla. In relazione al rispetto della vita fami-liare ex art. 8 CEDU, ma significativamente non alla libertà di matri-monio sub art. 12 CEDU, un esito del genere è poi giustificato dal fattoche la lesione subita dai ricorrenti risulta mitigata dall’introduzione,da parte del legislatore austriaco, di una normativa sulle unioni regi-strate che rende il divieto di matrimonio omosessuale meno limitativodella loro sfera di libertà.
Chiariti i termini del ragionamento della Corte, resta da capire seuna simile declinazione del margine d’apprezzamento costituiscaun’applicazione dei principi di giudizio impliciti nella CEDU comestrumento sovranazionale33 o, al contrario, se non ne rappresenti unalettura che paga un debito di deferenza eccessivo nei confronti deglistati.
Sul punto, vale la pena ricordare come negli anni passati si sia as-sistito ad un dibattito molto articolato sui presupposti metodologicidel margine d’apprezzamento e non siano mancate voci che ne hannocriticato tout court la legittimità in relazione a tutti quei moral rights,come quello sotto esame in Schalk e Kopf, il cui riconoscimento viene
537
33 Per un’interessante comparazione con la giurisprudenza della Corte Su-prema degli Stati Uniti, che affida agli Stati membri il compito di individuare – intalune occasioni e sulla base delle peculiarità del contesto locale – gli standard intema di moralità pubblica, a partire da Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973) M.A. Case, Community Standards and the Margin of Appreciation, in «Human RightsLaw Journal», 2004, 11.
subordinato al grado stesso della loro condivisione tra i paesi dell’areaCEDU. Lì dove c’è un diritto posto a tutela di una minoranza, come gliomosessuali o i transessuali, la Corte non potrebbe modularne i signi-ficati facendo affidamento al consensus standard, perché le preferenzelato sensu morali non possono mai condizionarne il godimento pienoed effettivo: qui, come è stato detto efficacemente, «rights block mora-listic preferences»34. La Corte, in questi casi, dovrebbe risolutamenteadottare un approccio definitional, teso ad individuare un nucleo di si-gnificati irrinunciabili di quel certo diritto riconosciuto dalla CEDU,senza che questi possano essere bilanciati con esigenze di natura col-lettiva, prima fra tutte quella rivolta al rispetto di una pluralità di so-luzioni a livello nazionale35.
Ora, a parte le difficoltà insite in ogni approccio rigidamente defi-nitional (a maggior ragione se relativo a nozioni e concetti così densiassiologicamente come i diritti della famiglia), il punto è che questevoci paiono sovrastimare il ruolo che può rivestire la CEDU (e conessa la Corte di Strasburgo) in rapporto agli ordinamenti nazionali.Pare difficile pensare, infatti, che in un sistema così articolato comequello posto a base della Convenzione, in cui convivono culture e tra-dizioni così diverse, possa spettare alla Corte di individuare sempre ecomunque dei contenuti univoci ai diritti in essa garantiti36, anche esoprattutto quando essi riguardano scelte come quelle in discussionenel caso di specie.
Questo non vuol dire, ovviamente, che la Corte possa in tutto eper tutto abbandonare le relative garanzie agli stati, e d’altra partespero di aver dimostrato nelle pagine precedenti come questo nonpossa dirsi avvenuto né in questo caso, né in altri filoni giurispruden-ziali simili (come quello sul transessualismo, nonostante l’estremacautela dimostrata dalla Corte). Il rinvio al margine d’apprezzamento,infatti, quando non è inteso (come in questo caso) in termini eccessi-vamente ampi, sottintende la possibilità per la Corte di tornare ad ap-propriarsi del compito di fissare un certo standard, o quando la con-vergenza tra legislazioni nazionali si mostra più evidente che in pas-sato, oppure quando quella certa rivendicazione, in ragione di unmutamento delle condizioni sociali e culturali, viene attratta nellasfera più protetta di un certo diritto fondamentale. Anche sul terreno
538
34 G. Letsas, A Theory of Interpretation, cit., 122, dove vengono illustrate echiarite le matrici dworkiniane di questo orientamento.
35 E. Benvenisti, Margin of Appreciation, Consensus and Universal Standards,in 31 «New York University Journal of International Law and Politics», 1998-1999,844 ss., C. Nowlin, The Protection of Morals under the European Convention for theProtection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in «Human Rights Quar-terly», 2002, 264 ss.
36 P. Mahoney, Marvellous Richness of Diversity or Invidious Cultural Relati-vism?, in «Human Rights Law Journal», 1998, 1 ss.
dei moral rights (se si vuole chiamarli così), i principi di giudizio ela-borati dalla Corte mostrano insomma come l’opera di inquadramentodel pluralismo non equivalga ad una rinuncia nei confronti dell’elabo-razione di standard e regole univoche, ma semmai miri a ridurre pro-gressivamente gli spazi d’azione del legislatore statale in presenza diun quadro di valori condiviso37.
Questa conclusione dimostra, da un ulteriore punto di vista,quanto questo approccio sia diverso da quello seguito dalla Corte co-stituzionale italiana nella già citata sentenza n. 138 del 2010. Si po-trebbe infatti ritenere che le due sentenze finiscano entrambe, anchese per strade diverse, per rimandare al legislatore il compito di disci-plinare il matrimonio same-sex, pur avendo ravvisato una potenzialeviolazione del relativo diritto (l’art. 8 CEDU, da un lato, e l’art. 2 Cost.,dall’altro). La Corte costituzionale, infatti, ha stabilito che dalla Costi-tuzione non discende un vincolo ad estendere il matrimonio agli omo-sessuali, benché le unioni di questi ultimi rientrino tra le formazionisociali di cui all’art. 2 Cost.: di conseguenza, «nell’ambito applicativodell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena di-screzionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento perle unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la pos-sibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni» (punto 8. Cons.in dir.). Non diversamente parrebbe essersi mossa, secondo alcuni, laCorte di Strasburgo allorché, pur ritenendo astrattamente applicabiligli artt. 8 e 12 CEDU, ha rimandato agli stati la scelta in questione38.
L’analogia pare ancora più evidente se si considera che, dichia-rando solamente inammissibile e non infondata la questione di legitti-mità sub art. 2 Cost. perché diretta ad ottenere una sentenza additivanon costituzionalmente obbligata, la Corte costituzionale avrebbe in-teso sgomberare la strada ad una soluzione legislativa a favore del ri-conoscimento delle unioni omosessuali, che costituirebbe una solu-
539
37 Dopo tutto, un impianto del genere non appare pregiudizialmente in con-trasto con una teoria costituzionale di judicial review: ricordo le parole di JohnHart Ely (Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review, Cambridge, 1980,70): «controlling today’s generation by the values of its grandchildren is no more ac-ceptable than controlling it by the values of its grandparents: a ‘liberal accelerator’ isneither less no more consistent with democratic theory than a ‘conservative break’».Sul punto cfr. P. Mahoney, Judicial Activism and Judicial Self-Restraint in the Euro-pean Court of Human Rights: Two Sides of the Same Coin, in «Human Rights LawJournal», 1990, 74, secondo il quale: «In the absence of a degree of consensus as evi-denced by a comparative study, there would be a greater risk of the European Court’sstraying beyond the bound of its legitimacy were it to impose a progressive interpreta-tion». Contro questa impostazione v. P. Van Dijk e G.J.H. Van Hoof, Theory andPractice of the European Court of Human Rights, Deventer, 1990, 603, secondo iquali il rifiuto della Corte di elaborare una “nozione europea di morale” si pone incontrasto con la CEDU quale strumento di garanzia collettiva dei diritti.
38 La somiglianza, in questi termini, tra le due sentenze è notata da M.D’Amico, nel commento audio alla sentenza Schalk e Kopf, in www.radioradicale.it(disponibile all’indirizzo http://alturl.com/umwq5).
zione ormai imposta ai sensi dell’art. 2 Cost., a fronte di una preclu-sione sul fronte dell’estensione agli omosessuali, anche in via legisla-tiva, della possibilità di sposarsi, in presenza della suaccennata inter-pretazione dell’art. 29 Cost.39 Non diversamente, come visto, l’introdu-zione in Austria di una legge sulle unioni registrate ha spinto la Cortedi Strasburgo a ritenere che lo stato ricorrente non avesse ecceduto ilmargine d’apprezzamento ad esso riservato in relazione all’art. 8CEDU, come a rimarcare una lettura che vuole queste unioni come unsecond best rispetto alla scelta certamente più audace, ma non percor-ribile, di consentire il matrimonio40.
A ben vedere, tuttavia, le analogie tra i percorsi argomentativi se-guiti dalle due corti appaiono più di facciata che altro. Dietro il ricorsoalla formula della sentenza additiva a contenuto non vincolato, infatti,la Consulta finisce per risolvere il problema degli obblighi positivi chegravano sul legislatore interamente sul piano di una political que-stion41: spetta al legislatore e solo ad esso individuare le forme e i modidi equiparazione tra matrimonio omosessuale e eterosessuale, non es-sendo percorribile, né ora né in futuro, un’equiparazione tra le due si-tuazioni affidata alla declaratoria di incostituzionalità della normativacivilistica42. Quello che la Corte italiana affida una volta per tutte al le-gislatore, per la Corte europea rimane, come visto, un restraint vinco-lato alla presenza di certe condizioni, prima fra tutte quelle legate alconsensus standard, con la conseguenza che l’azione degli stati non ri-mane in linea di principio sottratta al sindacato dei giudici di Stra-
540
39 Per due letture dei diversi dispositivi contenuti nella sentenza n. 138/2010v. P.A. Capotosti, Matrimonio tra persone dello stesso sesso: infondatezza versusinammissibilità nella sentenza n. 138 del 2010, in «Quad. cost.», 2010, 361 e E. Cri-velli, Il matrimonio omosessuale e la ripartizione di competenze tra legislatore e or-gano di giustizia costituzionale: spunti da una recente decisione del Tribunale costi-tuzionale portoghese, in «Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti»(www.associazionedeicostituzionalisti.it), 2010, 7.
40 Ed è proprio su questo aspetto che ha fatto leva la minoranza dissenzientedei giudici Rozakis, Spielmann e Jebens.
41 Ben diversamente sarebbero andate le cose ove la Corte costituzionaleavesse scelto di modulare in altro modo il rapporto tra gli spazi dell’interpretazionee la riserva al legislatore di uno spazio di discrezionalità, ad esempio ricorrendo aduna sentenza additiva di principio, così come auspicato prima della sentenza, tral’altro, da B. Pezzini, Dentro il mestiere di vivere: uguali in diritto o uguali in na-tura?, in Bin, Brunelli, Guazzarotti, Pugiotto, Veronesi (a cura di), La «societànaturale» e i suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, Torino,2010, 21.
42 Di un «riferimento alla discrezionalità del legislatore come spazio impregiudi-cato dalla norma parametro» parlano I. Massa Pinto e C. Tripodina, Sul come per laCorte costituzionale, cit., 4. E questo anche a tacere della preclusione che, secondotaluni, deriverebbe dalla sent. n. 138/2010 nei confronti di una normativa che in-troducesse nel nostro ordinamento il matrimonio omosessuale (v. F. Del Canto, Lecoppie omosessuali davanti alla Corte costituzionale: dalla «aspirazione» al matrimo-nio al «diritto» alla convivenza, in «Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzio-nalisti» (www.assciazionedeicostituzionalisti.it).
sburgo. In questo modo, nulla esclude che in futuro questa rivendica-zione venga attratta definitivamente a pieno titolo tra i diritti garantitidalla Convenzione: seppure ancora debolmente inquadrata, l’indivi-duazione dello spettro di significati degli artt. 8 e 12 CEDU resta pursempre nelle mani della Corte di Strasburgo, laddove la Corte costitu-zionale si riserva per il futuro, soprattutto in relazione alla portata del-l’art. 2 Cost., un ruolo di giudice della ragionevolezza di scelte che re-stano in linea di principio spettanti al legislatore43.
5. Per tutte queste ragioni, non pare plausibile assimilare la portatadella sentenza della Corte europea a quella della Corte costituzionale,raffigurando entrambe come casi di ambigua commistione tra attivi-smo e deferenza decisionale, tali per cui da un lato viene ampliata laportata delle relative garanzie, ma dall’altro se ne subordina l’effettivaapplicazione all’avverarsi di una condizione di là da venire.
È in effetti connaturato al peculiare ruolo della Corte europea deidiritti dell’uomo che la sua attitudine contromaggioritaria si dispieghisecondo percorsi che, nel rispetto della sussidiarietà e in presenza diun disaccordo sui valori da tutelare, progressivamente inquadrano ilpluralismo delle soluzioni esistenti a livello nazionale, restringendolocosì entro limiti ragionevoli, piuttosto che plasmarlo dall’alto in appli-cazione di standard morali, etici o culturali univoci44. Se, su questepremesse, si abbandona una lettura incentrata sull’alternativa seccatra activism e restraint, l’impressione è che dalla sentenza europea siriescano a trarre, a differenza di quanto avviene per la sentenza n. 138cit., non poche indicazioni utili per farne un’occasione di consolida-mento e di aggiornamento delle rivendicazioni portate avanti dallecoppie omosessuali. Mentre l’esito della pronuncia della Corte costitu-zionale finisce per coincidere con una rimessione della scelta al legi-slatore, la peculiare incompiutezza che caratterizza la sentenza Schalke Kopf, più che un ostacolo al pieno riconoscimento, può essere vistacome un vincolo per i giudici e i legislatori nazionali a non eludere infuturo la sostanza propriamente costituzionale delle istanze delle cop-
541
43 Questa diversità di approcci può essere meglio compresa e analizzata neitermini di una teoria del ragionamento giuridico, come ad esempio quella di NeilMacCormick in Legal Reasoning and Legal Theory (1978), tr. it. di A. Schiavello, To-rino 2001. Nel rimandare la definizione del contenuto dei parametri costituzionaliinvocati al legislatore, la Corte costituzionale si riserva solamente uno spazio peruna giustificazione di primo livello, cioè limitata al coerente svolgimento di regolegià date perché poste dal legislatore, mentre la Corte di Strasburgo, coinvolta sulterreno dell’attribuzione di significato ad un parametro dai contorni indefiniti, nonrinuncia a mettere in campo una giustificazione di secondo livello, attinente cioèalla stessa individuazione della regola, pur se nel contesto di un ordinamento cheguida e vincola l’attività interpretativa del giudice (op. ult. cit., 119 ss.).
44 Su una simile strutturazione del pluralismo v. M. Delmas-Marty, Les forcesimaginantes du droit (II). Le pluralisme ordonné, Paris, 2006.
pie omosessuali, pur secondo itinerari politici e decisionali calibratisulle sfere pubbliche interne ai vari paesi membri.
Come visto, la tutela delle coppie omosessuali in Europa si mostraun campo nel quale sussiste un indiscutibile disaccordo di fondo, il cuipieno superamento, se demandato alla Corte europea, rischierebbe dialterare gli equilibri che sovrintendono alla formazione di un ordinepubblico europeo dei diritti fondamentali. Di fronte a questo scenario,l’affidamento al margine d’apprezzamento statale, se non avviene inmodo incondizionato, può condurre ad esiti non meno auspicabili diuna soluzione “forte” e dai contorni ideologici netti. Laddove è impos-sibile per una corte fare propria una lettura dei diritti e delle garanziepienamente definita nei suoi presupposti di valore45, infatti, il ricorsoad un “accordo non completamente teorizzato”46 – come il marginestesso può essere rappresentato, per il fatto di fissare alcune coordi-nate senza per questo esaurire le matrici ideologiche di un certo isti-tuto –, può rivelarsi lo strumento più idoneo per non sacrificare deltutto la portata di una garanzia come quella in discussione, e al tempostesso adattarne i contenuti ai diversi contesti costituzionali, sociali eculturali, garantendo l’evoluzione dei suoi significati.
In primo luogo, il superamento del dissenso in nome dell’accogli-mento di una prospettiva chiaramente e unilateralmente delineatanelle sue premesse di valore può rischiare di ridurre il margine dellesoluzioni disponibili, predeterminando eccessivamente i significati e itermini del riconoscimento di un certo diritto e restringendoli all’in-terno di opzioni culturali che possono rivelarsi troppo strette di fronteai casi della vita47. Per le coppie omosessuali e il loro diritto a sposarsi,un dubbio del genere si pone in relazione alla possibilità di ricono-scere senz’altro al matrimonio un significato e un valore di liberazionedelle loro rivendicazioni e aspettative. Se si considera che, attual-mente, la stigmatizzazione degli orientamenti sessuali minoritari sem-bra muoversi – tranne alcune infelici eccezioni come quella italiana –più sul terreno della stereotipizzazione che della repressione aperta esocialmente condivisa, viene da chiedersi, con le parole di chi ha riflet-tuto sulle trasformazioni di senso dell’intimità nelle società capitaliste,se valga la pena «assumere il raggiungimento della libertà o dell’ugua-glianza come metro definitivo per valutare le trasformazioni sociali» ose non «dovremmo invece interrogarci propriamente sui modi in cui lenuove norme di uguaglianza e di libertà hanno trasformato la ‘trama
542
45 Penso, ovviamente, alla figura del giudice-Hercules teorizzato da R. Dwor-kin in Law’s Empire, Harvard, 1986, 225, non solo pienamente consapevole delle di-verse ricostruzioni possibili del bene comune che si contendono il campo nell’in-terpretazione costituzionale, ma capace anche di individuare costruttivamente lateoria che meglio delle altre rispecchia gli ideali interpretativi della comunità.
46 C.R. Sunstein, Incompletely Theorized Agreements, 108 «Harvard Law Re-view», 1995, 1733.
47 C.R. Sunstein, op. ult. cit., 1748.
emotiva’ dei rapporti personali»48. Da un riconoscimento affidato aduna strutturazione non pienamente determinata dei diritti familiaridegli omosessuali, in altre parole, potrebbe derivare un’articolazionedei modelli di tutela che scongiura i rischi di un’eccessiva categorizza-zione delle loro istanze: c’è da temere che il disegno emancipativo chene potrebbe scaturire, nell’immediato, sfoci in un disegno di normaliz-zazione delle loro rivendicazioni, non diversamente da quanto è avve-nuto, lo si è visto sopra, nella vicenda dei transessuali49.
In secondo luogo, il ricorso della Corte europea ad un accordonon completamente teorizzato ha anche il merito di attenuare i costipolitici di un disaccordo endemico50. Le aperture contenute nella sen-tenza dimostrano come i giudici di Strasburgo non abbiano fatto pro-pria una ricostruzione univoca delle garanzie delle coppie omoses-suali, respingendo il ricorso avanzato ma senza affatto precludere unmutamento di rotta in futuro. Ed anzi, l’attrazione delle istanze same-sex all’interno degli artt. 8 e 12 della Convenzione chiarisce come le ra-gioni che ostano all’accoglimento del ricorso non sono ragioni di prin-cipio, ma sono relative piuttosto a condizioni che possono mutare infuturo. Per parafrasare Sunstein, i ricorrenti hanno perso la decisione,ma non hanno perso il loro mondo51, come invece si può ritenere siaavvenuto nella sentenza della Corte costituzionale che, pur avendofatto alcune significative aperture, sembra aver sbarrato la strada aqualsiasi futuro revirement.
Ed infatti, un altro punto a favore dell’approccio scelto dalla Corteeuropea sta nel fatto che, in presenza di un disaccordo come quellopresente ora in Europa sul matrimonio omosessuale, esso garantisceun’apertura nei confronti dell’evoluzione nel tempo degli standard mo-rali, senza per questo limitarsi a rispecchiare il pluralismo esistente.Come visto, la sentenza si mostra particolarmente impegnata a supe-rare i vincoli, testuali o legati ai propri precedenti, che potenzialmentele avrebbero impedito di raggiungere il risultato che ha raggiunto, edè per di più significativo che ciò sia in larga parte dovuto ad un per-corso di eterointegrazione fondato sull’argomento comparativo. Nellaconsiderazione di questi aspetti si intravedono proiettate nel tempo lecapacità trasformative, e non meramente conservative, dell’approccioincompiuto scelto dai giudici di Strasburgo52.
543
48 E. Illouz, Intimità fredde. Le emozioni nella società dei consumi, Milano,2007, 62.
49 Emblematico il caso di cui alle sentenze citate supra in nt. 14.50 N. Krisch, The Open Architecture, cit., 215: «… by leaving issues of principle
open, the pluralist structure has limited the antagonism between the different institu-tions involved and has helped them move to a stage where they could mutually bene-fit from a cooperative relationship».
51 C.R. Sunstein, op. e loc. ult. cit.52 Il carattere non necessariamente conservatore degli incompletely theorized
agreements è d’altra parte sottolineato anche da Sunstein, con parole che vorrei ri-
L’approccio scelto in questa pronuncia, in definitiva, dimostracome né una narrativa costituzionalistica – che vuole la Corte di Stra-sburgo portatrice di un disegno di progressiva unificazione ispirato dasupposte better practices nazionali –, né una narrativa internaziona-listica – nel nome di una Corte rispettosa delle tradizioni nazionalicome se queste fossero “fatti” e non costruzioni storiche e ideologi-che –, possano guidare la composizione delle complesse e contrappo-ste esigenze che, soprattutto in relazione ai moral rights, è affidata aigiudici di Strasburgo. La sfida, più che rimandare alle alternative teo-riche che hanno accompagnato il consolidamento degli stati nazionali,sta piuttosto nell’elaborazione di argomenti in grado di edificare unitinerario pluralistico di articolazione dei valori della convivenza: mar-gine d’apprezzamento, interpretazione evolutiva e argomento compa-rativo, se non rinunciano a priori a veicolare una lettura trasformativadei diritti in tema di identità sessuale, possono rivelarsi strumenti ingrado di attivare un circuito di dialogo e di conflitto non necessaria-mente meno incisivo di una retorica “forte” dei diritti e delle libertà.
544
portare espressamente (op. cit., 1753-4): «… it should be remarked that incompletelytheorized agreements are not necessarily conservative, and it would therefore bewrong to identify enthusiasm for such agreements with a belief in Burkeanism ortraditionalism in law. Many incompletely theorized agreements are highly critical ofexisting social practices … Whether incompletely theorized agreements produce ap-proval or disapproval of existing practice depends on their content, not on the fact oftheir incomplete theorization».