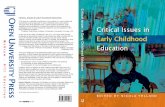‘Il Purgatorio, san Nicola e gli scolastici agostiniani. Presupposti per un'iconografia’
Transcript of ‘Il Purgatorio, san Nicola e gli scolastici agostiniani. Presupposti per un'iconografia’
Il Purgatorio, san Nicola e gli scolastici agostiniani. Presupposti per un'iconografia Ann M Giktti (traduzion~ di Tommaso Marani)
Tra i molti miracoli di san Nicola da Tolentino uno ha assunto una posizione di particolare rilievo nell'ambiro del suo culto ed è stato rappresentaro in oltre cento immagini: quello del Santo che libera delle anime dal Purgatorio. Si dice che tale evento abbia avuto luogo nel corso della sua vita, quando era un giovane sacerdote presso l'eremo agostiniano di Valmanente, vicino Pesaro, all'inizio degli anni settanta del Duecento. La Vita del Santo scritta da Pietro da Monterubbiano nel 1326, pochi anni dopo la morte, riferisce che una notte san Nicola ricevette la visira dell'anima di un suo defunto confratello, Pellegrino da Osimo, il quale rivelò le sofferenze che pativa era le fiamme del Purgatorio e lo implorò di celebrare una messa per i morti al fine di ottenere la sua liberazione. Quando Nicola, pur moscratosi compassionevole, gli rispose che non poteva, poiché quella settimana era stato incaricaro della messa convenruale, fra Pellegrino lo condusse presso una pianura vicino a Pesaro dove gli mostrò una folla di anime purganti. San Nicola fu mosso a pietà c il giorno successivo, con il permesso del priore, diede inizio a una settimana di Messe per i morti, che celebrò tutti i giorni. Alla fine del settena.rio l'anima di fra Pellegrino fece ritorno per dirgli di essere stata liberata dal Purgatorio insieme alla gran parte delle anime che erano con lui, grazie alle Messe celebrate, e di essere ascesa in Paradiso1•
Quest'episodio appare frequentemente nelle rappresentazioni di san Nicola dal Medioevo ai giorni nostri, come, per esempio, nel dipinco a olio di Francesco Maffei (1657) nell'oratorio di San Nicola a Vicenza (fig. 1). Le due immagini più anciche pervenuteci sono due frarnmenci di affreschi conservaci a Tolencino e a Fermo. Entrambi mosrrano delle anime nel Purgatorio, ma sono oggi lacunosi
proprio nella porzione dove verosirnilmeme venne rappresentato san Nicola. La scena nell'affresco di Pietro da Rimini e bottega nel Cappellone diTolentino (fig. 2) mostra anime di persone appartenenti a diverse categorie sociali (è possibile identificare un frate tonsurato, un vescovo che indossa una mitra e un laico con una berretta)2
, che attendono era le fiamme del Purgatorio paziencemente e piene di speranza: esse rivolgono infatti verso l'alto uno sguardo sereno, mentre una di loro, presumibilmence fra Pellegrino stesso, viene sollevata da un angelo. Oggi una porta che conduce alla sacresria raglia l'affresco proprio nel punto in cui era probabilmente raffigura m san Nicola nell'atto di celebrare la messa. Il ciclo di affreschi fu realizzato negli anni venci del TrecencoJ, o poco prima, e comunque poco dopo la morte del Sanro, avvenuta nel 1305, e in prossimità della composizione della Vita di Pietro da Monterubbiano e della preparazione del processo di canonizzazione descinaro a essere sottoposto al giudizio del papa (1326). Coincide dunque esattamente con lo slancio iniziale dell'immediata popolarità e fama del Santo. Nel periodo in cui il Cappellone venne affrescato, le raffigurazioni del Purgatorio erano molto rare; alcune rappresentazioni fecero la loro comparsa nel Trecento, ma non divennero frequenti prima della metà del secolo successivo4
•
La rappresentazione delle anime nel Purgatorio tra le fiamme compare anche in un affresco in Sant'Agostino di Fermo (inizio XV secolo) (fig. 3). Queseaffresco è ancora più danneggiaro del precedente (la figura di san Nicola è quasi del tutto scomparsa), ma siamo in grado di vedere come le anime abbiano deUe movenze gentili e come una di loro abbia le braccia levate in un acro di preghiera e di
65
SAN NICOLA DA ToL.ENTINO NEU.'AR'n
l. Fr:mcesco Malfei, Fra P~lkgrino mostra a Nicola k ani= purganti. C.kbr~Uione deUa santa messa in loro suffragio ( l 657). Vicenza, or2torio di San Nicola
66
speranza, forse in procinto di essere sollevata dalle fiamme. Entrambi gli affreschi probabilmente includevano san Nicola che celebrava la messa, secondo l'iconografia che infatti ritroviamo nelle opere successive. Essa mostra chiaramente san Nicola nell'ano di officiare la messa, la cui efficacia è evidenziata dalla presenza di anime che vengono liberate dal Purgatorios. Le scene nel ciclo di affreschi in San Giovanni in Carbonara, presso Napoli (XV secolo) (fig. 4), la pala d'altare della chiesa di San Michele de la Seu de Urgell (1433), ora nel Museo d'Arte della Catalogna a Barcellona (fig. 5) e il ciclo di affreschi in Sanra Brigida a Bergamo (tardo XV secolo), forse della borrega di Angelo Baschenis (figg. 6 e 7), presentano rutti san Nicola che solleva un'ostia, ben visibile, davanti a un altare posto in un'ambientazione archirerronica che suggerisce una cappella o una chiesa, mentre uno o più partecipanti alla messa s'inchinano in preghiera. Simili elementi compaiono nella pala d'altare di Antoine de Lonhy (tra il 1460 e il 1462), originariamente collocata nel monastero agostiniano della Domus Dei de Mirallers, a Castclvl de Rosanes, Baix Llobregat, ora nel Museo d'Ane
della Catalogna, Barcellona (fig. 8). Qui san Nicola è rappresentato mentre sta pregando, ma un calice coperJo sull'altare e i pa.ramenti che indossa (come a Napoli o alla Seu) indicano che sta celebrando la messa. Un pannello ligneo di Antonio Barili da Siena (tra il 1487 e ill499) in Sant'Agostino di Pesaro (fig. 9) presenta wìiconografia della m~ sa così simile alle immagini appena discusse (fìgg. 4, 5, 6 c 7) che, sebbene non vi compaiano le anime del Purgatorio, è estremamente probabile che a questo miracolo faccia riferimento. In nme queste raffigurazioni le anime del Purgatorio compiono gesti di supplica o di preghiera, sono pazienti, sembrano non patire sofferenze estreme e almeno una tra di loro viene sollevata dal Purgatorio come conseguenza della messa. Gli elementi iconografici che osserviamo in relazione al Purgatorio e all'efficacia della preghiera e delle Messe per la liberazione delle anime sono conformi a quanto era stato già accertatO da tempo dai fedeli e dai teologi cristiani e a quanto sarebbe stato successivamente stabilito nel dogma della Chiesa. Le preghiere per i defunti costituivano un'antica tradizione cristiana e l'intercessione dei santi fu
sempre più ricercata nel corso dd Medioevo, sebbene inizialmente non specificameme in connessione con il Purgatorio' . Le fonti delle Scrirrure e della Parristica facevano infatti riferimento ai sacrifici per la salvezza dei morti e al processo di purgazione nell'aldilà, ma non al Purgatorio in quanto tale. Le discussioni medievali sul Purgatorio citavano in particolar modo 2 Maccabei 12, 39-45, in relazione ai sacrifici per salvare i morti dalle pene per il loro peccati, e l Corinzi 3, 10- 15, dove veniva stabilita una connessione tra azioni compiute, fuoco e salvezza. Esse prendevano anche in considerazione l'Enchi
ridion di sanr'Agosrino, nel quale questi, a proposito dei suffragi per i defunti, divideva i diversi tipi di anima dopo la morte secondo il loro comportamento durante la vita: i "non così buoni" e i "non così cattivi", che potevano essere aiutaci mediante i suffragi dei vivi; i "talmente buoni", che non avevano bisogno di quest'aiuto, e i "talmente cartivi" che non potevano giovarsene affarro7
• Per quanto riguarda la purgazione, Agostino fa riferimento in diverse opere al fuoco purgaroriale (Enchiridion 69) o a un fuoco non eterno di salvezza sperimentato dalle anime nell'intervallo tra la morte e il Giudi-
l t i'URGATOIUO, SAN NICOLA E GU SCOI.ASllCI AGOSTINIANI. PREsUPPOSTI PER UN'IçQr-;QGRAFIA
3
zio Universale (De civitate Dei XXI, 26), e distingueva tra il fuoco di purgazione e la pena eterna (De Genesi contraManicheos II, 20). Un'altra fome fu per gli scolastici Gregorio Magno, il quale parlava di fuoco di purgazione (Dialogi IV, 39), e raccontava la storia di un monaco scomunicato e defunto la cui anima fu salvata grazie a trenta Messe di suffragio (Dialogi IV, 55). Nel dodicesimo secolo ebbe luogo un cambiamento nella concezione della purgazione dal peccato delle anime dei defunti. Si sviluppò infatti un concerro di Purgatorio come luogo, piuttosto che semplicemente come stato o condizione di un'anima dopo la morte. Si diceva che le an ime soggette alla pena purgatoriale e al fuoco si trovassero in un luogo distimo dal Paradiso e dall'Inferno. Jacques Le Goff ha evidenziato come l'affermarsi dell'idea di Purgatorio come luogo sia segnato dall'emergere della forma sostanrivale della parola purgatorium, che fino ad allora era stata solamente un aggettivo•. Durante il Duecento, prima di san Nicola e durante la sua vita, si sviluppò quindi La discussione circa la natura del Purgatorio, inizialmente in connessione agli sforzi di unificazione con la Chiesa greca com-
2. Pietro da Rimini, Amme tkl Purgatorio. Tolentino, Cappdlone di San Nicol~
3. Anonimo,~ mz k fiamme {iniz.io dd XY s=>lo). Fermo, Sant'Agostino
67
$AN NICOLA DA TOLENTINO NF.LÙRTE
4. Anonimo, San NU:o/a e rido agiotrafoo {prima metà dd )N
secolo). NapoiJ, San Giovanni in Carbonara
5. Jaumc Cirera, Masa in sujfozgu> delk anime tkl Purgatttrio (1432-1433). Barcdlona, Museo d'Arte de.lb Cawogna
68
piuti dalla Chiesa cattolica9• Si era infatti ritenuto erroneamente che la Chiesa greca negasse del tutto l'esistenza del Purgatorio, laddove invece essa aveva una concezione della purgazione dopo la morte priva dei caratteri di un luogo distinto o di fuoco 10. AJ secondo Concilio di Lione (1274) ai delegati greci venne consegnata una professione di fede in cui si asseriva che le anime dei defunti, una volta purificate mediante la pena espiatoria (poenis purgatoriiis hoc est cathartmis), venivano accoh:e immediatamente in Paradiso (mox in coelum recipt), e non solamente dopo il Giudizjo Universale, e che le preghiere, le Messe e le elemosine dei vivi potevano alleviare le loro soffereoze11
• Non veniva però fano alcun riferimento al fuoco purgatoriale, o al Purgarorio come sostantivo o come luogo; due punti prudentemente non considerati al fine di rimarcare l'essenziale idea comune di purgazione dopo la morte. La purg-azione nell'aldilà fu confermata in una bolla pontificia (Benedictus Deus) dd 1336, di Benedetto XII. Gli elemenri principali della professione di fede di Lione fUrono ripresi in un decreto del Concilio di Firenze {1439), che formalizzò cale insegnamento come un dogma della Chiesa, parte, questa volta,
di un'unione (alla frne priva di successo) con la Chiesa greca. Il Concilio decretò che le anime dei defunti che dovevano ancora espiare i loro peccati soffrivano pene purgatoriali (poeniis purgatoriis); che le Messe, le preghiere e le elemosine dei vivi potevano alleviare queste pene, e che le anime, una volta purgate dei loro peccati, erano accolte immediatamente in Paradiso12. Ancora una volta non veniva fatta menzione del fuoco o del Purgarorio come un luogo. Non fu prima dd 1563, alla fine del Concilio di Trento, che la parola purgatorium fece la sua comparsa come un sostantivo io un decreto dogmatico13, aJ frne di confermare esplicitamente che il Purgatorio esisteva ( Cum cattolica ecclesìa [ ... ) docuerit purgatorium esse) e che Messe, preghiere ed elemosine erano d'aiuto nel liberare da J) le anime14. Il Concilio rispondeva al rifiuto protestante rig-uardo l'esistenza del Purgatorio e la pratica delle indulgenze per gli individui, nella speranza di ridurre le sofferenze patite. Al tempo di san Nicola (durante la sua vita e nel periodo successivo) si sviluppò un importante dibattito sulla natura della purgaz.ione dopo la morte. I teologi scolastici erano al centro della discussione con gli agostiniani che svolsero un ruolo attivo nella formulazione di quesro concetto. Il più importante tra i primi teologi agostiniani fu Egidio Romano (t 1316), che srudiò con Tommaso d'Aquino e insegnò a Parigi. Fu uno scrittore prolifico nel campo della filosofia arisrotelica, cosl come di testi reologici e di sermoni; scrisse uno speculum principis per il fururo Filippo IV il Bello, oltre a vari uartaci sulla supremazia del potere papale suU'autorità secolare a sostegno di Bonifacio VIII nel suo scontro con lo stesso Filippo IV. Nel1285 divenne il primo magister del suo Ordine a Parigi e, in un Capitolo Generale dell'Ordine a Firenze (1287), fu dichiarato che il suo insegnamento teologico sarebbe divenuto la dottrina dell'Ordine che rutti i professori e studenti agostiniani sarebbero stati tenuti a seguire. Fu priore generale dell'Ordine (1292-1295) e arcivescovo di Bourges (1295-1316) 1 ~.
Egidio affermò chiarameme nel suo Liber de praedestinatione, praescienti.a, paradiso et inferno che il Purgatorio doveva esistere e che era per quelle anime morte in staro di grazia, ma non punire a sufficienza in quesro mondo per i loro peccati: "Ma in aggiunta al paradiso e all'inferno è da posrularsi un
SAN NICOV. DA TOLENTINO NELL'ARTI!
7
70
tel7.0 luogo, e cioè il purgatorio. Poiché però molti muoiono con la carità e con la grazia e tuttavia non hanno fano sufficiente penitenza dei loro peccati in questo mondo, e poiché nessun ano malvagio resta impuni m, così come nessun ano buono privo di remunerazione, è necessario che runi coloro che si trovano in questa condizione, dopo questa vita sopportino altre pene e enuino in paradiso e siano fatti salvi per così dire aruaverso il fuoco"16 (l Corinzi 3, 15). In un aluo passo della stessa opera descrive così i tre luoghi: "Un uiplice luogo va perciò postulato, vale a dire il paradiso, che è di coloro che decedono nella grazia e non devono purgarsi; e c'è il purgatorio, che è di coloro che decedono con la grazia e devono purgarsi; e l'inferno dei dannaci, che è di coloro che decedono senza grazia e non meritano di ricevere il purgatorìo"'7•
La distinzione dei tipi di anime richiama l'Enchiridion di Agostino18
• In entrambi i passi Egidio parla dd Purgatorio come di un luogo, discinto dal Paradiso e dall'Inferno, in accordo con una consolidata uadizione teologica, piunosto che usare la meno precisa caranerizzaz.ione di una "fase di purgazione" come era stato fano a Lione (1274). Se guardiamo alle raffìgurazioni di san Nicola del Quattrocento, vediamo il Purgatorio rappresentato come un luogo distinto, collocato all'interno, o al di sono, di rocce (figg. 5 e 8), o in una montagna (fig. 6), dalla quale le anime sono coodone in alto verso il Paradiso. Il movimento stesso suggerisce una concezione di luoghi distinti, dal momento che le anime si stanno spostando dall'uno all'altro. I.: idea che il Purgatorio fosse un luogo di pena temporaneo fu di cruciale importanza per la pratica dei suffragi per i defunti. Negli scritti teologici fu sottolineato come questa pratica fosse utile solamente per le anime nel Purgatorio. Anche gli scolastici agostiniani diedero il loro contributo a questa concezione: Agostino Trionfo da Ancona (t 1328) - il quale insegnò teologia a Parigi nei primi anni dd Trecento e successivamente a Padova, Venezia e Napoli - uanò specificamente questo punto nel suo Tractatus tk resurrectione mortuorum (1277)19
• Egli prende in considerazione l'asserzione "Prima della futura resurrezione le offerte di elemosine e le preghiere dei santi sono di beneficio alle anime presenri in Purgatorio; esse runavia non giovano in nessun
l
modo a coloro che sono dannati per sempre all'Inferno"20, e analizza i quarrro luoghi dell'aldilà (compreso il Limbo) e la questione se le preghiere e altri sacrifici dei vivi possano aiutare le anime che si trovano ll. Le sue risposte riflerrono l' insegnamemo di Agostino, Enchiridion 11011 , il quale a proposito del Paradiso sostiene che le anime che vi risiedono non possano essere aiutate per la semplice ragione che non hanno bisogno di aiuto: godono di tutti i beni, non mancano di nulla e non hanno sofferenze da alleviarell. Le anime in Purgatorio possono in-
lL P URGAfORIO, SAN NICOLA E GLI SCOLASTlCI AGOSTINIANI. P RESUPPOSTI PER UlÙ CONOGRAFIA
vece essere aiutate dalla preghiera poiché sono trattenute per l'espiazione del debito di pena che hanno contratto per i peccati compiuti in vita. Aggiunge inoltre che solo quando i vivi che pregano per i morti siano essi stessi in uno stato di grazia la loro carità può raggiungere i morriu. Le anime nel Limbo, come quelle dei bambini non barrezzari, e le anime all'Inferno non possono tuttavia essere aiutate: quelle nel Limbo non sono barrezzate e non possono perciò essere liberate prima del Giudizio Universal~; quelle all'Werno non possono essere
6 e 7 . Angdo Baschc:nis, Srorir di san N'za>/4 da Tolmtmo (tra cui Mt=J in su/ftagio ikl amfol«llo P~/kgrina e Prtghimz in suffozgio tkllimi1T14 dd folk/lo Gmtik) (1475-1490). Beq;uno, oratorio di SanCI Brigida
8. Antoine de Lonhy. LA Mmltmna col lJmnbinD ~ i lltnti Aglmino e N'=l4 da Tolmtino {1460-1462). con scena ddla sa.n12 messa. Barcdlona, Museo d' Aitt ddla Cawogna
71
------------------------------------------------------------- ----
SAN NJCOLA DA TOI.ENlìNO NEu.'ARTE
9. Antonio Barili da Sima, San Nirola ukfmz la uznta mnsa p•r k ani""' purganti (tra il1487 e il 1499). Pcs~ro, Sant'AgoStino
72
aiutare perché non sono morte in uno stato di grazia, e perciò non possono giovarsi delle buone azioni dei vivi25
•
Giovanni Di Lana da Bologna (t 1350 circa) si espresse in termini simili circa i possibili benefici delle preghiere e delle indulgenze da parre dei vivi per i morti nelle considerazioni preliminari a una quat:stio che poneva la domanda "Se le indulgenze siano efficaci per i morti"26• Giovanni studiò teologia a Parigi, vi insegnò intorno al 1316 e più tardi diresse lo studium generale agostiniano a Bologna21
• Come Agostino di Ancona, egli sostiene che i suffragi dei vivi non possono aiutare le anime all'Inferno, nel Limbo e in Paradiso. Coloro i quali si uovano all'Inferno sono dannati per l'eternità e non possono
·perciò essere aiutati dai viviu. Le anime nel Limbo non possono invece essere aiutate poiché hanno lasciato questo mondo senza il battesimo, la fede e la carità (la "disposizione" ad amare Dio), e sono ancora gravare dal peccato originale; dal momento
che sono la carità e la grazia a far sì che i suffragi di quesro mondo raggiungano l'aldilà, esse non possono giovarsi dell'indulgenza29
• Le anime che sono in Paradiso non mancano di nulla e già godono di Dio, pertanto le azioni compiute dai vivi in loro favore sono inutili30• Le anime del Purgatorio sono le uniche che i vivi possono aiutare, poiché la loro pena non è eterna, e hanno lasciato questo mondo con carità congiunta a peccati venali31
•
Il fatto che le Messe e le preghiere per le anime all'Inferno non potessero essere efficaci è un importante concetto nella formazione della dottrina del Purgarono, in conseguenza diveruJe particolarmente problematico imbattersi in episodi di agiografie che raccontavano di anime salvare dall'Inferno. In un celebre episodio si narra di come Gregorio Magno, mentre camminava atuaverso i Mercati Traianei a Roma, avesse ricordato un atto di pietà e giustizia compiuto da Traiano e, sebbene questi fosse staro malvagio e pagano, l'azione aveva avuto un valore
in senso cristiano: Traiano stava partendo per una battaglia quando una vedova si avvicinò per chiedergli vendetta per la mone del figlio innocente; mosso a pietà, Traiano le rese giustizia. Gregorio, richiamando alla memoria questa vicenda, pregò in San Pietro per l'anima di Trai ano, la quale venne liberata dall'Inferno. Una versione di questa storia appare nella Legenda aurea di Jacopo da Varagine (t 1298 circa), il quale, consapevole del fatto che non potesse esservi via di scampo dall'Inferno, spiegava che quello doveva essere sraco un caso di riduzione della quantità o del genere di sofferenze e privazioni inflirte, piurtosto che di una liberazione vera e propria dall'Inferno32• Anche gli scolastici ebbero ddle difficoltà con quest'episodio; Tommaso d'Aquino e Agostino da Ancona considerarono la possibilità che T raiano fosse sr:aro riportato in vita, avesse ortenuto la grazia e il perdono e che in tal modo fosse srato liberato dall'Inferno, oppure che la sua pena fosse stata sospesa fino al Giudizio Universalel' . Il problema dell'interpretazione di storie di anime salvate dall'Inferno si presentò nuovamente in connes.~ione con la Vìta di san Nicola. Nella Vìta di Pietro da Monterubbiano l'episodio in cui Nicola dà assistenza alle anime nel Purgatorio è seguico irnmcdiatamente da un altro avvenimento incentrato sull'anima di un defunto, il fratello Gentile, che era stato dannaro per l'eternità all'Inferno, ma era staco liberaco grazie alle preghiere di san Nicola>4. Questo miracolo è raffigurare nel ciclo di affreschi in Santa Brigida, a Bergamo (fig. 7), che comprende anche l'episodio delle anime :ù Purgatorio di cui si è trattato sopra. Entrambi i miracoli furono inclusi tra i grandi atri e miracoli compiuci dagli agostiniani nel Liber Vitasftatrum, di Giordano di Sassonia (t 1370/1380), completato inrorno al 1357, dopo ve m'anni trascorsi a raccoglierne il materiale. Era divenuro magisterdi teologia dopo aver studiato presso lo rtudium di Bologna sotto il grande magister Prospero di Reggio, quando Giovanni Di Lana era priore, e successivamente a Parigi. Nei suoi raccon-
Il P l!RGATORJO, SA.'< NICOlA E GU SCOl.ASTlO AGOffiNIANI. PRESUPPO>II PE.R lP.ÙCONOCRAFIA
ti nel Liber Vìtasftatrum sull'aiuto prestato da san Nicola alle anime di Pellegrino e Gentile, riporta le versioni di Pietro da Monterubbiano ma, al termine della storia di Gentile, aggiunge un'importante correzione dominale, affermando che laddove leggiamo "Inferno" si dovrebbe invece intendere "Purgarorio"')· Tenendo in considerazione l'insegnamemo dominale secondo cui le anime nel Purgatorio vi si trovano temporaneamente e che solo queste hanno la speranza di essere liberate prima del tempo se i vivi pregano per loro, quando osserviamo le anime nel Purgarorio nelle immagini dei miracoli di san Nicola, potremo notare come esse non si contorcano nell'agonia, ma piuttosto stiano pazientemente in piedi, all'apparenza piene di speranza (come nella fig. 2) o in preghiera (come nella fig. 4). Non si rratra di anime dannate per l'erernirà, ma di anime che scontano la loro pena e che sperano di essere liberate presto con l'aiuto delle Messe di san Nicola. Considerando ruttavia la grande importanza assegnata nella documentazione visiva e testuale al miracolo compiuto da san Nicola per le anime del Purgatorio, è singolare che non appaia nel processo per la sua canonizzazione, specialmente ove si consideri che la Vìta di Pietro da Monterubbiano (1326) e il ciclo di affreschi nel Cappellone di Tolenrino36
furono eseguiti contemporaneamente al suo svolgirnenco o poco prima (1326) . Tale assenUt porrebbe forse spiegarsi con il fatto che, sebbene ci sarebbero sraci dci testimoni almeno per gli eventi connessi con il miracolo (come il priore che diede il permesso a san Nicola per dire Messe di suffragio c il sacerdote che lo sostituì nella messa conventuale), pochi confratelli agostiniani furono ascoltati nel processo, forse al fine di evirare resrirnonianze di parre, e pochi testimoni porrebbero essere staci ancora in vita cinquant'anni dopo l'evento. Ciononostante, questo miracolo rimane uno rea quelli che distingue in modo più prominente il Santo e spiega la grande devozione verso di lui.
73
SAN NICOlA DA TOLENTINO Nru.'ARTE
74
' HiwJria, 646-647. 2 La HiSUJr.:: (p. 647) dc:scrive all'im:emo della folla di anime quc:lle di uomini e donne di età e posizione sociale differente. 'Potrebbe forse anche essere stato completato prima: cfr. Bisogni 1987, 289-296; Bellosi 1994, 187-194. 'Foumié 1999,41, 105,479 e 521 (dove il Cappdlone viene identificato come una dd le rare rappresentaZioni del Purgatorio dc:ll' epoca), oltre a 46-54, 64, 66 e 70; vedi anche Le Golf 1982, 494-495. 5 Sull'iconogralìa della messa in connessione dc:lla salvezza di anime dal Purgatorio e sulla rappresent2zione ddl'dficaòa della preghiera dei vivi peti defunti, si veda Fournié 1999, 90 e 92. 'Vedi McLaugb.lin 1994. ' "Neque negandum est defunctorum animas pierare suorwn vivenrium rdevaci, cum pro illis sacrifìòum Mediatoris olferrur vd deemosynae in Ecdesia fium. Sed eis haec prosunr qui cum viverenr haec ut sibi postea possint prodesse meruerum. Est enim quidam vivendi modus, nec ram bonus ut non rcquirar ista post mone.m, nec ram malus ut ci non prosinr isra posr morre.m; est vero ralis in bono ur isra non requirat; er est rursus talis in malo ut nec lùs valear, cum ex hac vira tranSierit, adiuvari [ ... )et quare non ornnibus prosunt, nisi propter diffccenciam vi~:;~e quaro quisque gessir in corpore? Cum ergo sacrifiòa sjve alraris sive quarumcumqut: deemosynarurn pro haptéacis defunctis omnibus offerunrur, pro valde bonis graciarurn acciones sum; pro non valde bonis propiciationes sunt; pro valde malis etiam si nulla sunr adiumenta morruorum; qualescumque vivorwn consolaciones sunt. Quibus autem proswu, aut ad hoc prosunt, ut sir piena remis~io, aut certe: ut tolcrabilior fiat ipsa darnnacio." Agostino, Enchiridio n ad Laurmtium (D~ fitk, sp~ a carita:.) 11 0, in Parrologiat Cor,uus Compktus, &ries LatiTUZ, a cura diJ.P. Migne, Parigi 1844-1903, vol. 40, coli. 283-284. 'Le Golf 1982, 209-240 e 489-493; ma vedi Bredero 1983. 'li quadro più esaustivo circa l'evoluzione della dottrina dd Purgatorio è ancora la voce Purgaroi" di Miche! 1936. " Si confronti la discussione in 1òmmaso d'Aquino, Contra trrora Grtucorum, Parre Il, c. 40: ma vedi Michell936, 1247-1249 su come, in una lettera, Innocenzo IV avesse òrcoscritto l'errore greco alla negazione che il Purgatorio fosse un luogo e che avesse il fuoco. " Bullarum diplomatum ... , rv; Gregorius X, p. 27: vedi anche Miche! 1936, 1249 e sgg. "Bullarum diplomatum .. . , IV, Benedictus Xli, pp. 345-347. '3 Bullarum dip/orrw.um. .. , V. Eugenius rv; p. 41; vedi anche Michd 1936, 1262esgg. 14 Concilium Trit:Unrinum. Diariùrum" act&rum, epistularum" traaatuum. Nova colkt:tW, a cura della Sociera~ Goerresiana, Freihurg im Breisgau 1901-2001, vol. 9, p. 1077; vedi anche Michd 1936, 1278 e sgg. '' Una biogralìa moderna ed esaustiva di Egidio Romano non è stata ancora pubblicata. t in corso un'edizione delle sue opere in Argidii Romani op.ra qmnia, a Cllt2 di F. dd Punta e G. Fioravanti, Firenze 1985. Le biografie e le opere di Egidio e degli altri primi scolastiò agostiniani sono riassume in ZumkeUer 1996, 11-79. '' ~'Practer autcm paradisum c:r infc:rnum est dare rerrium locum, sci) i .. cer purgatorium. Cwn enim multi decedunr cum charirate et gratia ramen quia non suflìcientem poeoirentiam egerunt in hoc mundo de peccatis suis, et quia oullurn malum impunitum, sic ur nec bonum irremuneratum, oportet sic se habentes post hanc vitam alias poenas rolc:rare er in paradisum introire, et salvi fiant, sic quasi prr ign=.· Egidio Rom:tno, Libn-tk praetksrinatio.u, prtUreientia, paradiJq tt inferno, Napoli 1525, c. 15, ff. 38v.a-40r.a, f. 38v.b; cfr. Agostino, D~ Civiratt Dn XXI, 26. A fini di coerenza, qui e nelle alue citvJoni i dirronghi sono stati resi in latino dassico. " Est ergo triplicem locwn dare, videlicct paradisum, qui est decedenciwn curo gratia et non habenrium ad purgandum. Er est puigarorium, qui est deeedenciurn cum gracia et habencium ad purgandum. Et infemus damnatorum. qu..i est dccedenrium si ne graria eT non valr:nrium purga .. toriwn recip.:rc." !bitkm, f. 39r.a; dopodiché Egidio aggiunge il Lmho come quano luogo. Cfr. f. 39r.b: "Et purgarorium quod est decedentiwn cum gratia, non carneo sine peccato". "Cfr. nota 7. Tra gli studiosi contemporanei si riscontra una rende.nza a vedefe quamo tipi di anima nel passo dell' Enchiridio11 c poi un cam-
hiamento verso solo tre tipi nd Medioevo; Agostino sembra invece parlare di rre tipi, comprendendo i "non cwl buoni" e i "non cosl cattivi" in una sola categoria. " Agostino Trionfo da Ancona, Tracrarus tk murnctiom mqrruorum prr 40 tht()rmutta distincrus, MS Città del Vaticano, Vat. Lat. 936 (XV secolo), ff 151 v.-J77v. Altri manoscritti: Roma, Angelica 79, ff. 1-29; e Città del Vaticano, Urhin. Lat. 555, ff l-142v. Sulla vira e le opere di Agostino da Ancona, vedi B. Misteri, D~ Aug:tstini tk Ancona, O.E.S.A. (m. 1328) vita aopmbus, in "An. Aug.", 22 (1951-1952), 7-56 e 148-262. "'Agosci:>o da Ancona, Tracratus tk rm.trnxtione morruorum, Theorema 17 {ff. J64v.a-166r.a}: "Ante fururam resurrectionern animahus in purgatorio existentihus elemosynarum largiciones et sanctorum orationes prosunt, quae tamen perpetuo in inferno damnacis nullarenus conferunr".
' 'Vedi nora 7. " "Animahus igi!UJ' existencihus in paradiso ralia suffragi a non prosunt quia suffiagia important rdevacionem alicuius poenae et alicuius indigenciae. Cum igirur animae in paradiso existentes iam sin t remotae ah omni poena et miseria et fruan!UJ' ornni bono, non indigent rclevari per vivo rum su.ffiagia." lbitkm, f. 164v.a. " "Animahus vero cxistencibus in purgatorio, sancrorum orationes, demosinarum largitiones et alia bona opera prosunt quia animae in purgatorio detinentur pro satisfactionc alicuius mortalis peccati, de quo piene in hac vira non fuir sarisfactum, vel pro peccacis venalibus. Et quia ex radice carir.atis unus pro alio satisfacere potesr, ideo dicendum quod animahus existencibus in purgatorio talia prosint inrerdum ex opereoperantis, ut si iUe qui F..cit huiusmodi orationes et suffragia est in gratia, runc ex ipso operante, ralia babenr meri rum sacisfactionis." Giovanni aggiunge un'eccezione interessante; "Interdum veto ex opere operato so
lum ur siquis ab hac vita deccden.s in suo testamento pro anjma sua fie .. ri suffiagia [iuber] quae pet malos cxequrores in peccato monali existentes persolvun!UJ', talia prosunt defuncro, licet non ex opera opetancis salciro ratione operis operati". lbitkm, f. 164v.b. " "Existencibus aurem in limbo, ut pueris non haptizacis, huiusmodi suffragio non conferunt quia ipsi non experiuntur ihi poc:nam sensus debi<;lffi pro peccaris pcrsonae, pro cuius sacisfaccione suffragia prosunt, sed experiunrm poenam darnni, qui a carent divina visione, cwn membra Christi F..cra non fuerint per baptismum, quae poena solum deberureis pro peccato narurae pro quo sacisfeòt passio C hrisci. Er quia ipsi non fuerunt consepulci in praedicra passione pet baptismum, idòrco cum me:rinun passionis non hahuerint, nec libe.rarione.m a culpa ha bere debebunr nec aliqua sufftagia vivorum ad hoc eos iuvare possum, cum pra.edi= suffragia non suffiòant ad talern culpam ddendam." lbitkm, f. 164v.b. ""Sed animahus perpetuo in inferno damnatis praedi= beneficia nihil ronferunt quia de hac vira decessc:runr sine gracia per quam prosunt mortuis vivorum opera." lbitkm, f. 164v.b. "Giovanni Di Lana, Quodlibet l, Q. 11: Utrum indu/gtnriM vakant tkfonais, M$ Città dd Vaticano, Chigi E.Vlll, 247 (XIV secolo), ff. 72r.a-74r.h. "'Sulla vira e le opere di Giovanni Di Lana, vedi D. Gucierrez, Dr Fratrt loann< tk BMonia qui dicitur tk Lana O. E.S.A. (f 1350 circa) baccalauf'f!o parisimsi, in "An. Aug.", 19 (1943-1944), 180-209. " "Ad istaro quaestionern dico quod defunctorwn qu.idam subdunrur poenae daropni et carentiae visionis divinae er poenae sensus id est af. fliccioncm ignis etemaliter, et talibus suffragia vd indulgenòae nichil valent." Giovanni Di Lana, Quodliber J, Q. 11, f. 72r.b; cfr. nota 7. ""Quidaro subdunrur poenae dampni, id est carentiae visionis divinae sine fine, cr talihus talia suffiagia et indulgenciae non valenr; hos autem diòmus pueros in limbo positos decedemes si ne fide et caritads dileccione et cum peccato originali. Un de Augustinus, suffragia non prosu n t illis qui si ne fide operanre per dilecrionem hinc ex:ierunt; rales sunt pueri qui graria et fide haptisrni non sunt ve.~titi et ideo indulgenòae ralibus non valenr quia radix indulgenciae est cariras et gracia." lbitkm, ( 72r.b; cfr. nota 7.
""Quidam perpetuo deo &uunrur per aperram essenciae divinae visi on cm quos norn mus bcaros, cr ralibus similircr non valcnt indulgcnciae
L
et ecdesiae su.ffragia quia ralia fuerim pro indigencibu.s; sciendum deo fruenres su n t si ne indigencia er ideo talia non sunt cis ucilia ... • lbidrm, f. 72r.b; cfr. nora 7. " "Quidarn subdunrur poenae sensus id est ignis afll ictioni et poenae darnpni id est carenciac visionis d.ivinae quae dicirur fruitio. Sed iscis poenis non subdunrur er<maEtor er pc:rpetuo, sed tc.mporalirer et cu.m tenni no, et tali sunt qui decesserunr cu.m cari rare pecca cis venali bus coniuncra, vel sarisf.u:tioni in corde p lenarie non consummatae, id est no n est complerae; hos autem dicimus purgatorio a]Jjgari et de talibus querirurcum quctirururrum indulg=ciae valeantdefunccis." Ibidem. f. 72r.b. "Jacopo da Varagine. L~mda auna, a cura di T. Graesse, Leipug 1850, pp. 196-197. Si confronti la discussione sulla natura dd Purgatorio e della salvezza delle anime nel Purgatorio mediante preghiere e Messe offerte dai vivi nel capi rolo 163 (De C()mmemoratio1U! ammarum), pp.
728-739. "Vedi Tommaso d'Aquino, Summa theoftJgùle, III (Supplemenrum), Q 71, an. 5, ob. 5 e ad 5, in Opn-a (f71mia, a cura di Commissio Leonina, Roma 1880, vol. 12, pp. 153-154 e 155; cfr. il suo Commmtum in quaruor lihrof Smr:mriarum, N, Disc. XLV. Q. 2, are. 2, 5 e ad 5, in Opera
lL PURGATORIO, SAN NICOLA E GLI SCOLASTICI AGOSTINIANI. PRESUPPOSTI PER UN'ICONOGRAFIA
omn!a, Panna 1852-1873, vol. 7.2, pp. 1122 e 1124; e Agostino da Ancona, Traceatus de murrectione mortuorum, f. 165r.a. >< Vita, p. 647. Dante ha collocato 1raiano in Paradiso, spiegando che, dopo l'intercessione di Gregorio, è tornaco al suo corpo per poi essere salvato: Paradiso, Canto XX, vv. 43-48 e l 00-117; vedi Prugatorio, Canto X, vv. 73-93 per la storia della buona auone di Traiano. ""Quod si cui viderur extraneu.m ad credendurn, quod ille de inferno pr<Ocibus istius sancti viri fuerir ereptus, porest imclligi, quod ille dantn.arus fuerir non ad poenarn aerernarn, sed remporalcnt, er quod per inti:rnum accipitur etiam locus purgarorii." (Lib_,- 1943, 203-204). Dopo questa affermazione c'è il breve racconto di un' alrra libcra4Ìone miracolosa di un'anima dal Purgatorio da pane di un priore provinciale (p. 204) . La versione in lingua iraliana della vita di san Nicola di Remigio da Firenze del 1355 o dd 1356, la quale segue liberamente il resto latino di Pietro da Monterubbiano, non commenta quesro problema dorrrinale. Si veda il racconto di Gentile in Stt»ia, 138-140. Per la biografia di Giordano e una valutazione critica delle sue fonti, s i veda l'inrroduzione all'edizione della Vìtasfratrum. "Vedi nora 3 e il tesro rdacivo.
75
Centro Studi Agostino Trapè di Tolentino Comitato Nazionale VII Centenario di san Nicola
San Nicola da Tolentino
nell'arte Corpus iconografico
Volume primo dalle origini al Concilio di Trento
Coordinamento scientifico Valentino Pace
Repertori iconografici a cura di Roberto Tollo
Biblioteca Egidiana > Convento San Nicola
-------------------------------------------- ------
Realizzazione ediroriale Federico Motta Edimre S.p.A.. Milano
l n copl!rtina Pietro da Rimini e bottega, San Nicola libera d.zi !adroni LormM Bottoni, particolare (secondo-teno decennio del XIV secolo). Tolemino, Cappellone di San Nicola
Sul raro Pieuo da Rimini e bo nega, San Nicola incoronato d.z un angolo per aver superato la prova di lasciare l'Ordin• Agostiniano, pani celare (secondo-reno decennio del XIV secolo). Tolentino, Cappellone di San Nicola
Redazione di Tolmrin.o Orlando Ruffini, Barbara Masuocola, Marisa Allegrini Teodori, Monica Ruffini, In es Allegrini
L• schede in Lingua sono srau tmdotu da Pablo Viola per lo spagnolo da Nicoletta Bernacchio per l'inglese
© 2005 Biblioteca Egidiana, convento di San Nicola, Tolentino Tutti i dirirti riservati Proprietà arristica e letteraria riservata per tutti i Paesi Ogni riprodHz.ione, anche parziale, è vietata
DuogJJ 11 qwurfiJ UJpra JN1t:T4 asor fiuta W'~<JI'!d(l k ttp.mti mo(kbr:a di lqg~:
J-otocople per LdlO personale dd kttor~ possono cssac dfc:ttu~ue nc:i lim.iri dd 1 5% di cia.'òCWl vol~ dietro J>apJnOliO alb SJAE dd oompc:nso previsto dal· l'art. 68, comma 4, della kggl: 22 aprile: 1941 11. 633. Le riproduzioni pet U$10
differmre d:1 qudJo pcrr.on:tk pon.,nnt) avvenire solo a ~ro dj specifia. au· rorìr.1~7jone ribuci:u~ <bD'cdiz..ote..
Prima edizione gennaio 2005
Con il contributo di
MiniStero per i Beni e le Attività Culturali D irezione Generale per i Beni Librari e gli lsri ruti di Cultura
~Banca delle Marche
REGIONE!R41 MARCHE~
Provincia di Macerata
Comune di Tolentino
Santuario Basilica S. Nicola Tolenòno
Con il patrOcini.() di
Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa
@ ~
Ordine di Sant'Agostino
Provincia Agostiniana d'Italia
Comiraro Nazionale per le Celebrazioni del VII Centenario della morte di san Nicola da Tolentino
Sono l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Ringraziamnui A nome degli aumri dei resti si ringrazia quanti hanno collaborato alla loro ricerca: Alessandro Angelini; Alessandro B"'gnoli; Sirnone Baiocco; don Arremio Basrianini; Danide Benati; Tom Bergamo Rossi; Fabio Bisogni; Arthur Blwnenrhal; Mikl6s Boskovits; Maria Grazia Br.mchea:i; Piera Briani; Anmlis:J Brisrol; Marco BrOsch; P. Bullini; Chules Bumett; Matteo Carletti di Gubbio; Giuseppe Cas.ocio; Bruno Cilienro; Melissa Conn; Mìchda Cornetti; dottor= D'Aniello; Stef.mo Davino; Wieslaw Dawidowski; Andn:a De Marchi; Corrado Fratini; Marco Fratini; Mìchal Jagosz; Hc:rbett Kessler, Peter Kidd; Hc:nry S. Kim; don Fabio Leonardis; Alessandro Long<:ga; Valia Giulio Manieri; Tommaso Marani; SteF..nia Mason; Martina Mian; Marina Muro; Giovanna Nepi Scirè; Enrica Neri Lusanna; Valentino Pace; Paolo Pacini; Ma· riella Platania; Guido Rebeccbini.; Adriano Ruggeri; Res<: Marie San Juan; Alessandro Scafi; monsignor Mario Senigaglia; don Andrea Tarticchio; Roberto Tollo; Maria Laura Tomea Ga=li; Fabio Torchio; Francesco Turio Bohm; Luisanna Verdoni; Enrica V Mani; jill Weirueich; Wolf.mg Wolm-s; johanna Zacharia,
La Biblioteca Egidiana desidera ringraziare in particolar modo il dottor Giovanni Filosa, di Banc:1 Marche Spa, per la sensibilità e la plniosa coUabornzione