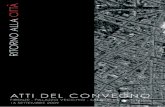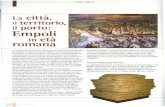città d'europa e cultura urbanistica nel mezzogiorno borbonico
Follonica: una città convertita in destinazione
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Follonica: una città convertita in destinazione
Indice Prefazione V (Francesco Pigliaru) Introduzione VII
(Guido Candela e Stefano Usai) Il progetto di ricerca VII Sardegna, Rimini e Follonica: tre storie e destini differenti IX Una guida alla lettura XIII
Parte prima. Il progetto e i metodi 1 1. Copiare come metodo di politica turistica 3
(Guido Candela e Stefano Usai) 1.1 Introduzione 3 1.2 Un modello semplice per formalizzare le differenze 7 1.3 Le fonti di informazione e l’analisi interdestinazione 10 Appendice 12
2. Turismo sostenibile come contratto fra residenti e turisti 15 (Salvatore Bimonte e Lionello F. Punzo) 2.1 Introduzione 15 2.2 Conflittualità e sostenibilità: un gap concettuale 17 2.3 L’equilibrio come risultato di uno scambio 21
3.Il Choice Modelling nell’analisi del turismo sostenibile 25 (Rinaldo Brau) 3.1 Introduzione 25 3.2 Metodo del Choice Modelling e applicazioni al settore turistico 26 3.3 Guida introduttiva all’analisi basata sugli esperimenti di scelta 30
3.3.1 La definizione del campione 30 3.3.2 La redazione del questionario. 32 3.3.3 Le interviste e la “somministrazione” degli esperimenti di scelta 36
3.4 L’elaborazione econometrica delle risposte 37 3.5 Valutazione delle preferenze e misure monetarie di benessere 40
3.5.1 Misure monetarie di benessere 40 3.6 Osservazioni conclusive 41
Parte seconda. Sardegna: a due km dalla sostenibilità 43 4. Stessa spiaggia, stesso mare: turismo, ambiente e qualità di vita 45
(Bianca Biagi e Manuela Pulina) 4.1 Introduzione 45 4.2 Uno sguardo all’indietro: il turismo e l’ambiente nella politica regionale 47 4.3 Quale prodotto, quanto mercato 51
II Indice
4.4 Alcune considerazioni finali 56 5. Sostenibili e contenti: le aspettative della domanda turistica in Sardegna 59
(Rinaldo Brau e Davide Cao) 5.1 Introduzione 59 5.2 L'indagine e la base di dati 60
5.2.1 Rappresentatività del campione 65 5.3 I principali risultati: l’analisi econometrica 67 5.4 Simulazioni della probabilità di scelta per alcune località tipo 69 5.5 Osservazioni e conclusioni 73
6. Tutela ambientale e sviluppo turistico secondo i residenti ad Alghero 77 (Gianfranco Atzeni e Giovanni Battista Concu) 6.1 Introduzione 77 6.2 Il quadro normativo e la definizione dell’ambito territoriale di indagine 78 6.3 L’indagine Choice Modelling 80 6.4 I risultati 83
6.4.1 I parametri degli attributi delle alternative 83 6.4.2 I parametri delle variabili socio-economiche 84 6.4.3 I prezzi impliciti 84 6.4.4 Effetti di cambiamento degli scenari 85
6.5 Conclusioni 85 7. Sardegna e turismo: il momento delle scelte 89 (Stefano Usai e Marco Vannini) Parte terza. In principio era Rimini. Un giovane turismo maturo 95 8. Il turismo a Rimini: un’identità cittadina concertata 97
(Patrizia Battilani e Maurizio Mussoni) 8.1 Una città per quattro prodotti 97 8.2 La concertazione consapevole e l’assemblaggio del prodotto 100 8.3 I progetti e gli investimenti del presente 104 8.4 Le politiche turistiche del futuro: presentazione della ricerca 109
9. L’immagine di Rimini nelle preferenze dei turisti 111 (Rinaldo Brau, Antonello E. Scorcu e Laura Vici) 9.1 Introduzione 111 9.2 Il turismo a Rimini 113 9.3 La struttura del questionario 114
9.3.1 Le domande rivolte ai turisti 114 9.3.2 La struttura e la somministrazione del questionario 115 9.3.3 La scelta dei regressori e dei termini d’interazione 118
9.4 L’evidenza empirica 119 9.4.1 Le caratteristiche del campione 119 9.4.2 Il modello logit multinomiale attributi ed effetti d’interazione 121 9.4.3 Tassi di sostituzione e prezzi impliciti 122 9.4.4 Un esercizio di politica turistica 128
9.5 Conclusioni 129 10. Le esternalità tra residenti e turisti 131 (Laura Vici, Massimiliano Castellani e Paolo Figini)
Indice III
10.1 Introduzione 131 10.2 L'indagine e le interviste 133 10.3 Le caratteristiche socio-demografiche dei residenti 137 10.4 Risultati econometrici 139
10.4.1 Il modello logit multinomiale 140 10.4.2 Il modello logit multinomiale con le interazioni 143 10.4.3 La stima dei prezzi impliciti 143 10.4.4 Analisi degli scenari alternativi 147
10.5 Conclusioni 150 11. Turisti, residenti e i modi dell’intervento pubblico 151 (Guido Candela e Antonello E. Scorcu)
11.1 Introduzione 151 11.2 Una visione d’insieme 151 11.3 Come confrontare le preferenze dei turisti e dei residenti 153 11.4 Valutazioni di benessere e selezione degli investimenti 155 11.5 Le difficoltà di una visione d’insieme 157
Parte quarta. Follonica: una città convertita in destinazione 159 12. Follonica, il mare in fondo alla strada 161 (Salvatore Bimonte e Lionello F. Punzo)
12.1 Introduzione 161 12.2 Caratteristiche di una ..… “città moderna” 164 12.3 Il turismo a Follonica: alcuni dati 165
13. Turisti e turismo a Follonica 171 (Salvatore Bimonte e Teresa Fratelli)
13.1 Introduzione 171 13.2 La descrizione del campione e della ricerca 172 13.3 Livelli e attributi della vacanza 173 13.4 Le disponibilità a pagare 179 13.5 Conclusioni 182
14. Cittadini di una città moderna 185 (Salvatore Bimonte e Teresa Fratelli)
14.1 Introduzione 185 14.2 Caratteristiche del campione e della ricerca 187 14.3 La percezione del turismo 188 14.4 Gli scenari di riferimento 192 14.5 I risultati dell’analisi 194 14.6 Conclusioni 198
15. Un patto sociale implicito? 201 (Salvatore Bimonte e Lionello F. Punzo)
16. Conclusioni 209 (Lionello F. Punzo e Marco Vannini)
Bibliografia 217
12 Follonica,
il mare in fondo alla strada Salvatore Bimonte e Lionello F. Punzo
12.1 Introduzione∗
Follonica è un caso tipico di città diventata destinazione turistica balneare ed allo stes-so tempo un laboratorio reale per testare un approccio ed una nuova metodologia. La scelta di Follonica come territorio di analisi, tra tutte le destinazioni marine della To-scana (e della Toscana meridionale), ha vari motivi, oltre a quello di dare un’occhiata a quella Toscana in qualche modo ritenuta minore, forse solo perché non presente sui grandi media. Il primo, anche se probabilmente inconscio (per un gruppo di ricerca ba-sato all’Università di Siena), è che Follonica ha rappresentato storicamente il mare di Siena, almeno per i senesi, e nessuno si è mai peritato di scriverne la storia marina (a differenza delle altre località, in questo libro, ma anche altrove raccontate).
Follonica è alla fine di una strada che connette Siena con il mare, passando per il possedimento storicamente più importante della Repubblica senese, la città di Massa Marittima, gioiello di arte medioevale. A quest’arte hanno largamente contribuito i se-nesi che la consideravano la loro città-fortezza più avanzata in Maremma. Quando la futura capitale della provincia omonima, Grosseto, era ancora poco più di un accam-pamento di costruzioni lignee, con l’ulteriore grave difetto di essere al centro di una pianura paludosa ed insalubre (e di essere stata fondata come avamposto longobardo), Massa era già una fiorente città adagiata su di una collina al centro di una fertile valle ed al limitare di miniere antiche quanto la civiltà degli Etruschi che avevano comincia-to a sfruttarle.
Molte centinaia di anni dopo, in fondo migliaia, Follonica è diventata la spiaggia dei senesi e di altri toscani dell’entroterra, come Ostia era dei romani, Milano Maritti-na dei Milanesi e Viareggio dei lucchesi, prima che del turismo jet set. Questo l’ha di-stinta anche da alcune località limitrofe, quali Castiglione della Pescaia e Punta Ala, ora più fiorentine, Monte Argentario, con le sue Porto Santo Stefano e Porto Ercole, e le varie Ansedonia, Feniglia etc. ormai spiagge di certi romani. Il resto della costa a ∗La ricerca presentata in questa parte è stata realizzata anche grazie al co-finanziamento del PAR Progetti 2004 dell'Universita' di Siena.
162 Parte Quarta
sud la conosciamo come associata ai nomi della cultura, della politica e del giornalismo italiano, tutti gravitanti se non anche residenti nella capitale.
Queste associazioni confermano la tesi secondo la quale una certa tipologia medi-terranea (o europea?) di turismo balneare si associa a destinazioni dependence di loro capitali culturali anche prima che economiche. A molti di questi luoghi la definizione di destinazione sta ormai stretta, dal momento che nei lunghi anni della dipendenza si so-no evoluti spesso in città, ed ora chiedono un ruolo ed un riconoscimento di città. È si-curamente il caso di Follonica, forse non di tutte le altre sopraccitate nell’area.
Analizzare il turismo di Follonica è, quindi, anche studiare il turismo di certe co-munità, tra queste quella dei senesi, e completare così un quadro della situazione che l’Osservatorio per il Turismo Sostenibile sta costruendo e monitorando negli ultimi an-ni. Condurre un’indagine su Follonica voleva dire, quindi, intervistare al mare i senesi che avevamo intervistato a casa: ovviamente non le stesse persone, ma sicuramente la stessa comunità. D’altra parte, permetteva di indagare cosa pensa, in senso lato, la co-munità ospitante di un turismo che, per molti versi, è fatto di ospiti semipermanenti più che di avventori estemporanei, con tutto quello che di buono e di cattivo ne può deriva-re.
Il secondo motivo per occuparsi di Follonica sta nei suoi vari aspetti di atipicità. Follonica può essere vista come un anello in una catena di destinazioni balneari che formano l’offerta balneare del sud della Toscana, ma è un anello diverso. Come le altre sta dove la Maremma entra nel mare, e intercetta la sua fetta di quel turismo balneare che tuttora costituisce circa il 70% del turismo totale della provincia di Grosseto. Que-sto accade nonostante gli sforzi costosi degli ultimi anni per differenziare qualitativa-mente l’offerta e conseguire, congiuntamente, una migliore distribuzione nel tempo (con l’allungamento della stagione) e nello spazio (penetrazione turistica verso l’interno, mobilitazione di risorse diverse da quella marine, valorizzazione delle 13 a-ree protette provinciali, del paesaggio unico, del patrimonio culturale ed enogastrono-mico). Di questa specializzazione forse, come vedremo nelle conclusioni, Follonica rappresenta un esempio molto particolare.
Follonica, d’altra parte, non ha il glamour di Monte Argentario, né gli ospiti di
questa; non ha le tradizioni marinare e la ancora viva attività di pesca di Porto Santo Stefano; non ha la storia né la riservatezza degli ospiti vips di Porto Ercole. Follonica è una città quieta e tranquilla, mai sui giornali, con ospiti che nessuno considera illustri o sufficientemente interessanti da scattargli foto di nascosto, che alla fine della stagione balneare torna come prima, anche se questo prima non è più uguale a quello di qualche tempo fa, precedente la crisi industriale degli anni 60.
A differenza di altre località balneari, infatti, Follonica esisteva prima del turismo, indipendentemente dal turismo. Era una città industriale, anzi una delle città industriali che dovevano assicurare lo sviluppo della Toscana. Essa è nata intorno alle lavorazioni del ferro proveniente dalle vicine miniere, e diviene una città quando nel 1836 il Gran-duca decide di accorpare la direzione di tutte le imprese nel ramo del granducato e di localizzarla appunto in questa città. Follonica nasce come la Milano del Granducato. Questa storia industriale, che ha lasciato segni importanti nell’architettura urbana, ter-
Follonica, il mare in fondo alla strada 163
mina improvvisamente nel 1963, quando queste produzioni vengono riconosciute defi-nitivamente operazioni non più economicamente valide.
La vicenda turistica di Follonica data idealmente da questa crisi e ne è largamente il frutto. A differenza di altre località, qui il turismo è nato dalla necessità di ritrovare un’attività economica trainante, dalla necessità cioè di riconversione di un’area indu-striale in crisi, la prima di tante. A Follonica, comunque, alla bellezza naturale dei luo-ghi poco occorreva aggiungere in termini di investimenti e, quindi, di capitale, per farli fruttare in un prodotto turistico molto semplice quale quello marino-balneare. La con-versione fu un’operazione spontanea dell’economia locale, con pochi aiuti pubblici e poca direzione. Contribuirono due fattori accidentalmente coincidenti: il boom dell’Italia della seconda metà degli anni 60, che mise le famiglie sulle quattro ruote e le mandò in vacanza; la vicinanza geografica e, via Massa Marittima, culturale di una cit-tà, Siena e, dietro Siena, del territorio toscano che per andare al mare passa per questa città. Rimini è al di là dell’Appenino, ha un altro bacino con gli stessi clienti.108
Proprio per questo, rispetto a tutte le località nominate, Follonica non si sente spe-
cializzata nel turismo, nonostante sia difficile dire che non lo sia. Per essere sicura di non essere confusa con una monocultura balneare ci tiene ad autodefinirsi una “città moderna”, non una spiaggia (nonostante la spiaggia sia un elemento di arredamento ur-bano imperdibile, da qualsiasi lato la si guardi). Si è convertita al turismo, ma a part time, e tiene a conservare il suo passato vivo. Per questo investe nella creazione di un campus universitario, nella certificazione ambientale delle strutture pubbliche (è certi-ficata ISO 14001 in attesa di registrazione EMAS)109, nei servizi ai cittadini (che si dichiarano generalmente contenti di viverci, almeno dal punto di vista dei servizi di cui usufruiscono), nella coltivazione della cultura locale.
Del turismo occupa una nicchia “di massa”, associata, a differenza di quanto acca-de ad altre destinazioni dello stesso tipo (per esempio in questo libro, l’icona Rimini), ad una clientela stabile, fatta di aficionados a vario titolo. Questi non rendono né molto ma nemmeno tanto poco, ma rappresentano una presenza che non risente delle mode e che, quindi, senza grandi sforzi (quelli sono ormai stati compiuti per l’occupazione del suolo necessario a costruire le case) garantiscono un reddito non elevato ma duraturo. Forse per questo a Follonica, pur essendo ormai l’attività economica principale, il turi-smo è ancora visto come “un’attività come un’altra”, che non richiede grande specia-lizzazione né grandi investimenti, di tempo o di denaro. Gli altri coltivano turismi di alta gamma, turisti ricchi, eventi prestigiosi che li attirano, fanno largo alle grandi pro-prietà immobiliari. Follonica costruisce condomini, e adesso si pone il problema di co-me ottimizzarne l’utilizzo.
108 Sarebbe infatti interessante ricostruire le separatrici dei due bacini. 109 Insieme ai comuni limitrofi di Scarlino e di Grosseto.
164 Parte Quarta
12.2 Caratteristiche di una ..… “città moderna”
Nonostante la sua storia, Follonica è ora una nota località balneare, una delle varie che, come abbiamo visto, si allineano lungo la costa Sud della regione, all’interno di un’area denominata Maremma. La città, come insiste a farsi considerare, è situata a nord di Grosseto al centro del golfo omonimo fra Piombino e Punta Ala (Figura 12.1), al limite con la provincia di Livorno, di fatto tra Maremma Sud e Maremma Nord. La sua popolazione, circa 21.500 abitanti, relativamente stabile a partire dalla fine degli anni 60, è composta per un 53% da femmine e un 47% da maschi. Gli over 65 contano per il 25% (ben al di sopra della percentuale nazionale del 19.5%), mentre il 10,7% sono ragazzi in età scolare (0-14). In entrambi i casi i dati sono in perfetta sintonia con quelli provinciali, mentre si differenziano leggermente dal dato regionale, dove le per-centuali sono rispettivamente il 23% ed il 12%. D’altronde, le caratteristiche orografi-che, il clima etc, tutte contribuiscono a favorire una percentuale elevata di anziani, ca-ratteristica che si riscontra in molte se non tutte le località analoghe.
Figura 12.1 Collocazione geografica di Follonica
Gli anziani di Follonica sono comunque residenti, e solo in parte sembrano essere
turisti semi-residenziali, proprietari di seconde case. Follonica d’inverno si svuota e, quindi, perde totalmente quell’aspetto di città turistica che conservano quelle località della Costa Azzurra o della Costiera Ligure dove una parte degli anziani-turisti sverna, giustificando così la continua apertura di alcuni servizi altrimenti solamente estivi. D’inverno Follonica ritorna ai follonichesi, accettando la contraddizione di essere una città piccola tutto l’anno che diventa una spiaggia durante l’estate.
Che i turisti non vi svernino è legato alle caratteristiche stesse del turismo di Follo-nica, destinazione balneare di seconde case di proprietari assenteisti ma vicini. D’altra parte, la domanda aggiuntiva praticata da turisti acquirenti “ricchi”, facendo per esem-
Follonica, il mare in fondo alla strada 165
pio lievitare i valori immobiliari, peggiora la crisi nella formazione di nuove famiglie e diminuisce i tassi di natalità.
Come detto, la città si caratterizza per essere una destinazione del cosiddetto turi-smo di massa, essenzialmente legato al mare. Quest’ultimo, quindi, rappresenta una delle sue principali risorse economiche e, quindi, anche dalla sua tutela dipende il futu-ro della città. Tale consapevolezza genera adeguati sforzi e spiega perché, per esempio, da otto anni consecutivi le viene conferita dalla FEE (Foundation for Environment Education) la bandiera blu, un riconoscimento, come è noto, attribuito alle destinazioni balneari sulla base di alcuni indicatori che rilevano il mare pulito, la qualità dei servizi e della vita. Per il suo ottenimento occorre un attivo coinvolgimento delle amministra-zioni locali, cosa che nel caso viene confermata.
Comunque, Follonica ha un cuore non turistico: il 22% delle imprese, infatti, viene classificato come industriale, le imprese di servizi, verosimilmente comprendenti tutte le imprese turistiche, sono il 35,6% del totale, mentre un robusto 37% è fatto di altre tipologie imprese, verosimilmente agricole, di trasformazione e di costruzioni. Corri-spondentemente, l’occupazione totale, poco più del 36 per cento della popolazione, si distribuisce tra industria (22%) e servizi (22,7%, dato che conferma la nota tendenza a non creare occupazione). Il resto trova occupazione in tipologie di impresa (32,2%) e negli uffici amministrativi (23%).
Follonica, quindi, conferma la sua dualità, le sue due “immagini produttive” diver-se, e questo contribuisce a spiegare la sua resistenza ad essere associata alla monocul-tura stagionale nella quale a cadenze fisse si trasforma. La resistenza, come accennato in precedenza, ha radici in una storia antica che solo recentemente ha avuto una crisi catastrofica:
12.3 Il turismo a Follonica: alcuni dati
Per effetto del turismo, che è praticamente solo o quasi balneare, Follonica vede au-mentare nel periodo estivo a dismisura la sua popolazione. Negli ultimi anni, In media gli arrivi ufficiali si sono attestati intorno alle 80.000 unità, con circa 500.000 presenze (una presenza media di poco più di sei giorni, la classica settimana al mare, una media tra i gruppi familiari e i capifamiglia). I turisti sono in prevalenza italiani: oltre il 60% delle presenze ed il 70% degli arrivi.
Anche per le ragioni storiche appena richiamate, si tratta prevalentemente di turi-smo di prossimità, caratteristica chiave questa che ci spiega vari tratti del fenomeno turistico locale. All’interno della componente nazionale, infatti, i Toscani rappresenta-no il 46% degli arrivi, seguiti dai Lombardi che rappresentano il 14% (Figura 12.2). In termini di presenza, i primi contano per circa il 30% delle presenze alberghiere e per ben oltre il 50% di quelle extralberghiere; i secondi, invece, rappresentano circa il 17%% delle presenze alberghiere ed il 13% di quelle extralberghiere.
166 Parte Quarta
Figura 12.2 Provenienza per regione dei turisti italiani (Fonte servizio statistica provin-cia di Grosseto)
Figura 12.3 Provenienza per paese dei turisti stranieri (Fonte servizio statistica provin-cia di Grosseto)
Quest’ultimo dato probabilmente riflette un legame che affonda le radici nella sto-
ria industriale di Follonica e dei dintorni (Piombino), legata, come si diceva, al ferro ed alle sue lavorazioni. Dall’altra parte, tra gli stranieri forte è la componente di lingua tedesca (dalla Svizzera e Germania), che rappresenta circa l’80% degli arrivi (Figura 12.3), il 45% delle presenze alberghiere ed oltre il 90% di quelle extralberghiere. L’affinità che la componente svizzera ha con il territorio è testimoniata anche dal fatto
7%
2%
2%
4%
5%
5%
6%
8%
14%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Altro
Umbria
Liguria
Veneto
Campania
Piemonte
Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Toscana
11%
2%
2%
2%
3%
18%
62%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Altri
Olanda
Slovenia
Francia
Austria
Germania
Svizzera
Follonica, il mare in fondo alla strada 167
che all’interno del comune di Follonica esiste una RTA convenzionata direttamente con la Svizzera.
Il turismo di lingua tedesca è comunque tipico della Toscana sia delle città d’arte
che del mare, in particolare nel sud della regione. Nonostante per esempio i pessimi siti internet e la relativamente scarsa comunicazione turistica (almeno comparando alle campagne svolte dalla località vicine), Follonica riesce ad intercettare una parte di un flusso che in qualsiasi caso si dirige verso questa zona della regione, spinto fondamen-talmente dalla possibilità di coniugare turismo di mare con turismo culturale delle vici-nanze.
Anche senza contare il fenomeno importante della ospitalità informale (di cui di-remo tra poco), i dati ufficiali evidenziano come oltre il 70% delle presenze si concen-tri in strutture extralberghiere, appartamenti, residence, e questo risulta essere ancor più vero per i turisti stranieri (intorno all’85%). La stessa struttura del sistema ricetti-vo, d’altra parte, ricalca questa caratteristica. L’offerta ricettiva della città si concentra prevalentemente (e questo è ancor più vero in termini di posti letto) nell’extralberghiero, in particolare alloggi in affitto, campeggi e villaggi turistici.. Ne-gli alberghi prevalgono quelli di fascia medio-bassa, a tre e a due stelle (non vi sono alberghi di categoria superiore alle tre stelle), con fasce di prezzo tra i 75 e i 130 eu-ro.110 I listini pubblicati in internet non prevede alta e bassa stagione, il che conferma l’osservazione che la maggior parte degli esercizi chiude quando termina la stagione balneare.
Questo insieme di dati ed osservazioni comincia a tracciare un profilo del turista di
massa a Follonica, che è confermato anche da un’indagine di qualche tempo fa condot-ta dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Centro Studi Turistici di Firenze, da cui emergeva che i turisti sono fondamentalmente “stanziali” (una settima-na di permanenza media è un valore alto se comparato con i valori di alcune località vicine, e con la media regionale, intorno ai 4 giorni). Per questo, tali turisti ricorrono a tipologie ricettive diverse da quella alberghiera, quindi essenzialmente a seconde case, di proprietà oppure prese in affitto. Follonica è dotata di un patrimonio ricettivo a po-tenziale turistico composto da circa 8000 appartamenti, per un totale di 18000 posti let-to. Questo implica che una rilevante quota di flussi turistici non viene rilevata ufficial-mente: parliamo di circa 1.700.000 presenze, cioè un rapporto di 1 presenza ufficiale per ogni 3,4 informali, ben al di sopra del rapporto stimato per l’intera Toscana.111
Infine, il turismo rappresenta sì un’importante fonte di reddito per l’economia della città. Allo stesso tempo, però, date le caratteristiche delle attività che mette in moto, sappiamo che da una parte tende a generare posizioni di rendita, dall’altra contribuisce molto marginalmente a creare occasioni di lavoro stabile. Questo duplice effetto, che è più accentuato con certi tipi di turismo, si associa al profilo temporale dei flussi turisti-ci di Follonica, vincolati alla sua specializzazione nell’offerta in un unico prodotto ad altissima concentrazione temporale. 110 Fonte: sito della proloco. 111 Intorno a 2,8 (stime IRPET).
168 Parte Quarta
Figura 12.4 Distribuzione mensile degli arrivi (Fonte servizio statistica provincia di Grosseto)
La Figura 12.4, naturalmente, mostra che i flussi turistici sono altamente concen-
trati nel periodo estivo, con un classico picco nel mese di Agosto, il che indirettamente ci conferma che i turisti sono in maniera predominante italiani. Più uniformemente di-stribuiti risultano gli arrivi degli stranieri, la cui stagione comincia nel mese di Aprile e si prolunga fino ad Ottobre, con una contrazione relativa di tipo anticiclico proprio nel mese di Agosto. In altre parole, possiamo dire che i flussi stranieri sono tendenzialmen-te più stabili nel tempo e tendono a funzionare, almeno parzialmente, come stabilizza-tori dei flussi complessivi. Questo riflette probabilmente anche una strategia di so-pravvivenza dei turisti stranieri per rifuggire l’affollamento che viceversa sembra at-trarre gli italiani. Se confermato (ma non è stato oggetto specifico della nostra analisi), questo evidenzierebbe, a sua volta, come il picco di un iceberg, un diverso sistema di preferenze dei turisti stranieri su temi come quello dell’affollamento, e suggerirebbe che anche il popolo dei turisti dovrebbe essere considerato come frammentato in varie comunità di interessi. Questo aspetto, che costituirà il tema di un prossimo studio,112 riporta alla luce il problema, prima evidenziato, della possibile non esistenza di una curva dei contratti che, in questo caso, varrebbe per questa tipologia di visitatori. In risposta, questi ultimi, quindi, si ritagliano una loro Follonica, parzialmente diversa dalla Follonica dell’indagine da noi condotta.
Questo ci rimanda al tema fondamentale del turismo quando viene visto nell’ottica
delle problematiche di sostenibilità: considerare l’articolazione delle due popolazioni, hosts e guests, in comunità per comprenderne le relazioni, di compatibili-tà/concorrenzialità e, quindi, le varie strategie che ciascuna gioca per ottimizzare i pro-pri risultati. In questo caso, di fronte alla scelta “non andare a Follonica” oppure “an-darvi fuori della stagione degli italiani”, i turisti stranieri sembrano optare per la se- 112 Anche perché la maggior parte gli intervistati sono italiani, come ci si poteva aspettare dai dati sugli arrivi e presenze turistiche nel periodo estivo.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
gen-0
2
mar-02
mag-02
lug-02
set-0
2no
v-02
gen-0
3
mar-03
mag-03
lug-03
set-0
3no
v-03
gen-0
4
mar-04
mag-04
lug-04
set-0
4no
v-04
ItalianiStranieri
Follonica, il mare in fondo alla strada 169
conda. Sono per la maggior parte di lingua tedesca e da ogni inchiesta condotta risulta-no essere sensibili ai temi dell’ambiente, mediamente più degli italiani; domandano na-tura e cultura più integralmente di quanto facciamo noi e prodotti a maggior contenuto esperenziale, quindi non amano l’affollamento (almeno quelli che scendono nel Medi-terraneo Orientale, che son anche giovani e giovani famiglie “avventurose”).113 Anche questo potrebbe essere un tipo di strategia per la sostenibilità, giocato da una comunità che frequenta il territorio sbagliato, perché probabilmente semplicemente tracima da altri territori circostanti per motivi anche economici. Follonica vende a basso prezzo un prodotto altamente competitivo. I vicini si posizionano su altri mercati, quelli di fascia medio-alta, dove il prodotto turistico è più bene di lusso che bisogno sociale.
Questi sono turisti che, finché possono si ritagliano uno spazio geografi-
co/temporale, infilandosi negli spazi non invasi dai turisti di cui parliamo nel prossimo capitolo. Sono sufficientemente pochi per non essere notati, ma agiscono all’occhio at-tento come marcatori biologici. Le due comunità non sarebbero in grado di sopravvive-re insieme, contemporaneamente sulla stessa spiaggia.114
113 A differenza dei pensionati che, viceversa, svernano nelle enclaves turistiche spagnole, dove riproducono la loro Germania al sole e, quindi, si attendono la densità di relazioni tipica delle città dalla quali periodicamente e temporaneamente migrano. 114 Il che ci rimanda ad un’analisi della composizione dei flussi turistici, analoga a quella precedentemente svolta con l’ipotesi della loro omogeneità.