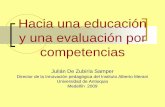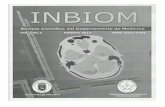Una città e una famiglia di imprenditori cartari: Varese e i Molina. L'accumulazione originaria nel...
Transcript of Una città e una famiglia di imprenditori cartari: Varese e i Molina. L'accumulazione originaria nel...
ATTI DEL CONVEGNO
CINQUE SECOLI DI CARTA
Produzione, commercio e consumi della carta nella “Regio Insubrica” e in Lombardia dal Medioevo all’età
contemporanea
a cura di Renzo P. Corritore e Luisa Piccinno
Varese, 21 aprile 2005
promosso da
organizzato da
in collaborazione conUniversità degli Studi dell’Insubria, Facoltà di Economia
International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities
Istituto varesino “Luigi Ambrosoli” per la storia dell’Italia contemporanea e del movimento di liberazione
con il patrocinio di
Comitato scientifico Carlo M. BelfantiUniversità degli Studi di Brescia Aldo CareraUniversità Cattolica del Sacro Cuore di MilanoRenzo P. CorritoreUniversità degli Studi di PaviaPatrizia MainoniUniversità degli Studi di MilanoLuisa PiccinnoUniversità degli Studi dell’Insubria
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e in particolare: Giuseppe ArmocidaArchivio di Stato di VareseArchivio di Stato di MilanoArchivio Storico del Comune di VareseCasa di riposo MolinaAlessandro Stagni
Sponsor
La realizzazione dell’opera è stata possibile per l’interessamento e la disponibilità del Dott. Giorgio Salvadè.
La riproduzione e la duplicazione con qualsiasi mezzo di illustrazioni pubblicate in quest’opera sono vietate.
Progetto graficoFRANCO ORSI BY ADVANCED AGENCY - VARESE
Realizzazione e stampa
© INSUBRIA UNIVERSITY PRESS
Marketing e Distributore esclusivo per l’Italia e l’estero
UNIVERSITÀ IN CASA
43010 ZIBELLO (PARMA)www.universitaincasa.it
I
INDICE
INTRODUZIONE pag. 1
IMPIEGO E CONSERVAZIONE DELLA CARTA. PRIMI SPUNTI DI RICERCA SUL TERRITORIO DELL’ANTICA DIOCESI DI COMO (SECOLI XIII-XV) 9Marta Luigina Mangini
PROFILI BIOGRAFICO-PATRIMONIALI DI ALCUNI MERCANTI DI CARTA MILANESI (SECONDA METÀ XV - INIZI XVI SECOLO) 25Maria Paola Zanoboni
“MAGISTRI A PAPIRO” E “FERRASTRAZZI”: PROFESSIONI DELLA CARTA A MILANO TRA XV E XVII SECOLO 49Beatrice Del Bo
LA MANIFATTURA DELLA CARTA NEL COMASCO, TRA NESSO E MASLIANICO (XV-XX SECOLO) 75Fabio Cani
CARTA E SOCIETA’ A BESOZZO IN ETA’ MODERNA 101Emanuele Colombo
LA LAVORAZIONE DELLA CARTA NELLA MAGNIFICA PATRIA DAL SUCCESSO AL DECLINO (1650-1850) 121Luca Mocarelli
UNA CITTA’ E UNA FAMIGLIA DI IMPRENDITORI CARTARI: VARESE E I MOLINA. L’ACCUMULAZIONE ORIGINARIA NEL SETTORE SERICO, LA CONVERSIONE ALL’ATTIVITA’ CARTARIA 133Renzo P. Corritore
ALLE SOGLIE DI UNA RICERCA: IL CILINDRO OLANDESE FRA CARTIERE PONTIFICIE, “VENETE”, PIEMONTESI E LOMBARDE (SECONDO ’700 –PRIMO ’800) 171Ivo Mattozzi
ABBREVIAZIONI E BIBLIOGRAFIA 197
132
Cartiera Molina 1845 1845: la cartiera Molina diventa Imperial Regia Fabbrica nazionale privilegiata. L’impianto a questa data occupa 95 persone ed è dotato di macchinari per un valore di 240.000 lire pari a oltre il 50 per cento del capitale complessivo investito nell’attività. Il biglietto rappresentato, come si arguisce dall’intestazione e dalle medaglie riprodotte, è però successivo all’unità d’Italia(ASMi, Commercio, p.m., cart. 387, fasc. 12).
133
Renzo P. Corritore
UNA CITTA’ E UNA FAMIGLIA DI IMPRENDITORI CARTARI: VARESE E I MOLINA.
L’ACCUMULAZIONE ORIGINARIA NEL SETTORE SERICO, LA CONVERSIONE ALL’ATTIVITA’ CARTARIA
L’avvento della carta come mezzo di trasmissione della scrittura, la nascita e lo sviluppo dell’industria cartaria, il lievitare dei consumi di carta, da quelli più nobili a quelli più umili, sono indicatori di sviluppo civile, economico e sociale nella storia della società europea, dal Medioevo all’età contemporanea. La diffusione delle cartiere nelle varie regioni europee, il passaggio da un’area all’altra del primato tecnologico e organizzativo nel settore seguono abbastanza fedelmente la gerarchia dei valori economici in Europa fra Medioevo e Ottocento. Dalla supremazia di Fabriano, e poi delle manifatture cartarie italiane fra il XIII e il XVI secolo, si passa all’ascesa dell’Europa del Nord, con il passaggio delle consegne all’Olanda durante il suo secolo d’oro, al Regno Unito della rivoluzione industriale.1
All’equazione tra sviluppo dell’industria della carta e progredire del processo di “civilizzazione” e modernizzazione non sfuggono neanche il Varesotto e la città di Varese.2
Le prime testimonianze certe sull’impianto di cartiere nel Varesotto si debbono agli status animarum di Besozzo del 1574 e del 1582.3 Il decentramento della produzione cartaria dalla metropoli ambrosiana e dal suo hinterland fino alle rive del Bardello, il fiume che mette in comunicazione il lago di Varese con il Lago Maggiore, e più in generale fino all’asse del Verbano-Ticino, è l’espressione, all’interno del ducato di Milano, dell’ascesa delle aree periferiche e della conquista, da parte di queste, di un ruolo nuovo sotto il profilo politico, economico-sociale, culturale. Nell’arco di qualche decennio l’area diventa una delle zone chiave dell’approvvigionamento di carta di Milano, insieme al
1 Per ripercorrere l’affascinante storia della carta, dalla sua invenzione in Cina nel II secolo a.C., sino all’epoca odierna, si possono indicare, a indispensabile compendio: BASANOFF 1965; BIASI 1999; e inoltre Produzione e commercio della carta 1992 (per un esame polifonico del periodo che si estende dall’introduzione della manifattura artigianale della carta in Europa nel secolo XI sino alle soglie della sua fabbricazione integralmente meccanizzata a cavaliere fra Sette e Ottocento).2 Una preliminare ricostruzione dell’evoluzione dell’industria della carta nel Varesotto, dalle prime testimonianze all’unità d’Italia, in CANI 2001a.3 Cfr. BEONIO-BROCCHIERI 2000: 88; CANI 2001a: 133; e, in questo stesso volume, COLOMBO 2005.
134
Comasco4 e alla Riviera di Salò,5 e Besozzo uno dei principali poli cartari della Lombardia. In quest’ultimo centro l’attività cartaria permarrà pressoché ininterrottamente dal secolo XVI a oggi, con un’“età dell’oro” manifatturiera fra la metà del ’700 e la metà dell’800 che farà da volano nel periodo successivo all’impianto di moderni stabilimenti industriali in campo tessile, e con una rinascita del comparto, all’inizio del ’900, in una sola grande impresa, secondo i dettami della seconda rivoluzione industriale.
L’avvio della produzione della carta nella città di Varese risale agli albori dell’età contemporanea – la data di partenza è da collocare intorno all’anno 1800 --, ma il dinamismo che riesce a mettere in campo la famiglia Molina è in grado di bruciare le tappe rapidamente sia sul piano del rinnovamento tecnologico, sia su quello dell’affermazione di Varese come moderno distretto cartario nei decenni centrali dell’Ottocento. Nell’arco di tre decenni i Molina riescono a far compiere un salto tecnologico senza precedenti all’intero settore secondario dell’economia varesina. La messa in opera nel 1828 a Biumo Inferiore della prima macchina per la produzione continua di carta da parte di Paolo Andrea Molina è una delle pietre miliari dell’affermazione del macchinismo in Lombardia. Fino all’ultima parte dell’Ottocento l’industria della carta rappresenta il settore più dinamico dell’economia varesina. L’Ottocento è, per Varese, il secolo dei Molina. Le vicende della famiglia Molina s’intrecciano strettamente con la storia della città nel momento in cui questa assume un ruolo nuovo in ambito lombardo e nazionale. Ma riprendere la loro parabola non significa solo ripercorrere la storia dell’industrializzazione varesina sino alla vigilia della prima guerra mondiale: grazie alla loro storia imprenditoriale è possibile scoprire l’originalità e la precocità della vocazione manifatturiera di Varese e della sua gente.
In questo lavoro è quindi al centro l’accumulazione originaria di questa dinastia di imprenditori cartari, così indissolubilmente legata alla specializzazione serica della città nel Sei e nel Settecento.
LE ORIGINI DELLA CARTIERA MOLINA:L’ACCUMULAZIONE ORIGINARIA NEL SETTORE SERICO
A quando risale la prima manifattura della carta dei Molina, nel territorio del Comune di Varese? La data è controversa. La storiografia locale tenderebbe a farla risalire all’ultimo decennio del ’700, se non
4 Cfr. CANI 2005b (in questo stesso volume); e inoltre STEVENS, GEHL 1994.5 Cfr. MATTOZZI 1995; MATTOZZI 2001a; e inoltre ancora STEVENS, GEHL 1994.
135
prima.6 Del resto, a non render chiare le cose sono le stesse dichiarazioni dei proprietari imprenditori. Essi dichiarano di aver iniziato l’attività ora intorno al 1791.7 Ora nel 1800.8 Ora nel 1801.9 Ora nel 1804.10
Di certo, alla fine del 1790, l’intendente provinciale Giacomo de Battisti non ravvisa nel territorio del capoluogo – in tema di “affari di commercio” -- altri impianti idraulici che due filatoi per la seta,11 né alcun fatto nuovo è segnalato otto anni dopo in un’analoga relazione economica inviata a Milano dalla municipalità.12 Ancora all’inizio del 1798 non esiste nel territorio di Varese alcuna cartiera. Ma nel 1804 Melchiorre Gioia testimonia – “Una delle cartiere di Valcuvia, le due di Varese hanno il mulino così detto d’Olanda, e formano carte che in finezza pareggiano quella di Bergamo” -- l’attivazione di cilindri olandesi nelle – a questo punto nuovissime -- due imprese cartarie di Varese.13
6 “Le origini delle Cartiere di Valle Olona risalgono al 1793 per merito dei Fratelli Carlo, Antonio, Vittore e Dott. Luigi Molina” (Industria della carta 1929: 18). “Nel corso del Settecento sappiamo che il mulino ivi ubicato, di proprietà Molina, era utilizzato anche come ‘folla’ di carta, ma è solo con la fine del secolo che l’attività deve aver raggiunto una certa rilevanza” (Fabbrica ritrovata 1989: 153).7 ASCo, Prefettura, cart. 916, “Fabbricatori di carta del Dipartimento del Lario”, 25 febbraio 1811 (“Epoca del negozio: da 20 anni circa”).8 ASCo, Prefettura, cart. 916, “Fabbricatori di carta del Dipartimento del Lario. Distretto di Varese”, 1811 (“Epoca del negozio: anno 1800”).9 ASCVa, cat. XI, cart. 36, “Prospetto delle principali manifatture esistenti nel Distretto di Varese”, 22 maggio 1819 (“Epoca in cui ebbe principio la manifattura: nell’anno 1801”).10 In un documento autografo del 17 gennaio 1818 Paolo Andrea Molina, a proposito di una richiesta di esonero di una tassa di L. 60, ricorda che “solamente da 14 anni circa da molino da macina il locale fu trasformato in fabbrica di carta”, con la riduzione dei rodigini da tre a due (Fabbrica ritrovata 1989: 153).11 ASMi, Commercio, p.a., cart. 12, “Protocolli della Visita generale in affari di commercio fatta dal Regio Intendente politico di Varese Giacomo de Battisti” (1790-1791), Distretto IX [di Varese], Varese, 21 dicembre 1790. Cfr. GIAMPAOLO 1975: 186-188.12 ASMi, Commercio, p.a., cart. 14, relazione di Domenico Adamoli da Varese (gennaio o febbraio 1798). Cfr. GIAMPAOLO 1975: 188n.13 GIOIA 1804: 115. E’ probabile però che, anziché due imprese cartarie modernamente dotate, a Varese ve ne fosse una sola, la ditta dei Fratelli Molina, forse dotata di due cilindri olandesi. Non vi è infatti documento statistico o relazione che attesti l’esistenza di un’altra impresa cartaria a Varese per tutta l’età contemporanea. Le più antiche attestazioni della cartiera sono nelle risposte all’Inchiesta del 1807 da parte del pro Podestà di Varese Carlo Antonio Molina, fratellastro dei proprietari (ASMi, Studi, p.m., cart. 1160, Varese, 14 ottobre 1807), e nei risultati dell’Inchiesta del 1808 (ASCVa, cat. XI, cart. 36, “Elenco delle principali fabbriche esistenti nel comune di Varese”, Varese, 14 ottobre 1808, firmato Carlo Antonio Molina; ASMi, Commercio, p.m., cart. 8, “Dipartimento del Lario. Elenco delle principali fabbriche esistenti nel detto Dipartimento…”, Como, 23 novembre 1808). In quest’ultimo caso si registra l’esistenza di due imprese di proprietà di Antonio Vittore e Luigi Molina: una cartiera specializzata nella produzione di “carta da scrivere ad uso di Bergamo e d’imballaggio”, con 7 operai, cui si aggiungono “varj ragazzi da sei alli sette anni e diverse donne occupate nella scelta e nel taglio de’ stracci”; e un “maglio, ossia fonderia di rame”, specializzata nella produzione di “recipienti d’ogni qualità”, con soltanto 2 operai.
136
Si tratta di contraddizioni figlie di una una vera e propria strategia omissiva attuata dai proprietari, che può essere perseguita con successo per la connivenza delle autorità municipali, più che di una rimozione. La dichiarazione su di un fatto indiscutibile -- la generale ristrutturazione dell’impianto nel 1804 con la riduzione dei rodigini da tre a due -- la possediamo perché Paolo Andrea Junior vuole farsi riconoscere una ridotta capienza fiscale per il periodo anteriore.14 Ma l’attivazione della folla – a prescindere dalla data -- non avviene a danno di un mulino -- come dichiara l’imprenditore --, bensì di un filatoio serico! Le fonti settecentesche rivelano l’evoluzione nella destinazione d’uso negli anni centrali del ’700.
Un salto cronologico all’indietro è a questo punto opportuno. Nel 1722 è testimoniato l’affitto intermediario pagato da Antonio (Lodovico) Molina a Carlo Antonio Rogora per l’uso di un mulino da cereali e un maglio per la lavorazione del rame nella castellanza varesina di Biumo Inferiore, in prossimità del fiume Olona.15 La situazione giuridica ed economica è intricata. Il titolare del possesso diretto, il Rogora, riceve 75 lire a titolo di livello, per l’uso del mulino e del maglio. Nel caso di quest’ultimo impianto,
Il soddetto Antonio Molino […] lo fa lavorare a propria mano, ed Carlo Antonio Ceresa, lavoratore del medesimo, depone che li pagarebbe di fitto annuo L. 200.
Nel caso invece dell’impianto di lavorazione dei cereali, è preziosa la testimonianza del trentacinquenne Giuseppe Trotti di Giuseppe:
Abito in Biumo Inferiore in un molino di tre ruote, compresa quella della pista, qual molino esercisco a metà con Antonio Molina, padrone del medesimo, al quale annualmente li spetteranno staia cento circa [di] mistura. Il padrone paga tutti li carichi reali e fa le reparazioni eccedenti soldi 20 e le minori de soldi 20 si fanno da me, come pure pago gli carichi miei personali, e sono anni trenta di tal accordo senza scrittura ed ho detto la verità.
Nel 1733 sono confermati gli stessi assetti: il maglio è mosso da due ruote, condotto in economia da Antonio Molina, il mulino è azionato da tre ruote, affidato dal Molina al mugnaio Giuseppe Trotti.16
Nel 1741 gli amministratori ed esecutori testamentari della Causa Pia Frasconi, titolare ora del diretto dominio del complesso detto “Molino del Maglio” (senza includere però il vero e proprio apparato tecnico del maglio), investono Paolo Andrea (Lorenzo) Molina del fu Antonio a livello
14 Cfr., supra, la nota 10.15 ASMi, Catasto, p.a., cart. 3370, “Processi di Varese” (1722).16 ACFOMi, cart. 1161, “Visita del fiume fatta dal camparo Gaspare Bombelli, dal principio sino a Gorla”, 7 febbraio 1733.
137
enfiteutico perpetuo.17 La concessione è giustificata con il fatto che il reddito si è ridotto ad appena 125 lire annue,
a motivo si’ delle annue riparazioni che delli annui agravij, [come il] mantenimento di mole, roggie et altri attrezzi, […] non ostante che […] sia di annue L. 247.
A fronte dell’impegno a conservare e migliorare gli impianti con le relative pertinenze (edifici, attrezzature, opere idrauliche, più 14 pertiche di terreno a prato od orto), l’enfiteuta ottiene diritti di sfruttamento perpetuo degli immobili e della ragione d’acqua pertinente all’Olona, con la garanzia in futuro, per sé e i discendenti, di poter affrancare il bene tramite l’esborso di 7.500 lire. Gli oneri e i vincoli non sono in realtà di poco conto: oltre alla manutenzione degli edifici e delle mole (due “da mistura” e una per il frumento), al livellario è affidato il compito di tenere in efficienza il sistema di adduzione delle acque dall’Olona attraverso due saracinesche, una roggia molinara, le tre condotte che mettono in azione le ruote degli impianti di macinazione, un canale “scaricatore”. Vi sono poi gli oneri pubblici (ordinari e straordinari), gli appendizi, e soprattutto le servitù, quest’ultime di particolare significato perché condizionano lo sfruttamento per fini energetici dell’acqua della roggia (che prima di giungere al mulino serve all’irrigazione di prati della veneranda abbazia di S. Maria alla Cavedra degli Umiliati e della potente casata degli Orrigoni).
Ottenuta la concessione, Paolo Andrea Senior non perde tempo e affianca al mulino e al maglio un filatoio idraulico. Con l’entrata in vigore del Catasto, nel 1760, Paolo Andrea Molina risulta intestario, in qualità di livellario, di una “porzione di casa per uso proprio di filatojo di seta e di parte del [mulino], compreso [il sito di casa] e n. 11 [pertiche di aratorio] ridotte a caseggiato”, e di un’“altra porzione di casa d’affitto per uso di mulino ed il rimanente del suddetto [mulino]”, comprese le tre ruote che danno un reddito in natura di moggia 1:5 di frumento e 12:3 di mistura;18 ma egli è anche diretto possessore del resto del Mulino del Maglio, cioè della “casa con mulino e maglio di rame di due ruote […], compreso l’orto”, con i suoi apparati tecnici, comprese quindi le ruote, passate ora a quattro, per il lavoro del maglio e del filatoio, e di
17 ASCo, Notarile, cart. 4816, Giuseppe Baroffio, n. 451, 1788 gennaio 7, “Vendita ossia affrancazione di livello fuori alli signori Molina ed alla Causa Pia Frasconi”, con allegato “1741. 4 maggio. Instromento del molino, et beni annessi, in Territorio di Biumo sotto, dato a livello al signor Pavolo Andrea Molina di Varese”.18 ASVa, Catasto teresiano, Tavola censuaria [Catastino] del Comune di Varese, nn. 3475.1 e 3475.2, Molina Paolo Andrea quondam Antonio, livellario della Pia Causa Frascona (valore censuario, fatte tutte le deduzioni: scudi 173 lire 3). La stessa situazione si ritrova nel “Catasto de’ beni stabili di ragione della Causa Pia Frascona di Biumo Inferiore…”, stilato nel 1776, documento privato che riporta però gli esatti riferimenti del catasto pubblico (ASCVa, Opere pie, cart. 33, fasc. 5).
138
un’altra ragione d’acqua pertinente all’Olona.19 Ad attestarlo è anche un nuovo censimento degli impianti idraulici operanti nella valle dell’Olona effettuato nel 1772 da Gabriele Verri, “Reggente senatore e conservatore del Fiume”, e dall’ingegnere Gaetano Raggi, che distingue due ragioni d’acqua a proposito del Molino del Maglio, una che serve quattro ruote (evidentemente il maglio e il filatoio), l’altra tre ruote (il mulino).20
Il filatoio idraulico appartiene ora ai figli di Paolo Andrea Molina, Carl’Antonio (nato nel 1742), il curato di Casciago Superiore don Giuseppe (Maria) (nato nel 1743), il dottor fisico Luigi (Angelo Vittore) (1749-1813), Antonio (Vittore) (1750-1816), Bartolomeo (nato nel 1753), i quali secondo le informazioni fornite da Pietro Verri posseggono nel 1762 più della metà dei valichi (14 su 27) notificati a Varese per la produzione di seta per trame.21 Dall’impianto dei Fratelli Molina escono, si può stimare,22 più di 10.000 libbre di seta annue. La stima è confermata dai dati globali sulla produzione di seta greggia a Varese. Nel triennio 1747-49, in base alla rilevazione fiscale, la città produce una media di 16.856 libbre annue,23 nel 1807 21.120 libbre.24 Di fatto, la ditta Molina, sin dagli anni di Antonio, esercita, se non un monopolio, sicuramente un oligopolio sulla seta prodotta nelle castellanze e nell’immediato distretto. I registri dell’Ospedale di Varese documentano con abbondanza di informazioni l’inizio, a partire dagli anni ’20 del secolo XVIII, e poi la crescita dei pagamenti in seta da parte degli affittuari dei beni del patrimonio e la vendita del prodotto al “Signor Molina di Varese”, oltre che a mercanti svizzeri di Lugano e “della Tresa”.25
Del resto, come avverte una relazione analitica del 1765 preparata nell’ambito dell’istruttoria per infeudare segretamente il borgo, 26
La situazione di Varese è molto opportuna al commercio, perché per una parte il suo Territorio è distante circa otto miglia solamente dal Lago di Lugano, da cui è separato mediante la Pieve d’Arcisate, e per l’altra ha il Lago Maggiore non più
19 ASVa, Catasto teresiano, Tavola censuaria [Catastino] del Comune di Varese, n. 3474, Molina Paolo Andrea quondam Antonio (valore censuario, fatte le deduzioni: scudi 325 lire 4 ottavi 7). 20 ACFOMi, cart. 1161, “Tippo dimostrativo l’origine del fiume Olona e di lui andamento sino sotto al luogo di Castiglione…” (1772), note poste a margine della mappa dell’ing. Gaetano Raggi.21 VERRI 1763: 207-210 (con la “Tavola dei mulini di seta per l’anno 1762”).22 Per questa inferenza mi avvalgo dell’informazione che a Como città nel 1750 due filatoi idraulici a due piante da 12 valichi si stima filino 3.750 Kg di seta in trama ciascuno (COVA 1987: 155).23 ASMi, Catasto, cart. 3036, “Pieve di Varese. Risposte ai 45 quesiti” (1751-54).24 ASMi, Studi, p.m., cart. 1160, risposte del Pro Podestà Carlo Antonio Molina al questionario a stampa del 15 luglio 1807 (Varese, 14 ottobre 1807).25 CAVALLERA 2002: 233, 233n-234n.26 ASMi, Feudi camerali, p.a., cart. 623, “Relazione di polizia” del 28 febbario 1765 (cfr. ZANZI, MONDINI 1981: 153-154).
139
lontano di circa miglia dodici.I rami principali del suo commercio sono il grano e il vino di buona qualità, de’ quali generi è in grado di fare esito agli Svizzeri mediante il comodo della detta sua vicinanza al Lago di Lugano. Soprattutto poi fiorisce in Varese il traffico della seta, perché oltre ai mercanti, non vi è persona che sia fornita di qualche capitale di denaro che non si studi d’impiegarlo in gallette per farle poi filare a proprio conto.Della seta, di cui abbonda in proporzione del suo territorio, una qualche porzione se ne impiega in manifatture stabilite nello stesso Borgo, cioè in bindelli, zendadi e fazzoletti: de’ primi si fa il maggior esito a Como e a Milano; de’ secondi e terzi a Lugano e sul Lago Maggiore; il restante si spedisce a Zurigo e a Basilea, o a Lione, da vendersi a conto e rischio de’ padroni.Di tutta la rimanente seta filata che sopravanza alle dette manifatture se ne fa esito direttamente a Lione, dove col favore di questo suo commercio si sono da molti anni stabilite due Case originarie di Varese, alle quali si spediscono la seta in ballotti per farne esito a conto dei particolari che le mandano. Una di queste è la Casa de’ conti Sacchi di Lione, ch’è in credito di molta ricchezza; e l’altra è la Casa Adamoli, venuta ancor questa in qualche fortuna per mezzo della detta vendita.
Anche per i Molina il fulcro dell’accumulazione, nel ’700, è rappresentato dalla gelsibachicoltura e dalla filatura della seta. Tuttavia la loro azione dimostra di saper piegare o, se si preferisce, interpretare al meglio il sentiero di specializzazione imboccato dall’economia locale.
Varese si orienta precocemente all’economia della seta.27 Nella Cronaca varesina di Giulio Tatto sono molti gli accenni, fin dal penultimo decennio del Cinquecento, a un mercato locale che si sta strutturando per quanto riguarda la compravendita dei prodotti della filiera serica di prima trasformazione (semenza de’ bigatti, foglia de’ moroni, gallette, seta sgregia).28 A dimostrare la rilevanza e la precocità del fenomeno nel quadro lombardo vi è l’apprensione con cui Milano segue l’evoluzione in corso nel distretto varesino. Nel 1654 il Magistrato ordinario dispone la regolare notifica delle sete prodotte in zona e contingenta l’estrazione di seta cruda a non più di tre volte la quantità di quella lavorata che singolarmente ogni mercante vuole esitare.29 Il provvedimento ha l’effetto, non tanto di proteggere i filatori milanesi o la tessitura nazionale, bensì di moltiplicare nel borgo e nelle sue castellanze il numero dei molini manuali che filano la seta con finalità di esportazione oltralpe.
Secondo una “Notificazione” del 2 gennaio 1679 i molini attivi a Varese sono complessivamente 170,30 più 35 inattivi.31 In una nota
27 SELLA 1982: 29n.28 Cronaca varesina 1954: XVII, XIX, 16, 22, 34, 36, 42, 53, 57, 82, 90, 93, 110, 124, 131, 143, 144, 156, 159, 186, 188.29 ASCMi, Gride, cart. 18, f. 334 (cfr. VIGO 1991: 120).30 A Biumo Inferiore sono attivi 62 molini, a Biumo Superiore 24, nel borgo 84 (ASCMi, Materie, cart. 875, doc. 20, Nota della notificatione de’ molini di seta che vi sono in questo Ducato di Milano, in esecutione della grida publicata per ordine di S.E. sotto li 14 del mese di decembre prossimo passato, Milano, 15 maggio 1679, documento a stampa).31 A Biumo Inferiore sono inattivi 19 molini, a Biumo Superiore uno, nel borgo 15 (ibidem).
140
successiva si fa lievitare il numero complessivo delle macchine a 219, contro un totale di 359 esistenti nel Ducato, al di fuori di Milano.32 Si tratta di
molini di seta di sedeci aspe per cadauno molino solamente, ogn’uno de’ quali, per quanto dicono […], fa solo la metà del lavorerio d’un molino della Città di Milano, e che sogliono per ordinario lavorare non più di sei, in otto mesi per ciascun anno, conforme al maggiore o minore raccolto della seta.
Sono strutture produttive erette nel borgo rapidamente nel corso degli anni ’40, ’50, ’60 del secolo XVII, spesso con il trasferimento diretto dalla metropoli – straordinariamente Cristoforo Negretti, iscritto all’“Abbatia de’ Mercanti di seta di Milano”, dichiara di aver commesso il lavoro “sino l’anno 1630” --, oppure da località, milanesi e no, più distanti, che individuano in Varese la base più conveniente per le eportazioni sul mercato francese – come spiegare altrimenti la presenza nel borgo di un mercante di Lugano, residente a Milano ma che fa lavorare i propri molini in Svizzera, e che presumibilmente fa incetta di sete lombarde? --.33 E’ una concentrazione che da sola rappresenta più di 2/3 dei molini in opera nel territorio del Ducato. E, a sua volta, è il frutto di una prima riconversione dell’economia della città verificatasi fra gli ultimi decenni del ’500 e i primi del ’600, solidalmente con quanto è avvenuto nella metropoli. A dar credito infatti ai mercanti della seta di Milano – il memoriale è del 163534 --,
le migliara de’ telari che a tempo adietro lavoravano nella Città di Milano, hora si ritrovano et lavorano in Francia, in particolare nella Città di Lione, et se ne trova anco maggior quantità nella Città di Torsi [Tours], che in questa sola ve ne sarà de 4 mila, oltre quelli che sono sparsi altrove, et nello Stato di Milano non ve ne sarà più di seicento, qual quantità vi sarebbe stata solo nella Terra di Varese del Ducato, che hora non ve ne se trova pur un solo. In Milano pur ve ne sarebbe stato più di 6 mila, che come s’è detto non se ne trova più di 600.
L’impianto della prima lavorazione della seta ha innescato, negli ultimi decenni del ’500, lo sviluppo della tessitura nelle case del borgo,35 dove la tradizionale lavorazione della lana lascia rapidamente posto a quella della seta. Ma tale specializzazione non dura più di una o due generazioni, perché dagli anni ’30 del secolo successivo la funzione del
32 ASCMi, Materie, cart. 875, doc. 21, lettera a stampa della Giunta per il ristabilimento del mercimonio al Magistrato ordinario, Milano, 5 giugno 1679.33 ASCMi, Materie, cart. 875, doc. 20, Nota della notificatione de’ molini di seta che vi sono in questo Ducato di Milano…, Milano, 15 maggio 1679. Un altro caso è quello degli Adamòli, originari di Indovero e Narro in Valsassina, da cui muovono verso Varese sin dalla fine del secolo XVI per esercitare il commercio della seta (cfr. ARMOCIDA 1995: 160).34 ASMi, Commercio, p.a., cart. 228, memoriale dei mercanti di seta al Governatore (1635) (cfr. VIGO 2000: 39-40).35 BEONIO-BROCCHIERI 2000: 108 (sulla presenza di velutari nel borgo e nel distretto di Varese).
141
distretto di Varese diventa quella di reparto decentrato per la produzione di seta filata per le manifatture di Milano, e sempre più di Lione.
Se si considera che nel maggio 1679 vengono censite nel borgo e nelle sue castellanze 33 ditte, operanti – a pieno regime -- in 47 torciere, ciascuna mediamente con non meno di 4 piante da un valico (da 16 naspi), 8 operai (4 “maestre di bicocha”, 4 “molini”) e un supervisore all’interno della manifattura (senza contare le incannatrici che lavorano all’esterno a domicilio) si comprende come il profilo economico e sociale di Varese sia fortemente improntato alla produzione serica nel corso del ’600, anche considerandola un’attività precaria, fondata sulla stagionalità dell’offerta di materia prima, che ai filatori offre lavoro soltanto per 6-8 mesi l’anno, oltre che sulla domanda altalenante dei mercati esterni.
Le ditte più dinamiche cercano comunque di assicurarsi, con la naturalizzazione di qualche ramo familiare, un più saldo radicamento sul principale mercato di sbocco: Lione.
In Lione si ritrovano stabilite due Case che contano la loro origine da Varese, alle quali quei di Varese affidano le loro sete da vendere. Una è la Casa del conte Antonio Mario Sacchi, nativo di detto Borgo, e l’altra è quella del sig. Gaspare Adamolli, nativo anch’esso di Varese.36
Un ramo degli Adamolli è nella città sul Rodano almeno dal 1661, costruendo la propria fortuna (di loro resta testimonianza sino alla Restaurazione) sul ruolo di corrispondenti di altre imprese varesine.37
Di ben altro calibro la famiglia Sacchi:
Il conte Sacchi si dice ricco di un milione e mezzo, guadagnato tutto con queste vendite [di seta]. Portossi il detto Sacchi a Lione circa l’anno 1697 per esigere alcune cartelle del Duca d’Orléans, e durante la di lui permanenza in quella città furono, da molti particolari di Varese, al medesimo inviate diverse balle di seta da vendersi per loro conto. Ebbe egli la sorte di ritrovarne un pronto esito, e di fare buoni contratti, di maniera che avendo in pochissimo tempo rimessi a Varese, secondo l’uso della Piazza di Lione, ai rispettivi padroni della seta i loro conti d vendita, questo produsse l’effetto che tutti quegli di Varese che avevano nei loro negozi, e Case sete, le spedirono tutte al predetto Sacchi, e da qui prese motivo di stabilirsi collà ad attendere a queste vendite. 38
Ritorniamo ora al Settecento. Il cronista di Varese Giovanni Antonio Adamollo ci offre un quadro drammatico dell’economia varesina nel 1723 che ci permette di individuare un’altra cesura fondamentale nella storia del borgo. Egli scrive:
36 ASMi, Feudi camerali, p.a., cart. 623, fogli annessi all’istruttoria per l’infeudazione del borgo di Varese (1765) (cfr. ZANZI, MONDINI 1981: 158).37 Ibidem e inoltre ARMOCIDA 1995. Nel 1765, comunque, il patrimonio della casata in Varese non viene giudicato “gran cosa ricca” (v., supra, la nota 26).38 ASMi, Feudi camerali, p.a., cart. 623, fogli annessi all’istruttoria per l’infeudazione del borgo di Varese (1765) (cfr. ZANZI, MONDINI 1981: 158).
142
Con mio grande spiacimento devo far memoria che questo nostro Borgo di Varese, da ricco e mercantile che era, si è reso povero e di poco traffico, mentre altre volte v’erano in questo borgo le fabbriche di veluti che gli erano di molto utile e di pia memoria di quelli che ora vivono; vi erano mercanti di seta che negoziavano, in detta mercanzia, capitali grossissimi, comprando e facendo lavorare in questo Borgo, ciascun mercante, molte balle di seta di libbre 300 l’una che mandavano poi in Francia, e ciascuno ne mandava ogni anno in Lione di Francia una buona quantità, mentre si estendevano li detti mercati per tutto lo Stato di Milano, Mantovano ed anche Bolognese, a comprar seta, ed ora essendosi diminuito il traffico della seta cresce la miseria di questo Paese, e si va spopolando essendosi molti assentati per non aver da lavorare.
Il quadro che offre l’Adamollo39 è confermato dalle fonti archivistiche. Una consistente quota delle forze di lavoro e imprenditoriali varesine è emigrata, durante il secondo decennio, verso la Svizzera. Le fonti denunciano una forte diminuzione -- quasi un terzo -- delle teste soggette ai carichi personali all’interno della comunità (da 1.304 teste nel 1710 a 889 nel 1718), e questo “in sì puoco decorso di tempo, ed in sì piccolo Distretto, in tempi che (per la Dio grazia) non vi fu morbo epidemico, né altra infenzione maligna, ma si godette una perfetta salute”.40 La conseguenza è che
Gli affitti delle case e botteghe, qui in Varese, da 40 anni a questa parte, si sono abassati e diminuiti a più della metà, per esser mancato il traffico ed il personale, ad all’incontro li affitti di Lugano accresciuto, come anche il personale.41
Il grave ridimensionamento dei traffici è frutto della lunga, infinita perturbazione che affligge l’interscambio con il mercato francese. Scrive a questo proposito Pietro Verri:42
Vari accidenti in questi anni intorbidarono gl’interessi della nostra Provincia. La guerra colla Porta Ottomana, l’invasione della Sicilia fatta dagli Spagnuoli, ed il timor che recava il Duca Vittorio Amedeo di Savoia armato ai nostri coinfini erano circostanze poco a noi favorevoli che, unite alla lentezza del nostro sistema politico, ritardavano le beneficenze di Cesare su questo Stato. Venivano non di meno dispacci dalla Corte per proteggere il commercio [Dispaccio Reale del 1716, 19 febbraio], per il quale il Senato fece nuova consulta [Consulta del Senato 1716, 2 aprile]; indi si pubblicò grida proibitiva de’ panni [Grida di bando de’ panni forestieri 1716, 19 maggio] e drappi forestieri [Grida di bando de’ panni forestieri 1716, 20 maggio]. Ma queste lettere, consulte e gride non furono, quanto al sortire effetto, più fortunate di tant’altre consimili.
39 ADAMOLLO, GROSSI 1931: 95v.40 ASMi, Catasto, cart. 3370, ff. 83r-84r, supplica dei reggenti della comunità del 22 novembre 1722.41 ADAMOLLO, GROSSI 1931: 96r.42 VERRI 1763: 64.
143
Ad aggravare la crisi giunge però il dissesto della finanza pubblica francesce e altre circostanze straordinarie:43
nel 1720 tutta era in precipizio la circolazione della Francia per il sistema del Law, e di più l’anno medesimo si manifestò la peste in Marsiglia, la quale anche l’anno seguente fece strage; per lo che interrotto fu ogni commercio dell’Italia colla Francia.
La crisi finanziaria si tramuta in crisi commerciale e colpisce duramente la manifattura e i patrimoni varesini:44
Dio non voglia che il negozio della seta, che è l’unico che presentemete dà da lavorare alla povera gente, non vada maggiormente deteriorando, massime per le gravi perdite fatte -- massime in questi 3 anni scorsi -- da suddetti negozianti che sono stati spogliati de’ capitali che avevano in Lione di Francia mentre, reggendo quel regno -- per la minorità del Re -- il Duca d’Orléans, questo ha obbligato i suoi sudditi a portare tanto il loro denaro, quanto quello de’ forastieri loro corrispondenti all’Errario Regio con riceverne invece degli biglietti, quali presentemente non ponno, detti negozianti, esitarli che con la perdita di circa un novanta per cento, onde è stato un grande assassinamente fatto da quel duca contro la buona fede ed il jus gentium, e per quante istanze si siano fatte anche con il mezzo di ricorsi fatti all’Imperatore nostro Sovrano, che si è interposto, non hanno mai potuto ottenere il loro rimborso, onde se si manterranno quelli pochi negozii di seta che ora vi sono, vi sarà poco, attesa una perdita così grande ed un fatto non mai più inteso, mentre non essendovi guerra tra il nostro sovrano e la Francia, questo si può dire una rappresaglia, che, quantunque sia totalmente ingiusta, non si sa con qual motivo tutti li Principi che hanno li suoi sudditi assassinati per un tal fatto non ne abbino fatto, e non ne faccino, un rigoroso e strepitoso rissentimento, ma la disgrazia si è che i Principi antepongono il loro interesse a quelli de’ sudditi, e che tutte le nazioni, come anche la nostra, non ostante un tanto assassinamento ed un sì grande mancamento di fede continuano ancora a trattare e mandare mercanzie in Francia, o ritraendoli il danno sofferto ma allettandoli il lucro che presentemete ne sentono dal continuamente a negoziare con la Francia, ben è vero che ora negoziano a denaro contante, pel prezzo della seta che si vendono, ed immediatamente cavano il denaro perché non soggiaccia ai passati pregiudizii.
La crisi ha effetti devastanti sulla rete di ditte mercantili operanti nel borgo:45
Le Case che altre volte negoziavano grossi capitali in sete e che ora più non hanno alcun traffico sono la Casa de signori Frasconi, in Biumo di Sotto, e due altre case della famiglia Giudici, pure nello stesso luogo; la Casa dei signori Carantani, in Biumo di Sopra; ed in Varese la Casa de’ signori Bazzi detti Callaresi, la Casa Martignona, la Casa Comoli, la Casa Marliani, Casa Negri e due Case de’ signori Mozzoni.
43 VERRI 1763: 66. Una spiegazione sintetica del sistema di John Law e del crack finanziario in WEE 1978: 435-437.44 ADAMOLLO, GROSSI 1931: 96v-96r.45 Ivi, 96v.
144
Peraltro, come sempre, la congiuntura opera una selezione tra le forze imprenditoriali, esaltando certi atout in termini di capitale, di posizione di mercato, di relazioni sociali e familiari. E qui entrano in campo i Molina. Ma seguiamo ancora una volta la cronaca dell’Adamollo:46
Le Case che continuano a far negozio di sete sono la Casa detta cotiscella Origona, in Biumio di Sotto, ed in Varese la Casa Trinchinetti, Adamolla e Frascona, Negretti, due case de’ Sig.ri Sacchi e Molina, non contando li pizzigaroli, cioè quelli che comprano sete e le rivendono lavorate ma non le mandano in Lione, che ve ne sono molti.
Quali sono i fattori di resistenza o di successo delle ditte superstiti? Una risposta la fornisce indirettamente lo stesso Adamollo:47
il mercimento dela seta è diminuito di molto, talmente che da 40 anni a questa parte molti molini sono andati in rovina, ed altri si sono streppati, perché non v’è più lavorerio di seta per tutti, e la quantità di detti molini mancati non è poca, […] [ma, se] si sono demoliti vari molini in questo borgo e molti sono andati in ruina per non aver più lavoro, […] poi se ne sieno creati sull’Olona alcuni più magnifici che vanno meglio coll’aqua.
L’erezione di grandi impianti idraulici diventa l’elemento decisivo di successo nella nuova fase che conosce l’economia varesina. Tale elemento non è però nelle possibilità di tutti, e non solo per ragioni di denaro.
UN VINCOLO:IL FRAGILE, INCOSTANTE E IMPREVEDIBILE
SISTEMA DELLE ACQUE VARESINO
A Varese l’acqua, per qualunque uso, è una risorsa assai scarsa. Esiste una fondamentale irregolarità stagionale nel rifornimento delle acque di pozzi e sorgenti e nella portata dei corsi d’acqua (fiume, torrenti, rii) che attraversano il territorio del borgo e delle castellanze, che possono passare dalla situazione di secca a quella di acque tumultuose in piena periodicamente pronte a esondare.
Fino alla realizzazione dell’acquedotto varesino negli ultimissimi anni dell’Ottocento, gli effetti delle siccità si ripresentano periodicamente, particolarmente nei mesi estivi e autunnali.
Seguiamo la cronaca del Tatto.48 Settantaquattro giorni senza pioggia fra il 24 agosto e il 7 novembre 1606 e in città “sono sugati la
46 Ivi, 96v.47 Ivi, 96v-97v.48 Cronaca varesina 1954: 80 ss.
145
maggior parte dei pozi et fontane vive, et si sono serati diversi molini che no’ mazinano per il mancamento del aqua”.
Nel 1611, per la scarsità di precipitazioni da giugno a settembre, pozzi e fonti incominciano a essere asiuti; ma l’arsura non accenna a diminuire nei mesi successivi:
La mesata di ottobre è passata co’ asiuti grandissimi, […] che si po’ dire che […] Varese habbia più vino che aqua, et no’ è mai a ricordare de’ homini hora viventi visto una simile sutezza et arsità, se bene dirò ma pochi pozzi co’ aqua ma vi ne sono alcuni privillegiati et quasi tutti asiuti delle terre al basso e, cosa incredibile, le fontane la maggior parte al fine et senza aqua, se ben tal volta, ma raro, [si sia] avuta coma una rossiata.
La mesata di novembre è passata una gran parte co’ bon tempo, se ben tal volta è piovuto, co’ una asiuteza che la maggior parte de i pozzi no’ hanno aqua, cosa no’ mai più vista.
Marzo 1616, asugamento di pozzi, fontane, peschiere, che non si risolve neanche nel mese successivo:
Va perseverando la suteza, di modi che quasi tutti i pozzi di Varese er castellanze sono senza aqua, [così come] no’ esser mai occorso per il passato. Et il fiume, l’Ollona, no’ ha tanta aqua, che a pena potria mazianare una rotta del molino, et li molini no’ po’ a pena mazinare che una sol rotta, co’ tutto che ne habino più assai.
Novembre 1617:
Il grande asiuto […] hora caggiona che i pozzi si vano abasando et asugando, come ancora fano le fontane, et i molini che si trovano sopra l’Ollona no’ macinano [che] sollo co’ una rotta, che è cosa notabile in questa staggione.
Ancora nel gennaio 1618,
Sono asiuti la maggior parte de li pozzi di Varese et castellanze, cosa notabile, et ancora sono asiugate quasi tutte le fontane, et abasata la fontana de Casbeno, cosa de importanza, et li molini […] macinano apena [con] una rota, et la Ollona è quasi senza aqua.
E, a distanza di non più di due anni, nel novembre 1619:
bel sole et mancho fredo co’ grande asiuto, che vi sono de i pozzi assai asiuti et di Malnate in su li molini no’ lavorano sollo che [con] una rotta per molino per mancamento di aqua.
Si tratta dei momenti parossistici, perché il cronista, sensibile al tema, segnala altri episodi minori che attestano il ricorrente stato di disagio e di difficoltà per la popolazione e per le strutture della città in merito al problema dell’acqua nelle sue diverse valenze. Che non si tratti di una barocca ipersensibilità al clima e alla meteorologia, lo dimostra il fatto che analoghi racconti si possono trovare nelle cronache di Antonio
146
e Luigi Maroni su Varese nella seconda metà dell’Ottocento. Così come Giulio Tatto ricorda la pratica di effettuare, nelle estati più siccitose (per esempio nell’agosto 1608 o 1619), la processione per le vie ad petendam pluviam,49 Antonio Maroni riferisce dell’uso popolare di far esporre il simulacro della Beata Vergine Addolorata presso l’altare maggiore della chiesa prepositurale per invocare la pioggia.50 Del resto, il tenore delle sue Memorie ricalca quello delle descrizioni di tre secoli prima. Nel 1870, per esempio,51 si verifica
Gran caldo in luglio con asciutto, distruttore d’ogni erbaggio, di conseguenza deficienza d’acqua nei pozzi e nelle fonti perenni, alcune delle quali completamente asciugate. Da principio continuò il caldo anche nell’agosto e parimenti la siccità, poi capitarono dei temporali […]. Parimenti l’ottobre si tenne sempre bello, continua solo la siccità nei pozzi, con grave incommodo ai cittadini. Eguale stagione nel novembre ed eguale inconveniente per l’acqua deficiente nei pozzi ed altre fonti. Verso l’11 […] cominciano le piogge benefiche […]. Continuano in seguito le piogge che furono vantaggio ai pozzi e fonti d’ogni parte.
Ma il sistema idro-meteorologico di Varese soffre anche di periodici eccessi di precipitazioni, piene abnormi ed esondazioni dei corsi d’acqua che confluiscono sul borgo o che lo attraversano. Affidandoci ancora al Tatto,52 scopriamo ricorrenti tempeste (generalmente nella tarda primavera) che riempiono d’acqua le “canepe sotto terra”, ma anche botteghe, magazzini e abitazioni, che sommergono i ponti sul torrente Vellone trascinandoseli talora via, che “ingierano” i mulini sull’Olona impedendogli di lavorare, che innondano orti, vigne, campagne. Per fare soltanto un esempio, in pieno agosto, nel 159153
fu per venire il deluvio, et a ricordar de homeni no’ si è visto mai una tal cosa, co’ haver guastato tutte le strade oltra modo et dannificato molti beni, et no’ si trova pane al prestino de Varese per esser restati tutti rovinati et ingierati li molini, che no’ si poté mazinare.
Ma nel successivo gennaio 1592 le cose non migliorano:
si missi a piovere grandemente che si bisognava andar in volta per Varese a’ cavallo, essendo andato l’aqua sotto li portichi di esso borgo et in alchune canepe sotto terra.
49 Cronaca varesina 1954: 89 e 204. L’Adamollo conferma l’uso: “Alli 5 del mese di settembre [1673] si fece processione generale per impetrare l’acqua da Dio per la grande siccità che vi era, e alli 9 di detto venne un diluvio d’acqua” (ADAMOLLO, GROSSI 1931: 77r).50 MARONI, MARONI 2003: 33 e 39.51 MARONI, MARONI 2003: 53.52 Cronaca varesina 1954: 17 ss.53 Cronaca varesina 1954: 35-36.
147
Le testimonianze forse più impressionanti su quali fossero i pericoli connessi con tale fragile assetto idrico è il racconto degli effetti delle innondazioni avvenute nel 1641 e nel 1680 sulla principale attività del borgo, quella serica:54
L’anno 1641 prossimo passato di novo seguì grandissima pienna d’acque scorendo il fosso [cioè il torrente Vellone] a segnio che al ponte di Campagna usciva dal suo letto et sopragiungendo l’altro ramo che viene dalla parte del giardino si alzarono talmente le acque che entrarono nella Torciera dei Signori Biumi in altezza d’uno brazzo e mezzo et in casa del detto Gioseffo Buzzo più d’uno brazzo, entrando nelli luoghi dove tiene il lavorerio delle sete in altezza di brazza 3, rovinando le sete et molini che restarono in [?] parte d’essi più de quindeci giorni nella dispensa crebbe a segno tale che li panelli di preda alti brazza 2 quali erano pieni di olio disperso, entrò in altri luochi et in particolare in fundico dove bagnò le sete lavorate che haveva nelli banchi et casse, et si guastarono restando macchiate, et se non haveva più che ben agiuto in reparare ad altri uscij et ferrate delle cantine si riempiva d’acque con la perdita del vino restò tuttavia dannificato più de cento scudi.
Da quante volte il Borgo di Varese è stato nel presente e passati secoli travagliato e danegiato dall’escrescenza de’ torenti et acque che da convicini Monti derivano al medesimo Borgo non c’è memoria ve ne sji stata alcuna maggiore della seguita la notte del di quatro del presente mese di luglio, né per conseguenza il medemo Borgo e suoi Particolari sono mai stati più danneggiati, e nelli muri atterati, e nelli mobili, supeletili e mercantie deteriorate, e vino rovesciato nelle cantine, posciache tutte le Case, Monastero delle Monache di S. Antonino ed il Pretorio, con evidente pericolo della desolatione et affogamento de’ carcerati, che sono coherenti al letto per cui passano dette acque, sono state, per l’essuberante acqua in esse traboccata, inondate nelle cantine e nelle stanze superiori a dette Cantine del primo piano, sino a tre e quattro brazze, e da dette inondate case, uscendo per le Porte. Et altri sfori, fatti dalla violenza della medesima acqua, s’è formato un novo Torente in mezo del Corso Maggiore del Borgo, così copioso che ha occupato tutto il Corso e li Portici, e dall’una e l’altra parte, riempiendo tutte le Botteche, Cucine e cantine de’ Bottegari e d’altri Particolari, non essendone andati essenti ne anche le Case e Cantine poste nella parte più lontana di detto Torente, et ultime del Borgo, che sempre furono preservate ne’ passati diluvji, con haver di più condotto via tutti li Ponti di legno sopra detto Torente, e rovinato quasi tutti gli altri, che in buon numero vi sono di pietra, publici e privati. In somma il danno è indicibile et inestimabile, che ne sentirà per molti anni il publico e privato, già tant’aflito dalla mala conditione de’ tempi, dalla grave tempesta caduta alla fine di maggio scorso, nella più fertile e miglior parte del Territorio e fatto privato di tutti li frutti di grano, foglia de moroni, fieno e vino, e molto più dalla cessatione de’ trafichi, massime della seta, che è sempre stato il sostegno maggiore e quasi unico di tutt’il Paese, o in persona de’ mercanti, de’ fillatori, o delle donne pratiche di questo solo esercitio, o da giratori de’ molini, e simili, ridotti perciò tutti a totale miseria et inhabilità di sostentar, non che di pagare li loro carichi personali. Il qual trafico è ridotto quasi al niente, sendo cessato per tre parti, e più delle cinque, a causa di diversi fallimenti di mercanti, seguiti in meno di due anni in detto Borgo, per più di trecento mille lire di capitale.
54 ASCVa, cat. X, cart. 178, fasc. 1. Cfr. COTTINI, METRA 2000: 16n e 17n-18n.
148
A sì grandi miserie s’aggionge amche la conseguente rovina delle strade, e regie e vicinali, e massime di quella che va ali mercati di Gavirate e del Lago Maggiore, che sono rese impraticabili a’ carri, e quasi a’ stessi cavali, e pedoni, se non entrano per le vigne e campi, ed accrescere la loro deserbatione, cauasata da dette acque, che gli hanno del tutto inondati, arenati et insteriliti per quasi tre miglia di Paese, e da qui ne segue che li detti Poveri particolari restano non meno imposibilitati ad andare a detti mercati, con le loro mercantie, per guadagnarsi qualche cosa, che a potere condure a casa quei puochi frutti, e fitti, che dalle terre più lontane e riservate si sono sopravanzati, restando quasi levato il reciproco comercio, altresì, con questo Borgo.
Preci e processioni, dunque, si ripetono nel borgo anche per invocare la cessazione di piogge disastrose, magari fuori stagione. Così nel 160255
Si va facendo processione questi tre giorni 25, 26 et 27 giugno per il tempo, che sono otto giorni che piove, però no’ continuo, che no’ si po’ far il ricolto de’ grani..
Persino un “Regio Visitatore sopra le manifatture” come il conte Marco Paolo Odescalchi non può non rilevare i condizionamenti che la meteorologia impone alle attività produttive quando alla fine di settembre del 1773 annota nella sua tappa varesina:56
Da Varese sino a Porto Codelago fa vera compassione il danno che si vede recato dalle dirotte piogge e dalle rovine succedute per l’accrescimento dell’acque, su’ terreni d’ogni sorta, strade, mulini e folle.
Quali fossero le conseguenze per chi avesse avuto bisogno di una continuità di portata nell’afflusso e nello scorrimento delle acque – tanto più per un uso manifatturiero o industriale – ce lo dicono nella maniera più esplicita le relazioni ottocentesche. Nella Statistica preparata dalla Camera di Commercio nel 1873 l’incostanza del sistema delle acque nel Circondario di Varese, e in particolare nel bacino dell’Olona, viene indicata come uno dei principali vincoli allo sviluppo industriale della zona. A proposito dell’Olona si dice:
Le acque di questo fiume danno moto ad un grandissimo numero di opificij. […] Dal lato industriale sono le acque di questo fiume preziosissime […]. Ma pur troppo questo fiume va soggetto a troppo frequenti peripezie di magre e di piene per poter giovare come si desidererebbe ai nostri industriali.
Si incolpano, fra l’altro, “gli attuali disperdimenti d’acqua che verificansi dalle centinaje di bocche concesse per l’irrigazione estiva settimanale dei prati”.57 Gli effetti sono misurati, sul piano
55 Cronaca varesina 1954: 60.56 Relazioni sull’industria 1941: 151.57 Statistica 1873: 84-85.
149
microecronomico, da quanto riportano i singoli industriali. Nel caso – di successo – della Cartiera della Ditta Paolo Andrea Molina si dichiara:58
Lo stabilimento è messo in movimento col mezzo di 2 turbine, da una macchina a vapore della forza di 30 cavalli, e da due altre della forza di 8 cavalli ciascuna. L’incostanza delle acque del fiume Olona, ora abbondanti ed ora scarsissime, fa sì che per circa sette mesi dell’anno bisogna servirsi della macchina a vapore di 30 cavalli, perché lo stabilimento possa essere tenuto in regolare attività. Fu per tale circostanza che nel 1859 dovette essere attivata la detta macchina a vapore. Se a quell’epoca questa macchina non rappresentava una grande passività per lo stabilimento, in oggi per l’aumento straordianrio dei carboni fossili, e d’ogni qualità di combustibile, essa rappresenta una non lieve perdita nei redditi dell’opificio.
Si comprende quindi il sollievo di Luigi Maroni quando, finalmente, alla data del marzo 1896, può annotare: “E’ una fortuna, oggi più che mai, per Varese l’acqua potabile, perché c’è scarsità d’acqua nei pozzi”.59 I lavori per la costruzione dell’acquedotto cittadino, iniziati nel 1893,60 nel pieno di un’annata siccitosa che prosciuga da gennaio a settembre pozzi e sorgenti, sono finalmente giunti a termine permettendo alla città di voltare pagina.61
LA FILATURA VARESINA
DAI MOLINI MANUALI “ALLA MILANESE”AI MOLINI IDRAULICI “ALLA BOLOGNESE”
Nei primi decenni del ’700, dunque, si fa avanti l’esigenza di riconvertire l’economia varesina, modificando mercati di sbocco, prodotti, modalità produttive e distributive, ma il passaggio dalla filatura svolta a braccia, o tramite animali, nelle case del borgo alla produzione in grandi impianti idraulici specializzati non si presenta come un cambiamento “naturale” e tanto meno “pacifico”. Nel 1733 sono attestati ufficialmente due impianti specializzati nella filatura della seta lungo il corso dell’Olona, entrambi localizzati a Biumo Inferiore: si tratta, il primo, di “uno edificio di seta che va con una rota del sig. Gerolimo Censo”, mentre il secondo è l’esito della diversificazione di un grande molino a 6 ruote: si tratta del “molino del sig. Gio. Antonio Porta, tenuto annivello del sig. Gio Battista
58 Ivi, 65-66.59 MARONI, MARONI 2003: 179.60 La costituzione ufficiale della Società in accomandita semplice Molina, Redaelli, Torelli e Compagnia, con la partecipazione delle principali forze economiche e finanziarie varesine, avente per oggetto e scopo la costruzione e l’esercizio dell’Acquedotto di Varese, è del 5 aprile 1893 (ASCVa, cat. X, cart. 178, fasc. 2, Acquedotto di Varese 1894). Cfr. anche SPARTA’ 1999: 26-32.61 Cfr. MARONI, MARONI 2003: 133-137.
150
Ponti, lavorato di Antonio Maria Ferari molinaro, per rote 5”, dove a fianco “al detto molino vi è altra rota […] qual serve per l’edifizio de n. 3 molini di setta, a una detta rota, mediante acqua di fontana proveniente dal Monte detto di S. Fermo”.62 E’ probabilmente quest’ultimo ad essere segnalato come “molino innovato” fra i beni “di seconda stazione” nel 1722.63
L’idea, quindi, che lo Stato di Milano non sia arrivato a possedere molini da seta a ruota idraulica fino all’erezione del filatoio dei fratelli Marco e Orazio Bianchi a Milano nel 1739 deve essere rivista.64 L’elenco dei valichi forniti da Pietro Verri per l’anno 1762 attesta la costruzione a Varese di due grandi molini idraulici per la filatura, binatura e torcitura della seta. Se nel caso del molino di Paolo Antonio Sopransi (12 valichi) l’informazione del 1733 ce lo fa ritenere composto da tre piante (cioè tre torri rotanti per il lavorerio delle sete), nel caso del filatoio eretto in epoca susseguente da Paolo Andrea Molina (14 valichi) si può ipotizzare che fosse costituito in modo più efficiente da due piante.65 All’epoca si tratta di alcuni fra i maggiori impianti del Ducato. Insieme a loro opera un piccolo impianto a un solo valico, condotto da Pietro Nieda, per il quale si può stimare una produzione non superiore alle 3.000 libbre di seta in trama.66 I primi due sono quindi in grado di assorbire interamente l’offerta locale di seta greggia.
Ma con la costruzione del filatoio Molina, per circa cinquant’anni, fino all’ultimo decennio del secolo, nonostante la precocità della loro messa in opera, il numero dei filatoi idraulici a Varese rimane immutato. Lievita soltanto il numero dei valichi. A Como, nello stesso periodo, lo stesso tipo d’impianto prospera, si perfeziona e si moltiplica nell’arco dello stesso periodo.67
62 ACFOMi, cart. 1161, “Visita del fiume fatta dal camparo Gaspare Bombelli, dal principio sino a Gorla”, 7 febbraio 1733.63 ASMi, Catasto, p.a., cart. 3370, “Processi di Varese” (1722), f. 54v.64 Cfr. PONI 1976: 472-475; e inoltre Relazioni sull’industria 1941: XVII. “Molini all’uso di quelli di Bologna” sono attestati a Treviglio nel tardo Cinquecento (MOIOLI 1981: 24n-25n), a Como nel 1667 (BEONIO-BROCCHIERI 2000: 184-185), a Lodi e nel Lodigiano nel 1699 (MOIOLI 1981: 49n-50n). Del resto, in base a un’attestazione del 1717, “Anche a Milano qualcuno provò, al termine del secondo decennio del ’700, ‘d’introdurre (…) un novo lavorerio di filare la seta all’uso bolognese’, incontrando la circospezione dei filatori” (TREZZI 1986: 139n).65 L’esempio dei mulini da seta in opera a Como nel 1750 e nel 1767, così come in altre località intorno al 1767, fa ritenere improbabile un’altra organizzazione tecnica (cfr. COVA 1987: 155; Relazioni sull’industria 1941: 87-89 e passim).66 Cfr. Relazioni sull’industria 1941: 191-194 e passim.67 Cfr. COVA 1987: 154 ss.
151
Filatoi di seta attivi nel Borgo e nelle castellanze di Varese nel corso del Settecento (piante e valici).
Anno/Molini
Ad acqua A mano TotalePiante Valici Piante Valici Piante Valici
1733 4 ? ? ? ? ?1762 6 27 ? ? ? ?1779 6 35 24 47 30 821791 6 35 24 45 30 80
Fonti: ACFOMi, cart. 1161, “Visita del fiume fatta dal camparo Gaspare Bombelli, dal principio sino a Gorla”, 7 febbraio 1733; VERRI 1763: 209 (“Tavola dei mulini di seta per l’anno 1762”); COVA 1987: 160 (tratto da ASMi, Commercio, p.a., cart. 231, 1779); ASMi, Finanze, p.a., cart. 11, “Specifica degli edificij da seta che esistono nello Stato di Milano” (1791).
Il passaggio dalla torcitura a mano a quella idraulica necessita di una serie di condizioni e di una radicale riconversione organizzativa. La diffusione dei nuovi impianti idraulici si fonda su:
1. la possibilità di disporre di forza idraulica a costi ragionevoli e senza condizionamenti eccessivi riguardo alla continuità e all’eventuale incremento delle potenze utilizzate, senza alea in merito alla loro disponibilità in un orizzonte temporale di lungo periodo;
2. il miglioramento della materia prima tratta nelle campagne, con il mantenimento, se non l’incremento, dei volumi estratti;
3. la disponibilità di capitale di avvio, ma più ancora l’esistenza di prospettive di mercato incarnate da reti di smercio e commercializzazione in un orizzonte a dimensione non solo locale.
Nel caso del Varesotto gli impianti idraulici sono sempre il frutto della riconversione di impianti preesistenti, generalmente dedicati alla macinazione. Anzi più spesso – nel caso dei due mulini maggiori si può parlare di una vera e propria diversificazione industriale -- la lavorazione della seta si affianca ad altre attività, come la macinazione o la lavorazione dei metalli. Il fatto, insieme a quello della concentrazione degli impianti a Biumo Inferiore, in Valle Olona, dimostra la difficoltà di reperire corsi d’acqua o condotte di derivazione adeguati alla bisogna. Di fatto, è precluso per questo utilizzo, il territorio del borgo e della maggior parte delle sue castellanze (per l’incostanza, l’imprevedibilità e l’elevata variabilità stagionale del sistema delle acque varesino). Lo stesso sviluppo massiccio nel territorio urbano degli impianti azionati a braccia (o con animali), e non dei mulini idraulici, può essere spiegato con l’oggettiva difficoltà di impiantare quest’ultimi all’interno del borgo.68
68 Cfr. gli effetti del medesimo vincolo in un’area innovativa come quella piemontese, dove “i filatoi mossi a mano erano diffusi soprattutto in aree marginali come il Monferrato i cui corsi d’acqua erano meno numerosi e meno regolari” (CHICCO 1995: 202).
152
Il territorio varesino, ma più in generale il bacino dell’Olona, poneva forti vincoli ambientali, ma anche e soprattutto istituzionali al possesso e all’uso per fini manifatturieri dell’acqua. La natura dell’accordo stipulato fra i Molina e la Causa Pia Frasconi nel 1741 in merito all’utilizzo del Mulino del Maglio è a questo proposito significativo nella parte che illustra le servitù d’acqua e la precedenza che viene data all’irrigazione dei prati rispetto alla macinazione, e di questa nei confronti della lavorazione del rame.69 Le servitù agricole che gravano sull’uso dell’acqua, nel caso del Mulino del Maglio, sono frutto di diritti posseduti ab antiquo da istituzioni venerande (Abbazia di S. Maria alla Cavedra e Casata degli Orrigoni), a significare un accesso fortemente condizionato dagli assetti pregressi e dalla tradizione. Lo stesso Mulino del Maglio, del resto, sembra coincidere con la localizzazione due e trecentesca dei mulini di Biumo Inferiore posseduti, uno, dal più antico ospedale di Varese (“de Novem Fontibus”) e, l’altro, dall’arcivescovo di Milano, ma affidato agli Umiliati della Cavedra.70
Altro elemento che osta al “naturale” passaggio alla filatura idraulica è rappresentato dall’offerta di materia prima. L’allevamento del baco nel territorio del Varesotto, abbiamo visto, si diffonde in maniera consistente già negli ultimi decenni del secolo XVI. Si tratta tuttavia di un’attività che resta, fino ancora alla crisi fra gli ultimi decenni del Seicento e i primi del Settecento, su standard qualitativi modesti. A dimostrarlo è la specializzazione del borgo nella filatura di trame – e non di organzino, che richiede una seta più fine –, con lavorazione per di più manuale.
Del resto, il potenziale produttivo delle campagne del distretto è largamente insufficiente alle necessità delle torciere del borgo. Se da una torciera con quattro piante “alla milanese” (da un valico ciascuna), possono uscire all’incirca 700-800 libbre l’anno di seta in trame,71 si può stimare il potenziale produttivo di Varese all’inizio degli anni ’70 del secolo XVII in circa 35.000 libbre di seta.72 Il distretto non è in grado di produrre un simile quantitativo di seta greggia, pur concentrandosi sulla qualità più corrente. Oltre tutto, sullo stesso mercato locale si esercita la domanda di filatori esteri, in particolare svizzeri.73 Di qui la maglia assai estesa dei mercati di approvvigionamento: l’intero Stato di Milano, il
69 ASCo, Notarile, cart. 4816, Giuseppe Baroffio, n. 451, 1788 gennaio 7, “Vendita ossia affrancazione di livello fuori alli signori Molina ed alla Causa Pia Frasconi”, con allegato “1741. 4 maggio. Instromento del molino, et beni annessi, in Territorio di Biumo sotto, dato a livello al signor Pavolo Andrea Molina di Varese”.70 Cfr. LUCIONI 2002: 59.71 Cfr. PONI 1976: 461 (l’esempio riportato è quello di un grande filatoio veronese nel 1765, con lo stesso numero di piante e valichi ma con 72 naspi e 432 fili).72 E’ quanto risulta ipotizzando che le 47 torciere notificate nel borgo e nelle castellanze nel 1679 producessero ognuna 750 libbre di seta l’anno.73 MOIOLI 1981: 48n-49n (dove si riporta un “Ricorso delli filatori di Varese…” del 1679, conservato in ASCMi, Materie, cart. 876, particolarmente dettagliato al riguardo); TREZZI 1986: 107-108, 110.
153
Mantovano, il Bolognese.74 Con il passaggio alla filatura idraulica, tuttavia, occorre innalzare la qualità degli input di produzione.75 Il “filar grosso” prevalente nelle campagne lombarde non poteva più rispondere né alla nuova struttura della domanda sul mercato dei tessuti serici, orientata verso tessuti più fini, né alle esigenze dei filatori più dinamici pronti ad ammodernare gli impianti. E d’altra parte le tradizionali commesse alle aziende contadine o all’industria domestica rurale o il presidio dei principali snodi dei circuiti di commercializzazione della seta greggia non erano più sufficienti a governare la prima trasformazione secondo le nuove esigenze produttive.76
La promozione dei Molina a principale ditta di filatura a Varese discende dalla posizione che essi detengono nei confronti dei cospicui patrimoni delle principali Opere pie varesine e dalla possibilità non solo di esercitare un quasi monopolio sulla seta prodotta nelle aziende agricole che li compongono,77 ma anche di poter orientare qualitativamente l’offerta dei contadini secondo le nuove esigenze di mercato.78 Del resto, a cementare il legame è la stratificazione di rapporti contrattuali e obbligazioni che legano i Molina all’Ospedale e alle principali Cause pie di Varese. La concessione del Mulino del Maglio da parte della Causa pia Frasconi con un contratto enfiteutico – che è sempre di miglioramento -- accresceva l’interesse dei suoi amministratori a farsi referenti sul lato mercantile – e in certa misura a rivalersi della concessione irrimediabile – agevolando, in qualità di possessori agrari, le fortune dei loro livellari trasformatisi passo dopo passo in negozianti di seta e in filatori imprenditori, dunque in fondamentali realizzatori delle loro rendite agricole.
Se dunque il primo passo fu, da parte dei Molina, di stimolare la produzione di seta greggia nelle aziende locate dagli Enti pii,79 il passo
74 ADAMOLLO, GROSSI 1931: 95v.75 Cfr. PONI 1976: 450-453. 76 MOIOLI 1981: 24n-25n, 48n-49n e passim; TREZZI 1986: 117 ss.77 Cfr. CAVALLERA 2002: 233, 233n-234n. Fin dagli anni 1650-52 ritroviamo un Antonio Molina nelle vesti di agente e amministratore del Venerabile Ospedale dei Poveri di Varese e dell’Eredità di Giovan Battista Sessa (ASVa, AO, Eredità Sessa, registro 5, libro mastro [1652-1671], cc. 19r-19v).78 Quanto annota Poni (PONI 1976: 467) a proposito del Piemonte – “i proprietari di filatoi (i ‘fatturanti’) che non erano commercianti di seta, e i commercianti di seta (i ‘negozianti’) che non erano ‘fatturanti’ realizzavano vantaggi e guadagni molto minori di coloro che erano nello stesso tempo grandi commercianti e proprietari di filatoi” – è estensibile alle altre realtà in cui avviene il passaggio dalla filatura manuale a quella idraulica.79 Antonio Molina, nel 1725, acquistando seta greggia prodotta dai massari dell’Eredità Sessa all’Ospedale di Varese, in territorio di Venegono Superiore e Vedano, contribuisce a introdurre surrettiziamente nei rapporti contrattuali, che prevedevano fin lì la consegna – insieme alla porzione dominicale di generi correnti e agli appendizi – di una quantità fissa di lino lavorato e la foglia de’ moroni riservata, la pratica della filatura della seta all’interno delle fattorie agricole, il prodotto della quale gli agenti dell’Ospedale acquisiscono interamente, anche nella quota non dominicale, a compensazione dei debiti degli affittuari (ASVa, AO, Eredità Sessa, registro 9, “Giornale dell’Heredità Sessa…” [1688-1749]).
154
successivo fu di pretendere direttamente i bozzoli allevati dai massari80 per commettere la trattura a terzi, elevando la qualità del semilavorato necessario a far funzionare i filatoi idraulici.
In tale privilegio risiede il segreto del successo dei Molina nel settore serico. Lo stesso privilegio è all’origine dell’accumulazione originaria da cui scaturisce dapprima il filatoio serico e successivamente la cartiera. Da questo punto di vista – la provvista del capitale -- la posta in gioco si misura meglio se accanto al dato del controllo della risorsa fondamentale, cioè l’accesso e il diritto d’uso sull’acqua, che pochi possono vantare sul piano locale, si pone l’accento sul controllo che i Molina riescono a esercitare, per quasi tutta la seconda metà de Settecento, sul mercato della seta distrettuale.
Questo il quadro che fa del settore serico varesino il Regio visitatore Odescalchi nel 177381 e poi ancora l’anno successivo:82
Vi sono in questo borgo forse 400 telai di nastri di seta e filogello, e circa altri otto per movelle e fazzoletti. Esaminate queste manifatture, non si sono trovate delle più ben fatte. Si sono scusati i manifatturieri sulla carezza delle sete e sul buon mercato voluto da chi loro commette le dette manifatture. La scusa addotta dai lavoratori, se si considera in relazione unicamente d’un privato interesse, sembra compatibile: ma sull’oggetto grande del commercio e dell’utilità, se potessero rendersi le manifatture in grado tale di perfezione che superassero le forastiere, sembra rendersi necessaria una precisa legge sopra la qualità dei lavori. Se non altro quando potessero introdursi in Varese que’ telai che lavorano più pezze di nastri in un colpo, potrebbero impiegarsi utilmente più mani e più materia prima a vantaggio dello Stato.
Questa importante signoria non farà meno di tremila anime, e generalmente tutti s’industriano in qualche modo. Vi sono molti fabbricatori di drappi di seta, e di filogello, di cendadi, e fazzoletti. Le donne battono i telaj da nastri, o dispongono le sete per i diversi lavorerj: come ho detto in altra mia relazione, non saranno meno di n. 400 telaj circa impiegati per le riferite manifatture.[…]Se l’annate sono abbondanti nel raccolto delle sete, la minuta gente di questo distretto si procaccia conveniente guadagno, ma riuscendo scarse, dice il Ricettore, esservi molte persone senza impiego. Rilevò anzi il medesimo che sarebbe stato opportuno introdurvi la filatura del cotone, e la fabbrica di fustagni e bombasine.
80 A partire dal 1756 – quale modo migliore per datare l’erezione del filatoio Molina? – Paolo Andrea Molina del fu Antonio esige soltanto gallette dai massari del patrimonio dell’Eredità Sessa, evidentemente per commettere il lavoro di trattura e di prima filatura secondo i nuovi dettami, sotto il suo diretto controllo (v. ASVa, AO, Eredità Sessa, registro 10, “Giornale Eredità Sessa…” [1750-1773]).81 Relazioni sull’industria 1941: 150-151.82 ASMi, Studi, p.a., cart. 192, “1774. 2 luglio. Relazione del Regio Visitatore Odescalchi sopra il commercio, manifatture ed agricoltura”.
155
Da tali brani si deducono alcuni fatti fondamentali:
1. la domanda di lavoro a Varese esorbita largamente le possibilità locali di occupazione;
2. proprio per questo è relativamente diffuso il lavoro a domicilio e famigliare di tipo artigianale o manifatturiero;
3. ne consegue un vasto serbatoio di forza-lavoro disposta a occuparsi nel settore secondario, per bassi salari, anche a fronte di un’offerta di lavoro volatile;
4. la seta filatoiata ha un costo relativamente elevato, benché il comparto non sia fra i più derelitti dello Stato, il lavoro sia localmente a buon mercato e l’offerta di materia prima crescente.
E’ da rimarcare la forte connotazione operaia e manifatturiera del borgo – altra storia quella delle castellanze, sebbene facenti parte del corpo del comune --. I 400 telai rapportati ai tremila abitanti del borgo danno la misura del carattere industriale e artigianale della città. Ma il dato ancora non dice abbastanza sulla costruzione storica e sociale del mercato del lavoro cittadino. Ai vellutari di tessuti serici di fine ’500 e dei primi decenni del ’600,83 eredi di una tradizione laniera che il distretto non smarrisce interamente, subentrano dopo la peste manzoniana centinaia di addetti alla filatura che affluiscono attirati dall’opportunità di lavoro. Ancora una volta sono i numeri a impressionare. Le 47 torciere censite nel 1679 contano al loro servizio non solo il mezzo migliaio di persone direttamente implicato nel lavoro delle manifatture accentrate, “sebbene sogliono per ordinario lavorare non più di sei in otto mesi per ciascun anno, conforme al maggior o minore raccolto della seta”,84 ma soprattutto migliaia di maestre dedite all’incannatura della seta fra le mura domestiche, specializzate nel dipanare la seta greggia in matassa avvolgendola su rocchetti per le operazioni meccaniche svolte successivamente all’interno dei filatoi. Ogni manifattura assimilabile alle torciere varesine – secondo il modello veronese che ha permesso già di stimare il volume di filato negli anni ’70 del secolo XVII – necessita di circa 150 maestre.85 Ciò vuol dire che nelle fasi parossistiche dell’attività di filatura all’incirca 7.000 persone – evidentemente non solo nelle case del borgo ma in tutto il distretto – si dedicavano, nel terz’ultimo decennio del ’600, all’operazione che
83 Cfr. BEONIO-BROCCHIERI 2000: 108; VIGO 2000: 39-40.84 ASCMi, Materie, cart. 875, doc. 21, lettera a stampa della Giunta per il ristabilimento del mercimonio al Magistrato ordinario, Milano, 5 giugno 1679.85 Cfr. PONI 1976: 461.
156
completava la prima trasformazione del prodotto organico in semilavorato tessile pronto a entrare come input di produzione nella lavorazione meccanica della fibra.
Il generale malessere della città nella saldatura fra il XVII e il XVIII secolo è connesso alla fase di massiccia disoccupazione che colpisce le forze di lavoro, che le costringe a emigrare o a riconvertirsi -- in una frazione davvero minima -- in indotto dei nuovi impianti idraulici, assai più produttivi dei filatoi manuali, oppure nuovamente in tessitori, di una materia prima che è largamente disponibile in loco, e tuttavia su cui pesano le pretese delle due grandi ditte di filatura operanti in loco. Ne risulta, a valle, per tutto il Settecento, un comparto serico a basso valore aggiunto e assai mal remunerato, che sul piano dell’occupazione rivela di aver ridotto drasticamente l’offerta di lavoro rispetto al secolo precedente, in ragione della meccanizzazione della filatura. In merito, la testimonianza più completa ce la fornisce l’Intendente politico provinciale Giacomo de Battisti, nel 1790:86
Nelle comunità del Distretto non vi sono fabbriche di manifatture, alla riserva del borgo di Varese, nel quale vi sono sei o otto fabbriche di stoffe di seta, e filoselo, drappetti, fazzoletti, damascati di seta, e di filosello, cendali e mocogliate; inoltre vi sono molti fabbricatori di bindelli da seta d’ogni colore. Vi sono altresì circa 20 filande da seta nel borgo e castellanze di Varese, e n. 50 altre circa nelle comunità del Distretto.In Varese esistono due filatoj e n. 8 molini, e nelle altre comunità del Distretto non ve ne sono: […] circa 20 in 24 persone sono impiegate nelle dette fabbriche e ricevono il sostentamento da queste manifatture. Un grosso numero di donne disperse nel borgo di Varese sono impiegate a far bindelli, dal di cui lavorerio ritraono la tenue mercede di soldi 6 a 8 al giorno. Due donne s’impiegano per ogni filanda, oltre il direttore, e due per ogni filatojo e molino, dal di cui lavoro non ritraono il totale sostentamento, poiché le filande durano 30 in 40 giorni all’anno, ed i filatoj e molini non sono operosi tutto il decorso dell’anno.[…] La materia delle suddette manifatture, che consiste in seta, filosello e filo, viene ricavata nel proprio borgo.[…] Li suddetti generi si vendono in Stato e fuori Stato, e specialmente agli esteri Svizzeri. Lo smercio era più abbondante in passato che al presente, ed il motivo della diminuzione si vuole che procede dall’aggravio de’ dazj. Lo smercio della seta è piuttosto abbondante, non potendosi però individuare il quantitativo della greggia e della lavorata, facendosene di quest’ultima maggior smercio in diverse piazze estere e dello Stato, calcolandosi l’introito di questa seta in annue L. 200 mila circa. [Inoltre] si calcola all’anno per un dipresso l’introito in Paese di 30 in 40 mille lire dallo smercio che si fa dalle manifatture di stoffa e filosello.
E tuttavia i Molina, sull’onda della congiuntura positiva sui mercati esterni, possono sfruttare la produttività più elevata, finché almeno
86 ASMi, Commercio, p.a., cart. 12, “Protocolli della Visita generale in affari di commercio fatta dal Regio Intendente politico di Varese Giacomo de Battisti” (1790-1791), Distretto IX [di Varese], Varese, 21 dicembre 1790.
157
possono godere in sede locale di un basso costo del lavoro e di un mercato protetto che li sottrae alla concorrenza degli impianti hi-tech rappresentati dai filatoi integralmente “alla bolognese” (in cui anche l’incannatura è meccanizzata e inglobata nelle fabbriche) o “alla piemontese”.
Ci sono dunque tutti i presupposti per presumere che il potenziale di accumulazione del settore, in termini di capitale, in una situazione di perdurante asimmetria nell’accesso alle risorse, sia elevato fino al penultimo decennio del secolo.
I MOLINA DA FILATORI A CARTAI
1788, 7 gennaio, Carl’Antonio, il dottor fisico Luigi, Antonio Vittore e il curato di Casciago Superiore Giuseppe Molina, figli del fu Paolo Andrea, realizzano quanto era implicito nella concessione perpetua del Mulino del Maglio, fin dal 1741: l’aspirazione a saldare, presto o tardi, il diretto all’utile dominio, quale frutto maturo di una lungimirante, testarda strategia di messa in valore delle potenzialità economiche del bene. L’atto notarile naturalmente riporta allegata la concessione originaria al padre, ma gli affianca la documentazione di una pratica più che settennale a cui fa da innesco la legge generale sulle manimorte del 1767 che riconosce agli utilisti la facoltà di procedere in ogni momento al riscatto dei beni stabili.87 Il lungo contenzioso, inaugurato nel 1780 dalla lettera con cui i fratelli Giuseppe, Carl’Antonio, Luigi e Bartolomeo Molina chiedono all’autorità di Milano l’affrancazione del bene, deriva dalla tenuità del prezzo del riscatto (7.500 lire), stabilito, peraltro, dall’investitura di quattro decenni prima. La transazione finale prevede la cessione da parte dei Molina agli amministratori della Pia causa Frasconi (il prevosto di Varese e il curato di Biumo Inferiore) di cartelle del R. I. Monte di Santa Teresa per L. 7.680, che garantiscono all’opera pia un interesse annuo del 3½ per cento, pari a 268:16 lire, un quinto in più della rendita enfiteutica, e il pagamento dei canoni di livello arretrati a partire dal decreto governativo di affrancazione emanato nel 1781 ma rigettato dagli esecutori testamentari e dagli amministratori della Pia causa Frasconi.88 La duttilità mostrata dai Molina nel ricercare un accordo con la controparte, a costo di procrastinare sì lungamente l’esito, e di elevare l’esborso che il diritto concede loro, si deve all’indubbia convenienza del negozio, che il formalismo dell’atto notarile, così come degli atti che lo precedono, cela a fatica continuando a riferirsi a una res che non è più: “un mulino da macina con piccoli pezzi
87 Per un inquadramento generale di tale legge, CAPRA 1984: 387-388.88 Tutta la documentazione in ASCo, Notarile, cart. 4816, Giuseppe Baroffio, n. 451, 1788 gennaio 7.
158
di terra adiacenti, in territorio […] di Biumo Sotto”…89
Fino al 1796 Varese rimane una città della seta. Tuttavia con sempre maggiore difficoltà, negli ultimi lustri del secolo XVIII, le sue produzioni seriche riescono a tenere dietro all’evoluzione del mercato internazionale e alla concorrenza sempre più invadente, sul mercato domestico e su quello elvetico, delle manifatture comasche.90 La congiuntura è un potente fattore di spinta nei confronti della manodopera specializzata, che è disposta, in Lombardia, ad abbandonare aree di antico e consolidato insediamento serico per le nuove frontiere della seta.91 Sul piano locale la tendenza si palesa con la diminuzione della popolazione nella Pieve di Varese fra il 1771 e il 1787, nel quadro di una provincia comasca che invece cresce ancora in modo sostenuto.92
Con l’inizio del Ventennio francese, Varese vede contrarsi i suoi tradizionali mercati di sbocco, innanzi tutto per la seta filatoiata. Il ripristino del dazio sull’esportazione per le sete greggie che, giunte dalla Svizzera, vengono riesportate ridotte in filato provoca la riduzione del lavoro per le filature in tutto il Dipartimento del Lario.93 L’abolizione da parte di Vienna del trattamento fortemente agevolato accordato nel 1784 alle stoffe lombarde dirette ai mercati degli stati ereditari,94 cui si aggiungono gli effetti della guerra franco-austriaca, porta nel 1796 all’interruzione dell’esportazione di tessuti verso l’Impero.95 Per sovrappiù, le difficoltà
89 Questo il tenore della richiesta di affrancazione da parte dei Molina nel luglio 1780, ma la descrizione si conserva fino all’ufficiale “vendita ossia affrancazione di livello fuori alli signori Molina e dalla Causa Pia Frasconi” del 7 gennaio 1788 (ASCo, Notarile, cart. 4816, Giuseppe Baroffio, n. 451).90 Sulla generale depressione dei prezzi del mercato serico negli anni Ottanta e Novanta del secolo XVIII, essenzialmente per l’arrivo in Europa delle sete asiatiche, CHICCO 1995: 293 ss. e passim. Sulla crescita del setificio comasco, MOIOLI 1981: 100 ss.; COVA 1987. A fronte di una crescita forse anche quadrupla del patrimonio gelsato nello Stato di Milano nei cinquant’anni centrali del secolo XVIII (MOIOLI 1981: 134-135), la produzione di seta nel borgo e nelle castellanze di Varese non riesce a crescere più del 25% fra il 1747-49 e il 1807 (da una media di 16.856 libbre a un totale di 21.120 libbre) (ASMi, Catasto, cart. 3036, “Pieve di Varese. Risposte ai 45 quesiti” [1751-54]; Studi, p.m., cart. 1160, risposte del Pro Podestà Carl’Antonio Molina al questionario a stampa del 15 luglio 1807 [Varese, 14 ottobre 1807]).91 Cfr. CHICCO 1995: 292 ss. e passim; MOIOLI 1981: 103-104 (sul trasferimento di maestranze lombarde o di aree limitrofe nel Bengala per condurvi a perfezione le tecniche della trattura).92 CORRITORE 2002: 29, 31-32.93 Cfr. COVA 1987: 168.94 Fino al 1796 “l’interrotto smercio per gli Stati della Monarchia austriaca […] restava animato dalle facilitazioni nella daziaria, poiché introducendo ivi le manifatture nostrali, in luogo del pagamento del 60 per cento collà imposto a tutte le merci estere, si caricavano quelle della Lombardia del solo 10 per cento, la qual cosa importava che gli altri non potessero stare in concorrenza” (ASMi, Commercio, p.m., cart. 9, rapporto della Camera primaria di commercio di Milano al Prefetto del Dipartimento d’Olona, Milano, 31 gennaio 1805).95 Cfr. COVA 1987: 191 ss.; MOIOLI 1992: 183.
159
a esportare coincidono con l’affermarsi di nuovi orientamenti nel campo della moda che rendono più ostico per la tessitura serica anche il mercato domestico. Nel nome di un “ritorno alla natura”, si invoca l’uso di abiti chiari di tela e di cotone, “sbandendo l’uso delle vesti di seta” ricche e raffinate, orientando tutta la piramide sociale a un maggior consumo di tessuti di cotone e di lino.96 La crisi congiunturale provoca disoccupazione e la forte emigrazione di tessitori dal Comasco (e dal Varesotto).97 La Pieve di Varese – questa volta in sintonia con il resto della provincia comasca -- manifesta, fra il 1787 e il 1799, una chiara tendenza alla diminuzione delle forze di lavoro, con l’accentuarsi delle correnti di emigrazione a lunga distanza -- complice la leva della Repubblica Cisalpina. --, in particolare verso i paesi svizzeri e tedeschi.98
Il drastico contrarsi degli sbocchi nei segmenti a valle della filatura serica si ripercuote su questa come un colpo di frusta. La filatura e, ancora a monte, la trattura della seta, che avevano conosciuto un’incessante espansione nella provincia comasca almeno dagli anni ’60,99 sono investite da una crisi che opera selettivamente ai margini delle produzioni. I forti scompensi che si manifestano fra domanda e offerta di semilavorato costringono gli impianti meno produttivi, o più svantaggiati sotto il profilo dei costi di distribuzione, a lunghi periodi di inattività, aggravando le loro difficoltà. Ne consegue una selezione territoriale e aziendale che mette fuori gioco gli impianti pur nuovi ma meno moderni, oppure che in ragione del più alto costo della localizzazione urbana lascia il passo a nuove meravigliose fabbriche rurali, di dimensioni maggiori e con maestranze più docili e flessibili.
Tale selezione colpisce in particolar modo la filatura varesina, ma non solo: da Besozzo si avverte fin dal 1798 che “mancano in questo Dipartimento [del Verbano] fabbriche di seta e di lana”, sicché, anche se “abbondano le filande, fuor esce la seta gregia per mancanza di lavoratori e di elaboratori”.100 Sette anni dopo il problema è strutturale, poiché – si denuncia – “non vi sono nemmeno filere in questo cantone di Varese
96 Cfr. CHICCO 1985: 304-305. E inoltre ASMi, Commercio, p.m., cart. 9, rapporto della Camera primaria di commercio di Milano al Prefetto del Dipartimento d’Olona, Milano, 31 gennaio 1805.97 Cfr. COVA 1987: 202; MOIOLI 1992: 220n-221n. Il Comasco subisce fra il 1795 e il 1805 un vistoso calo demografico per l’emigrazione di consistenti forze di lavoro (CANETTA 1987: 486). Nella città di Como i telai battenti nel ramo serico precipitano da 1.333 nel 1795 (e ancora 1.307 nel gennaio dell’anno successivo) a 375 nell’ottobre 1796. La crisi dura per lo meno fino ai primissimi anni dell’800 (GIOIA 1804: 109).98 CORRITORE 2002: 29-32.99 COVA 1987: 168.100 ASMi, Commercio, p.a., cart. 14, rapporto del Capo Legione Bernago all’Amministrazione centrale del Verbano del 22 Nevoso Anno VI Repubblicano [11 gennaio 1798].
160
[…]: per condurre un filatoio bisogna stentare molto per avere le filere di altri paesi, massime che vi sono molti filatoi nei vicini paesi di Luvino, Germignaga, Porto ed in molti altri centri del circondario”.101 Il fatto segnala un cambiamento di struttura: il borgo e il suo distretto non sono più importatori di seta greggia da lavorare, ma sono diventati esportatori netti di seta tratta, che viene ora lavorata nel circondario, per lo più sul Lago Maggiore, nel cantone di Luino.
In questo cambiamento – che pure assegna ancora un ruolo alla tessitura di nastri di seta o filogello, esercitata a Varese “in quasi tutte le case dal basso popolo”102 – è da ricercare la motivazione più semplice della decisione dei fratelli Molina di mutare attività, abbandonando la filatura serica e riconvertendo l’impianto totalmente in loro possesso in manifattura della carta.
Tale riconversione, peraltro, è frutto di un più diffuso convincimento sulle magnifiche e progressive sorti dell’industria cartaria in confronto alle prospettive di quella serica. Tanto che Simonde de Sismondi può esprimersi così nel 1799 (in verità, occupandosi della Toscana): “la fabrique de soie est sur son déclin […], la fabrique de papier est au contraire dans toute la vigueur de la jeunesse, l’avenir ne lui promet que prosperité”.103
Nel caso lombardo, del resto, come nota efficacemente Angelo Moioli:104
Va da sé che in connessione con il consolidarsi della nuova compagine statuale anche la manifattura cartaria, esercitata con vari gradi di concentrazione nella regione, si sia trovata a beneficiare in via diretta e indiretta di una domanda aggiuntiva. I moltiplicati fabbisogni di questo articolo connessi con la creazione di un sempre più articolato apparato burocratico, e con le maggiori esigenze di formalizzazione imposte dalle procedure amministrative più complesse che si andavano adottando, non potevano infatti non riflettersi positivamente sullo stato della produzione cartaria lombarda.
A tale scenario favorevole si aggiungono a Varese plurimi motivi per impiantarvi un’attività cartaria.
L’insediamento della corte di Sua Altezza Serenissima Francesco
101 ASCo, Prefettura, cart. 919, 1805 (cfr. COVA 1987: 170).102 ASMi, Commercio, p.m., cart. 8, relazione del Prefetto del Dipartimento del Lario al ministro dell’Interno, Como, 5 dicembre 1804.103 Cfr. SABBATINI 1992: 104-105.104 MOIOLI 1992: 196, che cita in nota il rapporto della Camera primaria di commercio di Brescia alla Prefettura dipartimentale del Mella del 28 novembre 1804: “E’ innegabile che dietro l’introdottosi grandioso consumo della carta in tutti i dicasteri, e dietro la dilatazione del commercio di dettaglio, le dette fabbriche [cartiere] hanno considerabilmente aumentato, in confronto de’ tempi anteriori alle occorse variazioni” (ivi: 230n).
161
III, duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc., oltre che, finalmente, signore di Varese dal 1765 sino alla sua morte nel 1780, rappresenta un vero e proprio salto di qualità per la vita culturale, civile e amministrativa del borgo. Varese sale alla condizione, prima, di corte nobiliare estiva, quindi di capoluogo provinciale e di municipalità, infine di città. L’introduzione dell’arte tipografica a Varese ha come principale motivo l’avvio di un’attività operistica strutturata, con l’apertura di un teatro d’opera nel 1776 e l’inaugurazione del Teatro Ducale nel 1779.105 Successivamente la stamperia Motta e Pedemonti deciderà di risiedervi stabilmente, abbandonando Milano – nel caso del Motta --, sulla scorta del decentramento di funzioni amministrative di grado provinciale prima a Gallarate, dove la ditta opera dal 1786 al 1787, poi a Varese, con il trasferimento colà degli uffici della nuova provincia. Per inaugurare l’attività, dai torchi bosini uscirà un Promemoria per l’Insigne Borgo di Varese (1787) dai toni così accesamente municipalistici da essere proibito dalla Polizia.106 Dal 1796 la tipografia, diventata Pedemonti, si specializzerà in stampati e opere quasi esclusivamente di carattere amministrativo e commerciale.107
L’insediamento a Varese di una ditta tipografica, con un’attività non più stagionale ed episodica dal 1787, si giustifica con il rilevante incremento delle attribuzioni amministrative, giudiziarie, politiche, fiscali assegnate a uffici e uomini del borgo a partire da quell’anno. Non è difficile immaginare quale lievitazione nel consumo di stampati, e quindi di carta, possa aver provocato in successione l’elevazione di Varese a sede dell’Intendenza politica provinciale nell’ottobre 1787108 o a capoluogo del Dipartimento del Verbano nel giugno 1797 (con la successiva istituzione in loco dei tribunali dipartimentali e correzionali).109
La domanda aggiuntiva di carta va dunque progressivamente affermando il ruolo nuovo dell’industria cartaria nell’ambito della struttura produttiva e della bilancia commerciale del Dipartimento del Verbano. Se fino all’istituzione del Dipartimento rimangono in ombra le attitudini all’esportazione (verso la Svizzera soprattutto) delle cartiere
105 Cfr. COVA 2001 (la prima committenza è rappresentata soprattutto da libretti d’opera, ma anche da un sonetto encomiastico in onore del duca).106 Cfr. AMBROSOLI 1973; AMBROSOLI 2001; COVA 2001; SARTORELLI 2001.107 AMBROSOLI 2001: 32.108 Sia sufficiente notare che la sola decisione di erigere la nuova provincia significò la pubblicazione, nel 1786, di un editto particolare con “il comparto territoriale spettante a ciascuna Intendenza e successivamente un ‘Tometto’ d’istruzioni diviso in 49 paragrafi di istruzioni generali e 10 particolari” (GIAMPAOLO 1958).109 Cfr. GIAMPAOLO 1958; GIAMPAOLO 1959.
162
di Besozzo,110 e ancora un prospetto generale del febbraio 1798 sul commercio attivo e passivo del Dipartimento trascura la voce “carta” dando rilievo all’onnipresente settore serico,111 le relazioni che in tale occasione vengono stilate in alcuni distretti forniscono un quadro assai più lusinghiero del comparto cartario varesino. Da Besozzo si rileva la presenza di “parecchie cartiere il di cui smercio passa a Milano e nel Novarese”; da Laveno si sottolinea l’esistenza di un “florido smercio di carta [che procede] da circa n. 10 cartiere per lo Stato Sardo, Svizzera, Parma e Piacenza”, o, in altra relazione, di “alcune fabbriche di carta in Besozzo [da cui] si smercia nella Repubblica e se ne spedisce nelle vicine provincie sarde”.112
Tali testimonianze sono significative, anche perché dimostrano l’attivazione di diverse cartiere nel Varesotto fra il 1779 (quando si rileva l’esistenza di impianti soltanto a Besozzo e Lonate Ceppino)113 e il 1798 (quando si parla di “varie fabbriche sparse qua e là” nel Dipartimento).114 Nel frattempo, è quindi avvenuto un processo di diffusione dell’attività cartaria dal polo originario di Besozzo, dove il quinto (e ultimo) impianto risale al 1753 o di lì appresso,115 ad altre località del Varesotto.
110 Sull’esistenza di esportazioni di carta dal Varesotto e dal Comasco verso le terre elvetiche nel 1767, CARERA 1992: 234n. Nel 1790 scrive l’Intendente politico provinciale Giacomo de Battisti, trattando del polo manifatturiero di Besozzo: “Ricavano le cartere la materia dai Paesi circonvicini dello Stato ed anche di fuori Stato. […] E nello Stato e fuori Stato si vendono le carte di dette [cinque] fabbriche, lo smercio però in questo circondario è scarso in proporzione del prodotto di tali cartere, per cui si procura lo smercio anche fuori d’esso, e fuori Stato. […] Verosimilmente entrerà nello Stato per le carte che si vendono fuori Stato, annue L. 10.000” (ASMi, Commercio, p.a., cart. 12, “Protocolli della Visita generale in affari di commercio fatta dal Regio Intendente politico di Varese Giacomo de Battisti” [1790-1791], Distretto VIII [di Brebbia più Leggiuno], Gavirate, 18 dicembre 1790).111 ASMi, Commercio, p.a., cart. 14, “Nel Dipartimento del Verbano. Commercio attivo. Necessariamente passivo. Passivo che si potrebbe almeno diminuire…”, 25 Piovoso, Anno VI Repubblicano [14 febbraio 1798].112 ASMi, Commercio, p.a., cart. 14, progetti inviati all’Amministrazione generale del Dipartimento del Verbano all’inizio del 1798.113 ASMi, Uffici e tribunali, p.a., cart. 832, p. 156, consulta della Camera dei conti del 7 ottobre 1779 (la statistica generale parla però ambiguamente, a proposito di Besozzo, di una sola “fabbrica” di carta e 5 “tini di lavoro”, mentre a Lonate Ceppino enumera una “fabbrica” con un tino). A proposito della cartiera di Lonate, riferisce nel 1790 Giacomo de Battisti: “Le persone impiegate alla suddetta fabbrica saranno ad un dipresso n. 6. […] Ricevono i fabbricanti le materie necessarie in Paese e nei circonvicini. […] La carta viene venduta in Stato e l’esito è discreto. […] Non si fa smercio fuori Stato” (ASMi, Commercio, p.a., cart. 12, “Protocolli della Visita generale in affari di commercio fatta dal Regio Intendente politico di Varese Giacomo de Battisti” [1790-1791], Distretto V [di Castel Seprio], Tradate, 26 novembre 1790).114 ASMi, Commercio, p.a., cart. 14, progetto dell’avv. Carlo Daverio, s.d. (ma 1798).115 Si tratta della cartiera Marliani-Besozzi eretta in località Molinazzo (cfr. CANI 2001a: 138; AIROLDI 2001: 45).
163
Non c’è dunque da stupirsi se il 20 aprile 1805 si trova la prima notizia sulla trasformazione dei Molina da imprenditori serici a imprenditori cartari.116 In tale data infatti:
Il prefetto del dipartimento, cittadino Longo, annuncia essersi stabilita per il giorno stesso della solenne incoronazione di Napoleone I in Re d’Italia [il 26 maggio], la festa nazionale che dovevasi celebrare nella prima domenica di giugno. Voglionsi ora per questa fausta e straordinaria circostanza distribuire premi ed elargizioni in denaro. Chiede quindi alla Municipalità se esistono cittadini noti per la importanza delle industrie o delle manifatture, che esercitino o che hanno, per i primi, introdotte in paese, oppure padri di dodici figli viventi. Fra i primi trovansi il dr. Luigi Molina per la fabbricazione a mano della carta…
Il premio per l’innovazione industriale a Luigi Molina si deve certamente a quanto l’anno prima ha segnalato il Gioia nella sua Discussione economica sul Dipartimento del Lario: l’attivazione se non di due, di un cilindro olandese a Varese.117
La messa in opera di uno o due cilindri olandesi è quindi un fatto recente. La notizia che nel 1804 l’edificio dei Molina originariamente dedicato alla macinazione (e quindi alla filatura serica) è stato sottoposto a una drastica ristrutturazione, con un intervento sui rodigini ridotti da tre a due,118 non può che significare l’introduzione del cilindro olandese, attestata del resto, per altra via, dalla qualità della carta prodotta (nel 1808 si definisce la cartiera specializzata nella produzione di “carta da scrivere ad uso di Bergamo”).119 Si tratta però ancora – come attesta lo stesso documento del 1808 – della convivenza tra pile e cilindro (raffinatore) in una versione che non ha ancora fatto proprie tutte le potenzialità della nuova tecnologia.120 Anche se è da presumere che la pubblica attestazione della novità tecnologica introdotta a Varese (premiata solennemente l’anno successivo) non possa aver indotto il Gioia all’errore grossolano di accrescere il numero degli ordigni in uso a Varese: il suo scritto segnala piuttosto, con ogni probabilità, l’esistenza nella cartiera Molina di due tine con due diversi cilindri olandesi.121 Peraltro la fondazione della cartiera non deve essere stata di molti anni precedente: il premio assegnato ai Molina si deve infatti a un’attività insediata da poco in città, e fino al 1798 non vi è testimonianza di lavorazione della carta a Varese. E’ quindi probabile
116 GIAMPAOLO 1959: 192.117 GIOIA 1804: 115.118 Vedi supra la nota 10.119 Vedi supra la nota 13.120 Cfr. MATTOZZI 2005 (in questo volume).121 L’esistenza di due tine (o due “fabbriche”) all’interno della cartiera Molina è attestata nel 1818 (ASMi, Commercio, p.m., cart. 110, “Tabella portante le diverse notizie delle fabbriche di carta esistenti nella Provincia di Como”, Como, 11 ottobre 1818).
164
che le dichiarazioni più esplicite e accurate dei Molina sull’epoca di avvio del “negozio” – nell’“anno 1800” o “nell’anno 1801”— siano anche le più attendibili, pur lasciando un piccolo margine d’incertezza sul momento esatto a partire dal quale la cartiera fu realmente operativa.
L’introduzione del cilindro olandese raffinatore nel 1804 è però solo una delle innumerevoli tappe della progressione tecnica e organizzativa che questa famiglia di imprenditori dimostra di saper mettere in atto nella gestione della propria azienda. Negli anni 1816-17 la successione di Paolo Andrea (Giuseppe) Molina di Luigi (1795-1860) allo zio Antonio Vittore, deceduto nel 1816, è l’occasione per riattare e riammodernare gli impianti e introdurre un cilindro di nuova concezione ideato dall’“espertissimo macchinista” Giuseppe Della Bianca di Borgosesia.122
Con l’ammodernamento, l’efficienza della cartiera, i volumi di produzione, la gamma dei prodotti, ma soprattutto il valore aggiunto crescono considerevolmente, come è evidente dalle statistiche consegnate nel 1819, che pur andrebbero depurate dei periodi di inattività, per i lavori di riattamento, e della ritardata operatività -- nel secondo quadriennio -- dei nuovi apparati.123
Prodotto medio annuo della cartiera Molina nei quadrienni 1811-1814 e 1815-1818 e suo valore.
Tipi di carta 1811-14 1815-18(risme) (lire it.) (risme) (lire it.)
“Carta fine” 3.000 21.000 3.800 26.600“Carta più ordinaria da scrivere” 4.000 18.000 4.000 18.000“Carta per stampe” 400 2.000 600 3.000“Carta reale” - 200 3.600“Carta ordinaria per involti ed altri usi” (Kg)
400 194 500 242
Totale 41.194 51.442
Fonti: ASCVa, cat. XI, cart. 36, Statistiche industriali, “Prospetto delle principali manifatture esistenti nel Distretto di Varese”, Varese, 22 maggio 1819.
Se si considera che il profitto dell’attività nell’anno 1812 raggiunge la rispettabile somma di 5.930:50:2 lire italiane (divise fifty-fifty fra Antonio
122 Esposto alla Pretura di Varese di Paolo Andrea Molina allegato a ASCo, Notarile, cart. 5150, Teodosio Cesare Savini, n. 2220, 1819 giugno 21. Cfr. CANI 2001b: 147. Sul Della Bianca, cfr. MATTOZZI 2005 (in questo volume).123 Nel 1818 le due tine della cartiera Molina producono 14 risme di carta al giorno e consumano complessivamente 34.000 Kg di stracci l’anno (ASMi, Commercio, p.m., cart. 110, “Tabella portante le diverse notizie delle Fabbriche di carta esistenti nella Provincia di Como”, Como, 11 ottobre 1818).
165
Vittore e Luigi), pari al 14 per cento del fatturato e a più del capitale liquido anticipato (4.605:11:1 lire) dal dott. Luigi, “proprietario capitalista di detta fabbrica”, al momento della stipula della società con il fratello (probabilmente nel 1805),124 si può valutare meglio l’elevata redditività dell’impresa.
Peraltro la ristrutturazione della cartiera negli anni 1816-17 avviene in una fase di flessione del mercato poiché:125
E’ notorio che dopo la cessazione di tanti ministeri ed altri uffici subalterni che esistevano in Milano e in tutto il già Regno d’Italia, e la abolizione dei sistemi francesi, si è diminuito a dismisura il consumo della carta e massime di quella di lusso, e quindi, sebbene non siasene diminuito il valore, anzi siasi aumentato, per l’incremento esorbitante del costo delle materie prime, pure il guadagno è scarsissimo, sì per diminuito consumo, come perché questo consumo non è tutto di carta nazionale ma in gran parte di estera fabbricazione.
IN CONCLUSIONE
Da tali primi passi nel settore cartario e dalla storia imprenditoriale pregressa nel settore serico le vicende ottocentesche della dinastia Molina escono quindi, per così dire, demistificate. La loro attitudine all’innovazione e al rischio imprenditoriale in un settore così proteso – nelle parole di Sismondi – verso l’avvenire si può definire un fatto antico, che affonda le sue radici nel milieu cittadino e in una storia manifatturiera più che secolare.
L’introduzione in Valle Olona nel 1828 della prima macchina per la produzione continua di carta in Lombardia126 è solo un episodio di un incessante sforzo di adeguamento tecnologico, da parte delle forze locali più vive, imposto dalle sfide con i mercati di sbocco e di approvvigionamento, i cui esiti sono però determinati dal pieno controllo delle limitate risorse locali e del lavoro.
124 ASCo, Notarile, cart. 5144, Teodosio Cesare Savini, n. 1410, 1813 dicembre 18.125 Esposto alla Pretura di Varese di Paolo Andrea Molina allegato a ASCo, Notarile, cart. 5150, Teodosio Cesare Savini, n. 2220, 1819 giugno 21. Cfr. CANI 2001b: 147.126 Cfr. CARERA 1981: 40 ss.
166
Sinossi diacronica sull’introduzione delle caldaie a vapore nelle cartiere lombarde (1835-58).
Datad’installa-zione
Decreto di approvazio-ne/fonte
Comunee distretto
Cartiera Caldaia Funzione
1835 (dic.) (ASCVa,cat. XI, cart. 36)
Varese/Biumo Inferiore(Distretto di Varese, Provincia di Como)
MolinaPaoloAndreadi Varese
Eric Watsondi Londra(Inghilterra)
“per asciugare la carta”
?(nel 1855 risulta “da tempo attivata”)
(ASMi, Commercio, p.m., cart. 436)
Varese/Biumo Inferiore(Distretto di Varese, Provincia di Como)
MolinaPaoloAndreadi Varese
Ruschettidi Milanodi 1,7 atmosfere
Per asciugare la carta
1853 1853 (26 ott.)(ASMi, Commercio, p.m., cart. 452)
Besozzo(Distrettodi Gavirate, Provincia di Como)
Fratelli Del Vittodi Besozzo
Weiss e Comp.di Zurigo(Svizzera)di 2 atmosfere
Per l’essicca-zione della carta e i “lessivaggi”
1854 1854 (23 set.) (ASMi, Commercio, p.m., cart. 426)
Vaprio d’Adda(Distrettodi Gorgonzola, Provincia di Milano)
Maglia e Pignae Comp.idi Milano
Robert Gordon e Compagnidi Stockport(Inghilterra)di 2½ atmosfere
“qual calorifero della cartiera meccanica producente carta senza fine”
1854 1855 (15 giu.)(ASMi, Commercio, p.m., cart. 429)
Alzano Maggiore(Distretto di Bergamo II, Provincia di Bergamo)
Maglia e Pignae Comp.idi Milano
Ditta Schlegele Comp.idi Milanodi 3 atmosfere
“per uso di semplice riscalda-mento”
1855 1856 (12 mar.)(ASMi, Commercio, p.m., cart. 436)
Varese/Biumo Inferiore(Distretto di Varese, Provincia di Como)
MolinaPaoloAndreadi Varese
Bryan Donkine Compagnidi Liverpool(Inghilterra)di 31/5 atmosfere
“al fine di alimentare una motrice ed a scaldare i cilindri per gli asciuga-menti della carta”
1855(data in cui viene elevato il limite di pressione)
1856 (12 mar.)(ASMi, Commercio, p.m., cart. 436)
Varese/Biumo Inferiore(Distretto di Varese, Provincia di Como)
MolinaPaoloAndreadi Varese
Ruschettidi Milanodi 2½ atmosfere
Per asciugare la carta
167
Datad’installa-zione
Decreto di approvazio-ne/fonte
Comunee distretto
Cartiera Caldaia Funzione
1857 1857 (19 set.)(ASMi, Commercio, p.m., cart. 439)
Briosco(Distrettodi Carate, Provincia di Milano)
Giovanni Prada e Merae Comp.idi Milano
DittaPantaleoneRegazzonidi Comodi 4 atmosfere
“al fine di alimentare il calore nella fabbri-cazione della carta senza fine”
1858 1858 (30 lug.)(ASMi, Commercio, p.m., cart. 444)
Vaprio d’Adda(Distrettodi Gorgonzola, Provincia di Milano)
Maglia e Pignae Comp.idi Milano
Ditta Schlegele Comp.idi Milanodi 4 atmosfere
“qual calorifero e per alimentare una motrice”
1859 Statistica 1873: 64
Varese/Biumo Inferiore(Distretto di Varese, Provincia di Como)
MolinaPaoloAndreadi Varese
Macchina a vapore della forza di 30 cavalli; più due macchine di 8 cavalli ciascuna
Far funzionare l’impianto
Fonti: ASCVa, cat. XI, cart. 36, Statistiche industriali (per il dato del 1835); ASMi, Commercio, p.m., cartelle 426, 429, 436, 439, 444, 452; Statistica 1873.
APPENDICE
DAL GIORNALE DI VIAGGIO DELL’IMPRENDITORE CARTARIO TOSCANO COSIMO CINI E DEI NIPOTI BARTOLOMEO E TOMMASO: LA SITUAZIONE DELLA
MANIFATTURA DELLA CARTA NELL’AREA INSUBRICA NEL 1828
In queste campagne, i gozzi che incominciansi a vedere a Milano si rendono molto più comuni e voluminosi, specialmente in alcuni individui che ne sono veramente deformati. E’ però osservabile che tali escrescenze sono generalmente più comuni e notabili nelle persone del basso popolo ed avanzate in età, che in quelle di buona condizione, e ne’ ragazzi. Onde se ne deurrebbe che questa malattia derivi da qualche abitudine della lor vita, e non da naturale disposizione in lor preesistente.
Al Nord Est di Varese, fuori della strada Maestra per quanto ci hanno detto circa 3 miglia, sta in una valle una rinomatissima fabbrica di carta, de’ Signori Molina, che passa per essere delle migliori del Milanese. La strada da Varese a Como, al solito inegualmente discendente e saliente, è assai buona e traversa belle campagne ripiene di gelsi, granturchi e viti.
Como, patria de’ Plinij, è città vescovile, murata ed assai abitata. L’antiquario vi troverà da osservare molte iscrizioni antiche, fra cui alcune spettanti ai Plinij; e la Cattedrale non che altre chiese richiameranno la sua attenzione. Qualche bel paesaggio ed un piccolo ma non inelegante porto sul lago adornano pure questa
168
Città. Il commercio vi fiorisce, e si occupano particolarmente della filatura della seta e di cotone.
Abbiamo veduta poco distante dalla città, nel borgo di Vico, una bellissima filatura di cotone a macchina, ben montata ed estesa. Le macchine sono le stesse che per scardazzare e filare la lana si adoperano; e, per quanto numerose e complicate che siano, sono messe in moto da un sol rotone che una piccolissima quantità d’acqua fa girare. Pare che questo rotone produca tanto effetto con il suo proprio peso, essendo il suo diametro grandissimo, e dell’acqua non abbisogni che per quell’urto necessario a determinarlo al moto. [Qui] usano per fare i pacchi del cotone un piccolo strettojo a mano che, essendo paruto molto semplice ed elegante, abbiamo disegnato alla figura. Un manubrio con rota mette in moto un’altra rota, che spinge all’insù una sbarra di ferro dentata la quale sorregge un piano mobile. Sei ritti tengono due tavole perpendicolari tra cui si alza il piano mobile: messo il cotone da impacchettarsi fra queste due tavole, si serrano al di sopra tre sbarre orizzontali di ferro. Allora girando il manubrio si spinge il piano mobile contro le tre sbarre superiori, e viene così a comprimersi il cotone, che può legarsi per mezzo di spaghi introdotti in fessiture a tale oggetto praticate nelle tavole perpendicolari.
Non molto lungi da questa fabbrica [il cotonificio Frey & C. di Borgo Vico] verso il sud, al piè d’un monte, prossimamente ad un’antica chiesa [S. Abbondio], è una buona fabbrica da carta d’un Sig. Carcano. Ha ancor egli due tini con le pile ed il cilindro, come nella cartiera sopradescritta, ed usa la stessa falce per tagliare i cenci, e gli stessi feltri (che disse [di] far venire di Brescia ed ora averne ordinati ad Annonay), forse anche più fini. Passano la carta moltissimo al tino, e, dopo averla pressata, portano la pasta sopra un tavolino separato, ove il levatore molto comodamente la leva, ponendola in piano e procurando che i fogli si attacchino poco l’uno all’altro, al qual oggetto mettono al di sopra, dimodoché essa resta sempre fra l’ultimo foglio ed il penultimo. Questa è la prima cartiera ove abbiano usato l’echange praticato dagli Olandesi. Dopo aver perciò levata la carta, la ripressano fortemente e quindi la rilevano in modo che restano a contatto le superficie che prima non lo erano; quindi ancora la pressano forte, e poi ripetono l’operazione, il tutto secondo il metodo Olandese. La spandono sopra due corde a coppia di 2 o 3 fogli soltanto. Quindi la incollano con colla di carniccio, che il fabbricante ci ha detto far venire chiara come l’acqua (non è sembrato che avesse qualche segreto particolare che non voleva far sapere). In quest’occasione, ci ha confermato che il viaggiatore di Canson, per veder il segreto d’incollare nel tino, è stato 3 mesi a far prove a Toscolano, senza che ciò gli riesca. Dopo incollata, spandono la carta a fogli, ma non sappiamo se ripetono l’echange. Quindi, dopo averla fatta ed acquidernata in bottega, la mettono sotto forte pressa, con una tavola ogni risma. La maggior parte delle carte le battono anche sotto un maglio molto debole, quelle sottilissime però non le battono punto, dandogli una forte pressa, la quale serve unitamente all’echange a fornirle di bel piano ed assai lucidezza. Per tutti i rapporti, questa cartiera è migliore e fa miglior carta delle altre che abbiamo fino ad or viste; il fabbricante pare molto intelligente, e ci ha detto che è 12 anni che qua è comune il cilindro. Le forme avevano i colonnelli incatenati insieme, con una traversa di legno ad angolo retto in essi infilata.
Como è assai popolato, e gli abitanti sono molto dediti, come dicemmo, al commercio. Le donne del volgo si assettano il capo come le Milanesi, e portano certi zoccoli di legno altissimi, non solo nel tacco di dietro ma anche davanti, dove hanno come un’altra specie di tacco. Il lago che prende il nome da Como è fatto prossimamente in figura di Y: ne’ vertici delle due branche o rami del lago
169
che restano al Mezzogiorno stanno in uno Como e nell’altro Lecco. La lunghezza di questo lago è di circa 30 miglia sulla larghezza di 3 miglia; la sua altezza dalla superficie del mare è di circa 663 piedi. Ancor qui sono stabiliti due battelli a vapore che uno da Como e l’altro da Lecco vanno ciascun giorno all’estremità settentrionale del lago e tornano.
Essendo il lago molto agitato, e la paura oltre il dovere cresciuta (poiché non abbiamo potuto profittare del legno a vapore), abbiamo fatto pochi passi in barca sul lago, e ci siamo privati del piacere di vedere le rive del più bel lago di Italia, fra cui la famosa Pliniana. A Como, Albergo dell’Angelo assai buono.
Da Como si può andare a Lecco passando alle falde meridionali de’ monti che sovrastanno alla penisola esistente nel lago di Como. La strada per il suo suolo è eccellente e l’unico difetto è l’esser qualche volta un poco stretta.
Lasciansi indietro diversi paesetti, che lungo sarebbe il volere annoverare.
Avvicinandosi a Lecco, si cammina sopra un’altura, donde a destra si vede due laghetti, l’uno d’Oggiano, l’altro di Pusiano, ed in quest’ultimo la graziosa e rinomata Isoletta de’ Cipressi, sebbene cipressi non contenga che pochi.
Giungesi sulla riva del ramo del lago che dicesi di Lecco, e scorgesi di faccia questo paese, onde per arrivarvi conviene fare un lungo giro costeggiando l’acqua ed infine passare sopra un lungo ponte l’Adda emissario del lago di Como. Dopodiché siamo in Lecco, ove all’Albergo della Posta puossi andare, che convenientemente e discretamente vi siamo trattati.
Fonte: ACSMPi, filza non numerata, “Diario di viaggio a Milano (1828)”, tappa del 9 luglio 1828.
197
ABBREVIAZIONI E BIBLIOGRAFIA
MBABassano Museo Biblioteca Archivio Bassano del GrappaASBellinzona Archivio di Stato di BellinzonaASCBormio Archivio storico civico di BormioACPCalcinate Archivio della Cooperativa dei pescatori di Calcinate ACLCh Archivio capitolare laurenziano di Chiavenna - AN Archivio notarileASCo Archivio di Stato di Como - ASC Archivio storico civico - CCC Camera di commercio di Como - CS Fondo Carte sciolte - Notarile Fondo Notarile - Ospedale S. Anna Ospedale di S. Anna - Prefettura Fondo Prefettura - Tribunale Fondo Tribunale di ComoASDCo Archivio storico diocesano di ComoACFOMi Archivio del Consorzio del Fiume Olona a MilanoAOMMi Archivio Ospedale Maggiore di MilanoASCMi Archivio storico civico di Milano - Lettere ducali Fondo Lettere ducali - Materie Fondo MaterieASDMi Archivio storico diocesano di Milano - Visite pastorali Sezione X, Archivio spirituale, Visite pastorali e documenti
aggiuntiASMi Archivio di Stato di Milano - Acque Fondo Acque - Catasto Fondo Catasto teresiano - Censo Fondo Censo - Commercio Fondo Commercio - Confische Fondo Confische - Famiglie Fondo Famiglie - Feudi camerali Fondo Feudi camerali - Finanze Fondo Finanze - Notarile Fondo Notarile - Studi Fondo Studi - Uffici e tribunali Uffici e tribunali regi - p.a. parte antica - p.m. parte modernaBAMi Biblioteca Ambrosiana di MilanoBNBMi Biblioteca Nazionale Braidense di MilanoMCAPn Museo civico d’arte di Pordenone - AP Archivio privatoACSalò Archivio Comunale di Salò - Magnifica Patria Archivio della Comunità della RivieraACSMPi Archivio Cini di San Marcello PistoieseASSo Archivio di Stato di SondrioASCVa Archivio storico del Comune di Varese - Opere pie Archivio Opere pie di VareseASVa Archivio di Stato di Varese - AO Archivio dell’Ospedale di Varese - Catasto teresiano Catasto c.d. TeresianoASVe Archivio di Stato di Venezia - Deputati e aggiunti… Deputati e aggiunti all’esazion del denaro pubblico e
Presidenti delle vendite
198
- Inquisitorato arti Inquisitorato sopra la regolazione delle arti - Inquisitori Stato Inquisitori di Stato - Savi mercanzia Cinque Savi alla mercanzia e Deputati al commercioBNMVe Biblioteca Nazionale Marciana di VeneziaASVi Archivio di Stato di VicenzaÖNBWien Österreichische Nationalbibliothek di Vienna
BIBLIOGRAFIA E SITI INTERNET
ABBIATI 1997: ABBIATI Antonia, Fra Como, Venezia e Amsterdam. Percorsi economici, strategie sociali e conflitti: il caso di Giovanni Battista e Francesco Benzi nella seconda metà del XVII secolo, in BRAMBILLA Elena, MUTO Giovanni (a cura di), La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca, Milano, Unicopli, 1997, pp. 155-174.
Acquedotto di Varese 1894: Acquedotto di Varese. Istromento sociale, Varese, Tip. Maj e Malnati, 1894.
ADAMOLLO, GROSSI 1931: ADAMOLLO Giocanni Antonio, GROSSI Luigi, Cronaca di Varese. Memorie cronologiche pubblicate per la prima volta a cura di Angelo Mantegazza, Varese, Tipografia Arcivescovile dell’Addolorata, 1931.
AIROLDI 2001: AIROLDI Massimo, Il polo cartario di Besozzo: origini, sviluppo e maturità (secoli XVI-XX), tesi di laurea, Facoltà di Economia, Università degli Studi dell’Insubria, anno 2000/1, relatore Renzo P. Corritore.
ALBINI 2002: ALBINI Giuliana, Sulle origini dei Monti di Pietà nel ducato di Milano, in EAD., Carità e governo delle povertà (secoli XII-XV), Milano, Unicopli, 2002, pp. 285-337.
ALFANO 1993: ALFANO Maria, Il Monte di Pietà di Ferrara tra Cinque e Seicento, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, a.a. 1992-1993.
AMBROSOLI 1973: AMBROSOLI Luigi, Per una storia dell’editoria varesina, “Calandari do ra Famiglia Bosina par or 1973”, pp. 81-83.
AMBROSOLI 2001: AMBROSOLI Luigi, Tipografi ed editori a Varese: primi risultati di una ricerca, in Editori e tipografi a Varese. L’editoria nel circondario di Varese dal Settecento alla metà del Novecento. Atti del Convegno di studi (17 novembre 2000 – Palazzo Estense, Varese) dedicato a Ernesto Redaelli, Varese, Edizioni Lativa, 2001, pp. 29-52.
Ancient and Medieval Book 1993: Ancient and Medieval Book Materials and Techniques (Erice, 18-25 september 1992), ed. by Marilena Maniaci and Paola F. Munafò, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1993, 2 voll. (Studi e testi, 357)
ANZANI, PROSERPIO 1996: ANZANI Roberta, PROSERPIO Annalisa, L’economia dell’acqua: la Roggia Molinara in Val Breggia dal 1669 al 1850, tesi di laurea, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, a.a. 1995-1996.
Archivio della Mensa di Como: Archivio della Mensa vescovile di Como. “Volumina Parva” e “Volumina Magna”, introduzione, schede descrittive e indici a cura di Marta Luigina Mangini e Rita Pezzola, Como 2002 (dattiloscritto depositato presso l’Archivio storico diocesano di Como).
199
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1951: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Guida ed inventario dell’archivio di Stato, vol. I, Roma, Ministero dell’Interno, 1951 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, V).
Archivio storico di Bormio: Archivio storico del comune di Bormio. Inventario d’archivio, Milano, Consorzio Archidata, 1996, 2 voll.
ARMOCIDA 1995: ARMOCIDA Giuseppe, Le “Notizie storiche di Besozzo e della famiglia Adamoli” di Giulio Adamoli, in LACAITA Carlo G. (a cura di), Fare Storia. Studi in onore di Luigi Ambrosoli, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 151-164.
BALSAMO 1959: BALSAMO Luigi, Giovann’Angelo Scinzenzeler tipografo in Milano (1500-1526): annali e biobibliografia, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1959.
BALSAMO 1977: BALSAMO Luigi, I primordi della tipografia in Italia e in Inghilterra, “La bibliofilia”, a. LXXIX (1977), pp. 231-262.
BARBIERI 1938: BARBIERI Gino, Economia e politica nel ducato di Milano (1386-1535), Milano, Società editrice Vita e Pensiero, 1938.
BARONI 1979: BARONI Maria Franca, Il preceptum. Note di diplomatica comunale milanese, “Studi di storia medioevale e di diplomatica”, n. 4 (1979), pp. 5-16.
BASANOFF 1965: BASANOFF Anne, Itinerario della carta dall’Oriente all’Occidente e sua diffusione in Europa, Milano, Il Polifilo, 1965.
BASTIANONI 1992: BASTIANONI Curzio, Le cartiere di Colle di Val d’Elsa e i loro segni nella prima metà del secolo XIV, in Produzione e commercio della carta e del libro. Secoli XIII-XVIII, Atti della Ventitreesima Settimana di studi dell’Istituto internazionale di storia economica “Francesco Datini” di Prato (15-20 aprile 1991), a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1992, pp. 221-232.
BEC 1967: BEC Christian, Les marchands écrivains. Affaires et humanisme à Florence, 1375-1434, Paris-La Haye, Mouton, 1967.
BECHTEL 1995: BECHTEL Guy, Gutenberg, Torino, Società editrice internazionale, 1995 (ed. orig. Paris 1992).
BECKER 1995a: BECKER Claudia, Beiträge zur Kommunalen Buchführung und Rechnungslegung in Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen – Funktionen – Überlieferung, a cura di Hagen Keller e Thomas Behrmann, München, Wilhelm Fink Verlag, 1995 (Münstersche Mittelalter Schriften, 68), pp. 117-148.
BECKER 1995b: BECKER Claudia, Die Kommune Chiavenna im 12. und 13. Jahrhndert, Frankfurt-am-Main, Peter Lang, 1995, tradotto in italiano con il titolo Il comune di Chiavenna nel XII e XIII secolo. L’evoluzione politico-amministrativa ed i mutamenti sociali in un comune periferico lombardo, edizione italiana a cura di Guido Scaramellini e traduzione dal tedesco di Gian Primo Falappi, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 2002 (Raccolta di studi storici valchiavennaschi, XVII).
BELLABARBA 1986: BELLABARBA Marco, Seriolanti e arzenisti. Governo delle acque e agricoltura a Cremona fra Cinque e Seicento, Cremona, Biblioteca statale e Libreria civica di Cremona, 1986.
BELOCH 1908: BELOCH Karl Julius, La popolazione dell’Europa nell’antichità, nel Medioevo e nel Rinascimento, Torino, UTET, 1908 (Biblioteca dell’economista, V/XIX).
200
BEONIO-BROCCHIERI 2000: BEONIO-BROCCHIERI Vittorio, “Piazza universale di tutte le professioni del mondo”. Famiglie e mestieri nel Ducato di Milano in età spagnola, Milano, Edizioni Unicopli, 2000.
BESTA 1931: BESTA Enrico, Per la storia del comune di Como, “Archivio storico lombardo”, s. VI, a. LVIII (1931), fasc. 4, pp. 403-424.
BESTA 1945: BESTA Enrico, Bormio antica e medioevale e le sue relazioni con le potenze finitime, Milano, Giuffrè, 1945.
BETTONI 1993: BETTONI Fabio, Le cartiere folignati nell’Ottocento preindustriale, in CASTAGNARI Giancarlo (a cura di), Carta e cartiere nelle Marche e nell’Umbria dalle manifatture medioevali all’industrializzazione, Ancona, “Proposte e ricerche”, 1993, pp. 243-276.
BIANCONI 1985: BIANCONI Sandro, Alfabetismo e scuola nei baliaggi svizzeri d’Italia, “Archivio storico ticinese”, a. XXVI, vol. 101, marzo 1985, pp. 3-28.
BIASI 1999: BIASI Pierre-Marc de, La carta: avventura quotidiana, Torino, Electa/Gallimard, 1999.
BIGATTI 1995: BIGATTI Giorgio, La provincia delle acque. Ambiente, istituzioni e tecnici in Lombardia tra Sette e Ottocento, Milano, Francoi Angeli, 1995.
BISCARO 1915: BISCARO Gerolamo, Panfilo Castaldi e gli inizi dell’arte della stampa a Milano (1469-1472), “Archivio storico lombardo”, s. IV, a. XLII (1915), pp. 5-14.
BONVESIN DE LA RIVA: BONVESIN DE LA RIVA, De magnalibus Mediolani. Meraviglie di Milano, testo critico, traduzione e note a cura di Paolo Chiesa, Milano, Libri Scheiwiller, 1998.
BRAIDA 2000: BRAIDA Lodovica, Stampa e cultura in Europa, Roma-Bari, Laterza, 2000.
BRÉJOUX 1999: BRÉJOUX Jacques, Le passage du papier artisanal au papier de grande série à la fin du XVe siècle, in Le papier au Moyen Âge: histoire et techniques. Actes du Colloque international du Centre national de la recherche scientifique, Institut de France (Paris, 23-25 avrile 1998), éd. par Monique Zerdoun Bat Yehouda, Turnhout, Brepols, 1999, pp. 233-241.
BRENTANI 1915: BRENTANI Luigi, La scuola pubblica a Bellinzona dalle fine del 1300 alla metà del 1500, “Rivista pedagogica”, a. VIII (1915), fasc. 10, dicembre 1915, pp. 3-31.
BRESSLAU 1998: BRESSLAU Harry, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia, traduzione di Anna Maria Voci-Roth, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998.
BRIQUET 1907: BRIQUET Charles Moïse, Les filigranes. Dictionnaire historique dès marques du papier des leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, Paris, Picard, 1907, 4 voll.
BRIQUET 1955: BRIQUET Charles-Moïse, La fabrication du papier, in Monumenta chartae papyraceae historiam illustrantia, vol. IV, Briquet’s opuscula. The complete works of Dr. C. M. Briquet, a cura di Allan H. Stevenson, Hilversum (Holland), The Paper Publications Society, 1955, pp. 1-34.
201
BRIQUET 1968: BRIQUET Charles Moïse, Le filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apprition vers 1282 jusqu’en 1600: a facsimile of the 1907 edition with supplementary material contributed by a number of scholars, edizione a cura di Allan Stevenson, Amsterdam, The Paper Publications Society, 1968, 4 voll.
BRUNELLA 1960: BRUNELLA Riccardo Lodovico, Frammenti di storia besozzese. (Brevi notizie preistoriche e storiche di Besozzo e dintorni), Varese, Tipografia arcivescovile dell’Addolorata, 1960.
BRUZZI 1940: BRUZZI E., L’industria della carta in Prato, “Archivio storico pratese”, a. XVIII (1940), fasc. 3-4, pp. 106-114.
BULFERETTI, COSTANTINI 1966: BULFERETTI Luigi, COSTANTINI Claudio, Industria e commercio in Liguria nell’età del Risorgimento (1700-1861), Milano, Banca commerciale italiana, 1966.
Burgo 1955: 50° Cartiere Burgo, Milano, A. Pizzi, 1955.
BUSONERO, FEDERICI, MUNAFÒ, ORNATO, STORACE 1993: BUSONERO Paola, FEDERICI Carlo, MUNAFÒ Paola F., ORNATO Ezio, STORACE M. Speranza, L’utilisation du papier dans le livre italien à la fin du Moyen Age, in Ancient and Medieval Book Materials and Techniques (Erice, 18-25 september 1992), ed. by Marilena Maniaci and Paola F. Munafò, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1993, vol. I, pp. 395-450.
CAIZZI 1965: CAIZZI Bruno, Industria e commercio nella Repubblica Veneta del XVIII secolo, Milano, Banca commerciale italiana, 1965.
CALEGARI 1985: CALEGARI Manlio, Mercanti imprenditori e maestri paperai nella manifattura genovese della carta (sec. XVI-XVII), “Quaderni storici”, n.s., a. XX (1985), n. 59, pp. 445-469.
CALEGARI 1986: CALEGARI Manlio, La manifattura genovese della carta (sec. XVI-XVIII), Genova, ECIG - Edizioni culturali internazionali Genova, 1986.
CAMMAROSANO 1996: CAMMAROSANO Paolo, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 19964.
CANETTA 1987: CANETTA Rosalba, Città e campagna nell’esperienza demografica, in Da un sistema agricolo a un sistema industriale: il Comasco dal Settecento al Novecento, a cura di Sergio Zaninelli, vol. I, Il difficile equilibrio agricolo-manifatturiero (1750-1814), Camera di Commercio, industria e agricoltura di Como, 1987, pp. 479-572.
CANI 1996: CANI Fabio, La produzione della cultura: i libri a Como nell’età di Volta, “Periodico della Società storica comense”, LVIII, 1996, pp. 109-124.
CANI 1997: CANI Fabio, Prima dei libri. La produzione della carta nel Comasco tra XVII e XVIII secolo, “Periodico della Società storica comense”, 1997, vol. LIX, pp. 15-40.
CANI 1999: CANI Fabio, Il torchio e la scansìa. Produzione e consumo dei libri a Como tra Cinque e Seicento, in L’architettura dipinta di Giovan Battista Recchi, Como, Musei Civici, 1999.b
CANI 2001a: CANI Fabio, Le industrie della carta nel territorio comasco e varesino, in Editori e tipografi a Varese. L’editoria nel circondario di Varese dal Settecento alla metà del Novecento. Atti del Convegno di studi (17 novembre 2000 – Palazzo Estense, Varese) dedicato a Ernesto Redaelli, Varese, Edizioni Lativa, 2001, pp. 131-150.
202
CANI 2001b: CANI Fabio, Leggende di santi, storie di libri: le vicende di un’impresa editoriale tra Cinque e Seicento, “Archivio storico della diocesi di Como”, n. 12, 2001, pp. 93-120.
CANI 2005a: CANI Fabio, Il lavoro dell’acqua, in CANI Fabio, VACCARELLA Rodolfo, Nesso. Il lavoro dell’acqua. L’insediamento urbano e gli opifici a forza idraulica, Como, NodoLibri, 2005, pp. 31-126.
CANI 2005b: CANI Fabio, La manifattura della carta nel Comasco, tra Nesso e Maslianico (XV-XX secolo), in Cinque secoli di carta. Produzione, commercio e consumi della carta nella “Regio Insubrica” e in Lombardia dal Medioevo all’età contemporanea. Convegno di studi (Varese, 21 aprile 2005), in questo volume.
CAPPONI 1993: CAPPONI Alfranco, Storia delle cartiere di Pioraco dai Varano ai Miliani, in CASTAGNARI Giancarlo (a cura di), Carta e cartiere nelle Marche e nell’Umbria dalle manifatture medioevali all’industrializzazione, Ancona, “Proposte e ricerche”, 1993, pp. 57-72.
CAPRA 1984: CAPRA Carlo, Il Settecento, in SELLA Domenico, CAPRA Carlo, Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796, in Storia d’Italia, a cura di Giuseppe Galasso, vol. XI, Torino, UTET, 1984, pp. 153-663.
CARERA 1981: CARERA Aldo, Tradizione ed innovazione nella manifattura milanese della prima metà dell’Ottocento: note sulla produzione della carta (1815-1860), in L’economia lombarda della prima metà dell’Ottocento: alcuni temi di ricerca, a cura di Alberto Cova, Milano, Edizioni Opera Universitaria, 1981, pp. 9-80.
CARERA 1992: CARERA Aldo, La produzione della carta in Lombardia nella seconda metà del XVIII secolo, in Produzione e commercio della carta e del libro (secc. XIII-XVIII), Atti della Ventitreesima Settimana di studi dell’Istituto internazionale di storia economica “Francesco Datini” di Prato (15-20 aprile 1991), a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1992, pp. 233-245.
Carta occidentale 2001: La carta occidentale nel tardo medioevo, a cura di Ezio Ornato, Paola Busonero, Paola F. Munafò, M. Speranza Storace, Roma, Istituto centrale per la patologia del libro, 2001, 2 voll.
Cartiere 1929-30: Le Cartiere di Maslianico, estratto da “Natura”, n. 7-8-9, 1929, n. 6, 1930.
Cartolare di Giovanni Scriba: Il cartolare di Giovanni Scriba (Genova, 1154-1164), a cura di Mario Chiaudano, Mattia Moresco, Torino, Lattes, 1935, 2 voll.
Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato: Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188), a cura di Laura Balletto, Giorgio Cencetti, Gianfranco Orlandelli, Bianca Maria Pisoni Agnoli, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, 1978.
CASANOVA 1928: CASANOVA Eugenio, Archivistica, Siena, Stabilimento di Arti Grafiche Lazzeri, 1928.
CASTAGNARI 1990: CASTAGNARI Giancarlo, Le principali fonti documentarie fabrianesi per la storia della carta dal XIV al XV secolo, in Contributi italiani alla diffusione della carta in Occidente tra XIV e XV secolo. Convegno di studio (22 luglio 1988), a cura di Giancarlo Castagnari, Fabriano, Pia Università dei cartai, 1990, pp. 31-60.
CASTAGNARI 1993: CASTAGNARI Giancarlo (a cura di), Carta e cartiere nelle Marche e nell’Umbria dalle manifatture medioevali all’industrializzazione, Ancona, “Proposte e ricerche”, 1993.
203
CASTAGNARI, GREGOIRE, MANNUCCI 1991: CASTAGNARI Giancarlo, GREGOIRE Réginald, MANNUCCI Ulisse (a cura di), Miscellanea di storia della carta: origini, tecniche, imprenditori, fede religiosa., Fabriano, Pia Università dei cartai, 1991.
CASTAGNARI, LIPPARONI 1989: CASTAGNARI Giancarlo, LIPPARONI Nora, Arte e commercio della carta bambagina nei libri dei mercanti fabrianesi tra XIV e XV secolo, “Atti e Memorie della Deputazione di Storia patria per le Marche”, LXXXVII (1989), pp. 185-222.
CAVALLERA 2002: CAVALLERA Marina, “Pia loca” e società di antico regime (secoli XVI-XVIII), in CAVALLERA Marina, GHEZZI Angelo Giorgio, LUCIONI Alfredo, I luoghi della carità e della cura. Ottocento anni di storia dell’Ospedale di Varese, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 191-258.
CAVALLERA 2003: CAVALLERA Marina, Vie di ascesa economica e sociale: dal Lago Maggiore a Milano, in CAVALLERA Marina (a cura di), I Tinelli. Storia di una famiglia (Secoli XVI-XX), Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 133-163.
CAVALLERA, GHEZZI, LUCIONI 2002: CAVALLERA Marina, GHEZZI Angelo Giorgio, LUCIONI Alfredo, I luoghi della carità e della cura. Ottocento anni di storia dell’Ospedale di Varese. Atti del Convegno promosso dal Centro culturale Massimiliano Kolbe e dall’azienda ospedaliero-universitaria Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (Varese, 11 ottobre 1997), Milano, Franco Angeli, 2002.
Censimento degli archivi di Como: Censimento degli archivi dei comuni e delle parrocchie della provincia di Como, Como, Regione Lombardia, Provincia di Como, 2002.
Censimento degli archivi di Sondrio: Censimento degli archivi ecclesiastici e degli antichi fondi librari della provincia di Sondrio, a cura di Antonioli Gabriele e Xeres Saverio, Sondrio, Provincia di Sondrio, 1997.
CHERUBINI 1839: CHERUBINI Francesco, Vocabolario milanese-italiano, Milano, 1839, ed. consultata Milano, A. Martello, 1968.
CHIAPPA MAURI 1987: CHIAPPA MAURI Maria Luisa, Carta e cartai a Milano nel secolo XV, “Nuova rivista storica”, a. LXXI (1987), n. 1-2, pp. 1-26.
CHIAPPA MAURI 1990: CHIAPPA MAURI Luisa, Paesaggi rurali di Lombardia. Secoli XII-XV, Roma-Bari, Laterza, 1990.
CHIAPPA MAURI 1997: CHIAPPA Mauri Luisa, Terra e uomini nella Lombardia medievale. Alle origini di uno sviluppo, Roma-Bari, Laterza, 1997.
CHICCO 1995: CHICCO Giuseppe, La seta in Piemonte (1650-1800). Un sistema industriale d’ancien régime, Milano, Franco Angeli, 1995.
CHIESI 1989: CHIESI Giuseppe, “Donatum et Catonem legere”. La scuola comunale a Bellinzona nel Quattrocento, “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 69 (1989), pp. 125-150.
CHITTOLINI 1984: CHITTOLINI Giorgio, Avvicendamenti e paesaggio agrario della pianura irrigua lombarda (secoli XV-XVI), in Agricoltura e trasformazione dell’ambiente. Secoli XIII-XVIII. Atti della Undicesima Settimana di studi dell’Istituto internazionale di storia economica “Francesco Datini” di Prato (25-30 aprile 1979), a cura di Annalisa Guarducci, Firenze, Le Monnier, 1984, pp. 555-566.
204
CHITTOLINI 1988: CHITTOLINI Giorgio, La pianura irrigua lombarda fra Quattrocento e Cinquecento, “Annali dell’Istituto Alcide Cervi”, a. X (1988), pp. 207-221.
CHITTOLINI 1994a: CHITTOLINI Giorgio, Introduzione, in Roma capitale (1447-1527), a cura di Sergio Gensini, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, pp.
CHITTOLINI 1994b: CHITTOLINI Giorgio, Il “privato”, il “pubblico”, lo “Stato”, in Origini dello stato e processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di Giorgio Chittolini, Anthony Molho, Pierangelo Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 553-589.
COLOMBO 2005: COLOMBO Emanuele, Carta e società a Besozzo in età moderna, in Cinque secoli di carta. Produzione, commercio e consumi della carta nella “Regio Insubrica” e in Lombardia dal Medioevo all’età contemporanea. Convegno di studi (Varese, 21 aprile 2005), in questo volume.
COMBA 1988: COMBA Rinaldo, Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale, Roma-Bari, Laterza, 1988.
COMBA 2002: COMBA Rinaldo, Cartiere cuneesi fra Quattro e Cinquecento, in Dal manoscritto al libro a stampa nel Piemonte sud-occidentale (secoli XIII-XVII), Atti del Convegno (Mondovì, 16 febbraio 2002), a cura di Rinaldo Comba e Giancarlo Comino, “Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo”, a. CXXVII (2002), pp. 53-62.
COMINO 2002: COMINO Giancarlo, Produzione e diffusione della carta nel Monregalese del Quattrocento: le cartiere di Margarita e di Mondovì e relative filigrane, in Dal manoscritto al libro a stampa nel Piemonte sud-occidentale (secoli XIII-XVII), Atti del Convegno (Mondovì, 16 febbraio 2002), a cura di Rinaldo Comba e Giancarlo Comino, “Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo”, a. CXXVII (2002), pp. 63-78.
Constitutiones editae a Lazaro Carafino Cremonensi epicopo Melphiensis et Rapollensis comite et cetera in synodo celebrata pridie nonas viii et vii idus novembris anno Domini MDCXXIV, Romae, ex Typographia Alphonsi Ciacconi, 1625.
Contributi italiani 1990: Contributi italiani alla diffusione della carta in Occidente tra XIV e XV secolo. Convegno di studio (22 luglio 1988), a cura di Giancarlo Castagnari, Fabriano, Pia Università dei cartai, 1990.
CORRITORE 2002: CORRITORE Renzo P., Tra montagna e pianura. La difforme evoluzione della popolazione nel Varesotto e nell’Alto Milanese alle soglie dell’industrializzazione (1751-1871), in FORNASIN Alessio, ZANNINI Andrea (a cura di), Uomini e comunità delle montagne: paradigmi e specificità del popolamento dello spazio montano (secoli XVII-XX), Udine, Forum, 2002, pp. 23-56.
CORRITORE 2005: CORRITORE Renzo P., Una città e una famiglia di imprenditori cartari: Varese e i Molina. L’accumulazione originaria nel settore serico, la conversione all’attività cartaria, in Cinque secoli di carta. Produzione, commercio e consumi della carta nella “Regio Insubrica” e in Lombardia dal Medioevo all’età contemporanea. Convegno di studi (Varese, 21 aprile 2005), in questo volume.
COSTAMAGNA 1970: COSTAMAGNA Giorgio, Il notariato a Genova tra prestigio e potere, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1970.
205
COTTINI, METRA 2000: COTTINI Paolo, METRA Piero, Il Vellone e il Verro: le acque che hanno alimentato Varese nel passato, “Tracce”, a. XX (2000), n. 35, gennaio-febbraio 2000, pp. 5-22.
COVA 1987: COVA Alberto, L’alternativa manifatturiera, in Da un sistema agricolo a un sistema industriale: il Comasco dal Settecento al Novecento, a cura di Sergio Zaninelli, vol. I, Il difficile equilibrio agricolo-manifatturiero (1750-1814), Camera di Commercio, industria e agricoltura di Como, 1987, pp. 133-265.
COVA 1988: COVA Alberto, Le corporazioni milanesi nel Seicento, in Economia e corporazioni: il governo degli interessi nella storia d’Italia dal medioevo all’età contemporanea, a cura di Cesare Mozzarelli, Milano, A. Giuffrè, 1988, pp. 109-132.
COVA 2001: COVA Fernando, Tipografi ed editori varesini dei secoli scorsi: aggiornamenti, in Editori e tipografi a Varese. L’editoria nel circondario di Varese dal Settecento alla metà del Novecento. Atti del Convegno di studi (17 novembre 2000 – Palazzo Estense, Varese) dedicato a Ernesto Redaelli, Varese, Edizioni Lativa, 2001, pp. 117-129.
Cronaca varesina 1954: GIAMPAOLO Leopoldo, La Cronaca varesina di Gliulio Tatto (1540-1620) ed i prezzi dei greni e del vino sul mercato di Varese dal 1525 al 1620, Varese, Società storica varesina, 1954.
DANGON 1954: DANGON Georges, Moulins à papier et compagnons papetiers, “Courrier graphique”, n. 72, maggio 1954, pp. 13-25.
DEGRASSI 1996: DEGRASSI Donata, L’economia artigiana nell’Italia medievale, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1996.
DEGRASSI 2000: DEGRASSI Donata, Organizzazioni di mestiere, corpi professionali e istituzioni alla fine del medioevo nell’Italia centro settentrionale, in MERIGGI Marco, PASTORE Alessandro (a cura di), Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 17-35.
DE LA MARE 1973: DE LA MARE Albinia, The shop of a Florentine “cartolaio” in 1426, in Studi offerti a Roberto Ridolfi direttore de “La bibliofilia”, a cura di Berta Maracchi Biagiarelli e Dennis E. Rhodes, Firenze, Leo S. Olschki, 1973, pp. 237-248.
DEL BO 2001: DEL BO Beatrice, Un uomo d’affari del XV secolo: Mariano Vitali da Siena a Milano, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a.a. 2000/01, relatori prof. Rinaldo Comba e prof.ssa Patrizia Mainoni.
DELLA MISERICORDIA 2004: DELLA MISERICORDIA Massimo, Fra autorità centrali e comunità rurali: scrittura e parola scritta nei consigli delle Università di valle nella montagna lombarda (secoli XIV-XVI), tenuta al “Seminario di Studi Storici. Scritture del, al, sul governo” (10-12 maggio 2004, Fondazione Giorgio Cini, Venezia), di prossima pubblicazione negli atti del Seminario.
DE LUCA 1999: DE LUCA Giuseppe, Mercanti imprenditori, élite artigiane e organizzazioni produttive: la definizione del sistema corporativo milanese (1568-1627), in GUENZI Alberto, MASSA Paola, MOIOLI Angelo (a cura di), Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 79-116.
DERENZINI 1988: DERENZINI Giovanna, La carta occidentale nei manoscritti greci datati del XIII e XIV secolo (con un aggiunta sulla produzione della carta agli inizi del Quattrocento), in Contributi italiani alla diffusione della carta in Occidente tra XIV e XV secolo. Convegno di studio (22 luglio 1988), a cura di Giancarlo Castagnari, Fabriano, Pia Università dei cartai, 1990, pp. 99-136.
206
DESMAREST 1788: DESMAREST Nicolas, L’art de la papeterie par…, s.i.l., s.i.e., 1788.
DEVOTO, OLI 1971: Dizionario della lingua italiana, a cura di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, Firenze, Le Monnier, 1971.
DEYON 1984 : DEYON Pierre, Fécondité et limites du modèle protoindustriel: premier bilan, “Annales. Économies. Sociétés. Civilisations”, a. XXXIX (1984), n. 5, pp. 868-881.
DI GIANFRANCESCO 1975: DI GIANFRANCESCO Mario, Per una storia della navigazione padana dal Medioevo alla vigilia del Risorgimento, “Quaderni storici”, a. X (1975), n. 28, pp. 199-226.
Dizionario illustrato della legatura: Dizionario illustrato della legatura, a cura di Federico Macchi e Livio Macchi in collaborazione con Alessi Milena; introduzione di Wittock Michel; prefazione di Quilici Alessiani Piccarda, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002.
DUBINI 1982: DUBINI Marco, E più vi è il torchio per torchiare la detta carta. L’industria della carta in Chiasso nei secoli XVI e XVII, “Almanacco di vita chiassese”, 1982, pp. 5-10.
DU CANGE 1883-87: DU CANGE Charles, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 1971 (ripr. facs. dell’ed. Niort, L. Favre, 1883-87).
DUVIA 2003: DUVIA Stefania, Maestri di scuola e fermenti culturali a Como nel XV secolo, relazione presentata alla Sesta Settimana di alti studi rinascimentali “L’istruzione dei fanciulli nel Rinascimento” (Ferrara, 6-10 ottobre 2003), in corso di pubblicazione negli atti.
Encyclopédie: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et de métiers…, Paris, chez Briasson…, 1751-65, 17 voll.
Encyclopédie méthodique: Encyclopédie méthodique…, Paris, chez Panckoucke, Liege, chez Plomteux, 1782-91, 8 tomi (11 voll.).
Esposizione 1857: Sulla esposizione bresciana. Lettere di Giuseppe Zanardelli, Milano, Valentini, 1857.
Fabbrica ritrovata 1989: La fabbrica ritrovata. Mostra di archeologia industriale nella Valle Olona. Musei Civici di Villa Mirabello (28 gennaio - 12 marzo 1989), Varese, Università popolare di Varese, Amministrazione provinciale di Varese, Comune di Varese, 1989.
FANTONI 1990: FANTONI Giuliana, L’acqua a Milano. Uso e gestione nel basso medioevo (1385-1535), Bologna, Cappelli Editore, 1990.
FASOLI 1978: FASOLI Gina, Navigazione fluviale. Porti e navi sul Po, in La navigazione mediterranea nell’Alto Medioevo, Spoleto, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 1978, pp. 565-607.
FATTARELLI 1986: FATTARELLI Martino, La sepolta Olonio e la sua Pieve alla sommità del Lago di Como e in Bassa Valtellina, Oggiono-Lecco, Cattaneo, 1986, p. 393.
FEBVRE, MARTIN 1958: FEBVRE Lucien, MARTIN Henri Jean, L’apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1958.
FEDRIGONI: FEDRIGONI Antonio, L’industria veneta della carta dalla seconda dominazione austriaca all’unità d’Italia, Torino, ILTE, 1966.
207
FOGLIA 2000a: FOGLIA P., Il lungo viaggio: note sulla storia della carta, “Grafica d’arte”, XI (2000), n. 41, gennaio-marzo 2000, pp.
FOGLIA 2000b: FOGLIA P., L’arte di fabbricare la carta, “Grafica d’arte”, XI (2000), n. 42, aprile-giugno 2000, pp.
FOSSATI 1928: FOSSATI Felice, Lavori e lavoratori a Milano nel 1438, “Archivio storico lombardo”, s. VI, a. LV (1928), vol. III, fasc. 19, pp. 225-258.
FRANGIONI 1979: FRANGIONI Luciana, I tessuti di lana e di cotone, in Artigianato lombardo. 3. L’opera tessile, Milano, Cariplo, 1979, pp. 12-37.
FRANGIONI 1983: FRANGIONI Luciana, Aspetti della produzione delle armi milanesi nel XV secolo, in Milano nell’età di Ludovico il Moro, Atti del Convegno internazionale (28 febbraio-4 marzo 1983), Milano, Comune di Milano, Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, vol. I, pp. 195-200.
FRANGIONI 1984: FRANGIONI Luciana, Martino da Milano “fa i bacinetti” in Avignone (1379), “Ricerche storiche”, a. XIV (1984), n. 1, pp. 69-115.
FRANGIONI 1987: FRANGIONI Luciana, La tecnica di lavorazione dei bacinetti: un esempio Avignonese del 1379, in Tecnica e società nell’Italia dei secoli XII-XVI, Atti dell’undicesimo Convegno internazionale di studio tenutosi a Pistoia nei giorni 28-31 ottobre 1984, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’arte, 1987, pp. 191-208.
FRANGIONI 1989: FRANGIONI Luciana, Sui modi di produzione del settore metallurgico nella seconda metà del Trecento, “Società e storia”, a. XII (1989), n. 45, pp. 545-565.
FRANGIONI 1993: FRANGIONI Luciana, Alcuni problemi su modi di produzione del settore metallurgico (seconda metà del XIV secolo), “Studi di storia medioevale e di diplomatica”, n. 14 (1993), pp. 7-24.
GALLAZZI 1980: GALLAZZI Cesare, L’editoria milanese nel primo cinquantennio della stampa: i “da Legnano” (1480-1525). Annali tipografici, Busto Arsizio, Bustrino, 1980.
GANDA 1980: GANDA Arnaldo, Marco da Roma, sconosciuto editore dei prototipografi milanesi (1473-1477), “La bibliofilia”, a. LXXXII (1980), pp. 97-129 e 219-246.
GANDA 1984: GANDA Arnaldo, I primordi della tipografia milanese: Antonio Zarotto da Parma (1471-1507), Firenze, Leo S. Olschki, 1984.
GANDA 1985: GANDA Arnaldo, Il “tipografo del Servius H 14708” ha un nome: Domenico Giliberti da Vespolate, “La bibliofilia”, a. LXXXVII (1985), pp. 227-266.
GANDA 1988: GANDA Arnaldo, Niccolò Gorgonzola editore e libraio in Milano, 1496-1536, Firenze, Leo S. Olschki, 1988.
GANDA 1994: GANDA Arnaldo, Vicende editoriali della Patria historia di Bernardino Corio, “La bibliofilia”, a. XCVI (1994), fasc. 3, pp. 218-232.
GANDA 1995: GANDA Arnaldo, Pietro Giustino Filelfo editore della “Sforziade” di Giovanni Simonetta (Milano 1490), in Studi in memoria di Paola Medioli Masotti, Napoli, Loffredo Editore, 1995, pp. 73-78.
GANDA 2003: GANDA Arnaldo, La cartiera della Certosa di Pavia a Boffalora sopra Ticino (secoli XVII-XVIII), “Bollettino della Società pavese di storia patria”, a. CIII (2003), pp. 115-166.
208
GANDA 2004: GANDA Arnaldo, Giovanni Angelo Scinzenzeler: il testamento e altri documenti inediti (Milano, 1499-1503), in L’organizzazione del sapere. Miscellanea in onore di Alfredo Serrai per i suoi 70 anni, Milano, Edizioni Silvestre Bonnard, pp. 118-119.
GARZONI 1585-89: GARZONI Tomaso, La piazza universale di tutte le professioni del mondo, a cura di Paolo Cherchi e Beatrice Collina, Torino, Einaudi, 1996, 2 voll.
GASPARINETTI 1938: GASPARINETTI Andrea Federico, Carta, cartiere e cartai fabrianesi, “Risorgimento grafico”, XXV (1938), pp. 373-431.
GASPARINETTI 1962: Osservazioni intorno all’arte di fabbricare la carta dedotte da vari autori dell’Accademia R. delle Scienze per la maggior perfezione delle cartiere negli Stati di S.A.R. il sig. Infante D. Filippo, Duca di Parma, Piacenza, Guastalla, ecc. con la dimostrazione del mulino all’olandese fatto a cilindro, introduzione e note di Andrea Federico Gasparinetti, Milano, Il Polifilo, 1962.
GASPARINETTI 1963a: GASPARINETTI Andrea Federico, Documenti inediti sulla fabbricazione della carta nell’Emilia, Milano, Industria della carta, 1963.
GASPARINETTI 1963b: GASPARINETTI Andrea Federico, Pietro Miliani fabbricante di carta, Fabriano, Cartiere Miliani, 1963.
GAZZINI 2002: GAZZINI Marina, “Dare et habere”. Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento, Firenze, Firenze University Press, 2002.
GIAMPAOLO 1958: GIAMPAOLO Leopoldo (a cura di), Cartografia varesina, Varese, Casa ed. toscana, 1958.
GIAMPAOLO 1959: GIAMPAOLO Leopoldo, Varese dall’avvento della Repubblica Cisalpina alla fine del Regno Italico: cronaca ricavata dagli appunti di Carlo Castiglioni, di Luigi Borri e dai protocolli municipali di Varese, Varese, Rivista della Società storica varesina, 1959.
GIAMPAOLO 1975: GIAMPAOLO Leopoldo, Note su una inchiesta economica del 1790 sulla prima Provincia di Varese, “Rivista della Società storica varesina”, fasc. XII, marzo 1975, pp. 179-197.
GIANONCELLI 1982: GIANONCELLI Matteo, Como e il suo territorio. Le vicende degli ordinamenti territoriali comaschi dall’epoca romana agli albori dell’età moderna, Como, presso la Società Villa Gallia, 1982.
GIAVARELLA 1951: GIAVARELLA A., Antonio Zarotto da Parma e gl’incunaboli della tipografia milanese, “Aurea Parma”, a. XXXV (1951), pp. 106-16; 162-70.
GILMONT 1992: GILMONT Jean-François, Les centres de la production imprimée aux XVe et XVIe siècles, in Produzione e commercio della carta e del libro (secc. XIII-XVIII). Atti della Ventitreesima Settimana di studi dell’Istituto internazionale di storia economica “Francesco Datini” di Prato (15-20 aprile 1991), a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1992, pp. 343-364.
GIOIA 1804: GIOIA Melchiorre, Sul Dipartimento del Lario: discussione economica, Milano, Pirotta e Maspero, 1804.
GIUSBERTI 1999: GIUSBERTI Fabio, La forza dell’usato. Strazzaroli e rigattieri a Bologna in età moderna, in GUENZI Alberto, MASSA Paola, MOIOLI Angelo (a cura di), Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 437-443.
209
GRECI 1996: GRECI Roberto, Corporazioni e mondo del lavoro nell’Italia padana medievale, Bologna, Editrice CLUEB, 1988.
GRILLO 1994: GRILLO Paolo, Le origini della manifattura serica in Milano (1400-1450), “Studi storici”, a. XXXV (1994), n. 4, pp. 897-916.
GRILLO 1995: GRILLO Paolo, Le strutture di un borgo medievale. Torno, centro manifatturiero nella Lombardia viscontea, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1995.
GRILLO 2003: GRILLO Paolo, Comuni urbani e poteri locali nel governo del territorio in Lombardia (XII-inizi XIV secolo), in Contado e città in dialogo: comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale, a cura di Luisa Chiappa Mauri, Milano, Cisalpino, 2003.
GRISELINI 1769: GRISELINI Francesco, Dizionario delle arti e de’ mestieri compilato da…, in Venezia, appresso Modesto Fenzo, 1768-78 (18 voll.), vol. IV (1769).
GUENZI, MASSA, MOIOLI 1999: GUENZI Alberto, MASSA Paola, MOIOLI Angelo (a cura di), Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna, Milano, Franco Angeli, 1999.
Guida dell’Archivio di Stato di Como: Guida dell’Archivio di Stato di Como, a cura di Gabriella Poli Cagliari, Como, Camera di commercio, industria e artigianato, 1971.
Helvetia Sacra 1989: Helvetia Sacra. La diocesi di Como. L’arcidiocesi di Gorizia. L’amministrazione apostolica ticinese poi diocesi di Lugano. L’arcidiocesi di Milano, a cura di Patrick Braun e Hans-Jorg Gilomen, Basilea-Francoforte sul Meno, Helbing & Lichtenhahn, 1989.
HILLS 1992: HILLS Richard L., Early italian papermaking. A crucial technical revolution, in Produzione e commercio della carta e del libro (secc. XIII-XVIII), Atti della Ventitreesima Settimana di studi dell’Istituto internazionale di storia economica “Francesco Datini” di Prato (15-20 aprile 1991), a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1992, pp. 73-97.
HUNTER 1978: HUNTER Dard, Papermaking: the history and technique of an ancient craft, New York, Dover Publications, 1978 (ristampa identica alla 2ª ed. del 1947).
Industria della carta 1929: L’industria della carta, “La Provincia di Varese”, n. 1, gennaio 1929, pp. 14-20.
IRIGOIN 1980: IRIGOIN Jean, La datation par le filigranes du papier, in Codicologia, V, Les matériaux du livre manuscript, Leiden, E. J. Brill, 1980, pp. 9-36.
KAPR 1986: KAPR Albert, Johannes Gutenberg. Personlichkeit und Leistung, Leipzig-Jena-Berlin, Urania Verlag, 1986.
LEVEROTTI 1997: LEVEROTTI Franca, Gli officiali del ducato sforzesco, in Gli officiali negli Stati italiani del Quattrocento, “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”, s. IV, Quaderni 1 (1997), pp. 17-77.
Liber datii mercantie: Liber datii mercantie Communis Mediolani: registro del secolo XV, a cura di Antonio Noto, Milano, Ed. Università L. Bocconi, 1950.
210
LIPPARONI 1990: LIPPARONI Nora, Il ruolo dei mercanti fabrianesi nella commercializzazione della carta e nell’organizzazione della attività produttiva tra XIV e XV secolo, in Contributi italiani alla diffusione della carta in Occidente tra XIV e XV secolo. Convegno di studio (22 luglio 1988), a cura di Giancarlo Castagnari, Fabriano, Pia Università dei cartai, 1990, pp. 63-82.
LIPPARONI 1993: LIPPARONI Nora, Produzione e commercio della carta nel XV secolo. I libri dei “chamboreri” fabrianesi, in CASTAGNARI Giancarlo (a cura di), Carta e cartiere nelle Marche e nell’Umbria dalle manifatture medioevali all’industrializzazione, Ancona, “Proposte e ricerche”, 1993, pp. 15-31.
LUCIONI 2002: LUCIONI Alfredo, Carità e assistenza a Varese nel Medioevo: la genesi del sistema ospedaliero nel borgo prealpino, in CAVALLERA Marina, GHEZZI Angelo Giorgio, LUCIONI Alfredo, I luoghi della carità e della cura. Ottocento anni di storia dell’Ospedale di Varese, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 31-98.
Macchinario Carcano 1930: Figli di Carcano Gerolamo. Macchinario per cartiere, Cernobbio, Asperi, 19303.
MAGNI 1937: MAGNI Cesare, Il tramonto del feudo lombardo, Milano, Giuffrè, 1937.
MAINONI 1982: MAINONI Patrizia, Note per uno studio sulle società commerciali a Milano nel XV secolo, “Nuova rivista storica”, a. LXVI (1982), fasc. 5-6, pp. 564-568.
MAINONI 1983: MAINONI Patrizia, L’attività mercantile e le casate milanesi nel secondo Quattrocento, in Milano nell’età di Ludovico il Moro. Atti del convegno internazionale (Milano, 28 febbraio - 4 marzo 1983), Milano, Comune di Milano, Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, vol. I, pp. 575-584.
MAINONI 1984: MAINONI Patrizia, Il mercato della lana a Milano dal XIV al XV secolo. Prime indagini, “Archivio storico lombardo”, s. XI, a. CX (1984), pp. 20-43.
MAINONI 1988: MAINONI Patrizia, La Camera dei mercanti di Milano: tra economia e politica alla fine del Medioevo, in Economia e corporazioni: il governo degli interessi nella storia d’Italia dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di Cesare Mozzarelli, Milano, A. Giuffrè, 1988, pp. 57-78.
MAINONI 1992: MAINONI Patrizia, Arti, mestieri, corporazioni, in Storia illustrata di Milano, a cura di Franco Della Peruta, vol. II, Milano, Elio Sellino Editore, 1992, pp. 461-480.
MAINONI 1994: MAINONI Patrizia, Economia e politica nella Lombardia medioevale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo, Cavallermaggiore (Cn), Gribaudo Editore, 1994.
MAINONI 1994a: MAINONI Patrizia, Ricerche sulle arti milanesi fra XIII e XV secolo, in EAD., Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo, Cavallermaggiore (Cu), Gribaudo Editore, 1994, pp. 207-228.
MAINONI 1994b: MAINONI Patrizia, La seta a Milano nel XV secolo: aspetti economici e istituzionali, “Studi storici”, a. XXXV (1994), n. 4, pp. 871-896.
MAINONI 1999: MAINONI Patrizia, Economia e finanza a Chiavenna, un borgo alpino del Duecento, “Clavenna”, XXXVIIII (1999), pp. 69-88.
MALANIMA 1988: MALANIMA Paolo, I piedi di legno. Una macchina alle origini dell’industria medievale, Milano, Franco Angeli, 1988.
211
MALANIMA 2003: MALANIMA Paolo, Uomini, risorse, tecniche nell’economia europea dal X al XIX secolo, Milano, Bruno Mondadori, 2003.
MANGINI 2002: MANGINI Marta Luigina, Le pergamene dell’archivio capitolare laurenziano di Chiavenna, “Clavenna”, XLI (2002), pp. 9-50.
MANGINI 2004: MANGINI Marta Luigina, “Infrascripta sunt necessaria sciri ad artem notarie”. Un formulario notarile valtellinese della fine del XIV secolo, “Archivio storico lombardo”, s. XII, a. CXXX (2004), in corso di stampa.
MANGINI 2005a: MANGINI Marta Luigina, Impiego e conservazione della carta. Primi spunti di ricerca sul territorio dell’antica diocesi di Como (secoli XIII-XV), in Cinque secoli di carta. Produzione, commercio e consumi della carta nella “Regio Insubrica” e in Lombardia dal Medioevo all’età contemporanea. Convegno di studi (Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, 21 aprile 2005), in questo volume.
MANGINI 2005b: MANGINI Marta Luigina, I “quaterni consiliorum” trecenteschi di Bormio nel panorama delle fonti di matrice consiliare dell’area alpina lombarda, “Nuova rivista storica”, a. LXXXIX (2005), n. 2, in corso di stampa.
MANGINI, PEZZOLA 2004: MANGINI Marta Luigina, PEZZOLA Rita, Pergamene dell’Archivio della mensa episcopale di Como (secc. XI- 1666), “Archivio storico della Diocesi di Como”, XIV (2004), in corso di stampa.
MANNUCCI 1992: MANNUCCI Ulisse, La gualchiera medioevale fabrianese, Fabriano, Museo della carta e della filigrana, 1992.
MARIANI 1992: MARIANI Franco, L’introduzione della “olandese” nelle cartiere dello Stato Pontificio, “Cellulosa e carta”, n.s., a. XLIII (1992), n. 4, pp. 59-68.
MARIANI 1999: MARIANI Franco, La cartiera di Bracciano, relazione tenuta al convegno di studi sulla famiglia Odescalchi organizzato dal Comune di Bracciano (31 luglio 1999).
MARONI, MARONI 2003: MARONI Antonio, MARONI Luigi, Varese: memorie cronologiche (1 gennaio 1847 – 30 settembre 1903), a cura di Antonio e Clemente Maggiora, Varese, Edizioni Lativa, 2003.
MARTIN 2004: MARTIN Lidia, Marzo 1944. Gli scioperi, in I cancelli erano chiusi. La situazione nelle fabbriche e gli scioperi del 1944 a Como, Como, NodoLibri, 2004, pp. 49-74.
MARTINELLI PERELLI 1996: Liliana MARTINELLI PERELLI, Abbondiolo de Asinago notaio in Como. I cartulari di un professionista della prima metà del Trecento, in L’età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo, a cura di Luisa Chiappa Mauri, Patrizia Mainoni, Laura De Angelis Cappabianca, Milano, Editrice La Storia, 1996, pp. 393-406.
MARTINI 1956: MARTINI Giuseppe Sergio, La bottega di un cartolaio fiorentino della seconda metà del Quattrocento: nuovi contributi biografici intorno a Gherardo e Monte di Giovanni, Firenze, Leo S. Olschki, 1956.
MARTINOLA 1945: MARTINOLA Giuseppe, La cartiera di Mendrisio, “Bollettino storico della Svizzera italiana”, s. IV, vol. XX (1945), n. 1, pp. 44-45.
Maslianico 1906: Maslianico e le sue industrie, “La Provincia di Como della Domenica”, 1906, pp. 373-382.
212
Matricola dei mercanti di lana: La matricola dei mercanti di lana sottile di Milano, a cura di Caterina Santoro, Milano, A. Giuffrè, 1940.
MATTOZZI 1975: MATTOZZI Ivo, Produzione e commercio della carta nello Stato veneziano settecentesco. Lineamenti e problemi, Bologna, Istituto di Storia medioevale e moderna dell’Università degli studi di Bologna, 1975.*
MATTOZZI 1990: MATTOZZI Ivo, I Remondini e le cartiere, in INFELISE Mario, MARINI Paola (a cura di), Remondini, un editore del Settecento, Milano, Electa, 1990, pp. 84-93.
MATTOZZI 1994: MATTOZZI Ivo, I Galvani fabbricanti di carta (1744-1855). Un modello di formazione dell’imprenditorialità?, in GANZER Gilberto (a cura di), Andrea Galvani (1797- 1855). Cultura e industria nell’Ottocento a Pordenone, Pordenone, Editoriale Studio Tesi, 1994, pp. 13-34.
MATTOZZI 1995: MATTOZZI Ivo, Il distretto cartario dello stato veneziano. Lavoro e produzione nella Valle del Toscolano dal XIV al XVIII secolo, in Cartai e stampatori a Toscolano. Vicende, uomini, paesaggi di una tradizione produttiva, a cura di Carlo Simoni, Brescia, Grafo, 1995, pp. 23-65.
MATTOZZI 1997: MATTOZZI Ivo, Una cartiera, molte storie, in Acque e cartiere nel parco di San Valentino, Pordenone, Comune di Pordenone, 1997, pp. 15-28.
MATTOZZI 2001a: MATTOZZI Ivo, Le cartiere nello Stato veneziano: una storia tra strutture e congiunture (1450-1797), in GRAZIOLI Mauro, MATTOZZI Ivo, SANDAL Ennio (a cura di), Mulini da carta. Le cartiere dell’Alto Garda.Tini e torchi fra Trento e Venezia, Verona, Cartiere Fedrigoni, 2001, pp. 97-162.
MATTOZZI 2001b: MATTOZZI Ivo, Un caso a parte: le cartiere del Veronese tra interessi fondiari, privilegi corporativi, imprenditorialità, in GRAZIOLI Mauro, MATTOZZI Ivo, SANDAL Ennio (a cura di), Mulini da carta. Le cartiere dell’Alto Garda. Tini e torchi fra Trento e Venezia, Verona, Cartiere Fedrigoni, 2001, pp. 235-245.
MAZZALUPI 1993: MAZZALUPI Claudio, Le cartiere del comune di Santa Anatolia, in CASTAGNARI Giancarlo (a cura di), Carta e cartiere nelle Marche e nell’Umbria dalle manifatture medioevali all’industrializzazione, Ancona, “Proposte e ricerche”, 1993, pp. 73-89.
MAZZOLDI 1990-91: MAZZOLDI 1990-91, Filigrane di cartiere bresciane, Brescia, Ateneo di Scienze, lettere ed arti, 1990-91, 2 voll.
Mercanti scrittori 1986: Mercanti scrittori. Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento, a cura di Vittore Branca, Milano, Rusconi, 1986.
MERIGGI, PASTORE 2000: MERIGGI Marco, PASTORE Alessandro (a cura di), Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX, Milano, Franco Angeli, 2000.
MERLO 2000: MERLO Elisabetta, Idoneità e identità di mestiere: analisi e confronto di alcune esemplificazioni (Milano XVII-XVIII secolo), in MERIGGI Marco, PASTORE Alessandro (a cura di), Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 105-119.
MIRA 1939: MIRA Giuseppe, Aspetti dell’economia comasca all’inizio dell’età moderna, Como, Casa editrice Emo Cavalleri, 1939.
MEDICI 1980: MEDICI Mario, Storia di Mendrisio, Mendrisio, Banca Raiffeisen, 1980.
213
MOCARELLI 1992: MOCARELLI Luca, Cure del lino e fucine da chiodi. Attività manifatturiere e mercanti-imprenditori nella Riviera bresciana, in Atlante del Garda. Uomini, vicende, paesi, Brescia, Grafo, 1992, vol. II, pp. 33-51.
MOCARELLI 1995: MOCARELLI Luca, Le “industrie” bresciane nel Settecento, Milano, CUESP, 1995.
MOIOLI 1981: MOIOLI Angelo, La gelsibachicoltura nelle campagne lombarde dal Seicento alla prima metà dell’Ottocento. Parte prima. La diffusione del gelso e la crescita produttiva della sericoltura, Trento, Dipartimento di Economia della Libera Università degli studi di Trento, 1981.
MOIOLI 1992: MOIOLI Angelo, L’economia lombarda fra tradizione e innovazione, in Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni. Atti del convegno (Vicenza e Bassano del Grappa 19-21 ottobre 1989), a cura di Giovanni Luigi Fontana e Antonio Lazzarini, Milano-Roma-Bari, Cariplo-Laterza, 1992, pp. 179-244.
MONTECCHI 1994: MONTECCHI Giorgio, Il libro nel Rinascimento. Saggi di bibliologia, Milano, La Storia, 1994.
MORIGIA 1603: MORIGIA Paolo, Historia della nobiltà et degne qualità del Lago Maggiore..., in Milano, per Hieronimo Bordone et Pietro Martire Locarni compagni, 1603 (ristampa anastatica: Intra, Alberti Libraio Editore, 1983).
MOTTA 1884: MOTTA Emilio, Panfilo Castaldi, Antonio Planella, Pietro Ugleimer e il vescovo d’Aleria, “Rivista storica italiana”, a. XI (1884), pp. 252-272.
MOTTA 1887: MOTTA Emilio, Dei cartai milanesi nella seconda metà del XV secolo e de’ loro statuti, “Il bibliofilo”, a. VIII (1887), pp. 108-112.
MOTTA 1895: MOTTA Emilio, Un tipografo a Milano nel 1469, “Archivio storico lombardo”, a. XXII (1895), pp. 150-155.
MOTTA 1898: MOTTA Emilio, Di Filippo di Lavagna e di alcuni altri tipografl-editori milanesi del Quattrocento. Nuovi documenti, “Archivio storico lombardo”, a. XXV (1898), pp. 28-72.
NAI 1934: NAI Pietro, I primi quattro tipografi di Milano: Castaldi, Zarotto, Lavagna, Valdarfer, “Archivio storico lombardo”, s. VII, a. LXI (1934), fasc. 3, pp. 569-594.
NAI 1936: NAI Pietro, 1 collaboratori di Panfilo Castaldi, “Archivio storico lombardo”, s. VIII, a. LXIII (1936), fasc. 3, pp. 424-448.
NUOVO 1998: NUOVO Angela, Il commercio librario nell’Italia del Rinascimento, Milano, Franco Angeli, 1998 (2a ed. riveduta e ampliata 2003).
ORNATO, BUSONERO, MUNAFÒ, STORACE 1999: ORNATO Ezio, BUSONERO Paola, MUNAFÒ Paola, STORACE M. Speranza, Aspects qualitatifs de la production de papier filigrané à la fin du Moyen Âge, in Le papier au Moyen Âge: histoire et techniques. Actes du Colloque international du Centre national de la recherche scientifique, Institut de France (Paris, 23-25 avrile 1998), éd. par Monique Zerdoun Bat-Yehouda, Turnhout, Brepols, 1999, pp. 177-191.
ORSINI 1954-55: ORSINI Giustino Renato, La giurisdizione spirituale e temporale del vescovo di Como, “Archivio storico lombardo”, s. VIII, a. LXXXI-LXXXII (1954-55), pp. 131-191.
214
OSSANNA CAVADINI 1997: OSSANNA CAVADINI Nicoletta, Chiasso fra Ottocento e Novecento. La costruzione di una forma urbana, Muzzano, Edizioni San Giorgio, 1997.
Osservazioni intorno all’arte: Osservazioni intorno all’arte di fabbricare la carta dedotte da vari autori dell’Accademia R. delle scienze per la maggior perfezione delle cartiere negli Stati di S.A.R. il sig. Infante D. Filippo, duca di Parma, Piacenza, Guastalla, ecc., con la dimostrazione del mulino all’olandese fatto a cilindro, introduzione e note di Andrea Federico Gasparinetti, Milano, Il Polifilo, 1962 (rist. anast. Verona, Stamperia Valdonega, 1977).
OVERTON 1963: OVERTON John, Nota sui progressi tecnici nella fabbricazione della carta prima del diciannovesimo secolo, in SINGER Ch. (a cura di), Storia della tecnologia, Torino, Boringhieri, 1963, vol. III, pp. 419-424.
PAOLI 1942: PAOLI Cesare, Diplomatica, nuova edizione aggiornata da Giacomo C. Bascapé, Firenze, Sansoni, 1942.
Papier au Moyen Âge 1999: Papier au Moyen Âge: histoire et techniques. Actes du Colloque international du Centre national de la recherche scientifique, Institut de France (Paris, 23-25 avrile 1998), éd. par Monique Zerdoun Bat-Yehouda, Turnhout, Brepols, 1999 (Bibliologia, 19).
PEZZOLA 2002: PEZZOLA Rita, Ricognizione delle pergamene dell’archivio notarile dell’Archivio di Stato di Sondrio, Sondrio, 2002 (dattiloscritto depositato in Archivio di Stato di Sondrio).
PICCARD 1981: PICCARD Gerhard, Cartiere e gualchiere, in Produttività e tecnologie nei secoli XIII-XVII, a cura di Sara Mariotti, Atti della Terza Settimana di studio dell’Istituto internazionale di storia economica “Francesco Datini” (23 aprile - 29 aprile 1971), Firenze, Felice Le Monnier, 1981, pp. 223-226.
PICCARDI 1992: PICCARDI Marco, Mercato, consumi e prezzi della carta nel regime monopolistico del Granducato di Toscana (1648-1749), in Produzione e commercio della carta e del libro (secc. XIII-XVIII), Atti della Ventitreesima Settimana di studi dell’Istituto internazionale di storia economica “Francesco Datini” di Prato (15-20 aprile 1991), a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1992, pp. 279-296.
PINI 1986: PINI Antonio Ivan, Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano, Bologna, Editrice CLUEB, 1986.
PIRANI 2000: PIRANI Francesco, I maestri cartai, Firenze, Libreria Chiari, 2000.
PIRANI 2003: PIRANI Francesco, Fabriano in età comunale: nascita e affermazione di una città manifatturiera, Firenze, Nardini, 2003.
PLANTA 1993: PLANTA Tumasch, Alte Wege am Splügenpass, in trad. ital. a cura di Francesca Balatti e Gian Primo Falappi con il titolo Le antiche strade dello Spluga, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 1993.
PONI 1976: PONI Carlo, All’origine del sistema di fabbrica: tecnologia e organizzazione produttiva dei mulini da seta nell’Italia settentrionale (sec. XVII-XVIII), “Rivista storica italiana”, a. LXXXVIII (1976), n. 3, pp. 444-497.
215
Produzione e commercio della carta 1992: Produzione e commercio della carta e del libro (secc. XIII-XVIII), Atti della Ventitreesima Settimana di studi dell’Istituto internazionale di storia economica “Francesco Datini” di Prato (15-20 aprile 1991), a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1992.
PROSDOCIMI 1939: PROSDOCIMI Luigi, Problemi sulla formazione e sull’ordinamento del territorio di Como, “Periodico storica comense”, n.s., 3/XVII (1939), pp. 7-34.
RAPETTI 1997: RAPETTI Anna Maria, Le corporazioni milanesi in età medievale, in Le corporazioni milanesi e Sant’Ambrogio nel Medioevo, a cura di Annamaria Ambrosioni, Milano, Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, 1997, pp. 9-50.
Recueil de planches: Recueil de planches, sur les sciences, les arts liberaux et les arts mecaniques, avec leur explications, Paris, chez Briasson…, 1762-72, 11 voll.
Relazioni sull’industria 1941: Relazioni sull’industria il commercio e l’agricoltura lombardi del ’700, a cura di Carlo Antonio Vianello, Milano, A. Giuffrè, 1941.
RIBOLZI 2001: RIBOLZI Maryse, Besozzo tra Otto e Novecento, Gavirate, Nicolini, 2001.
ROGLEDI MANNI 1980: ROGLEDI MANNI Teresa, La tipografia a Milano nel XV secolo, Firenze, Leo S. Olschki, 1980.
ROMITI 1994: ROMITI Antonio, L’armarium comunis della camara actorum di Bologna. L’inventariazione archivistica nel XIII secolo, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XIX).
ROSENBAND 1992: ROSENBAND Leonard N., Formazione ed evoluzione dei centri della produzione della carta, in Produzione e commercio della carta e del libro (secc. XIII-XVIII), Atti della Ventitreesima Settimana di studi dell’Istituto internazionale di storia economica “Francesco Datini” di Prato (15-20 aprile 1991), a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1992, pp. 49-71.
ROVEDA 1984: ROVEDA Enrico, Il beneficio delle acque. Problemi di storia dell’irrigazione in Lombardia tra XV e XVII secolo, “Società e storia”, a. VII (1984), n. 24, pp. 269-287.
ROVEDA 1992: ROVEDA Enrico, Le istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca, in Società, istituzioni, religione nelle età del Comune e della Signoria (Storia di Pavia), Milano, Banca del Monte di Lombardia, 1992, pp. 55-115.
ROVELLI 1808: ROVELLI Giuseppe, Storia de’ principali avvenimenti dopo l’ingresso de’ francesi in Lombardia, cioè dal maggio del 1796 a tutto il 1802, per servire di appendice alla Storia di Como. Con un prospetto fisico e politico della stessa città ed antica sua provincia, Como, presso Carl’Antonio Ostinelli impressore dipartimentale, 1808.
RUPPEL 1967: RUPPEL Aloys, Johannes Gutenberg. Sein Leben und sein Werk, Niewkoop, B. De Graaf, 1967.
SABBATINI 1985: SABBATINI Renzo, La formazione di un centro cartario: Villa Basilica, “Quaderni storici”, n.s., a. XX (1985), n. 59, pp. 427-444.
SABBATINI 1987: SABBATINI Renzo, La produzione della carta dal XIII al XVI secolo: strutture, tecniche, maestri cartai, in Tecnica e società nell’Italia dei secc. XII-XVI, Undicesimo convegno internazionale (Pistoia, 28-31 ottobre 1984), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’arte, 1987, pp. 35-57.
216
SABBATINI 1990: SABBATINI Renzo, “Di bianco lin candida prole”. La manifattura della carta in età moderna e il caso toscano, Milano, Franco Angeli, 1990.
SABBATINI 1992: SABBATINI Renzo, La manifattura cartaria in età moderna: imprenditorialità, rapporti di produzione e occupazione, in Produzione e commercio della carta e del libro (secc. XIII-XVIII), Atti della Ventitreesima Settimana di studi dell’Istituto internazionale di storia economica “Francesco Datini” di Prato (15-20 aprile 1991), a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1992, pp. 99-142.
SACCHI 2004: SACCHI Matteo, “Alla ferrata solita della loggia dei mercanti”. Il mercato dei feudi in Lombardia (1680-1700), “Società e storia”, a. XXVII (2004), n. 103, pp. 51-95.
SALICE 1997: SALICE Tarcisio, La Valchiavenna nel Duecento, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 1997.
SANTORO 1948: SANTORO Caterina, Introduzione a Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500), Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1948, pp. XV-XXXIX.
SANTORO 1961: SANTORO Caterina, I registri delle Lettere Ducali del periodo sforzesco, Milano, Castello Sforzesco, 1961.
SANTORO 1968: SANTORO Caterina, Introduzione a Gli offici del Comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1315), Milano, A. Giuffrè, 1968, pp. 13-55.
SANTORO 1973: SANTORO Caterina, Appunti e documenti per una storia dei cartai milanesi, in Studi offerti a Roberto Ridolfi direttore de “La bibliofilia”, a cura di Berta Maracchi Biagiarelli e Dennis E. Rhodes, Firenze, Leo S. Olschki, 1973, pp. 421-426.
SARTORELLI 2001: SARTORELLI Fabio, La produzione a stampa per il teatro d’opera, in Editori e tipografi a Varese. L’editoria nel circondario di Varese dal Settecento alla metà del Novecento. Atti del Convegno di studi (17 novembre 2000 – Palazzo Estense, Varese) dedicato a Ernesto Redaelli, Varese, Edizioni Lativa, 2001, pp. 223-234.
SASSI 1951: SASSI Romualdo, La Pia Università dei Cartai di Fabriano e la sua chiesa di S. Maria Maddalena, Fabriano, Pia Università dei cartai, 1951.
SCARLATA 1968: SCARLATA Gaetano, L’Archivio di Stato di Sondrio e altre fonti storiche della provincia, Sondrio, Bonazzi, 1968.
SCHAEFER 1954: SCHAEFER Paul, Il Sottoceneri nel Medioevo: contributo alla storia del Medioevo italiano, Lugano, Associazione Ex Allievi della Scuola Politecnica Federale, 1954.
Segni del ’700: Segni del ’700 in Varese: l’infeudazione, il catasto, le ville, Varese, Credito Varesino, 1981.
SELLA 1978: SELLA Domenico, Per la storia della coltura e della lavorazione del lino nello Stato di Milano durante il secolo XVII, in Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini, Milano, s.i.e., 1978, pp. 791-803.
SELLA 1982: SELLA Domenico, L’economia lombarda durante la dominazione spagnola, Bologna, Il Mulino, 1982 (Cambridge, Mass., 1979).
SIMONI 1992: SIMONI Carlo, Economie, paesaggi, identità del Garda (1797-1914), in Atlante del Garda. Uomini, vicende, paesi, Brescia, Grafo, 1992, vol. II, pp. 69-210.
217
SIMONI 1995: SIMONI Carlo, Lavoro, tecnologie, percorsi imprenditoriali. Le cartiere del Toscolano dall’età napoleonica agli anni Trenta del nostro secolo, in Cartai e stampatori a Toscolano. Vicende, uomini, paesaggi di una tradizione produttiva (a cura di Carlo Simoni), Brescia, Grafo, 1995, pp. 99-154.
SOLMI 1926a: SOLMI Arrigo, Formazione territoriale della Svizzera italiana, “Archivio storico della Svizzera Italiana”, a. I (1926), prima parte, n. 1, pp. 5-39.
SOLMI 1926b: SOLMI Arrigo, Formazione territoriale della Svizzera italiana, “Archivio storico della Svizzera Italiana”, a. I (1926), seconda parte, n. 2-3, pp. 97-129.
SPARTA’ 1999: SPARTA’ Gianni, Per acqua ricevuta. Sorgenti, pozzi, fontane: l’affascinante storia di una conquista civile, Varese, Macchione Editore, 1999.
Statistica 1873: Statistica agricola, industriale, commerciale del Circondario di Varese. Anno 1873. Relazione della Camera di Commercio e d’Arti di Varese a S. E. il Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d’Italia, Varese, Tipografia Ubicini, 1873.
Statuti del comune di Padova: Statuti del comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285, a cura di Andrea Gloria, Padova, F. Sacchetto, 1873.
Statuti di Bologna: Statuti di Bologna dall’anno 1245 all’anno 1267, vol. I, a cura di Luigi Frati, Bologna, Regia Tipografia, 1869.
Statuti di Como… 1335: Gli Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum, a cura di Guido Manganelli, Como, Tipografia editrice Cesare Nani, 1936, voll. 3 (Regia deputazione di storia patria per la Lombardia - Sezione di Como, Società storica comense, XIV).
Statuto di Bergamo… 1331: Lo statuto di Bergamo del 1331, a cura di Claudia Storti Storchi, Milano, Giuffrè, 1986 (Fonti Storico-giuridiche. Statuti, 1).
STEVENS, GEHL 1994: STEVENS Kevin M., GEHL Paul F., Giovanni Battista Bosso and the the paper trade in late sixteenth-century Milan, “La bibliofilia”, a. XCVI (1994), n. 1, pp. 43-90.
Storia di Livigno 1995: Storia di Livigno dal Medioevo al 1797, a cura di Mario Gaiaschi, Alberto Gobetti, Francesco Palazzi Trivelli, Ilario Silvestri, Nadia Taglietti, coordinatore Francesco Palazzi Trivelli, Sondrio, Società storica valtellinese, 1995 (Raccolta di studi storici sulla Valtellina, XXXII).
STROMER 1992: VON STROMER Wolfang, Die erste Papierműhle in Mitteleuropa: Ulman Stromeirs “Hademűhle” Nűrnberg 1390-1453. An der Wiege der Massenmedien, in Produzione e commercio della carta e del libro (secc. XIII-XVIII), Atti della Ventitreesima Settimana di studi dell’Istituto internazionale di storia economica “Francesco Datini” di Prato (15-20 aprile 1991), a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1992, pp. 297-311.
SUTERMEISTER 1946-48: SUTERMEISTER Guido, Gli editori “da Legnano” (1470-1525), Varese, Tipografia arcivescovile dell’Addolorata, 1946-48, 2 voll.
TORELLI 1980: TORELLI Pietro, Studi e ricerche di diplomatica comunale, Mantova, Stab. tip. G. Mondovì, 1911 (rist. anast. Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980).
TORRIANI 1893: TORRIANI Edoardo, Dall’Archivio dei Torriani in Mendrisio. La famiglia Lavizzari, “Bollettino storico della Svizzera italiana”, a. XV (1893), n. 4, pp. 186-188.
218
TOUBERT 1995: TOUBERT Pierre, Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell’Italia medievale, a cura di Giuseppe Sergi, Torino, Einaudi, 1995, pp. 3-19.
TREZZI 1986: TREZZI Luigi, Ristabilire e restaurare il mercimonio. Pubblici poteri e attività manifatturiere a Milano negli anni di Carlo VI, Milano, Franco Angeli, 1986.
TSCHUDIN 1999: TSCHUDIN Pierre F., Le passage du papier artisanal au papier de grande série à la fin du XVe siècle, in Le papier au Moyen Age: histoire et techniques. Actes du Colloque international du Centre national de la recherche scientifique, Institut de France (Paris, 23-25 avril 1998), éd. par Monique Zerdoun Bat Yehouda, Turnhout, Brepols, 1999, pp. 2-16.
VACCARI 1958: VACCARI Pietro, I diritti concessi alle città lombarde sulle acque e sui fiumi nell’alto Medioevo, “Archivio storico lombardo”, s. VIII, a. LXXXV (1958), vol. VIII, pp. 201-212.
VERRI 1763: VERRI Pietro, Considerazioni sul commercio dello Stato di Milano… (1763), a cura di Carlo Antonio Vianello, Milano, Università L. Bocconi, 1939.
VIGO 1991: VIGO Giovanni, Politica economica e metamorfosi industriale nella Lombardia spagnola, “Rivista milanese di economia”, a. X (1991), n. 40, pp. 113-124.
VIGO 2000: VIGO Giovanni, Nel cuore della crisi. Politica economica e metamorfosi industriale nella Lombardia del Seicento, Pavia, Università di Pavia, 2000.
VISMARA 1978: VISMARA Giulio, Il patriziato milanese nel Cinque-Seicento, in FASANO GUARINI Elena (a cura di), Potere e società negli stati regionali italiani del ’500 e ’600, Bologna, Il Mulino, 1978, pp. 153-171.
WEE 1978: WEE Hermann van der, Sistemi monetari, creditizi e bancari, in Storia economica Cambridge, vol. V, Economia e società in Europa nell’età moderna, a cura di E. E. Rich e Charles H. Wilson, Torino, Einaudi, 1978 (Cambridge 1977), pp. 338-451.
www.museodellacarta.com: sito Internet del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano.
www.museodellacarta.it: sito Internet del Museo della Carta di Amalfi.
ZALIN 1983: ZALIN Giovanni, Tra serre, opifici e fucine (le tipiche attività di produzione e trasformazione nella Riviera benacense, seoli XV-XVIII), in BORELLI Giorgio (a cura di), Un lago, una civiltà: il Garda, Verona, Banca popolare di Verona, 1983, vol. I, pp. 327-374.
ZALIN 1985: ZALIN Giovanni, Origini e sviluppo dell’industria cartaria nella “Riviera” bresciana del Garda, “Archivio storico italiano”, n. 526, ottobre-dicembre 1985, pp. 595-610.
ZALIN 1992: ZALIN Giovanni, L’arte cartaria nella Riviera bresciana, in Atlante del Garda. Uomini, vicende, paesi, Brescia, Grafo Edizioni, 1992, vol. II, pp. 53-65.
ZALIN 1998: ZALIN Giovanni, L’arte cartaria sulle rive del Garda: tecniche, produzioni scambi (sec. XIV-XVIII), in FANFANI Tommaso (a cura di), Saggi di storia economica. Studi in onore di Amelio Tagliaferri, Pisa, Pacini Editore, 1998, pp. 93-118.
ZANETTI 1986: ZANETTI Dante, La vite e il vino nell’economia lombarda del Cinque e del Seicento, in Studi in onore di Antonio Petino, vol. I, Momenti e problemi di storia economica, Catania, Università di Catania, 1986, pp. 194-209.
219
ZANINELLI 1991: ZANINELLI Sergio, Aspetti economico-produttivi, di mercato e tecnologici, in Storia dell’industria lombarda (a cura di Sergio Zaninelli), vol. II, Alla guida della prima industrializzazione italiana, II, Dalla fine dell’Ottocento alla Grande Guerra, Milano, Il Polifilo, 1991, pp. 1-99.
ZANOBONI 1994: ZANOBONI Maria Paola, Gli statuti del 1511 dei filatori di seta milanesi, “Archivio storico lombardo”, s. XII, a. CXX (1994), vol. I, pp. 423-444.
ZANOBONI 1996: ZANOBONI Maria Paola, Artigiani, imprenditori, mercanti. Organizzazione del lavoro e conflitti sociali nella Milano Sforzesca (1450-1476), Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1996.
ZANOBONI 1997: ZANOBONI Maria Paola, Produzioni, commerci, lavoro femminile nella Milano del XV secolo, Milano, CUEM, 1997.
ZANOBONI 2001: ZANOBONI Maria Paola, “Noctis tempore rapuit et exportavit rotam”. Disavventure dell’unico mulino da seta ad energia idraulica di Milano (seconda metà del secolo XV), “Storia economica”, a. IV (2001), n. 1, pp. 149-183.
ZANOBONI 2005: ZANOBONI Maria Paola, Profili biografico-patrimoniali di alcuni mercanti di carta milanesi (seconda metà XV - inizi XVI secolo), in Cinque secoli di carta. Produzione, commercio e consumi della carta nella “Regio Insubrica” e in Lombardia dal Medioevo all’età contemporanea. Convegno di studi (Varese, 21 aprile 2005), in questo volume.
ZANZI, MONDINI 1981: ZANZI Luigi, MONDINI Piero, Lotta per le riforme e per la statualizzazione dell’Impero nel ’700: il caso di Varese, tra istituzione del Catasto e infeudazione. Fonti nuove per la storia della politica di Maria Teresa in Lombardia, in Segni del ’700: Segni del ’700 in Varese: l’infeudazione, il catasto, le ville, Varese, Credito Varesino, 1981, pp. 130-187.