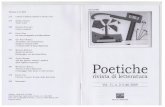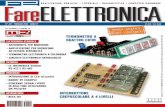«Fare gli Italiani»: La Scuola in “Cuore” di Edmondo De Amicis tra missione sociogenetica e...
Transcript of «Fare gli Italiani»: La Scuola in “Cuore” di Edmondo De Amicis tra missione sociogenetica e...
i
i
III
J
r
Ii
I
I
Roemro UgsTDENTE
"FARE GLI ITALIANI".LA SCUOLA IN CUORE DI EDMONDO DE AMICIS
TRA MISSIONE SOCIOGENETICA E UTOPIA SOCIALE
,l::.I Il piü grande problema che l'Italia dovette affrontare nel suo
costituirsi a Stato modemo fu quello di creare una unitä nazio-nale operante nella coscienza dei cittadini. La classe dirigente af-fidö questo compito alla scuola 1.
Cuore. Libro per i ragazziz - Sin dal suo sottotitolo questo fomanzo indicaespressamente i zuoi destinatari ben tenuti presente dall'Autore lungo tutta lastÄsura. Cuore ö un libro di ngazzi (ossia che parla di loro) e per ngazzi (cioE
che parla a loro). La scelta däl titolo scaturisce direttamente da quell'amorefraterno che De Amicis, nella successiva ricostruzione della sua genesi, ltrole
1 P. }}1rrrreRr,(Jn caore grande cosi. Edmondo De Amicis: un uotno per il socialismo,Mi-lano, Sugarco, 1989, p. 4) .',
Cuorc viene plbblicato nel 1886 dall'editore Treves. Quella di scivere un libro per ra-
gazzi ambientato in una scuola era una vecchia idea di De Amicis che risaliva al 1878 ma solo
äel 1884 egli aveva cominciato a concreizzarla lavorandoci per circa due anni_fino gl giu.gng
dell' '86. Säcondo la testimonianza del Mosso (I tempi del Cuore\: "1' 15 ottobre [1886] I'Italia ö
inondata di Cuori". Anche se enfatizzate, queste paiole rendono appena l'idea dell'enorme dif-fusione e dello srepitoso successo che quästo romanzo ebbe sia in Italia sia all'estero. Risulta
difficile, se non impossibile, render corrtö di tutte le edizioni che da allora ha avuto il libro. Le
tappe principali dilh sua storia editoriale sono comunque almeno le seguenti: 1886: Prima edi-ziöne;lgSO, Cenresima edizione; I892:P{rmaedizione illustrata; I9l0 Edizione del mezzo mi-lione di copie; 1916: Edizione del Cinquantenario;1946: Edizione del Centenario della nascita
dell'Autore; 1958: Edizione per il Cinquantenario della mone dell'Autore. A ciö vanno aggiun-te le numerose traduzioni in inglese, spagnolo, polacco, tedesco, ungherese, portoghese, serbo-croato, svedese, olandese, daneie, russo,lrancese, armeno e... Iatino. Per maggiori dettagli sullastoria editoriale dell'opera e delle sue numerose Edizioni in lingua straniera si rimanda alle"Note e notizie sui testi", in E. Dp Aurcrs, Opere scebe, a c. di F. Portinari e G. Baldissone, (IMeridiani Collezione), Milano, Mondatori, 2006, pp. ll29 -lß 0.
I
I
I
"f.
iI
I
I.l 83
Roberto Ubbidiente
all'origine del romanzoi una carezzas. Questa ricostruzione tanto semplicequanto idealnzata non rende ragione, perö, della complessitä dell'ordito te-
siuale di questo romanzo-multistrato. Dal punto di vista della tama, Cuore -ö noto - si presenta anzitutto come il diario di uno scolaro di terza classe, En-rico Bottini, tenuto nell'anno scolastico 1.88I-824. La sua trama ö dunquescandita dal ritmo del calendario scolastico (calendario del tutto civile e nonreligioso)5 e dal succedersi di fatti, episodi, awenimenti, piccoli e grandi, le-
eati al mondo della scuola e ai suoi protagonisti. Nel suo complesso, perö, iliesto ö ben lungi dall'essere un mero racconto lineare di fatti e awenimentilungo un tracciato esclusivamente cronologico. Intersecati con quello diari-stico, infatti, appaiono almeno altri due piani testuali:
1) Pagine scritte dal padre, dalla madre o dalla sorella del protagonista, dicui essi si servono per 'comunicare' con tl ngazzo, sopperendo in tal modoall'evidente mancanza di dialogo franco e diretto tra genitori e figlio o mem-bri della stessa famiglia, nell'ambito di un sistema pedagogico sostanzialmen-te paternalistico e improntato alla subordinazione e all'indiscusso rispettodell'autoritägenitoriale,paternaanzitutto6. 9
2) Copie di racconti mensili scritti a scuola sotto dettatura e ricopiati a
casa nel diario.
In tal modo, la riflessione sugli awenimenti condotta da Enrico come au-tore del diario e la conseguente analisi introspettiva del ngazzo appaiono in-
r In "Come nacque il Cuore" I'Autore racconta di aver assistito ad una carezza che suo figlio Ugo diede ad un compagno di scuola, figlio di un fabbro: "Fu come un lampo; mi passödavanti l'immagine di un sogno: I'immagine della fratemitä umana predicata con la voce del-l'infanzia" . Cfr. G. Bnnrolrur, "Come nacque il Cuore di Edmondo De Amicis", n La Lettura.Rivista mensile del Corriere della Sera, n. 5 , mag. 1908. Questa visione "romanzata" della gene-si del romanzo ö del tutto "parziale" e non rende conto del lungo periodo di gestazione cheebbe il progetto, di cui testimoniano anche gli scambi epistolari con Treves.
a Bisogna perö tener presente che rl.Regolanento per le scuole rnunicipali di Torino (Toi-no, Botta, 1879) suddivideva la prima elementare in una classe inferiore ed una successiva su-periore. Di conseguenza,Iaterza classe, di cui si parla nel libro, veniva a corrispondere in realtäalla quana, ossia alla prima del grado superiore.
5 La scansione dei Capitoli awiene lungo la successione dei giomi della settimana e deivari mesi, iniziando da ottobre e tinendo con luglio, rispettivamente inizio e fine dell'anno sco-lastico. Ogni capitolo, inoltre, risulta suddiviso in pani, corrispondenti alle pagine del diario,con titoli diversi (sintetizzanti I'argomento rattato o iI fatto narrato) e corredate ciascuna conrelativa data e giomo della settimana.
6 Va notato che i familiari di Enrico si inseriscono nel suo monologo interiore sia per co-municargli i loro sentimenti sia - piü spesso - prendendo spunto dall'awenimento appena nar-rato nella pagina immediatamente preiedente, non di rado per rimproverargli qualche mancan-za o impartirgli un insegnamento morale facendogli notare questa o quella mancanza nella suacondotta-
u 85
La scuola in Ctote di Edmondo De Anicis
tersecate a fitmo piü o meno regolare (nel caso dei racconti scolastici, a sca-
denza mensile) con I'inserimento di voci esterne che si materializzano sotto
forma di pagine inframmezzate a quelle del diario-pefsonale, I^ cui segretezz^
viene cosi irrimediabllmente violata. Per i suoi, dunque, Enrico ö un vero e
proprio "libro aperto" che non ha e non puö avere segreti. Il s-t'o diario regi,tr" l'"rrdu-ent; del suo sviluppo interiore che, perö, viene influenzato - per
non dire: guidato - dagli interventi esterni dei coautori. Ciascuno di questi
(p"dr., *är", sorella) i"pp..r"rrt, una determin ataistanza e lascia nel diario
ärl r^gur"o un'improntaäirr.rr" dalle altreT. In tal modo, ciö che dovrebbe
esser;n *otololo interiore viene trasformato in una polifonia di voci e in-
terventi che s'insJriscono nella riflessione introspettiva del rugazzo influen-
zandola, condizionandola, dirottandola verso determinati ideali tipici della
concezione della scuola e della societä sostanzialmente borghese.
A queste voci delT'auctoritas f.amigliare si aggiungono poi quelle a scaden-
," -..ril. fappresentate dai ,"..otii dettati in classe dal maestro e fedel-
mente riportaii nel diario. Tali racconti costituiscono la voce dell'auctoritas
istituzioriale scolastica di stampo civile, che si inserisce nel discorso diaristicoproponendo modelli ed esempi di virtü e coraggio civile volti afarc diEnrico(. di t,-rtti gli alunni della scuola) dei cittadini esemplari dai ndicativalori so-
ciali. Rinvlndo ad altra occasione un'analisi piü dettagliata di questi nove
"racconti del cuore", facciamo qui almeno notafe dei punti che emergono
chiaramente dalla sola lista dei titoli 8:
1) I protagonisri sono sempre dei ngazz,i o addirittura bambini (mai
bambinei). Ci5 viene stigmatizzÄto giä dal titolo con il frequente uso dell'ag-
gettivo "piccolo" (indicinte non solo I'etä o la statura ma anche l'atteggia'
mento paterno - o paternalistico - dell'Autore) oppure di forme diminutive
in " -ino" .
7 In particolare, il padre (rappresentante I'autoritä indiscussa e indiscutibile del pater fa'*itiai ÄfeÄene .on ,i?lessioni ä"1 *ut.uto tono di rimprovero per qualche disattenzione o
Äüitäolrrr del figlio, o, in alternativa, per suscitare irlui nobili sentimenti iqProntati per-
i;;il ;i ti;;;;;r +gfi ia.ai patriottici e d'ell'Autoritä in os{ri.sua forma e manifestazione. La
-äär.. i" L*U., i-irr..., ,rppro.rrt*o I'ideale "femminile" di un amore incondizionato e au-
l"r".riti.""Äi .ü. ""Uu
.t iLä.. ,,rtto dona, salvo poi registrarlo nel suo diario con lieve tono
di rimprovero per mancata gratitudine o corrispondenza da pane di Enrico'- ^-;?aliiiJ
r*ä""o iia"" della funzione "civile" e söciogenetica di questi racconti nel
qgudro d.l programma educativo scolastico. In ordine cronolog_i:o da ottobre a giugno, abbia-
äi-il iäit" i"tiota padouano, La piccola uedetta lonbarda, ll 4icgolo s.criuano fioren-tino, Il;;;tr;no ,oräo, L'iofrr*;ere di Tan (in abbozzo: ptima L'ospeikle, poi ll piccolo inferrniete
nipoietano\, Sangue romagnolo,Valor cioile (non un iacconto come.gli altl *? * resoconto di*" p"gi"" di .ön"." neä'ambito della fabula\, Dagli Appennini alle Ande e Naufragio (n oli-gtrne: Il piccolo naufrago\.
Roberto Ubbidiente
2) Ciascun racconto illustra una dote o una virtü civile, diventando cosivn exemplurn di quei valori cui la Scuola ö chiamata ad educare i cittadini didomani. Si tratta -perlopiü di storie i cui piccoli protagonisti mostrano unospiccato quanto elevato senso civico e patrlottico ihe non li fa esitare a sacri-ficarsi per gli altri (amici, famigliari o iemplici sconosciuti) e per il bene co-mune,
l) Il filo che unisce i nove racconti si dipana lungo I'intera penisola italia-na (sia pure con uno sbilanciamento verso il Nord) e unisce tra loro protago-nisti originari di diverse regioni e cittä, tutti uniti dagli stessi ideali civici e pa-triottici, dallo stesso spirito di sacrificio per la famiglia, la societä, I'Italia.
Tralasciando, per motivi di spazio, gli interventi esterni, ci concentrere-mo di seguito sulle pagine autografe di Enrico, pet analizzare il ruolo svoltodall'istituzione scolastica nel percorso formativo della sua personalitä di citta-dino e 'pattiota'.
Prima, perö, andrä contestuaüzzata, siapur in forma sintetica, la situazio-ne del sistema scolasdco in cui venne a trovarsi l'Itaha all'indomani dell'Uni-tä.
La Scuola postunitaria
All'epoca in cui ö ambientato Cuore (anno scolastico 1881-82) I'istruzio-ne primaria in Italia era stata regolata da due importanti leggi. A ridosso del-I'Unitä era stata varata la legge Casati (Nr. 1752 dell'l1 novembre 1859) chestabiliva e ganntiva I'obbligatorietä e la gratuitä dell'istruzione primaria, affi-dando la gestione delle scuole ai singoli Comuni e il controllo ai Consigli pro-vinciali. La scuola veniva inoltre distinta in due ordini (inferiore e superiore)e si prevedeva per la prima volta I'impiego di maestre anche in classi maschili,mentre gli istituti continuavano ad essere divisi in sezioni maschili e femmi-nili.
A questa norma si aggiunse successivamente la legge Coppino (Nr. 3968del 15 luglio 1877) che, a un anno dall'awento della Sinistra al potere, ribadi-va i principi della Casati fissando I'obbligo scolastico dai6 ai9 anni. Tale leg-ge, inoltre, mirava ad unire Scuola e lavoro, promuovendo scuole professio-nali, serali e addirittura festive. Al di lä di ciö, il sistema dell'istruzione creatocon la legge Casati continuava a sussistere, anzi eru stato allargato a tutta I'I-talia.Tale sistema era stato modellato sugli interessi della classe dirigente e sibasava sulla centralitä del ginnasio cui accedevano i suoi figli. Dal momentoche la scuola era di competenza comunale, ö chiaro che I'arretratezza socio-economica e culturale di moltissimi Comuni (specialmente del Sud) non po-
86 87
I-a scuola in Crore di Edmondo De Atnicis
teva non riflettersi anche sul sistema scolastico. Dieci anni dopo l'Unitä,lungidall'attenuarsi, questo divario era addirittura cresciuto e.
Il fenomeno venne variamente denunciato da attenti intellettuali e opera-tori del settore 10. Fu cosi che il problema delf istruzione venne gradualmentea coincidere con la questione dell'emancipazione sociale ed economica delleclassi subalterne. Non meraviglia, perciö, che "i movimenti che si facevanointerpreti delle esigenze del popolo erano anche i piü pronti a far propri ioroblemi della scuola" 1I.
^ E it caso della rivista Cuore e uitica che in quegli anni abbracciö la causa
del malfunzionamento scolastico e delle condizioni di lavoro degli insegnanti.Al piü tardi a partire dal censimento del 1878, da cui risultö un tasso di anal-fabetismo pai. al78Yo della popolazione (sceso nel 1881 d,67y"), apparechiaro che "la scuola post-unitariaeta,in tutto e per tutto, lo specchio delpaese" e il problema dell'istruzione e della cultura come patrimonio comunet'ö la pronu di una giustizia sociale vera" 12.
"Quell'edificio gentile": la Scuola del Cuore
Per il suo carattere formativo e per il ruolo fondamentale che essa gioca
nell'acculturazione popolare e nella diffusione dell"'educazione civica", l'i-struzione pubblica tri"n" dnnqne a trovarsi al centro degli interessi nazionali.
Sintomatica ö "la risposta dilvlazzinia Bakunin che gli chiedeva quale s-1eb-
be stato il primo articolo del programma della eventuale Repubblica italiana:<Fonderei^scuole, poi scuole, poi ancora scuole>>" 1i. Giustamente Asor Rosa
rileva che "I'esigsÄza dell'educazione domina sovrana la realtä italiana diquesti anni" 14.Ilcarattere cruciale di questa esigenza ö sonolineato in Cuore
dale ultime parole di un Cavour agontzzante: "Educate l'rnfanzia... educate
I'inf.anziae lä gioventü. .. governate con la libertä" 15.
De Amicii ö consapeirole che nell'Italia postunitaria "la disuguaglianza
e Secondo |e statistiche, per esempio, ai 676) istitntiscolastici piemontesi ed ai 626) lom'bardi in Calabria e in Sardegna ne corrispondevano rispettivamente solo- 940 e678'
10 Grande eco ebbe pE .r.-pi. un articolo di Pasquale Villani-dal titolo I-a scuola e la
questione tiritr,ncui si öoncludeva provocatoriamente: nlasciatemi la mia ignoranza, poich6
mi lasciate la mia miseria". Tra i piü autorevoli interventi, poi, si registra la prolusione tenuta
da Francesco De Sanctis all'universitä degli Studi di Napoli. cfr. P. Pnrrrrrm, op. cit., p. 4) .
11 P. Pu,rnreru, op. cit., p.47 .
t2 Iui,p.49.tt lui. o. 4J .
to A.'Äson Rosn, "Le voci di un'Italia bambina (<<Cuore>> e <Pinocchio>)", i" M,YV',stoia d,Italia. Datlunitä ad ogi,Torino, Einaudi, l975,Edtz. spec. per Il sole 24 ore, Milano2005, vol. 9: Letteratura e suiluppo della nazione, p.926.
lt Cfr. "Il conte di Cavour" (29 marzo\.
Roberto Ubbidiente
del sapere faceva tutt'uno con la disuguaglianza economico-sociale" t6 e, purnon abbandonando I'ottica borghese, propone con Cuore un modello socialecui awiare le giovani generazioni. Pertanto, sarä la Scuola a rappresenrare"l'ambiente privilegiato di cuore,l'ambiente di kradiazione di tuitä la sua fi-losofia morale e sociale, di tutti i suoi nutrimenti sentimentali" 17. L'etä mediadei lettori a cui il romanzo d. indüzzato ö fissata dallo stesso Autore in unaNota iniziale tra i nove e i tredici anni 18.
Queste considerazioni, perö, non ci aiutano a f.otogr^fare gli alunni dellascuola fittizia che, infatti, risultano sorprendentemente in una fascia di etäpiü ampia che va dagli otto anni di Rabucco (il cosiddetto "muratorino") aiquattordici di Garrone. Enrico, da parte sua, ne ha undici, mentre Derossi, ilprimo della classe, ne ha dodici. Il fatto di essere fuori etä scolare per la clas-se frequentata si spiega con il carattere fittizio ed esemplare della scuola e deisuoi alunni, minando ab ouo la storia nelle sue pretese di racconto realistico.Alle diverse etä degli alunni fa eco la loro diversa origine sociale. La classe diEnrico comprende alunni del ceto nobile, borghese, e figli del popolo, torine-si e immigrati (il piccolo Calabrese). Il lettore viene a trovarsi inizialmentenelle stesse condizioni del nuovo maestro (sucieduto alla maestra del primociclo), che all'inizio dell'anno scolastico deve imparare tutri i nomi degli alun-ni e associarvi i relativi volti. Tranne che per ii protagonista, i ragazzi di Cuo-/e vengono indicati sempre e solo con il loro cognome o, in alternativa, colmestiere del padre, sia pure addolcito del suffisso del diminutivo (v. "il mura-toino") oppure con la provenienza geografica (v. "il piccolo Calabrese"). Piüantipatrca, invece, risulta la stigmatizzazione del difetto fisico nel caso di"Nelli il gobbino". L'uso dei cognomi lungo tutto I'arco del romanzo contri-buisce a mantenefe l'atmosfera scolasdca e i rapporti "di classe" anche quan-do la trama si sposta al di fuori dell'istituto päitrasferirsi, per esempio, "Inuna soffitta" (28 ottobre), "In casa del ferito" (i8 dicembre), ne "La libreriadi Stardi" (4 gennaio), "In campagna" (19 giugno) o semplicemente a casa diEnrico (per es. "Una bella visita", 12 gennaio). Dopo 1ä presentazione delnuovo maestro, Perboni, il lettore fa ben presto la conoscenza dei principaliprotagonisti del libro: ossia i compagni di classe di Enrico. Dei 54 alunni checompongono la sua classe, solo una quindicina sono suoi vecchi compagni,
16 P. PrLrrrnnr, op. cit., p. 44.
f ] B.Tnavry9rrn, In t ro duzio n e a D e Am i ci s, Roma-Bari, Laterza, 199 L, p. 7 3 .
. 18 "Questo libro ö panicolarrnente dedicato ai ragazzr delles.nole el.-.rrtari, i quali sono
tra i nove e i tredici anni, e si pouebbe intitolare: Sioria d'un anno scolastico, scritta da unalunno di 3', d'una scuola muniiipale d'Italia. [...] ora leggete questo Lbro, rugazzi: io speroche ne sarete contenti e che vi fara del bene'. E. De Arr,ncr"sl cz ore, n operi srihr, op. ,i., p.101. Va notato, ma questo esula dal nostro tema, che nella complessiviia della fabato, qu."t^Nola esplicativa sortisce un effetto contrario al suo intento e confände il lettore .h. a it dätto ,chiedersi quale istanza prenda qui veramente la parola.
88 89
La scuola in Cr;rte di Ed'mondo De Amicis
passati con lui dalla seconda alla tena. E solo di loro egliparlerä nel suo dia-iio. Ognuno di essi viene presentato contaddistinto da una determinatadote, vizio, virtü o caratteristica fisica o morale che lo accompagnerä per tut-to il libro.
Cognome
Garrone
Coretti
Nelli
Votini
I1 muratorino
Garoffi
Carlo Nobis
Precossi
Crossi
Stardi
FrantiDerossi
Segno distintivo
"Il piü grande della classe" e il piü buono di tutti:I'altruismo in persona.
"Figliuolo di un venditore di legna", giä soldatopluridecorato durante la guerra del 1866 (IIIGuerra d'Indipendenza).
"Un povero gobbino, gracile e col viso smunto".
"Molto ben vestito" (il vanitoso sempre attentoall'aspetto).
"Sa fare il muso di lepre" (che intenerisce a gua-
darlo).
"IJn coso lungo e magro" che "traffica semprecon pennini, immagini, scatole di fiammiferi" e siscrive la lezione sulle unghie
Il "signorino" (l'unico presentato anche colnome) che "sembra molto superbo".
"Figliuolo di un fabbro"; a lui Enrico vuole piübene che agli altri.
Il bambino dai capelli rossi "che ha un bracciomorto" appeso al collo.
"Un grugnone" che "pare che capisca poco, masta attento al maestro senza battere palpebra".
"L'infame".
"Il piü bello di tutti" e il primo della classe.
La galleria di questi personaggi, con i loro difeni e le loro qualitä, corri-sponde ad una rappresentazione di varia umanitä chiamata a crescere e a cor-räggersi attraversö I'interazione e il commercio delle reciproche rclazionire.
le A ben guardare, a partire dai loro tratti tipici, ö possibile ordinare questi personaggi incoppie per analogia o per conuapposizione. Oltre a due gemelli "vestiti eguale, che si somiglia-no a pennello" (di cui perö non si farä piü cenno nel corso della vicenda), individuiamo almenodue coppie per contrapposizione: 1) Garrone/Franti (rispettivamente il piü buono e il piü catti-vo, a giudizio di Enrico); 2) Derossi,/Stardi (ossia colui che impara con maggiore facilitä e coluiche invece ha maggiore difficoltä di apprendimento, sia pur compensata da una volontä di fer-ro). A queste coppie se ne aggiungono almeno tre per analogia: 1) Nobis/Votini (rispettivamen-te superbo / vanitoso); 2) NeVCrossi (gobbino / invalido); 3) Coretti./Precossi (figlio di le-
Roberto Ubbidiente
La Scuola rappresenta lo spazio ideale, I locus deputatus in cui, nell'eserciziodei reciproci rapporti, vengono forgiati i carutterie le personalitä di questi ra-g zzi,ptep^randoli ad essere i cittadini di domani, in modo tale che all"'Italtabambina" di oggi, cui Cuore dä voce 20, sia presto possibile crescere democra-ticamente, culturalmente e civilmente.
Sin dalla prima pagina,la Scuola appare dunque nella sua funzione di pa-lestra ideale per esercitare le virtü e correggere i difetti degli italiani di doma-ni, chiamati a costruire una societä e un Paese migliori e piü giusti. Questo öanche lo scopo dei racconti mensili (v. supra) che, con la loro esemplaritä, de-vono suscitare nell'animo dei piccoli alunni I'amore per i valori e le virtü civilie il disprezzo per il loro contrario. La virtü fondamentale che i rugazzi sonochiamati a sviluppare ö la solidarietä. Il vizio piü grande che essi devonoemendare ö I'egoismo. Egoismo e solidarietä sono gli estremi di una lineacomportamentale e di sentimenti dalle molte sfumature, lungo la quale sipongono i vari coprotagonisti. Alle due estremitä di questa linea troviamoGarrone (massima espressione di altruistico amore fraterno) e Franti (la catti-veria in persona, che verrä espulso dalla sguola come il vizio che egli rappre-senta deve essere espunto dagli animi dei suoi compagni).
Oltre e prima che essere luogo di istruzione,la Scuola deamicisiana ö luo-go di formazione della personalitä in vista della futura convivenza civile deisuoi alunni in seno ad una erigenda societä che I'Autore auspica piü giusta edequa. Dal punto di vista programmatico, la sociogenesi cui ö chiamata a con-tribuire la Scuola va a braccetto con la solidarietä sociale e la disponibilitä all'(auto)sacrificio per il bene comune. Ciö vale soprattutto per la classe piü privilegiata cui appartiene il protagonista:
Anche l'Enrico di Cuore ö un personaggio messo di fronte a prove dolorose e difficfi,che ci fanno capire come il primo valore educativo sia per questi scrittori e per il loroambiente il "sacrificio" (cioö, la dedizione, lo sforzo e I'altruismo) 1...1: l"'Italietta"postunitaria, messa continuamente di fronte ai propri limiti e alle proprie debolezze,doveva essersi fatta I'idea che senza un incremento strenuo di questo valore non si sa-
rebbe mai creata una mentalitä e delle abitudini di nazione modema; che, anzi, fra lenon molte "risorse" di cui poteva disporre, il sacrificio, - cioö il rafforzarnento alta-mente soggettivo e volontaristico della tempra morale e intellettuale, - fosse una delle
gnaiolo / figlio di fabbro) cui va aggiunto anche il muratorino. Coraci, il piccolo calabrese, eGaroffi, il "trafficone" sembrano invece esemplari unici nella loro diversitä fisica e morale. Inrealtä il secondo ö destinato a ereditare il negozio del padre (e per il commercio ö particolar-mente portato, visto che "traffica" giä in tenera etä), mentre il primo farä I'emigrante a Torino.Una coppia, se si vuole, per contrapposizione.
20 Cfr. il titolo del giä citato contributo di Asor Rosa: "Le voci di un'Italia bambina(<<Cuore>> e <Pinocchio>)".
90 9t
La scuola in Cuore di Edmondo De Arnicis
piü importanti. Niente di strano, dunque, che lo si indicasse alla-generazione dei gio-
"anissimi come la strada da battere per la grandezza della patna2l.
Il motivo del sacrificio valn Cuore di pari passo con quello del lavoro chenella visione borghese dal suo Autore diventa un "valore-principe" che
giustifica a sua volta la concezione solidaristica delle classi sociali, in quanto nel lavo-io tutte le classi possono riconoscersi sorelle. Dove ö possibile vedere come dalla mo-rale borghese (evoluzionistica) al socialismo riformista e gradualista, il passo ormaisia breve22.
Oltre che dall'idea di lavoro e sacrificio,l'immagine della Scuola deamici-siana risulta contaminata da quella della "vita militare", per riprendere un tito-lo che aveva fatto la fortuna dell'Autore in gioventü2'. In effetti, come ha giänotato Tamburini, "la scuola ö la protagonista vera" diCuore insieme all'eser-cito24. L'immagine piü volte suggerita ö quella di un esercito di studenti inmarcia verso la conquista di migliori e piü degne condizioni di vita sociale epersonale, nella convinzione (dell'Autore, che di li a poco abbraccerä la causa
iocialista) che non ci possa essere emancipazione sociale senza istruzione e cre-scita culturale. Tale convinzione, certo non difficilmente condivisibile, sarä piütardi alfa base di Primo Magio, il romanzo piü "socialista" e umanitarista diDe Amicis che in bocca al protagonista Alberto Bianchini (non a caso un inse-
gnante!) metterä le seguenti parole: "La libertä non ö che per chi ha mezzi e
ä.rltura. Chi non ha n6 gli uni n6 I'altra ö schiavo della miseria, dell'ignoranzae del caso" 2t. Il motore immobile diCuore risiede nell'intenzione di costruiree trasmettere "l'immagine della fraternitä umana predicata con la voce dell'in-fanzia" (v. supra).Per"il suo carattere interclassista la Scuola (e dopo di questa,
I'esercito) viäne'sociogeneticamente a costituife "quella specie di canozza de-
mocfatica, dove tutte"le classi continuamente siioccano e si confondano",come De Amicis scriverä piü avanti neLa carrozX.a di tutti26 in cui il tram ö de-
finito "istituzione educati*". q,r.tto cafattere "pedagogico" deriva al tram(cosi come alla nave che trasporti gli emigranti italiani iÄ Sull'Oceano) dal' con'
21 A. Ason Ros^, op. cit., p.926.22 lui,p.9)2." C(r.'iBouetti di uita militare (1867), primo grande successo del giovane Edmondo che
lo spingerä a lasciare la carriera militare per darsi alle Lettere'' ,0"L. Tawunnqr, "Peripezie di ,rn i rot. sui banchi di scuola del Novecento",i" AA.VY.'Edmonilo De Amicii, Atti äel Convegno nazionale di studi (Imperia, 10 aprile -) magg;o
1981), a c. di F. Contorbia, Milano, Garuani, 1985.''3 E.DnAlucrs, Pimo Maglgio, n Opere scelte, op. cit., pp. 601-1110; 9t P' 615' Per i
."pponl tr" t. a,r. op... cfr. L. femuruNi, "C.to..'r piogress. De Amicis^socialista", n Sebe'
stiäo Timpanaro e l) caltura del secondo Nouecento, a c. di E. Ghidetti, (Storia e Letteratura,
222),Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,2005, pp. 275-299'26 Milano, Treves, 1914, p.2. (postumo)
Roberto Ubbidiente
t^tto tra le classi e da una sorta di mescolamento reso possibile dall'abbatti-mento di qualsivoglia barriera e delimitazione nello spazio pubblico.
A ben guardare, tuttavia, non di abbattimento si tratta ma di spostamento odi momentanea sospensione causa bene comune, awertito come ßtanza priori-taria rispetto ai sia pur legittimi interessi personali. La Scuola ö la prima palestranella vita in cui potersi allenare in quesio esercizio. La scuola fitsizia di Cuoreö chiamata ad annullare e rup.rar. quella conosciuta da bambino dallo stessoDe Amicis, di cui abbiamo testimonianzaneiRicordi d'infanzia e di scuola:
Nella scuola lunga e nuda come un camerone di caserma, v'erano due file di rczzi ta-voloni congiunti: una fila per gli alunni estemi, I'altra per quelli dell'ospizio, i qualieran tutti vestiti di panno grigio. La distinzione non era soltanto nel posto e nel vesti-re; ma anche nel trattamento che usava il maestro, il quale faceva ancora una secondadistinzione fra gli estemi di famiglia cospicua e quelli della piccola borghesia. Egliaveva la voce dolce per i signori, agrodolce per i borghesucci, agra per i poveri: questicastigava a ceffoni, scrollava gli altri per le braccia, non toccava i primi. Io appartene-vo all'ordine degli scrollati2T.
Se questa era la scuola frequentata dalDe Amicis prima dell'Unitä, dopot 1,871, - altalia giä f.atta - l'istituzione scölastica doveva essere riconsiderätae profondamente cambiata per diventare il crogiuolo in cui mescolare le clas-si e cominciare, cosi, a"fare gliitaliani". Non bisogna, perö, lasciarsi fuorvia-re. La societä vagheggiata in Cuore non prevede l'abbattimento delle classi,come non ne prevede la cancellazione delle separazioni. La Scuola non öchiamata a costruire una societä di uguali per ceriso ma di uguali per dignitäe opportunitä. Come ha rilevato Asor Rosa,
De Amicis si sforza infatti di dimostrare che, pur restando inalterate le differenze diclasse, tra i bambini di quella famosa terza elementare, in quanto esseri umani e inquanto italiani, poteva egualmente nascere un vincolo fatto di anicina, di amore e direciproco rispetto (e di adesione, s'intende, ad un corpus sufficientemente omogeneodi valori): lo stesso vincolo, sul quale avrebbe potuto reggersi, qualora si fosse estesoe consolidato fino a diventare un vero e proprio "patto nazionale", il destino dell'Ita-lia futura, al quale avrebbero contribuito nei loro rispettivi ruoli, - diversi e diversa-mente collocati, ma tutti necessari e quindi tutti egualmente gratificanti, - quei bimbidivenuti adulti28.
Pur essendo tutti fratelli (e figli della stessa madre Italia) i ngazzidevonosa_pere che le differenze tra loro esistono e sono destinate a rimanere (si pensialla visione "profetica" del padre di Enrico che vede suo figlio tra vent'anni se-natore del Regno salutare con il dovuto rispetto un ex compagno di scuola riu-scito a diventare, gt^zie all'istruzione ricevuta, macchinista di treni come suo
2i Milano, Treves, 1901.28 A. Ason RosA, op. cit., p. 93 1 (corsivo nel testo).
92 9)
La scuola in Ctore di Edmondo De Amicis
padre). Compito della Scuola ö quindi assicurare I'emancipazione sociale deipiü svantaggiati attraverso la loro istruzione ma anche e soprattutto la formazio-ne di una coscienza civile che susciti in tutti - indipendentemente dal ceto diapp^rrenenza - I'orgoglio di essere italiani, I'amor di Patria e la disponibilitä alsacrficio personale per il bene comune nonch6 all'aiuto dei piü deboli. I poveridi cui ä popolato Cuore non sono mai accattoni o mendicanti ma dignitosi e"sanno esser poveri: quasi se ne contentano"2e. Non si tratta di straccioni: illoro abbigliamento ö modesto ma pulito e decoroso. La rappresentazione deglialunni piü disagiati non ö mai priva di una consapevolezza dei propri limiti do-vuti al rango occupato sulla scala sociale ma altresi della propria dignitä e delproprio valore che scaturiscono dal proprio lavoro e dal contributo personaleche si ö chiamati a fomire nell'Italia di domani. Nel rappresentare i suoi poveri,De Amicis, che di li a poco si convertirä al socialismo, muove dalla consapevo-lezza che "nel povero ö racchiusa la figura ideale del sofferente ed oppresso" r0.
Ai deboli e ai diseredati la Scuola deamicisianaha L compito di dar voce -come nell'episodio della bambina sordomuta che impara ad articolare non conil "metodo antico" (i gesti) ma "col metodo nuovo" ossia con la parola (cfr. "Lasordomuta",28 maggio). Dar voce alle classi subalterne significa emanciparleculturalmente come presupposto del loro riscatto sociale, sia pur inserito in unordine non sowertito. L'immagine della Scuola tn Cuore non ö priva di un cer-to tono poetico-sentimentale: "Tu cominci a comprendere la poesia della scuo-la, Enrico", scriverä il padre 1.26 maggo. "Quell'edificio gentile, che racchiudetanta giovinezza etante speranze" ö per la sua funzione sociogenetica una "im-m"rrr^ promessa [...] pel mondo" (ifr. "Poesia", 26 maggio) . Va da s6 che laScuola i"ppt.t.t tata in questi termini vuole essere un microcosmo sociale, I'im-magine di una piccola Italia in miniatura. Nei suoi confronti si nutrono senti-
-.iti id."lirzanti simili a quelli nutriti per la Patria, il Re e gli uomini che fece-
ro l'Italia (Garibaldi, Cavour, Mazzini)3t.Ma il parallelismo 6a la nuova Scuola e I'erigenda societä italiana non ö
solo di tipä sentimentale. Del festo, "classe" ö un termine che usiamo sia perla prima ri, p..la seconda. Certo, l'immagine deamicisiana della Scuola nonö priva di sentimenti discutibili: il paternalismo dei maestri' il maternalismodä[e maestre, il generale umanitarismo nei confronti dei piü "sfortunati" e" disgraziati" (il gäbbino, ma non solo). Tuttavia, la visione sociale in cui si in-serisce la Scuola ö quella di un'unica "farniglia" al cui bene e progresso si ö
2e G. Frnnpm, "De Amicis e la scuola del pudore", ßt Nuoua Antologia, dic' 1946,
p. )40.t0 P. SppraNo, socialismo e classe operaia a Toino dal 1892 al 7913,Toino, Einaudi,
1958,p.6.3t' Srr1l" presenza di queste figure della storia patri nel romanzo v. i Capp. "I funerali di
Vittorio Emanuele" (17 gennaio), "'Il
conte di Cavour" (29 mano), "Re Umberto" (3 aprile),"Giuseppe Mazznl" (29 aprle) e "Garibaldi" (3 giugno).
Roberto Ubbidiente
tenuti a contribuire. Sin dalle prime battute il maestro si rivolge ad un alunnoappellandolo "figliuol mio", dopo aver confessato a tutti che:
Io non ho famiglia. La mia famiglia siete voi. [...] Non ho piü che voi al mondo, nonho piü alto affetto, altro pensiero che voi. Voi potete essere i miei figlioli. Io vi vogliobene, bisogna che vogliate bene a me.
E ancora: " [...] la nostra scuola sarä una famiglia e voi sarete la mia con-solazione e la mia altetezza" ("Il nostro maestro", 18 ottobre). Dal canto suo,la partecipazione con cui la maestra segue le vite dei suoi alunni ed ex alunnidi cui "non si scorda mai" rammentandone "i nomi per anni" ("La mia mae-stra di 1" superiore" ,27 ottobre) ricorda molto da vicino quella di una madreapprensiva e iperprotettiva.Lavediamo "malata e stanca, ma sempre premu-rosa" (Ibidenn) dispenrsi quando un suo allievo ha difficoltä a scrivere, tre-mare mentre gli ispettori interrogano, esultare ai buoni esiti conseguiti, in-somma "buona sempre e amorosa come una madre" (Ibidern).Il maesüo-padre, la maestra-madre, gli alunni-figli sono tutti membri di un'unica fami-glia il cui nome ö Italia. E se si vuole chd questa f.amigha funzioni eprogredisca bisogna che ciascuno sia educato ad essere consapevole del po-sto che vi occupa e del contributo che ö chiamato a darc. Ma soprattutto, bi-sogna che ci sia armonia e mutua solidarietä e rispetto tra i suoi membri. Ol-ffe che ad insegnare a leggere, scrivere e far di conto, la Scuola deamicisiana öinvestita di una fondamentale funzione sociogenetica che la rende crucialeper le sorti della neonataltaß,a. E ciö soprattutto in considerazione della gio-vane etä dei destinatari del libro. In tal modo, la funzione della Scuola viene acoincidere con quella dello stesso libro: infondere nei lettori, attraverso unaserie di exempla e personaggi, sia in positivo sia in negativo, il valore della fra-tellanza, collante di qualsiasi societä. Questa funzione fa eco all'altro altret-tanto importante compito della Scuola come sede d'istruzione e formazioneculturale e personale quale presupposto di ogni riscatto ed emancip azionesociale. Fntellanza, riscatto! - Questi termini scaturiscono direttamente da-gli ideali umanitaristi e protosocialisti dell'Autore.
Come risulta dalla lettura del successivo Prirno Maggio,per De Amicis ab-bracciare le idee socialiste era anzitutto una questione di-pietä, poi di fede e infi-ne di speran za.i! nfatiper pietä che Alberto Bianchini, il pi&agonista del ro-manzo, "non poteva veder soffrire senza soffrire egli stesso con intensitä quasieguale a quella di chi I'impietosiva" )2.Malapietä da sola basta solo a denuncia-re le ingiustizie sociali, a non tollerarle e a ihiedersi "Che fare?". Per trovareuna risposta a questa domanda Alberto "avs/abisogno di una fede, e la volevaad ogni costo" (Ibiden). Ma ogni fede ha bisogno di una spetanz^:nella vittoria,
r2 E. De Artcrs, Pimo Maggio, op. cit., p. 652.
94 95
La scuola in Ctote di Edmondo De Anicis
nel raggiungimento dell'obiettivo. Fede, Speranza, Pietä (versione laica della Ca-
ritas cristiana) si materializzano in Primo Maggio quale versione laicamente ag-
giornata delle tre Virtü teologali in tre personaggi che rappresentano "le tregrandi forze del socialismo"': ii direttore del giornale Questione sociale e duesuoi collaboratori: un operaio-giornalista e una femminista ante litteram che" paröta una monaca che avesse buttato il velo" (Ibiden) . Se questo sarä lo sboc-co cui di li a poco De Amicis approderä tn Primo Magio, non ö difficile vederegiäin Cuore alcuni segnali anticipatori di questa posizione, anche se - ne siamoconsapevoli - ciö comporterä una parziale revisione del drastico giudizio di cuiö stato oggetto il libro (spesso, in veritä, piü per motivi di prevenzione ideologi-ca che a seguito di una approfondita analisi). NelLibro per i ragazzi l'appelloalla fratellanza ed alla solidarietä sociale, unito all'anelito di riscatto culturale deipiü disagiati, rappresentano un primo e decisivo stadio di partenza di quellaFede, Speranza e Pietä focalizzate nell'opera successiva.
Attraverso la sua galleria di exempla ed i modelli positivi, diffusamente cele-
brati, cosi come negativi, aspramente condannati, il libro Cuore diventa una sor-ta di catechismo laico, un uadernecum per formare coscienze civili che prendeil posto del catechismo cattolico inteso a formare anime e coscienze religiose,in una visione sostanzialmenteluca e positivista se non addirittura laicista e anti-clericale. Del resto, tale impostazione si rivelö in linea con i principi che di h apoco ispirarono i nuovi programmi scolastici (1388) che prevedevano; "educa-zione intelleftuale, morale e fisica, formare le teste, chiarire le idee, lotta al dog-matismo" ra e nonostantel'irnprinting positivista, insistevano (fin troppo) sullaformazione etica e civile e sul "formare della gente retta, tranquilla, solida, se-
rt^" )5. D'altro canto, la giä citatalegge Coppino, in vigore d '77, premeva "peruna decisa laicizzazionedelf insegnamento: la legge prevede lo studio dei doveridell'uomo e del cittadino al posto della religione")6. Aproposito di programma-tica laicitä, si noti come il calendario scolastico, che scandisce il ritmo del diariodi Enrico e genera la suddMsione delle parti del testo, non presenti alcun riferimento a festivitä e ricorrenze di carattere religioso owero allevacanze di Nata-lerT o di Pasqua, che pure interrompono l'anno scolastico'8. A quelle religiose sisostituiscono le festivitä o le ricorrenze civili,le commemonzionidi personaggi
tt lui, p.661.ra Cfr. P. PnLrrurru, "Cuore...socialista?", in op. cit.,Nota6.rt "Non gioverä [...] insegnargli lal bambino], suppongasi, che non dovrä mancare all'ap-
pello in caserna, se non lo si awezza per intanto a non mancare alla scuola, n6 parlargli del ri-spetto dovuto al Re, se innanzitutto non saluta il maesrro". Cit. da P. Prllnreru, op. cit., p. 48.
16 Cfr. "Note e notizie sui testi", in E. DE A-nncrs, Opere scelte, op. cit., p. 1ß7.t7 Dopo il 28 dicembre segue un inserto paterno datato )l e poi si riprende con il 4 gen-
naio, dicendo che "da tre giomi viene in sua vece ldel maestro malato] il supplente', sego cheI'attivitä scolastica era ripresa il 2 gennaio.
i8 Ciö ö stato ampiamente riconosciuto dalla critica. Cfr. per es.l'Introduzione diStamo-ne al Cuore fek rinelliano che sottolinea una scuola "laica e schierata nella battaglia anticlericale
Roberto Ubbidiente
illustri epadri della patria cosi come varie cerimonie di premiazioneper meriti;Ji; scälastici: i funerali di Vittorio Emanuele (17 gennaio),la mortä di Gari-i"ldt7 giugno),la commemonzione di Cavour (29 mamo),la festa nazionaleti Ä"n"o ma l.L,a causa del lutto dovuto alla morte di Garibaldi), la distribuzio-
,r.i"i"pr..i aglt opetai (25 giugno), la visita di Re Umberto (3 aprile). O, inalternaTiva, feste 'pagane' come Carnevale (21 febbraio)". In tutto questo laScuola definisce e delimita lo spazio di civica "sacralitä" in cui va in scäna la li-ursialaica dellaformazione delle coscienze e delle personalitä dei futuri cittadi-ni. Quest'azione.civile della S_cuola si propone comä version elaicadi quella pa-,toril" svolta dalla Chiesa nella formalzione delle coscienze dei fedeli
"tt."uäroil catechismo, i riti e i sacramenti. Tra I'altro, il paralleiismo Chiesa/Scuola ri-chiama una serie di similitudini che in questa säde possiamo solo schematica-mente elencare:
Chiesa
Anno liturgicoFestivitä e ricorrenze religiose, comme-morazione di Santi e Beati
Formazione delle coscienze
Scuola
Anno scolastico
Festivitä civili, commemorazione dei Pa-dri della Patria e di awenimenti storicicome vittorie e battaglie
Formazione della coscienza civile
Vinü civili, valore civico
9atechismo {manuale per diventare per- Cuore (vademecum per diventare perfet-tettl cnsüani) ti cittadini)Episodi e storie della Bibbia, exempla Raccontimensili: exemplaestoriediva-tratti dalla Tradizione e dalla Storia della lori civiliChiesa, agiogtafiaVirtü teologali, virtü cardinali
(in cuore nonv'ö cenno a feste.di Gesübambini, e cristi in croce)". E. Dn Aurcrs, cuore, a c. diD. Starnone, Mllano, Feltrinelli, r9.%,^p. XXiv. Escluse da['ambito ,ffid[; p,rbbrico, r.manifestazioni di re.ligiositä restano in Aä-rk^rtai-^ll;";bil;;i;r. .?-oÄ"i.o. E non me_ravlgla che rn casa -Bottini sia p.roprio la madre di Enrico a ricoidargli i suoi doveri di cristianoe fungrcr^e da pungolo 4la sensibilitä ptigio* aJfigli"- Cf.. ;;; ;i;;;;ilä; "n ;"r;;.imoni" (2 novembre).-euesta,,privatiz.zizion.', deliä,.lijiorä;ril;J;";ä;tüio ir, ü.,.".o'un assunto molto diffuso di stämpo moderatamente anticlericale . toll..urri.. Secondo Bram-billa, in cuore essa serva a."sminuit. l'i-po.tÄru-.1'".rtor.uol.rr" d.l .o-.rri" ..lii.;;, ;le€andolo perciö nell'ambito della frrgiliia .ÄLi*-. p.i.ologi."-fä.i.iF.;. Bnaunnre,.De Amicis e la scuola: appunti e dtiasaziion(,-; n Z;;;tü.-R;;;;;;';; ;"'ia umanitä, a.XXXVI, n. 2, as. tgg+, p.'>9.
'l ,S:h. quando ia ricorrenza rientrerebbe nel calendario liturgico-religioso, come nelcaso delta Uommemorazione.dgi defunti (2 novembre), il richiamo de[ä rehtivä pagina non halulla dipligloso ma muove.dalta gratitudine p.r i",,iq".tti ;;li" ;;;;p.i
".i, per ingaz-
1! p.tibt",bd" ossia per "q.r".l si logoraräno lavttäd.t""oro;i.L. ..Iifi;. ää;.;i"i 2
novembre). lnsomma, una commemorazione civile incentrata piü sul contiibuto dato dai tia-passati al progresso della societä che sul riscatto delle loro ,"it"; a"l!;;;-äJü,r.g",orio.
96 97
La scuola in Cuote di Edmondo De Amicis
Alla religione rivelata De Amicis sostituisce quella laica dell'Umanitai-smo protosocialista basato sulla rivisitazione delle tre virtü teologali in 1)
compenetrazione per i piü deboli (Pietä), cieca fiducia negli ideali socialisti(Fede), anelito di riscatto attraverso istruzione e cultura (Speranza). I compa-gni di scuola di Enrico diventano, cosi, gli Apostoli di questo nuovo Credoiutto terreno, non rivelato, ma non meno determinato a redimere e riscattare.Tutti, tranne, owiamente, Franti che, novello Giuda, ö espulso dalla Scuola/ecclesia per il suo malvagio egoismo. Franti "l'infame", che al passaggio di unreggimento ride proprio "in faccia a un soldato che zoppicava" 40, Franti chenon ha pietä neppure per le lacrime della madre, precipitatasi a scuola a im-plorare perdono per il figlio e pregare (in ginocchio ai piedi del direttore) che
vi sia per caritä! riammessoal, Franti il dissacratore beffardo di tutti i simbolidell'autoritä e dell'ordine costituito ("Uno solo poteva ridere mentre Derossidiceva dei funerali del Re: e Franti rise"a2), questo Franti risulta evidente-mente sowersivo dell'ordine sociale cui, nei progetti ancora borghesi del-I'Autore, la societä itahana doveva aspirare. Il suo riso ö una minaccia perquanti, come il diarista Enrico, si preparano a ereditare le redini del coman-do, forti di un universale riconoscimento del loro ruolo, che ricambiano con"sacrificio" solidaristico e abnegazione.
Franti sorride di fronte a vecchie inferme, a operai feriti, a madri piangenti, a maestricanuti, Franti lancia sassi contro i vetri della scuola serale e cerca di picchiare Stardiche, poverino, gli ha fatto solo la spia. Franti, se diamo ascolto ad Enrico, ride trop-po' il suo ghigno non ö normale, il suo sorriso cinico ö stereotipo, quasi deformante;ihi ride coii cirto non ö contento, oppure ride perch6 ha una missione. Franti nel co-
smo di Cuore rappresenta la Negazione, ma - strano a dirsi - la Negazione assume imodi del Riso. F-ranti ride perchd ö cattivo - pensa Enrico - ma di fatto pare cattivoperch6 ridear.
Stigmatizzato il "raditore", Cuore diventa nella visione deamicisiana ilVangelo di una nuova religione solidaristica ,laica e civile che mita a superarequella rivelata e confession ale rcalizzando ciö che essa agli occhi dell'Autorenon ö stata capace di fare: formare una coscienza nuova per i cittadini di unmondo migliore. Ben dice Asor Rosa, quando soffolinea che questo libro
fu uno degli strumenti piü potenti di unificaione culturale nazionale (intesa in sensoantropologico e psico-sociologico) sotto il segno dell'egemonia intellettuale della bor-
a0 Cfr. il Cap. "I soldati" (22 novembre).at Cfr. "La madre di Franti" (28 gennaio): "Il Direttore guardö fisso Franti, in mezzo al
silenzio della classe, e gli disse, con accento da far tremare: - Franti, tu uccidi tua madre! - Tut-ti si rivoltarono a guardar Franti. E quelf infame sorrise".
a2 Cfr. "Franti cacciato dalla scuola" (21 gennaio).a' U. Eco, "Elogio di Franti", n Diario ninimo, Milano, Mondadori, 1997 (19(f), p. 90.
Roberto ubbidiente
ghesia settentrionale. [...] Facendosi voce di tali idealitä il De Amicis si ricollegava altempo stesso a tendenze culturali e spirituali proprie della borghesia europea con-temporanea, [...] e ciö spiega, forse, perchd questo libro riuscisse a varcare i confiniitaliari e a trovare anche altrove,rna per noi inconsueta corrispondenzaaa.
N6 questo processo era destinato agli occhi dell'Autore a limitarsi all'Ita-lia. In una sorta di anticipazione inconsapevole del Socialismo successiva-mente abbracciato, De Amicis scrive infatti un romanzo "dominato dallaconsapevolezza che I'unitä politica rcalizzata in Italia ö solo il primo passo diuna unitä assai piü sostanziale ancora da rcalizzare" at. Pertanto, in quest'otti-ca "evangelizzante" del catechismo laico, in cui si suggerisce qui di leggerequesto libro, la definizione data diDe Amicis come di un "Don Bosco laico"non puö che risultare felicemente indovinata a6.
44
45A. AsonRose, op. cit.,p.928.Iui, p.9)0.F. PonrrNAxI, "Introduzione" , n Edmondo De Anicis. Operc scebe, op. cit., p. XLI
98 99
I'a scuola in Cuore di Edmondo De Amicis
Bibliografia
Ason Rosa A., "Le voci di un'Italia bambina (<<Cuore>> e <<Pinocchiot )", in AA.W.,Sturia d'Italia. DalfUnitä ad oggi, Torino, Einaudi, L975,Ediz. spec. per Il sole 24Ore, Milano 2005, vol. 9: Letteratura e suiluppo della nazione, pp.925-940.
BrnroLtNI G., "Come nacque il Cuore di Edmondo De Amicis", in La Lettura.Rjvt-sta mensile del Corriere della Sera, n. 5, mag. 1908.
Bnel.le[,ra A., "De Amicis e la scuola: appunti e divagazioni", in Il Cristallo. Rasse-gna d.i uaria umanitä, a. XXXVI, n.2, ag. 1994, pp.55-68.
De AMtcts E., Cuore, a c. di D. Stamone, Milano, Feltrinelli, 1991.
Io., Opere scelte, a c. di F, Portinari e G. Baldissone, (I Meridiani Collezione), Mila-no, Mondaton,2006.
lContiene: Carnzela,Furio,Cuore,Amore e ginnastica,La maestrina d.egli operai,Cine-mato grafo cele bra le, Pinzo Ma ggio).
Eco U., "Elogio di Franti", inDiario rnininzo, Milano, Mondadori, 1997 (1963), pp.85-96.
FEnnsrfl G., "De Amicis e la scuola del pudore", in Nuoua Antologia, dic. 1946, n.$8,p3)8-341.
Mosso M.,I ternpi del Cuore. Vita e lettere di Edmondo De Amicis ed Enzilio Treues,
Milano, Mondadori, i925.Pnrnrrnr P., [Jn cuore grande cosi. Ednnondo De Anicis: an aontro per il socialisrno,
Milano, Sugarco, 1989.Regolamento per le scuole rnunicipali di Torino, Torino, Botta, 187,9'
TelrsuRlNt L., "Peripezie di un cuore sui banchi di scuola del Novecento', inAA.W., Edmondo De Amicis, Atti del Convegno nazionale di studi (Imperia, 30aprile - 3 maggio 1981), a c. di F. Contorbia, Milano, Gatzani, 1985, pp.
)r7 -357 .
ID., "Cuore's pfogress. De Amicis socialista", in Sebestiano Timpana.ro_e la cubuta dcl'secondo
Näueiento,a c. di E. Ghidetti, (Storia e Letteratura ,222) ,Roma, Edizionidi Storia e Letteratura , 2005 , pp. 27 5 -299 .
TnavrnsErrl B.,Introduzione a De Arnicis, Roma-Bari, Laterza, 199I.