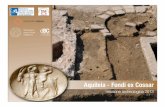(2013) Mappe interculturali della letteratura italiana nel Risorgimento
Le mappe della missione di Robert Mallet nelle aree del terremoto del 1857.
-
Upload
accademiagalileiana -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Le mappe della missione di Robert Mallet nelle aree del terremoto del 1857.
Viaggio nelle aree del terremoto del 16 dicembre 1857
L'opera di Robert Mallet nel contesto scientifico e ambientale attuale del Vallo di Diano e della Val d'Agri
a cura di Graziano Ferrari
Con le 156 fotografie del Fondo Mallet conservate alla Royal Society di Londra
Indice
Introduzione Graziano Ferrari
Robert Mallet e il terremoto del 16 dicembre 1857: dalla teoria alla sperimentazione di un metodo Graziano Ferrari e Anita McConnell
Fotografia e osservazione scientifica. Robert Mallet e il reportage fotografico nelle aree del terremoto del 16 dicembre 1857 Piero Becchetti e Graziano Ferrari
Le mappe della missione di Robert Mallet nelle aree del terremoto del 1857 Vladimiro Valerio
Il punto di vista di Robert Mallet nella sua missione in Basilicata Emanuela Guidoboni
Il grande terremoto del 1857 e gli effetti di altri eventi sismici
7
11
63
93
105
nel Vallo di Diano e nella Val d'Agri 111 Emanuela Guidoboni e Graziano Ferrari
Il terremoto del 16 dicembre 1857: geologia e geomorfologia dell' area epicentrale e identificazione della sorgente sismogenetica 187 Pierfrancesco Burrato
Fluidi sotterranei naturali e terremoti: le osservazioni di Robert Mallet nel contesto idrologico delle province di Salerno e Potenza 209 Giovanni Martinelli
Le osservazioni di Robert Mallet in relazione al dissesto idrogeologico attuale delle province di Salerno e Potenza 221 Fausto Guzzetti, Marco Caciagli e Paola Reichenbach
Il silenzio dei sismologi italiani dopo il terremoto del 1857: le interpretazioni di letterati ed eruditi 233 Alberto Comastri
" ... camminando tra le macerie". Governo e terremoto nelle carte borboniche dell'Archivio di Stato di Potenza 239 Valeria Verrastro
Vedere, fotografare, osservare la catastrofe. Il resoconto di Robert Mallet come documento antropologico 269 Enzo V. Alliegro
Sulle tracce di Robert Mallet e Alphonse Bernoud: paesaggi naturali e antropici che cambiano 289 Graziano Ferrari, Marco Caciagli e Gabriele Tarabusi
Padula nel Rapporto di Robert Mallet e l'intervento attuale di restauro della Certosa di S . Lorenzo 313 Gennaro Miccio
Il Fondo Sismico della Società Napoletana di Storia Patria 331 Loredana Esposito
Viaggio nei paesaggi virtuali del Vallo di Diano e della Val d'Agri: dal dato storico alla modellazione 3D ambientale 337 Graziano Ferrari, Gabriele Tarabusi e Marco Gualdrini
Testi e documenti Lettere sulla missione di Robert Mallet conservate in archivi italiani e stranieri 353 I commenti degli esperti della Royal Society di Londra sul manoscritto di Robert Mallet 371 Documenti dell' Archivio di Stato di Napoli relativi alla ricostruzione 379 Fenomeni precursori osservati, effetti sui suoli e sulle acque in occasione del terremoto del 1857 393
Le 156 fotografie sugli effetti del terremoto allegate al Rapporto di Robert Mallet, conservate alla Royal Society di Londra 405
Le mappe della missione di Robert Mallet nelle aree del terremoto del 1857
Vladimiro Valerio Dipartimento di Storia dell'Architettura - Università IUAV di Venezia
Il 28 dicembre 1857 Robert Mallet indirizza una lettera alla Royal Society di Londra nella quale segnala la "opportunità di grandissimo interesse per lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze" fornita dal disastroso terremoto della Basilicata avvenuto una decina di giorni prima (Mallet 1862; trad. it. 2004, p.lI). La lunga e nota lettera, nella quale Mallet espone tutte le più recenti teorie sui fenomeni tellurici e sulle osservazioni da fare prima durante e dopo di essi, termina con la richiesta di finanziamento al viaggio di studio nelle zone disastrate. L'ansia di intraprendere il viaggio emerge prepotentemente nella richiesta ove egli scrive "fossi benestante, partirei sicuramente all'istante sotto la mia stessa responsabilità" e dalla dichiarazione, che segue di lì a poco, di essere già in possesso "delle migliori carte geografiche e di tutti gli strumenti che mi occorreranno" (p.12).
Quali fossero le migliori carte geografiche di cui disponesse Mallet lo possiamo ricavare dalle operazioni svolte sul terreno e dai resoconti da lui successivamente pubblicati. Oltre, ovviamente, che per il riconoscimento dei luoghi (centri abitati, monti, valichi) e delle vie di transito (strade, fiumi, canali), Mallet si trovava nella necessità di utilizzare le carte per lo studio e la registrazione della declinazione magnetica. Ecco come egli stesso spiega l'uso delle carte a sua disposizione fornendocene anche, per la prima volta la loro esatta indicazione:
fig. 1 Cartigli delle cartografie di G.A.Rizzi Zannoni (sinistra) e di L.A.G.BacIer d'Albe (destra).
Le carte furono utilizzate da R.Mallet per orientarsi e localizzare siti relativi alla sua missione nelle
zone più colpite dal terremoto del 16 dicembre 1857.
93
"La conoscenza del dato relativo alla declinazione magnetica, in quanto poi avrebbe influen-. zato tutte le mie considerazioni successive, rese molto importanti frequenti osservazioni che
portassero ad accertare con precisione il dato; sfortunatamente a causa della stagione e dell'inclemenza del tempo in queste regioni montuose, l'osservazione del sole o della stella polare fu raramente effettuabile. Oltre alle osservazioni solari o stellari, decisi quindi di procedere al rilevamento magnetico da diversi punti elevati conosciuti di altri punti visibili e riconoscibili sulle due grandi carte geografiche del paese, quelle di Zannoni e di Bachler D'Albe, in modo che, confrontando le rilevazioni osservate con quelle indicate dalle carte, si potesse controllare la declinazione" (Mallet 1862; trad. it. 2004, p.180).
Quali erano le carte di Zannoni e Bac1er D'Albe e chi i loro autori? Erano affidabili e fino a che punto? C'era qualcosa di meglio che potesse utilizzare Mallet in quegli anni? Perché proprio quelle due carte e non altre? Per rispondere a queste domande è necessario ripercorre sia pur brevemente le vicende della cartografia nel Mezzogiorno d'Italia, ed in particolare in quella terra "incognita" che era la Basilicata ancora pochi anni prima dell'Unità e, per qualche lustro, anche dopo.
" In Napoli si conosce forse più lo stato dell'isola degli Otaiti che quello delle nostre provincie", con questa celebre frase Giuseppe Maria Galanti, nel 1787, introduceva la propria ricognizione economica e geografica sul regno di Napoli, che andava alle stampe dopo un lungo e travagliato percorso. La frase, in seguito divenuta emblema dell'arretratezza delle conoscenze geografiche sul regno e dell ' inefficienza dell' intero apparato statale borbonico, si può riferire alla realtà geografica della Basilicata, terra di antichissima colonizzazione ma tagliata fuori, in età moderna, dalle grandi linee di traffico mercantile tanto terrestri quanto marittime. Lo stato dei litorali, bassi e sabbiosi, con paludi ed acquitrini costieri, senza approdi sicuri, se non quelli alquanto primitivi delle foci dei fiumi denunciava, proprio sul finire del Settecento, le condizioni di abbandono di quelle terre. Nell'interno, poi, le uniche vie di attraversamento toccavano a mala pena il territorio lucano: ad ovest la via delle Calabrie, l ' antica strada Regio-Capuam passava per Lagonegro e Lauria, mentre a Nord la via Appia attraversava il territorio di Melfi e di Venosa. La realtà geografica e sociale di forte isolamento e soprattutto la marginalità di questo territorio nella vita politica del regno di Napoli costituiscono i fattori caratterizzanti le conoscenze geografiche e le rappresentazioni cartografiche della regione.
Una svolta decisiva nelle analisi territoriali e nella vera e propria esplorazione delle aree interne del regno di Napoli avvenne nel 1781 con la formazione del primo stabilimento cartografico di Stato in Italia. Le operazioni scientifiche furono affidate all'astronomo padovano Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (1736-1814) che lavorò all 'allestimento della carta del regno in 31 fogli in scala 1: 114.000 circa tra il 1781 ed il 1812 (figure 1 e 2). La Basilicata gode del singolare primato di essere stata l'ultimo lembo di terra meridionale disegnato ed inciso nel 1812, anno di completamento della carta. I dati temporali di esecuzione della carta erano noti a
fig.2 Nella due pagine precedenti: particolare della foglio n.25 dell'Atlante Geografico del Regno
di Napoli di Rizzi Zannoni relativo alla parte occidentale della Basilicata.
96
Mallet, che ne fa spesso riferimento: "Questa carta - egli scrive - fu ideata intorno al 1810-1812, ed essendo stata impostata con la tecnica della triangolazione, usando una scala molto grande, le posizioni indicate sono in generale estremamente accurate".
La carta di Rizzi Zannoni sappiamo con certezza che fu acquisita dalla Royal Society a mano a mano che si andava stampando. Fino alla nascita dello Hydrographical Office e, nel corso dell'800, della Royal Geographical Society, la Royal Society si occupava di tutti i campi di ricerca relativi alle scienze della terra, compresi quelli cartografici. L'idrografo Alexander Dalrymple comunicò alla Royal Society e fece pubblicare in un'edizione inglese nel 1794 la carta idrografica del golfo di Napoli realizzata da Rizzi Zannoni nel 1792.
La carta del regno di Napoli in 31 fogli di Rizzi Zannoni, come si è detto, fu terminata solo nel 1812, quindi durante il periodo di reggenza francese a Napoli e solo dopo il 1815, anno nel quale la corte Borbonica rientrò in possesso del regno, fu interamente posseduta dalla Royal Society. Va inoltre notato che, a partire dal 1815 , con l'istituzione dell' Officio Topografico e del Deposito della Guerra in Napoli, tutto il materiale cartografico prodotto dall' ente di Stato era commercializzato ed acquistabile attraverso precisi punti di vendita. Quella di Rizzi Zannoni, unitamente alle carte prodotte dall'Officio Topografico di Napoli, furono le prime carte ufficiali di uno Stato poste in vendita al pubblico. È probabile che, oltre le copie acquisite per "dovere d'ufficio" o regalate alla Royal Society, circolassero in Inghilterra copie private e che la carta di Rizzi Zannoni fosse acquistabile attraverso i mercanti ed i librai inglesi.
Più complessa è la storia dell' altra fonte cartografica citata e posseduta da Mallet, quella prodotta da Louis-Albert-Ghislain Bac1er D'Albe (1761-1824), direttore del Bureau Topographique al seguito della Armata di Italia durante le guerre napoleoniche (figure 1 e 3). La carta, in scala 1 :300.000 circa, fu costruita sulla scorta di materiale documentario proveniente dalla raccolta cartografica del Dépot de la Guerre di Parigi, dalle carte a stampa del nord Italia pubblicate a Milano dagli astronomi di Brera, dalle carte di Rizzi Zannoni, per la sola parte sino ad allora pubblicata sul regno di Napoli, e su ricognizioni dirette effettuate sul terreno dai topografi francesi durante la marcia di attraversamento della penisola e la conquista del regno di Napoli. La carta d'Italia di Bac1er D'Albe si compone di due volumi separati, ognuno con un proprio frontespizio: la prima parte dal titolo Carte Générale du thééitre de la Guerre en Italie, si compone di 30 fogli e fu incisa a Milano dai fratelli Gaudenzio e Giovambattista Bordiga intorno al 1800; la seconda, intitolata Carte Générale du Royaume de Naples, Sicile & Sardaigne ... formant la seconde partie de la carte G.le du thééitre de la Guerre en Italie, è composta di 24 fogli e fu stampata a Parigi nel 1802.
La disparità di qualità e di densità di informazione all'interno dell'intera carta d'Italia di Bac1er D'Albe fu notata sin dal suo apparire: lo stato delle conoscenze
fig. 3 Nella due pagine seguenti: particolare del foglio della carta Bac1er d'Albe relativa all' area di
confine tra il Principato Ultra e la Basilicata.
97
cartografiche e itinerarie nel nord Italia erano nettamente superiori a quelle disponibili per il sud della penisola. Il generale francese fu costretto a rimediare a questa differenza con ricognizioni dirette ed approssimazioni, queste ultime evidenti soprattutto nelle zone non ancora visitate dai cartografi napoletani.
Tuttavia, in seguito alla penuria di materiale cartografico sul Mezzogiorno d'Italia, e grazie all'autorità conquistata, potremmo dire, "sul campo" dal Bureau Topographique de l'Armée d'Italie, la carta di Bac1er D'Albe godette di un credito ben superiore alle sue qualità. È ben strano, ad esempio, che Mallet confronti e lavori su due materiali nettamente differenti per quanto attiene la scala (1: 114.000 di Rizzi Zannoni contro 1 :295.000 di Bac1er D'Albe), la proiezione (Cassini contro una conica non meglio identificata), la topografia (una rilevata con strumentazione e attraverso triangolazione, l'altra su materiale d'archivio e su ricognizioni parziali) e la simbologia (strutturata e ricca nell'una, sommaria nell'altra).
In effetti, ben presto Mallet dovette rendersi conto della disparità tra le due carte e quasi tutte le successive considerazioni furono riferite alla carta di Rizzi Zannoni:
"Tutti questi dati - ebbe a scrivere Mallet durante le sue osservazioni sulla declinazione magnetica - una volta riportati sulla grande carta di Zannoni, danno come risultato una declinazione fra 13° e 14° ovest da nord. Questa carta fu ideata intorno al 1810-1812, ed essendo stata impostata con la tecnica della triangolazione, usando una scala molto grande, le posizioni indicate sono in generale estremamente accurate" (Mallet 1862; trad. it. 2004, p.284).
Tuttavia, viene da porsi la domanda: è possibile che Mallet abbia usato per i suoi studi una carta topografica, ancorché accurata, ma di ben cinquant'anni più antica? Quale era lo stato della cartografia napoletana nel 1858?
In effetti, Mallet non poteva disporre di altro materiale a stampa, sebbene nel 1814 si fosse decisa la realizzazione di una moderna carta topo grafica in scala 1 :80.000 in proiezione di Bonne, la stessa utilizzata in Francia per la carta dello Stato Maggiore, e che doveva sostituire la "antica" rappresentazione zannoniana.
Con la nascita dell'Officio Topografico del regno di Napoli e con il decreto murattiano del settembre 1814, con il quale si ordinava l'allestimento di una gran carta del regno da rilevarsi in scala 1 :20.000 e da incidersi in scala 1 :80.000, si stabilirono le premesse per la costruzione di uno strumento cartografico che potesse rispondere a tutte le più moderne esigenze civili, militari ed amministrative della nazione. Purtroppo, malgrado i buoni propositi ed il dispiego non indifferente di mezzi, uomini e danaro, il progetto si arenò ben presto per il forte contrasto all'interno dell' amministrazione militare tra i settori progressisti filo murattiani e i legalisti borbonici. Sta di fatto che, dopo i primi anni sperimentali, che vanno dal 1815 fino al 1821, i rilevamenti in scala 1:20.000 interessarono solo le aree di maggiore interesse politico, economico e militare del regno, quindi i confini, l'area napoletana, il bacino del Samo, le fortezze, lo stretto di Messina e l'area del palermitano, queste due ultime interessate, però, solo dopo i moti del 1847 e 1848. Insomma per oltre 50 anni le parti interne e marginali del regno furono assolutamente ignorate, e tra queste la Basilicata; dunque il vecchio e datato rilevamento di Rizzi Zannoni, ter-
100
minato nel 1812 rimase il biglietto da visita con il quale il meridione si presentò all'appuntamento dell'Unità. Dei 68 fogli della carta in scala 1:80.000, nel 1858 risultava stampato solo il foglio di Napoli, e solo altri due erano in via di completamento.
Nell'Archivio dell'Officio si conservavano alcuni disegni manoscritti che potevano certamente essere usati con maggiore profitto da Mallet; si tratta della ricognizione sulla carta di Rizzi Zannoni effettuata dagli austriaci negli anni 1824-1826, durante il periodo di occupazione militare, carta tanto esatta e ricca di particolari da essere utilizzata come modello per la prima carta corografica dell'ex regno di Napoli pubblicata dal Corpo di Stato Maggiore Italiano nel 1870. Ma si trattava di manoscritti, e probabilmente, anche in considerazione dei pessimi rapporti diplomatici tra i due stati in quegli anni, sarebbe stato oltremodo difficile ottenerne copia.
Certamente di grande ausilio potevano essere le carte delle province del regno pubblicate da Benedetto Marzolla (1801-1858) tra il 1829 ed il 1854. Soprattutto l'ultima edizione, raccolta nella Descrizione del Regno delle Due Sicilie per provincie (figura 4), forniva dati estremamente aggiornati su ogni provincia, sia dal punto di vista topografico che dal punto di vista statistico. Le carte, difatti, erano disegnate in scala 1 :280.000 (leggermente superiore a quella del Bac1er D'Albe) ed erano corredate di una enorme messe di informazioni storiche, geografiche, economiche ed amministrative, e risultavano aggiornatissime per la rete viaria. Ma l'atlante di Marzolla, impiegato dell'Officio Topografico di Napoli, nonché membro della Commissione di Statistica presso il Ministero dell'Interno, avevano un'enorme circolazione nel regno ma erano pressoché sconosciute al di fuori dei suoi confini.
Insomma, a conti fatti, sembra che Mallet non potesse proprio disporre di nulla di meglio della carta di Rizzi Zannoni, sulla scorta della quale riuscì a realizzare le sue carte sismiche dell'area, come da egli stesso confermato in alcuni passi: "Prendiamo in considerazione la Mappa sismica A, ricavata della grande carta geografica delle Due Sicilie di Zannoni" (Mallet 1862; trad. it. 2004, p.421). Tuttavia alcune osservazioni, che seguono il brano sopra riportato creano qualche dubbio circa la reale conoscenza di Mallet della carta che si trovava ad utilizzare.
"Questa mappa - continua Mallet - comprende tutta la zona in esame, è tracciata secondo la proiezione di Mercatore, in scala uniforme sia in parallelo che in meridiano, di 0.64 pollici inglesi o 0.162 metri francesi, al miglio geografico, ed è suddivisa in quadrati che misurano dieci miglia geografiche per ogni lato, numerati consecutivamente a partire dall'Osservatorio di Napoli pari a Zero" (Mallet 1862; trad. it. 2004, p.421).
In effetti il passo contiene alcune errate valutazioni sulla carta di Zannoni e, soprattutto, sulla sua proiezione. È vero che la scala della carta è di 6,4 pollici per dieci miglia geografiche (cioè circa 1: 114.000), ma l'origine delle coordinate non è
fig. 4 Nelle due pagine seguenti: carta della Basilicata di Benedetto Marzolla inserita nella
Descrizione del Regno delle Due Sicilie per provincie, Napoli 1854.
101
11. 3._.._. iJ<, ' c-... ......... ; .. i . • _~.~ ..... ~.~ .H.",. . ç •• U .. c. ••. ut.' ..... "".;; , """'"' c_ .. ò .l ..... .".. ... ... .... ......... ,.. .. , .. ~ fa .. .,.w .... -.) ...-... .. _}a- ..... _ .. <.".où.~,
~ ... J·'U~ .... ~_' .... ~ ..... J.rc:_ .. "v.,. ,....uJv:
102
sull'Osservatorio di Napoli, all'epoca ancora non costruito (fu progettato nel 1815 e terminato solo nel 1821) e la proiezione adottata non è quella di Mercatore. Rizzi Zannoni, che aveva vissuto a Parigi tra il 1762 ed il 1775, deve molto della sua formazione alla cultura geografica francese. Negli anni della sua permanenza a Parigi si stava portando a compimento la grande impresa della carta di Francia realizzata in proiezione di Cassini, in 180 fogli alla scala di 1 :86.400 ed allorché si trovò a progettare la nuova carta del regno di Napoli, egli pensò bene, ed a ragione, di adottare la stessa proiezione utilizzata in Francia ed in altri paesi europei. Il reticolato quadrato di dieci miglia per lato, è un reticolato geometrico (oggi detto chilometrico) e non geografico, il cui asse verticale non coincide con il nord se non lungo il meridiano di Napoli. A mano a mano che ci si sposta verso ovest, o verso est, cresce la differenza angolare tra meridiano geografico e reticolato miliare, che non può assolutamente assimilarsi al nord geografico. A questo punto le valutazioni sulle declinazioni magnetiche calcolate da Mallet "confrontando le rilevazioni osservate con quelle indicate dalle carte" (Mallet 1862; trad. it. 2004, p.180) sono inficiate dalla mancata consapevolezza del tipo di carta che egli stava utilizzando.
Mallet disponeva delle uniche carte metriche disponibili su quella porzione di territorio, purtroppo non troppo moderne da essere esenti da errori e non ancora abbastanza antiche da necessitare di un' operazione di interpretazione e di vera e propria esegesi. D 'altronde, in quegli anni, la storia della cartografia non era ancora nata e gli stessi costruttori di mappe (il termine cartografo e cartografia saranno di molti anni successivi), quando si trovavano a lavorare su carte del passato, mancavano degli strumenti necessari per la loro decodifica.
Bibliografia Alisio G. e Valerio V. (a cura di) 1983, Cartografia napoletana dal 1781 al 1889, Prismi, Napoli.
Angelini G. 1989, Basilicata, in I.Principe (a cura di), Cartografia storica di Calabria
e di Basilicata, Mapograf, Vibo Valentia.
Bertahut H.M.A. 1902, Les lngénieurs Géographes Militaires 1624-1831, Imprimerie
du Service Géographique, Paris.
Immagini della Terra dei Re. Cartografia, vedute e costumi della Basilicata 2001, catalogo
della mostra, Potenza, Museo Provinciale (26 giugno-31 ottobre 2001), Paparo Edizioni.
Mallet R. 1862, Great Neapolitan Earthquake oj 1857. The First Principles ojObservational
Seismology, London, 2 voll. (ristampa anastatica e traduzione italiana in Mallet's macroseismic
survey on the Neapolitan Earthquake oj 16th December, 1857, a cura di E.Guidoboni e G.Ferrari,
SGA, Bologna 1987; trad. it. 2004 nel secondo volume di quest 'opera).
Mori A. 1922, La cartografia ufficiale in Italia e l'Istituto Geografico Militare , Stabilimento
Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra, Roma.
Valerio V. 1993, Società uomini e istituzioni cartografiche nel Mezzogiorno d'Italia, Istituto
Geografico Militare, Firenze.
104