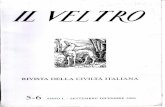Esperienza e causalità. Avenarius con e oltre Schopenhauer.
Transcript of Esperienza e causalità. Avenarius con e oltre Schopenhauer.
149
1. Una caratteristica ricorrente delle opere di Richard Avenariusè l’assenza di luoghi di confronto tra le sue idee e quelle di altri pen-satori. A differenza di altre personalità dell’epoca, Avenarius è sem-pre stato solo un filosofo, piú che un filosofo-scienziato, e in quan-to tale non si preoccupava di condurre indagini in prima persona sutemi che lo interessavano, come quelli psicologici o di fisiologia del-le sensazioni, preferendo appoggiarsi ai risultati forniti da altri. Perquesto nella Kritik der reinen Erfahrung (1888-1890) e in Der mensch-liche Weltbegriff (1891) è facile incontrare i nomi dei massimi studio-si di psicologia, fisiologia e teoria della conoscenza dell’Ottocento,quali Helmholtz, Kirchoff, Wundt, etc. Vanamente però si cerche-rebbero dei passi in cui Avenarius discute, sia per sostenerli che perrigettarli, di quegli aspetti del pensiero di questi autori che hannomaggior rilievo filosofico, cosí come risulta difficile trovare citazio-ni e riferimenti diretti alle idee di suoi colleghi piú propriamente fi-losofi.La principale occasione in cui Avenarius viene meno al suo di-
chiarato «tentativo di “riallacciarsi” invece che a questo o a quel fi-losofo, invece che a dei libri, direttamente alle cose»1 è costituita daun brano del Weltbegriff in cui viene chiamato in causa Arthur Scho-penhauer. D’altronde che l’interesse per il pensiero del filosofo diDanzica non fosse occasionale è testimoniato anche dal Vortrag cheAvenarius dedicò a La quadruplice radice del principio di ragione suffi-
Esperienza e causalità: Avenarius con e oltre Schopenhauer
di Chiara Russo Krauss
1 R. Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung, 2 voll., O. R. Reisland, Leipzig, 1888-18901, 1907-19082 (d’ora in poi: R. A., Kritik), vol. I, p. XVIII.
150
Chiara Russo Krauss
ciente durante il semestre invernale�83-84, il quale costituisce un’an-ticipazione degli appunti mossi a Schopenhauer nel Weltbegriff.Anche se Avenarius ritiene che sia l’intera storia delle filosofia ad
essere afflitta da un errore originario, che ha portato ad abbandona-re la nostra esperienza naturale del mondo ed ha aperto la strada al-la metafisica e al dualismo, egli sceglie come suo interlocutore pro-prio Schopenhauer perché ritiene che nel suo pensiero si possa tro-vare l’espressione piú perfetta di questi errori compiuti dalla filoso-fia. Il motivo per cui Schopenhauer viene visto come principalecontraltare polemico non è però dovuto ad una maggiore distanzache lo separerebbe da Avenarius ma, in un certo senso, alla sua vici-nanza. Analizzando il pensiero di entrambi possiamo infatti osserva-re come Avenarius concordi con Schopenhauer su diverse questio-ni fondamentali, per cui è proprio il fatto che essi percorrano insie-me un tratto del cammino a far risaltare con maggior forza il mo-mento in cui le loro strade si separano.Lo scopo di questo scritto è dunque ricostruire la strada che Ave-
narius percorre tacitamente al fianco di Schopenhauer, per poi ana-lizzare, alla luce di questa, le pagine in cui il filosofo di Zurigo si ri-fà esplicitamente e in modo critico al suo predecessore, cosí da faremergere lo snodo problematico che segna l’ideale punto di rotturatra i due.
2. Come abbiamo anticipato, se si osservano i presupposti da cuiSchopenhauer e Avenarius sviluppano le loro riflessioni gnoseologi-che si possono trovare diversi punti di contatto tra i due. In partico-lare possiamo individuare due assunti fondamentali che accomuna-no il pensiero dei due autori: 1) l’affermazione che bisogna partiredalla rappresentazione, e non dal soggetto e dall’oggetto; 2) la de-nuncia dell’errore consistente nell’applicazione del principio di cau-salità ai rapporti tra soggetto e oggetto.Prima di proseguire nell’analisi di questi due punti è bene sotto-
lineare che Avenarius, nella sua ricerca di un lessico scevro da frain-tendimenti metafisici, tende a non utilizzare termini come “sogget-to”, “oggetto” o “rappresentazione”, specialmente quando si tratta dipresentare il suo punto di vista. Ciò nonostante, l’idea avenariusianache si debba partire dall’esperienza, da ciò che viene semplicemen-te trovato da ciascuno di noi, perché se si danno un “soggetto” e un“oggetto” essi si possono dare comunque soltanto in quanto sono
collocati sul piano dell’esperienza e non prima o oltre di essa, al di làdelle differenze terminologiche, procede chiaramente nel solco diquanto detto da Schopenhauer ne Il mondo come volontà e rappresen-tazione, quando afferma che «noi non siamo partiti né dall’oggettoné dal soggetto, bensí dalla rappresentazione, che contiene e presup-pone già quei due»2.Mettere al primo posto il mondo dei nostri contenuti di co-
scienza, sia questo chiamato “rappresentazione”, come nel caso diSchopenhauer, o “esperienza”, come in Avenarius, per i due pensa-tori vuol dire ribaltare la prospettiva classica della filosofia della co-noscenza, la quale, partendo dalla distinzione tra soggetto e oggetto,si trova di fronte alla difficoltà di spiegare il rapporto tra questi duetermini, finendo col commettere il duplice errore di interpretare ta-le rapporto in base al principio di causalità e di tentare di ridurreuno dei due termini all’altro.Avenarius concorda quindi con Schopenhauer nell’affermare
che, nella loro apparente opposizione, l’idealismo e il materialismosono figli dello stesso errore: per l’appunto quello di provare a risol-vere il problema dei rapporti tra soggetto e oggetto riducendo l’u-no all’altro tramite il principio di causalità. Mentre l’idealismo sisforza di mostrare come la realtà non sia altro che una produzionedel soggetto, il materialismo fa della soggettività qualcosa che nascee dipende dal mondo esterno, dalla corporeità (nell’ultima declina-zione di questa prospettiva ciò accade tramite il ricorso al cervelloquale sede del pensiero). Per entrambi i pensatori la gnoseologia ri-sulta cosí prigioniera dell’insopprimibile circolo vizioso per cui, sesi parte dal soggetto, da una prospettiva “idealistica”, sembra impos-sibile riguadagnare una conoscenza oggettiva della realtà, perché
151
Esperienza e causalità: Avenarius con e oltre Schopenhauer
2 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di S. Giametta,Bompiani, Milano 2006 (d’ora in poi: A. S., Mondo), § 7, p. 83. In una nota delWeltbegriff, dopo aver presentato i risultati delle sue riflessioni, secondo cui par-tendo dall’esperienza per poi analizzarla si ottengono l’io e l’ambiente comeelementi che appartengono indissolubilmente ad ogni esperienza, Avenarius fai nomi di alcuni autori il cui pensiero concorderebbe con il suo, «anche se noncompletamente, considerando i diversi punti di vista». Dopo aver citato le ope-re di Ernst Laas, Alois Riehl, Ernst Mach e Wilhelm Wundt, Avenarius riman-da alle parti iniziali dei due volumi de Il mondo come volontà e rappresentazione diSchopenhauer. Cfr. R. Avenarius, Der menschliche Weltbegriff, O. R. Reisland,Leipzig, 18911, 19052 (d’ora in poi R. A., Weltbegriff ), p. 120.
questa sfuggirebbe sempre nell’irraggiungibile cosa in sé, mentre sesi pretende di partire dall’oggetto, secondo una prospettiva “realisti-co-materialistica”, non si riesce ad approdare al mondo della co-scienza. Il risultato di questo circolo vizioso è che la filosofia si ri-troverebbe perennemente sul baratro dello scetticismo3.
3. Se Avenarius e Schopenhauer concordano nel rifiuto di appli-care il principio di causalità ai rapporti tra soggetto e oggetto restacomunque da stabilire se e in che modo tale principio possa essereapplicato alle nostre rappresentazioni.Anche se Schopenhauer ritiene un errore gravissimo dedurre un
«rapporto di causa ed effetto» fra l’oggetto e il soggetto dal fatto chel’intuizione si realizza per mezzo della nozione di causalità, egli so-stiene per l’appunto che un tale rapporto abbia luogo «fra oggettoimmediato e oggetto mediato»4. Come funzioni il meccanismo cheper Schopenhauer è alla base della rappresentazione è noto, ma vo-gliamo comunque riportarlo brevemente, servendoci delle parolecon cui lo stesso Avenarius lo riassume nel suo Vortrag. L’“oggettoimmediato” è costituito dal corpo con le sue modificazioni, ovverole sensazioni:
attraverso l’azione necessaria dell’intelletto il dato, la sensa-zione, viene interpretato come un effetto, rispetto al qualeviene posta una causa. Quest’ultima viene costruita spazial-mente grazie alla forma del senso esterno e reca in sé en-trambe le forme a priori, quella del tempo, perché deve prece-dere l’effetto, e quella dello spazio, in cui è posta5.
152
Chiara Russo Krauss
3 Per Schopenhauer si veda in particolare: A. S., Mondo, p. 61 e sgg. e p. 83 e sgg.Nelle pagine introduttive del Weltbegriff Avenarius racconta di come egli stessosi sia trovato invischiato nel circolo vizioso che rimanda continuamente dall’i-dealismo al realismo, per cui la soluzione al problema proposta nel libro costi-tuirebbe in primo luogo una «liberazione personale». Cfr. R. A., Weltbegriff, pp.IX-XIII. Un simile discorso viene accennato anche nella Kritik, laddove si par-la della «Cariddi “realistica” dell’“oltrepassamento della coscienza”» e della«Scilla “idealistica” del “solipsismo” (R. A., Kritik, vol. II, p. 247). Per maggioridettagli mi permetto di rimandare ai primi tre capitoli di C. Russo Krauss, Ilsistema dell’esperienza pura: struttura e genesi dell’empiriocriticismo di Richard Avena-rius, Le Cariti, Firenze, 2013, pp. 39-101.
4 A. S., Mondo, § 5, p. 61.5 R. Avenarius, Einiges über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde
L’“oggetto mediato”, ovvero il mondo esterno, si presenta dun-que come il risultato di questa operazione dell’intelletto, che“proietta” le nostre sensazioni sulla base delle forme della causalità,del tempo e dello spazio.Nelle pagine seguenti del Vortrag Avenarius sottolinea la proble-
maticità insita nel “precedere” della causa rispetto all’effetto. Infattise da un lato «questo precedere viene presupposto in conformità conil contenuto della funzione causale», per cui la causa viene sempreprima dell’effetto, dall’altro,
se si vuole osservare il processo in quanto tale da un puntodi vista genetico, può sorgere il paradosso per cui alla com-parsa della sensazione, e solo allora, viene posto qualcosa co-me causante, anche se questo qualcosa doveva certo esseregià stato presente proprio per poter essere causa della sensa-zione6.
Il fatto che la sensazione da un lato venga “prima”, in quanto og-getto dato immediatamente alla coscienza, e dall’altro venga “dopo”,in quanto effetto di una causa antecedente, costituisce il nucleo pro-blematico dell’applicazione del principio di causalità alle nostre sen-sazioni, perché implica uno sdoppiamento, una duplicazione dellesensazioni stesse. Come scrive Avenarius:
L’essenza della funzione causale di Schopenhauer in sostan-za consiste in ciò, che da un effettivamente dato se ne rica-vano due, perché quando io devo afferrare la sensazione da-ta come effetto di una causa, dunque di un che di antece-dente, allora questo antecedente viene per ciò stesso postocome già presente7.
153
Esperienza e causalità: Avenarius con e oltre Schopenhauer
von A. Schopenhauer, manoscritto conservato nel Nachlass dell’autore presso laStaatsbibliothek di Berlino, Kasten 10 (d’ora in poi: R. A., Einiges).
6 Ibidem.7 Ibidem. Nel denunciare il paradosso che sarebbe presente nella concezione
schopenhaueriana Avenarius si appoggia anche all’analisi dei quattro momentiche secondo Benno Erdmann comporrebbero «il processo di oggettivazione»,per cui: «1) poniamo le nostre sensazioni come proprietà di cose; 2) poniamoqueste proprietà come cause delle nostre sensazioni; 3) poniamo le cose comeesistenti indipendenti da noi; e 4) poniamo le cose come portatrici di quelleproprietà» (B. Erdmann, Logische Studien, in «Vierteljahrsschrift für wissen-
Certo per Schopenhauer le sensazioni non sono causate né da unoggetto sussistente indipendentemente dalla rappresentazione, comenel realismo ingenuo, né da un soggetto che – fichtianamente – leprodurrebbe inconsciamente, eppure esse continuano ad essere pen-sate come causate, e con il principio di causalità rimane in vita quel-l’elemento che è in grado di incrinare l’originaria unità e coerenzadella nostra esperienza. Difatti, nel momento in cui i nostri vissutivengono visti come effetto di una causa, che per sua natura vieneprima di essi, o si assume che tale causa è qualcosa che è al di là del-le nostre rappresentazioni – cosa che lo stesso Schopenhauer rifiu-ta, in quanto sconfinamento nel dogmatismo – oppure si assume cheall’interno della sfera delle rappresentazioni esiste un circolo vizio-so, perché queste sono al contempo la condizione e il risultato del-la posizione di nessi causali. La strada scelta dal filosofo di Danzica sembrerebbe essere pro-
prio quest’ultima. Il paradosso per cui la sensazione è l’effetto di unacausa che essa stessa ha contribuito a porre, infatti, non è altro cheun’ulteriore declinazione di quella che Schopenhauer chiama «anti-nomia della nostra facoltà conoscitiva», consistente nel fatto che l’es-sere senziente è allo stesso tempo la condizione del mondo e deglieventi che in esso si succedono (perché questi esistono solo in quan-to sono rappresentati) ed un loro effetto (perché la sua comparsa sul-la terra è la conseguenza di una lunga successione di eventi)8. L’antinomia della facoltà conoscitiva e il circolo vizioso insito
nell’esser causate delle sensazioni sono accomunabili e risultano en-trambi inevitabili perché la contraddizione si annida nella naturadella forma a priori del tempo (e perciò in quella della causalità, chepure ha carattere temporale), in base alla quale, dato un «primo fattodi conoscenza», con esso è già posta la temporalità e dunque anchel’idea di «una serie di fenomeni che si estende all’infinito nel passa-to», dove «tale passato è d’altronde condizionato da quel primo pre-sente, come questo, a sua volta, dal passato»9.
154
Chiara Russo Krauss
schaftliche Philosophie», VI, 1882, pp. 28-61, VII, 1883, pp. 184-204: VII, pp.187-188, citato in R. A., Einiges). Come sottolinea Avenarius «dall’1 e 2 risul-terebbe che le nostre sensazioni vengono poste, per via traversa, come cause del-le nostre sensazioni» (R. A. Einiges).
8 Cfr. A. S., Mondo, § 7, p. 93.9 Ibidem.
Per Schopenhauer non è un problema assumere che all’internodella rappresentazione vi siano dei circoli viziosi, delle contraddi-zioni, perché ciò è funzionale al suo scopo ultimo, che è superare ilmondo come rappresentazione per approdare al mondo come vo-lontà. Come si legge nella sua opera principale, tali contraddizionitrovano infatti la loro soluzione:
nella considerazione che il tempo, lo spazio e la causalità nonappartengono (per adottare il linguaggio kantiano) alla cosain sé, ma soltanto al fenomeno, di cui sono la forma. Il chepuò tradursi nel mio linguaggio cosí: il mondo oggettivo, ilmondo come rappresentazione, non è l’unico aspetto dell’u-niverso; ne è, per cosí dire, la sola faccia esteriore; ma il mon-do ha pure un’altra faccia assolutamente diversa dalla prima,e che ne costituisce l’intima essenza, il nocciolo vero, la co-sa in sé10.
Anche se Schopenhauer ha scorto il carattere contraddittoriodovuto all’applicazione del principio di causalità alle nostre rappre-sentazioni, egli lo ha accettato come qualcosa che fa necessariamen-te parte della rappresentazione (perché è insito nella natura delle no-stre forme a priori) e che ci spinge ad andare al di là della rappre-sentazione stessa. Avenarius dal canto suo non intende seguire Scho-penhauer lungo la strada che dalla rappresentazione condurrebbe al-la scoperta della volontà, ma non può nemmeno rassegnarsi ad ac-cettare che nella nostra esperienza si annidi necessariamente unacontraddizione, dato che il suo scopo è proprio riguadagnare unmondo dell’esperienza coerente e unitario, per assicurare alle scien-ze il loro fondamento. Per sciogliere la contraddizione che tiene in scacco la nostra
esperienza naturale non basta però rifiutarsi di applicare il principiodi causalità alle nostre sensazioni, perché abbiamo pur sempre biso-gno di pensare che le nostre rappresentazioni dipendano da qualco-sa; non solo perché siamo portati a ciò dal principio di ragione suf-ficiente, come vuole Schopenhauer, ma anche perché se cosí nonfosse non potremmo assumere alcun correlato oggettivo per le no-stre sensazioni. Inoltre è la stessa scienza moderna, con la fisiologia
155
Esperienza e causalità: Avenarius con e oltre Schopenhauer
10 Ibidem.
e la psicologia sperimentale, a insegnarci che le nostre sensazioni so-no condizionate dal mondo esterno, per cui il problema è propriotenere insieme la consapevolezza che le nostre esperienze dipendo-no da ciò che ci circonda con l’assunto che tutta la realtà si dà solocome esperienza, evitando che queste due proposizioni conducanoa circoli viziosi, contraddizioni o questioni insolubili. Nel Vortrag schopenhaueriano dell’83-84 Avenarius si limita a
evidenziare l’esistenza della contraddizione insita nell’applicazionedel principio di causalità ai vissuti, ma non avanza ancora una pos-sibile soluzione. Tale soluzione viene invece presentata nel 1891, conla pubblicazione del Weltbegriff, dove Avenarius prova per l’appuntoa venire in aiuto di quella
schiera di fautori dell’idealismo filosofico, formatisi sullescienze naturali, che vivrebbero con sollievo la restituzionedel loro precedente ‘realismo’, e che lascerebbero con gioiache ciò accadesse, se solo sapessero come poter sfuggireall’‘idealismo’ con la coscienza pulita – da un punto di vistalogico. Ma per loro è un fatto ineliminabile che, non appenasi riflette sulle cose, si giunge allo schema di causa ed effetto,per cui le cose sono la causa e le ‘sensazioni’ = ‘percezioni’ =‘fenomeni di coscienza’ sono l’effetto; questi effetti sono va-lori ‘idealistici’ e questi valori ‘idealistici’ sono ‘ciò che è im-mediatamente dato’, e quindi – conseguentemente – ‘l’unicacosa che è data’, a partire dalla quale si potrebbe forse ‘dedur-re’ ‘ciò che si trova fuori dalla coscienza’, stante che ogni ‘de-dotto’ dovrebbe nuovamente essere soltanto ‘nella nostra co-scienza’11.
4. Come abbiamo visto, nel VortragAvenarius aveva già evidenzia-to lo sdoppiamento insito nell’applicazione della causalità ai vissuti:nel momento in cui la sensazione viene vista come l’effetto di qual-cosa, il piano della rappresentazione risulta duplicato, perché da unaparte ho l’oggetto come causa della rappresentazione e dall’altro l’og-
156
Chiara Russo Krauss
11 R. A., Weltbegriff, pp. 108-10. Avenarius adopera le virgolette ad apice singoloper segnalare che sta riportando dei “contenuti di asserzione” (cfr. infra, para-grafo 5), mentre adopera le virgolette a doppio apice per tutti gli altri usi, in-cluse le citazioni testuali. Nel riportare i brani delle opere di Avenarius mi so-no attenuta a quest’uso.
getto come rappresentazione, e quindi come effetto. In Schopenhauerquesto sdoppiamento era necessario perché serviva a dare profonditàall’immagine piatta del mondo della sensazione, costruendo cosí ilmondo tridimensionale, spaziale, della realtà oggettiva. Avenarius ri-prende l’intuizione del filosofo di Danzica secondo cui, partendo dal-la sensazione e applicandole il principio di causalità, si viene proiet-tati oltre il piano dell’esperienza immediata e si crea il mondo fuoridi noi, ma questo stesso meccanismo viene riletto in chiave critica: lacreazione del “mondo fuori di noi” tramite il principio di causalitànon è piú la costruzione dell’oggettività dal materiale grezzo dellesensazioni, ma è la rottura dell’unità costituita dalla nostra esperienzaimmediata o, per meglio dire, dalla nostra esperienza naturale.Per Schopenhauer uno degli errori di Kant era stato quello di
considerare l’oggetto esterno che causa la sensazione, e che verreb-be inferito grazie al principio di causalità, come l’irraggiungibile co-sa in sé, mentre egli ribadisce che tale “oggetto esterno”, essendoposto dal soggetto, è invece già parte di quell’intuizione intellettua-le che crea la realtà esterna tramite le forme a priori di tempo, spa-zio e causalità12. Dal punto di vista di Avenarius, dopo che Kant hasvelato l’inconoscibilità della presunta “realtà esterna”, e dopo cheSchopenhauer ne ha ribadito il carattere di creazione della menteumana, è giunto il momento di sbarazzarsi definitivamente di que-sta idea che falsifica la nostra esperienza13. Per poter eliminare l’ideadel “mondo esterno” bisogna però indagare piú nel dettaglio il mo-do in cui essa si lega all’applicazione del principio di causalità ai vis-suti, cosí da poter sviluppare una concezione che sia in grado di par-lare delle cause delle nostre sensazioni senza ricadere nell’errore didare origine all’“esteriorità”.Dal momento che la duplicazione delle esperienze, cui conduce
157
Esperienza e causalità: Avenarius con e oltre Schopenhauer
12 Cfr. A. Schopenhauer, Sulla quadruplice radice del principio di ragione sufficiente, acura di E. Amendola Kühn, Boringhieri, Torino 1959 (d’ora in poi: A. S., Qua-druplice), pp. 134-135.
13 Nei Prolegomena Avenarius aveva affermato che il compito della “critica dell’e-sperienza pura” fosse proprio «eliminare dai contenuti dell’esperienza l’aggiun-ta dei concetti a priori dell’intelletto», che la Critica della ragion pura kantianaaveva rivelato essere “mescolati” in essa, «cosí da ottenere un’esperienza puraκατ’ έξοχήν». Cfr. R. Avenarius, Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Prin-cip des kleinsten Kraftmasses. Prolegomena zu einer Kritik der reinen Erfahrung, Fues(R. Reisland), Leipzig 1877, p. 31.
la causalità, si traduce in modo immediato nella divisione del mon-do in interno ed esterno, il nucleo problematico che si nascondenell’applicazione della causalità ai vissuti per Avenarius non è altroche la cosiddetta “introiezione”14. Come dice la parola, essa consistenel movimento di pensiero, spesso involontario e inconsapevole, percui l’esperienza viene collocata all’interno degli individui, comequalcosa che accade dentro di loro. Ma se lo sdoppiamento implica-to dalla causalità in realtà non è altro che una conseguenza di quel-lo «sdoppiamento originario»15 che è l’introiezione, è proprio que-st’ultima a dover essere smascherata e rimossa per poter tornare aparlare di cause delle sensazioni.Secondo Avenarius lo stesso Schopenhauer si ritrova a parlare di
“interno” ed “esterno”16 non tanto per la causalità in sé, quanto perla prospettiva introiezionistica all’interno della quale viene applicatatale nozione di causalità. Per poter andare oltre il filosofo di Danzi-ca Avenarius ha dunque bisogno di smascherare l’introiezione che sinasconderebbe ancora nel pensiero di Schopenhauer. Per far ciò egliricorre ad un espediente: dopo aver spiegato come si presenti in ge-nerale l’introiezione, facendo riferimento ad un «immaginario indi-viduo M, che può essere adoperato per tutte le epoche e per tuttele forme di civiltà», si serve di alcuni passi della Quadruplice per mo-strare come agisce l’introiezione in «un individuo del tutto deter-minato di un’epoca del tutto determinata e di una forma di civiltàdel tutto determinata», qual è Arthur Schopenhauer17.
158
Chiara Russo Krauss
14 «Il circolo per cui la “cosa” prima condizionerebbe la ‘rappresentazione’ e poi ver-rebbe a sua volta condizionata dalla ‘coscienza’ (cosí che la ‘cosa’ diverrebbe unaforma particolare di causa sui) è ‘possibile’ – e certo anche ‘necessario’ – solosulla base dell’introiezione» (R. A., Weltbegriff, p. 120).
15 R. A., Weltbegriff, p. 41.16 Già nel Vortrag Avenarius si mostra consapevole del fatto che in Schopenhauer
«il puro interno» si contrapponga all’«esterno» proprio perché «non può affatto es-sere inteso in senso spaziale», dato che lo spazio è per l’appunto la forma del-l’esterno, ma – per usare le parole di un suo scritto successivo – «se l’espressio-ne “interno” non viene intesa in senso spaziale, ma in uno fondamentalmentediverso, essa perde quel senso che le deriva dalla contrapposizione con l’“ester-no” – un senso che, seppur non sostenibile, è comunque perlomeno compren-sibile». Cfr. R. A., Einiges e Id., Bemerkungen zum Begriff des Gegenstandes der Psy-chologie, in «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie», XVIII (1894),pp. 137-161, pp. 400-420; XIX (1895), pp. 1-18; pp. 129-145: XVIII, p. 160.
17 R. A., Weltbegriff, p. 72.
Se per Avenarius il punto di partenza di ogni indagine è l’espe-rienza naturale, ciò che troviamo semplicemente guardandoci intor-no, dobbiamo assumere che «anche Schopenhauer originariamentetrovava ciò che per M abbiamo definito esperienza-M, con le sueparole: “il mondo della percezione che è là fuori, cosí come esso ri-empie lo spazio nelle sue tre dimensioni”»18. Ad alterare questo quadro iniziale interviene però l’introiezione.
Il germe da cui essa si sviluppa è la difficoltà nel concepire in chemodo si diano le esperienze altrui: io so che il mio prossimo è si-mile a me ed ha pertanto un’esperienza come la mia; dal momentoperò che questa esperienza altrui non è qualcosa che io posso espe-rire, mi spiego la sua inaccessibilità col fatto che essa si trova dentroil mio prossimo. A ciò corrisponde
l’assunto ulteriore secondo cui Schopenhauer introducevanegli altri uomini ciò che riferendoci a T abbiamo chiama-to esperienza-T, e cioè percezione, rappresentazione, senti-mento e volontà; e in particolare anche da parte sua inizial-mente ciò accadeva senza intenzione o coscienza dell’attodell’introiezione, come è solito succedere tra le “merci difabbrica” della natura19.
Una volta collocata l’esperienza altrui all’interno del suo prossi-mo, «per Schopenhauer il mondo esiste due volte: una volta là fuorie una volta nella testa», da cui nasce la domanda:
Come entra il mondo là fuori nella testa? Questa domandaavrebbe un senso sempre solo se essa si riferisse alla testa diquell’individuo in cui è stato introdotto il mondo come‘rappresentazione’; ma, attraverso lo scambio tra se stessi e glialtri individui, Schopenhauer si chiede: Come entra nella no-stra testa?20.
159
Esperienza e causalità: Avenarius con e oltre Schopenhauer
18 Ibidem (citazione di A. S., Quadruplice, p. 93). Nelle schematizzazioni di Avena-rius M corrisponde a me stesso, all’io, mentre T rappresenta l’altro uomo.
19 R. A., Weltbegriff, pp. 72-73. L’espressione “merce di fabbrica della natura” (Fa-brikware der Natur) è un riferimento alla celebre definizione dell’uomo comu-ne data da Schopenhauer in Mondo, p. 276.
20 R. A., Weltbegriff, p. 73. I corsivi sono di Avenarius.
Infatti, dal momento che la somiglianza tra me e il mio prossimoagisce nei due sensi, quando si inizia a pensare all’esperienza altruicome a qualcosa che si trova dentro di loro, si finisce per considera-re allo stesso modo anche se stessi, facendo della propria esperienzaun che di interno. Alla domanda tipica della prospettiva introiezionistica su come
faccia il mondo esterno a riflettersi nell’esperienza interna verrebbe darispondere:
Tramite la ‘sensazione’. Ma è impossibile che il mondo pos-sa entrare nella testa […] tramite la mera ‘sensazione’; “poi-ché che misera cosa è in fondo la semplice sensazione!”. Inverità, aggiungiamo noi, essa non vede e non sente nulla. “Lasensazione, di qualsiasi specie, è e rimane un processo nellostesso organismo, limitato come tale alla regione sottocutaneae che pertanto non può mai contenere in sé qualche cosache stia al di là della pelle, quindi fuori di noi”. […] Allora, co-me Schopenhauer ha detto in precedenza, bisogna essere“abbandonato da tutti gli dei per credere che il mondo del-la percezione, che è là fuori, … esista là fuori tutto oggetti-vo e reale e senza il nostro concorso, e poi per mezzo di unasemplice impressione sensibile giunga nella nostra testa”. Al-la ‘mera sensazione’ bisogna quindi aggiungere il ‘nostro in-tervento’, ovvero l’‘intelletto’!21
Ovviamente nell’opera di Schopenhauer il problema non è co-me faccia il mondo esterno a penetrare nella nostra mente, dato cheegli si occupa proprio della costruzione del mondo esterno a parti-re dalle forme dell’intelletto. È Avenarius ad assumere che Scho-penhauer: 1) sia partito dall’introiezione, e quindi dalla domanda sucome faccia il mondo “esterno” a diventare l’esperienza “interna”;2) abbia accettato che il mondo esterno “causi” l’esperienza internaper mezzo degli organi di senso; 3) e poi, una volta ritrovatosi conin mano le mere sensazioni (che non sono in grado di darci il mon-do esterno se non tramite l’intervento dell’intelletto), abbia decisodi ribaltare la prospettiva, ripercorrendo a rovescio la strada seguitain precedenza, ovvero muovendo dalla costruzione della realtà og-
160
Chiara Russo Krauss
21 Ibidem (citazione di A. S., Quadruplice, p. 93). I corsivi sono di Avenarius.
gettiva per mezzo dell’intuizione intellettuale, per arrivare da questaal mondo esterno. Come si legge nel Weltbegriff:
In Schopenhauer, infatti, l’‘intelletto’ ripete precisamente ilruolo che ha recitato in precedenza – soltanto in direzioneopposta, un po’ come l’uomo nello specchio, che ripete imovimenti da noi eseguiti col braccio destro da sinistra ver-so destra, compiendoli con il braccio sinistro da destra versosinistra. O, con un’altra metafora: l’‘intelletto’ dipana nuova-mente quel che Schopenhauer ha arrotolato: Schopenhauerha prima esperito “il mondo là fuori”, poi – attraverso l’in-troiezione – lo ha “trasferito nella testa” come sensazioni che“il mondo là fuori” “causa” attraverso l’“eccitazione” degliorgani di senso, e strada facendo ha spogliato queste sensa-zioni di tutto ciò che a lui non appariva immediatamentetrasferibile lungo questa via. Ora l’‘intelletto’, guidato dalnesso causale, per mano del quale Schopenhauer era giuntonella testa, […] ritorna tutto contento al punto di partenzainsieme al suo mondo dell’esperienza-T e nel farlo riag-giunge puntualmente ciò che Schopenhauer in precedenzaaveva tolto. “Per questo la nostra quotidiana intuizione empi-rica è una intuizione intellettuale”22.
In altre parole Avenarius sostiene che il processo di proiezione del-le sensazioni per mezzo del principio di causalità descritto da Scho-penhauer non sia altro che il riflesso del processo di introiezione at-traverso cui egli aveva tacitamente collocato l’esperienza dentro gliindividui. È per questo motivo che l’applicazione del nesso causale– che lo si percorra nella direzione che conduce dal mondo ester-no all’esperienza interna, oppure in senso inverso, dall’esperienza in-terna al mondo esterno – conduce a contraddizioni insolubili, per-ché l’elemento contraddittorio è l’introiezione stessa, lo sdoppia-mento della realtà in interno ed esterno23.
161
Esperienza e causalità: Avenarius con e oltre Schopenhauer
22 R. A., Weltbegriff, p. 74 (citazione di A. S., Quadruplice, p. 95). I corsivi sono diAvenarius.
23 Oltre alle pagine appena citate, in cui il riferimento a Schopenhauer è esplici-to, piú in generale possiamo vedere una critica al filosofo di Danzica nell’av-versione dimostrata da Avenarius verso il termine “rappresentazione”, il quale,specialmente quando accompagnato dall’aggettivo “mera”, viene visto comeespressione stessa dell’introiezione. Cfr. R. A., Weltbegriff, pp. 50, 59 e sgg., 70 e
5. Per poter andare oltre Schopenhauer, ad Avenarius resta dun-que da rispondere ad una domanda: com’è possibile applicare ilprincipio di causalità in un’ottica non introiezionistica? Per scio-gliere questo nodo bisogna considerare innanzitutto che l’introie-zione si fonda su un duplice scambio di prospettiva tra me e il mioprossimo, per cui prima applico all’altro ciò che vale per me stesso,ma nell’attribuirgli un’esperienza come la mia finisco con il collo-carla dentro di lui, e poi trasferisco a me stesso ciò che vale per l’al-tro, considerando anche la mia esperienza come un che di interno.Per eliminare l’introiezione bisogna quindi tenere fermo che la miaesperienza e l’esperienza altrui si danno in due modi del tutto di-versi, evitando ogni scambio tra le due prospettive24. Per Avenarius la mia esperienza costituisce il piano su cui si dà
tutto ciò che c’è; se cerchiamo invece come si presenta l’esperienzaaltrui in una prospettiva “naturale”, non contaminata da teorie filo-sofiche, dobbiamo riconoscere che essa si dà attraverso il linguaggio,in ciò che il mio prossimo mi comunica con i suoi movimenti, ge-sti, parole. Mentre in un’ottica introiezionistica il linguaggio costi-tuisce tutt’al piú uno strumento per risalire a ciò che si trova nel-l’interiorità dell’altro uomo, per Avenarius esso è il modo stesso didarsi della sua esperienza, proprio in quanto egli non è un io, ma unaltro uomo. Limitarsi a considerare l’esperienza altrui come essa effettiva-
mente si dà, ovvero come “contenuti di asserzioni”, non costituisceperò una restrizione delle nostre possibilità conoscitive, perché èproprio questa peculiarità del suo modo di darsi a permetterci di
162
Chiara Russo Krauss
sgg., 106 e sgg., 119 (nota 46), 126 (nota 58, par. VIII). In particolare nella no-ta n. 46 Avenarius spiega quale sia per lui l’unico senso accettabile dell’espres-sione “mondo come rappresentazione”. Ovvero, considerando che tutti i con-tenuti della mia esperienza possono darsi o come fatti o come pensieri (moda-lità che in quanto confrontabili tra loro sono solo relativamente diverse l’unadall’altra, e costituiscono perciò una “dualità” e non un “dualismo”), l’espres-sione dovrebbe significare «il ‘mondo come pensiero’ in opposizione al ‘mon-do come fatto’».
24 Si potrebbe azzardare l’ipotesi che anche il meccanismo dello scambio dei pun-ti di vista sia stato suggerito ad Avenarius da Schopenhauer, dato che quest’ulti-mo aveva già avuto modo di rimarcare la differenza fondamentale che intercor-re tra me stesso e l’altro uomo in alcune pagine della sua opera principale, dovesi legge – tra le altre cose – che l’altro individuo «non è senz’altro il soggetto,bensí innanzi tutto un individuo conoscente». Cfr. A. S. Mondo, cap. 1, p. 1027.
uscire dai circoli viziosi in cui ci si imbatte quando si prova a stabi-lire da cosa dipendono le esperienze. Difatti, anche se il principio dicausalità non riesce a condurci dall’“esterno” del mondo all’“inter-no” dell’esperienza, e non riesce nemmeno spiegare in che modo lamia esperienza possa condizionare il mondo per poi essere da que-sto condizionata, esso ci permette comunque di istituire dei rappor-ti tra i diversi elementi che si danno nell’esperienza, e le asserzionialtrui rientrano tra questi. Come non costituisce un problema par-lare di dipendenza tra variazioni quando si analizza un fenomeno,come può essere l’incendio di un albero dovuto alla caduta di unfulmine, cosí non vi può essere alcun problema ad affermare chel’asserzione altrui “A fuoco!” dipende dall’albero in fiamme, perchécome il fulmine e l’albero, cosí anche l’asserzione non è altro che uncomponente del piano della mia esperienza, e come tale può trovar-si in un rapporto di dipendenza con gli altri componenti di tale pia-no. Semmai bisognerebbe specificare di che tipo di dipendenza sitratti. Per Avenarius, infatti, stante che ogni dipendenza consiste inuna relazione funzionale tra due elementi variabili, per cui se unocambia anche l’altro si modifica, bisognerebbe parlare di causalità o,meglio, di “dipendenza fisica” solo in caso di relazioni funzionali chericadono anche sotto il principio di conservazione dell’energia,mentre negli altri casi si dovrebbe parlare di semplice “dipendenzalogica”. In base a questo modo di vedere, se si analizza la dipenden-za indiretta che sussiste tra un’asserzione e un oggetto, come può es-sere il suddetto albero in fiamme, si ottiene da un lato una serie con-tinua di dipendenze fisiche, che va dall’oggetto in questione fino agliorgani di senso dell’altro uomo e da questi fino al suo cervello, e dal-l’altro una dipendenza diretta di tipo logico (o psicologico, come pu-re la definisce Avenarius) tra il cervello stesso e l’asserzione25.Quel che bisogna mettere in chiaro è che i rapporti di causa ed
effetto e le relazioni di dipendenza riguardano sempre e soltanto lerelazioni dei componenti della mia esperienza tra loro, mentre nonpossono mai essere adoperati per cercare la causa di un contenuto diesperienza in quanto tale, in quanto rappresentato, perché nel mo-mento in cui mi chiedo quale sia la causa di una data esperienza nelsuo essere esperita, che io lo voglia o meno, che io ne sia consapevo-le o meno, vengo immediatamente rimandato a un altro piano, il
163
Esperienza e causalità: Avenarius con e oltre Schopenhauer
25 Cfr. R. A., Weltbegriff, pp. 18-19 e pp. 126-127.
quale è o una mera duplicazione dell’originario piano dell’espe-rienza o un che di inconoscibile. Considerando però che di queicomponenti della mia esperienza che sono dipendenti tra loro fannoparte anche gli altri uomini con le loro asserzioni, ecco che possocercare la causa delle loro esperienze nel loro essere asserite, analizzan-do il modo in cui ciò che essi affermano dipende dal loro cervelloe, indirettamente, dagli oggetti del mondo che agiscono su di essotramite il sistema nervoso.
6. Possiamo quindi dire che Avenarius ha tenuto fede alla lezio-ne schopenhaueriana che vuole che non si debba partire dal sog-getto e dall’oggetto bensí dalla rappresentazione. Allo stesso tempoegli ha però sostenuto che se si vuole evitare di cadere nelle trap-pole della prospettiva introiezionistica, come pure è accaduto al fi-losofo di Danzica, non si può applicare il principio di causalità allenostre rappresentazioni, ai nostri contenuti di esperienza, perché leuniche esperienze di cui posso cercare la causa sono quelle altrui, lequali non vanno considerate in quanto esperite in prima persona (per-ché si ricadrebbe nello scambio delle prospettive e nell’introiezio-ne), ma vanno invece considerate come esse effettivamente si dan-no, ovvero in quanto asserite da un altro uomo. Con la scoperta dell’errore insito nello scambio dei punti di vi-
sta, e grazie alla soluzione costituita dal limitarsi a ricercare le causedelle asserzioni altrui, Avenarius ritiene di aver trovato la via d’usci-ta da quell’antinomia tra realismo ed idealismo che già Schopen-hauer aveva denunciato, dal momento che egli tiene fede sia al prin-cipio “idealistico” in base al quale tutto si dà solo nell’esperienza (lamia), che al principio “realistico” per cui l’esperienza (quella altrui)dipende dagli oggetti del mondo. Per arrivare a questo risultato, checostituisce il fulcro della sua filosofia, Avenarius ha però percorso untratto di strada con Schopenhauer, che ai suoi occhi è stato «il pri-mo ad aver esplorato in modo sistematico il campo della fondazio-ne di tutta la conoscenza tramite la separazione dei diversi tipi dipossibili ragioni», una prospettiva «da cui possono scaturire diversispunti interessanti»26. Ed è sviluppando uno di questi spunti, quello
164
Chiara Russo Krauss
26 R. A., Einiges.
riguardante il ruolo giocato dalla causalità nella costruzione del“mondo esterno”, che Avenarius è potuto approdare alla scopertadell’introiezione e all’elaborazione del meccanismo concettuale che,distinguendo tra esperienza propria e altrui, permetterebbe di aggi-rarla. Che per giungere alla soluzione del problema Avenarius si sia
servito del pensiero di Schopenhauer, anche solo per riflettere suglierrori che questi avrebbe commesso, è testimoniato non solo dallapresenza del filosofo di Danzica nelle pagine del Weltbegriff, ma so-prattutto dal fatto che le risposte presentate in quest’opera furonosviluppate proprio negli anni di stesura del Vortrag schopenhaueria-no ed esposte per la prima volta in una Vorlesung dell’anno a questosuccessivo27. Possiamo quindi dire che è proprio negli anni di rifles-sioni “schopenhaueriane” che Avenarius arriva a sciogliere il nodoche lega causalità e dualismo, perché è Schopenhauer a mostrarglicosa accade quando si prova, erroneamente, ad applicare il principiodi causalità alle nostre rappresentazioni, alla nostra stessa esperienza.
165
Esperienza e causalità: Avenarius con e oltre Schopenhauer
27 Cfr. R. Avenarius, Einleitung in die Entwicklungstheorie der Philosophie, Vorlesungtenuta nel semestre invernale 84-85 e conservata nel Nachlass dell’autore, Kas-ten 10. Per un’analisi delle anticipazioni degli sviluppi maturi del pensiero diAvenarius presenti nei manoscritti del suo Nachlass si veda C. Russo Krauss, Ilsistema dell’esperienza pura, cit., p. 359 e sgg.
























![Monni, S. (2013) “ Oltre il velo di Maya: il ruolo delle idee e delle Istituzioni” [in Italian].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63225731050768990e0fd043/monni-s-2013-oltre-il-velo-di-maya-il-ruolo-delle-idee-e-delle-istituzioni.jpg)