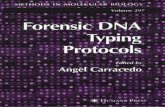DNA Perugia. Mobilità DinamicaNaturaleAlternativa
Transcript of DNA Perugia. Mobilità DinamicaNaturaleAlternativa
DNA PerugiaMobilità DinamicaNaturaleAlternativaa cura diPaolo Belardi, Valeria Menchetelli, Luca Martini
DNA PerugiA
Mobilità DiNAMicANAturAleAlterNAtivA
a cura di Paolo Belardi, Valeria Menchetelli, Luca Martini
progetto grafico e videoimpaginazione Valeria Menchetelli
La pubblicazione raccoglie gli esitidel progetto di ricercaDNA PerugiA
Mobilità DiNAMicANAturAleAlterNAtivA
realizzato con il sostegno della
cofinanziato da
Gli esiti intermedi della ricercasono stati presentatiin occasione del convegnoDNA PerugiA
Mobilità DiNAMicANAturAleAlterNAtivA
svoltosi il 21 febbraio 2014 a Corciano.
© 2014 EFFE Fabrizio Fabbri Editore06132 San Sisto, Perugiatel. +39 075 5271076www.fabriziofabbrieditore.it
ISBN 978-88-6778-036-5
Università degli Studi di PerugiaDipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
direttore del Dipartimentodi Ingegneria Civile e AmbientaleAnnibale Luigi Materazzi
responsabile scientifico del progetto di ricercaPaolo Belardi
gruppo di lavoro
uNiversità Degli stuDi Di PerugiA
DiPArtiMeNto Di iNgegNeriA civile e AMbieNtAle
Paolo Belardi, Fabio Bianconi, Simone Bori,Marco Filippucci, Luca Martini, Valeria Menchetelli, Giacomo Pagnotta, Enrico Tombesi
tPs trANsPort PlANNiNg service srl
Stefano Ciurnelli, Francesco Filippucci
L’elaborazione dei dati trasportistici è stata svolta in collaborazione con TPS Transport Planning Service srl (Stefano Ciurnelli, Francesco Filippucci).Le esercitazioni didattiche di carattere progettuale sulle aree di Perugia e Corciano sono state svolte nell’ambito dei corsi integrati di Progettazione digitale (docente Paolo Belardi) e Laboratorio di Progettazione digitale (docente Simone Bori) attivati nell’anno accademico 2013-2014 all’interno del corso di laurea magistrale in Ingegneria edile-Architettura.
Si ringraziano
coMuNe Di PerugiA
Enrico Antinoro, Leonardo Naldini
coMuNe Di corciANo
Francesco Cillo
regioNe uMbriA
Ambra Ciarapica
AzieNDA osPeDAliero-uNiversitAriA Di PerugiA
Walter Orlandi
uNiversità Degli stuDi Di PerugiA
Fabio Piscini, Aurelio Stoppini
DNA Perugia. Mobilità DinamicaNaturaleAlternativa
DNA PerugiaPaolo Belardi
Le elaborazioni trasportisticheStefano Ciurnelli
La ZTS per il futuro della cittàEnrico Tombesi
DNA Perugia. Dalla storia al futuro
L’area di Sant’Andrea delle FratteSimone Bori, Valeria Menchetelli
le iPotesi ProgettuAli
MUTA PerugiaSimone Bori
...e quindi (ri)uscimmo a riveder le stelleAlessandro Bulletti
A TtRA VERSO PerugiaAndrea Dragoni
inTRAMezzo VERDEValeria Menchetelli, Giacomo Pagnotta
L’area di ElleraFabio Bianconi, Marco Filippucci
le iPotesi ProgettuAli
Greenmark stationFabio Bianconi, Marco Filippucci
Connect CorcianoLuca Martini
lA PreseNtAzioNe PubblicA
FoNti citAte
5
7
21
26
30
34
38
42
47
51
55
60
62
5
È ormai quasi mezzo secolo che la città di Perugia continua a incarnare un modello trasportistico studiato (e talora emulato) a livello internazionale. Il che è assolutamente logico visto che, nella contemporaneità, lo spostamento fisico di persone e cose all’interno delle città ha assunto un’importanza esponenziale e visto che Perugia, fin dalla scelta pionieristica di pedonalizzare corso Vannucci (1971), ha sempre affrontato il tema della mobilità urbana optando per la costruzione piuttosto che per la dissoluzione della città. Tanto da realizzare prima un sistema articolato di risalite meccaniche suggellate dalle scale mobili introdotte nelle viscere crepuscolari della rocca Paolina (1983) e poi un sistema di trasporto automatico su rotaia quale il minimetrò (2008) qualificato dalla firma prestigiosa di Jean Nouvel. Il che potrebbe far pensare a un piano compiuto, ma non è così. A ben guardare, infatti, il Piano Regolatore Generale vigente (2002), oltre ad accarezzare l’idea di un’ulteriore risalita meccanica nel versante settentrionale del centro storico (via Pinturicchio-piazza Piccinino) e oltre a considerare il possibile ampliamento della rete del minimetrò (Pincetto-Monteluce e
Fontivegge-Ponte della Pietra), presenta un pallido tratteggio, che custodisce e in qualche modo alimenta l’ipotesi di trasformazione dell’attuale tracciato ferroviario mediante la realizzazione di un tratto passante tangente al margine sud della città, volto a collegare direttamente l’area di San Martino Delfico a quella di Sant’Andrea delle Fratte bypassando l’ansa con cui da più di 150 anni la linea ferroviaria Foligno-Terontola, dopo essere risalita dalla valle del Tevere e dopo avere attraversato in galleria il crinale, si approssima a Perugia per poi allontanarsene dirigendosi verso Magione e Terontola. Il che comporterebbe molte modifiche nell’organizzazione della parte sud della città e del suo intorno territoriale. A cominciare dallo spostamento della stazione ferroviaria di Perugia in corrispondenza della zona produttivo-commerciale di Sant’Andrea delle Fratte che in tal senso, anche a seguito del trasferimento del Polo Unico Ospedaliero e dei dipartimenti dell’area medica dell’Università degli Studi di Perugia, vedrebbe enfatizzato il proprio ruolo di crocevia, configurandosi come vera e propria porta di accesso alla città. Nondimeno il riposizionamento della stazione ferroviaria comporterebbe una serie di azioni progettuali volte a riconfigurare un sistema di aree che dovrebbero necessariamente mutare la propria destinazione originaria: in particolare il rilevato curvilineo posto a valle delle aree residenziali di Prepo e di
DNA PerugiaPaolo Belardi
6
hanno preso le mosse dall’analisi delle reti esistenti e hanno considerato le interrelazioni trasportistiche tanto alla scala urbana quanto alla scala territoriale. Al fine di esplorare le qualità ambientali, sono state condotte attività progettuali specifiche, svolte nell’ambito dell’attività didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-Architettura e dedicate alla ricomposizione paesaggistica delle aree destinate alla nuova stazione ferroviaria di Perugia oltre che alla nuova stazione ferroviaria di Ellera-Corciano. È indubbio che l’attivazione del nuovo tratto ferroviario ipotizzato nel Piano Regolatore Generale vigente avrebbe profonde ricadute su Perugia, modificando sensibilmente le abitudini di chi vi abita, di chi vi lavora e di chi vi si muove. In tal senso, gli esiti della ricerca, che vanta il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il cofinanziamento di PAC 2000A, non sono rivolti soltanto agli enti preposti all’amministrazione del territorio e alle aziende che gestiscono il trasporto pubblico, ma sono rivolti anche e soprattutto ai soggetti privati insediati nelle aree coinvolte direttamente e/o indirettamente. Perché, così come dimostra la storia della città (dall’assetto cardo-decumanico dell’età etrusca all’assetto palmare dell’età medievale), l’organizzazione della mobilità è da sempre volano delle trasformazioni fisiche. Ovvero è parte integrante del DNA Perugia.
San Vetturino (che potrebbe accogliere i servizi di cui tali aree sono carenti), l’area fuseiforme compresa tra via Campo di Marte e la stazione ferroviaria di Fontivegge (che potrebbe essere completamente ripensata, dismettendo la propria condizione di cesura e diventando un’occasione di ricucitura) e la stazione ferroviaria di Ellera (che potrebbe essere riposizionata in base al potenziamento del polo commerciale ex Quasar e all’ottimizzazione del funzionamento dell’intero modello policentrico di trasporti su ferro). Prendendo le mosse dall’insieme di queste problematiche e di queste potenzialità, l’attività di ricerca svolta dall’équipe interdisciplinare organizzata nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia si è concentrata su tre obiettivi: verificare la fattibilità tecnica, valutare l’efficienza trasportistica ed esplorare le qualità ambientali del nuovo tratto ferroviario ipotizzato nel Piano Regolatore Generale vigente. Al fine di verificare la fattibilità tecnica, è stato eseguito un approfondito rilievo architettonico-ambientale delle diverse aree di studio, svolto sia con tecniche tradizionali sia con tecniche avanzate, che è stato debitamente integrato con un’attenta disamina del contesto normativo di riferimento. Al fine di valutare l’efficienza trasportistica, sono state svolte analisi specialistiche, in collaborazione con la società “TPS Transport Planning Service”, che ©COOP HIMMELB(L)AU
7
Contestualizzazione
L’ipotesi di bypass dell’ansa della linea ferroviaria Foligno-Terontola tra la valle del Fosso dell’Infernaccio a San Vetturino e il passaggio a livello (P.L.) su viale San Sisto è una delle numerose proposte d’intervento elaborate, soprattutto nella seconda metà del secolo scorso, in relazione al nodo ferroviario di Perugia. L’obiettivo di queste previsioni, alcune delle quali rimaste tali e altre concretizzatesi in progetti in parte realizzati, è quello di sfruttare appieno le potenzialità del sistema ferroviario per garantire l’accesso al capoluogo da gran parte del territorio regionale, considerata la buona copertura assicurata dalla rete convergente su Perugia e composta dalla linea RFI (Rete Ferroviaria Italiana) Foligno-Terontola e dalla diramazione Ponte San Giovanni-Perugia Sant’Anna della linea Terni-Ponte San Giovanni-Sansepolcro dell’FCU (Ferrovia Centrale Umbra) [figura 1]. La previsione normativa1 da cui prende le mosse e su cui concentra la propria attenzione il presente contributo è stata oggetto di una vivace discussione tra il 1993 e il 1995 all’epoca della redazione del
Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Perugia. Il bypass dell’ansa con cui la linea Foligno-Terontola, dopo essere risalita dalla valle del Tevere e aver attraversato in galleria il crinale delle colline della destra orografica, si avvicina a Perugia per poi allontanarsene dirigendosi verso Magione e Terontola, aveva una duplice finalità: da un lato ridurre i tempi di percorrenza per treni veloci di collegamento dell’Umbria con Firenze; dall’altro lato riservare la tratta urbana della linea attuale, tra il quartiere di San Sisto e la zona di San Vetturino, al trasporto locale ricorrendo alla tecnologia treno-tram in modo da consentire anche una radicale rivisitazione dell’assetto urbanistico di tutto il fuso a cavallo della ferrovia da via Palermo al quartiere di Santa Lucia, oggi penalizzato dalla presenza della linea ferroviaria.Dei progetti di potenziamento del nodo ferroviario di Perugia, a oggi sono stati realizzati quelli riguardanti quattro fermate in campo urbano, di cui tre su rete RFI (Silvestrini, Università e Capitini, quest’ultima attrezzata anche come posto di movimento (P.M.) per l’incrocio dei treni) e una su rete FCU (Pallotta), mentre sono in corso di realizzazione gli interventi di potenziamento della stazione RFI di Ponte San Giovanni e quelli di raddoppio selettivo della linea FCU Ponte San Giovanni-Perugia Sant’Anna. La scelta del Comune di Perugia di investire sulla mobilità alternativa con la realizzazione del minimetrò ha
Le elaborazioni trasportisticheStefano Ciurnelli
8
fatto invece accantonare il progetto di interconnessione ferroviaria tra le stazioni di Perugia Fontivegge e Perugia Sant’Anna, che si prefiggeva di porre in collegamento diretto con la base del centro storico sia la stazione RFI che i quartieri della periferia ovest di Perugia serviti dalla tratta Ellera-Fontivegge[figura 2]. Il trend degli ultimi decenni della popolazione residente nel comune di Perugia e nei comuni confinanti è stato contrassegnato da un forte incremento in aree esterne alla città compatta rafforzando il peso delle frazioni ma anche quello delle aree comunali di Bastia e Corciano. Ciò ha comportato la crescente congestione del traffico in accesso alla città, soprattutto per le provenienze dalla valle del Tevere tramite il raccordo autostradale Perugia-Bettolle (circa 60.000 spostamenti/giorno) che ormai, assieme alla tratta Collestrada-Ponte San Giovanni della E45, presenta fenomeni di congestione strutturale. Questa emergenza, resa più acuta dai ritardi nella realizzazione dei progetti di potenziamento della viabilità extraurbana principale del nodo di Perugia, unitamente alle esigenze di velocizzazione del trasporto ferroviario interregionale sulla linea Foligno-Terontola con funzioni di collegamento alla rete dell’Alta Velocità, ripropongono l’attualità di una riflessione sul ruolo che la ferrovia può svolgere per contribuire a migliorare la mobilità verso e nell’area metropolitana del capoluogo regionale.
figura 1L’ipotesi di bypass dell’ansa della linea ferroviaria
Foligno-Terontola tra la valle del Fosso dell’Infernaccio a San Vetturino e il passaggio a
livello su viale San Sisto.
il traffiCo attuale nel nodo di Perugia
In base alle stime più recenti elaborate nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), l’area che ricomprende il nodo infrastrutturale multimodale stradale e ferroviario di
Perugia, e che si identifica con i territori dei comuni di Perugia e Corciano, è interessata da un traffico giornaliero complessivo di circa 500000 spostamenti automobilistici2 e di 3000 mezzi pesanti. Circoscrivendo in questa sede l’attenzione al traffico automobilistico,
l’incidenza della componente di puro attraversamento è inferiore al 10%, mentre quella di scambio ammonta al 30% e il restante 60% rappresenta la componente del traffico interno al nodo di Perugia. La stessa area è interessata giornalmente da circa 50000
9
figura 2L’ipotesi accantonata di interconnessione ferroviaria
tra le stazioni di Perugia Fontiveggee Perugia Sant’Anna.
spostamenti su mezzo pubblico, di cui circa 4000 su treno e 46000 ripartiti tra autobus extraurbani, urbani e minimetrò, cui corrisponde una quota modale di trasporto pubblico pari all’8%.Questi dati rendono evidente il contributo ancora troppo modesto da parte del trasporto collettivo al funzionamento del sistema della mobilità nell’area del nodo, sia per quanto riguarda la mobilità interna che per quanto riguarda quella di scambio; aspetto, quest’ultimo, assolutamente strategico tenuto conto dell’entità dei flussi sulla rete stradale e dello scarso livello di servizio che contraddistingue gli elementi fondamentali della viabilità principale in accesso a Perugia.Tenuto conto delle proporzioni esistenti tra le diverse componenti di traffico automobilistico, un approccio possibile potrebbe essere quello di riservare capacità sulla porzione della rete ferroviaria regionale che interessa il nodo per creare servizi di carattere metropolitano territoriale in grado di costituire una reale alternativa all’uso dell’auto privata, in particolare per gli utenti che effettuano spostamenti di natura sistematica di medio raggio verso Perugia provenendo dalle quattro direttrici servite dalla viabilità extraurbana principale, ma anche dalla ferrovia. La realizzazione del bypass dell’ansa ferroviaria, pur creando un problema rilevante di collegamento tra l’area centrale della città e la nuova stazione dei servizi interregionali e di
lunga percorrenza che dovrebbe sostituire quella di Fontivegge, sarebbe in grado di produrre queste condizioni in quanto il tratto della linea attuale compreso tra San Sisto e San Vetturino risulterebbe sgravato dalla circolazione di quest’ultima tipologia di treni e dedicata al trasporto
metropolitano e regionale di corto raggio effettuabile, ad esempio, con tecnologia treno-tram (cfr. paragrafo dedicato al modello di esercizio di progetto).A partire da queste premesse sono state prefigurate una serie di visioni future che restituiscono alcune suggestioni
progettuali: una nuova stazione che si candida a divenire un elemento identitario per tutta la zona sud ovest di Perugia; nuovi modelli di mobilità all’interno del nodo con particolare riferimento a possibili ruoli per le stazioni di Ellera e Ponte San Giovanni in una logica
10
policentrica di organizzazione del sistema della mobilità su ferro; prospettive di riqualificazione lungo tutto il corridoio urbano della linea ferroviaria esistente.
lo sCenario Progettuale.il byPass e la nuova stazione di Perugia
Il bypass dell’ansa ferroviaria presenta una lunghezza di 5130 metri e un tracciato pressoché rettilineo essendo previste solo due curve entrambe di raggio superiore a 2000 metri. Dal momento che i due punti estremi, di raccordo con la linea esistente, si trovano rispettivamente a quota 260,2 metri s.l.m. quello lato Ponte San Giovanni e a 257,2 metri s.l.m. quello lato Ellera, il profilo longitudinale della nuova linea presenta pendenze massime del 5,1‰ (fa eccezione la livelletta imposta dal raccordo con la linea esistente lato Ponte San Giovanni, che nel tratto in cui è previsto il bivio ha una pendenza del 17‰) e raccordi verticali di 5000 metri di raggio [figura 3].Il bypass, procedendo da Ponte San Giovanni verso Perugia, si sfiocca dall’infrastruttura esistente con un bivio in linea ubicato 400 metri dopo il portale ovest della galleria di Colonnetta di Montebello e procede inizialmente per
figura 3Il bypass dell’ansa ferroviaria.
11
circa 300 metri in rilevato e a mezza costa, successivamente su una sequenza di due viadotti, rispettivamente di 250 e 350 metri di lunghezza, inframmezzati da una breve galleria di circa 130 metri, sino alla galleria che sottopassa via Settevalli in prossimità dell’abitato di Case Nuove di Ponte della Pietra. Dopo un primo tratto in scavo a foro cieco di circa 150 metri, questa galleria è realizzata in scavo a cielo aperto dato il modestissimo ricoprimento sino a raggiungere il cassone della nuova stazione ferroviaria. L’area della stazione si trova a quota 252 metri s.l.m. e ha una lunghezza di circa 850 metri misurata tra la punta scambi delle due radici dei deviatoi. La stazione è realizzata in gran parte all’interno di un cassone realizzato in scavo a cielo aperto (profondità 8-10 metri) e, limitatamente al tratto iniziale della radice est, all’interno della galleria artificiale di Case Nuove. Al termine della stazione, lato Ellera, la linea procede per un breve tratto in piano per poi riemergere in superficie dopo aver sottopassato viale San Sisto in corrispondenza dell’attuale P.L. e raccordarsi alla linea attuale all’altezza del dismesso raccordo ferroviario con lo stabilimento della Perugina [figure 4 e 5].La nuova stazione è dotata di 5 binari di modulo variabile da 400 (i due binari destinati all’incrocio dei treni interregionali e di lunga percorrenza) a 250 metri (i tre binari destinati al trasporto locale). La collocazione sotterranea della stazione oltre a essere
figura 4Lo sviluppo altimetrico del bypass.
12
dettata dalla volontà di minimizzare l’impatto visivo, le interferenze e il consumo di suolo, è stata prescelta per garantire la massima permeabilità traversale e un’ampia libertà di manovra per riorganizzare il sistema delle relazioni di corto raggio nell’area. Tenendo conto dei tempi di fermata in corrispondenza della nuova stazione, il tempo di percorrenza tra Ponte San Giovanni ed Ellera si riduce di 8 minuti, passando dai 24 minuti medi attuali a 16 minuti, il che si traduce in un risparmio del 10% circa sul tempo di percorrenza dell’intera linea Foligno-Terontola da parte di un treno regionale veloce. La nuova stazione potrebbe contare su un bacino di utenza potenziale per i servizi di lunga percorrenza di circa 45000 abitanti entro un’isocrona di 10 minuti in auto privata (quartieri di Castel del Piano, San Sisto, Pila, via Chiusi, Santa Sabina, Lacugnano, Olmo, Ellera, San Mariano-Girasole) per i servizi di lunga percorrenza e di circa 30000 abitanti per i servizi regionali veloci considerata la complementarietà della nuova stazione con la stazione di Ellera-Corciano. Un elemento non trascurabile è costituito dal fatto che la viabilità che insiste nell’area presenta ampi margini di potenziamento per garantire un’adeguata accessibilità automobilistica e gli spazi a disposizione consentono di prevedere una consistente dotazione di parcheggi. Inoltre l’eventuale realizzazione del collegamento stradale Madonna del Piano-Sant’Andrea delle
figura 5Lo sviluppo altimetrico del bypass.
13
Fratte, parte integrante del progetto del nodo stradale di Perugia, consentirebbe inoltre di migliorare l’accessibilità della stazione anche dalla valle del Tevere a vantaggio di tutti i comuni a sud di Perugia, oggi particolarmente penalizzati nell’accesso ai servizi ferroviari di rango interregionale.La buona accessibilità stradale consente anche di prevedere interventi di trasformazione urbanistico-architettonica coordinati con quello prettamente ferroviario; aspetto, questo, particolarmente interessante tenuto conto del contesto in cui la nuova opera s’inserisce, particolarmente carente di luoghi identitari e di qualità urbana[figura 6].
figura 6Piano schematico della nuova stazione di Perugia.
14
lo sCenario Progettuale.il nuovo assetto del sistema ferroviario: modello di eserCizio e interventi ProPedeutiCi
L’ipotesi di bypass e nuova stazione si fonda su una radicale riorganizzazione del modello di esercizio in corrispondenza del nodo di Perugia, che prevede sostanzialmente due categorie di servizi ferroviari, tra loro integrati, effettuati con materiale rotabile di adeguate e differenti caratteristiche tecniche. In primo luogo, servizi regionali veloci destinati a collegare tra loro (e con Roma e Firenze) le principali città della regione: appartengono a queste categorie di servizi i treni che corrono sulla dorsale Firenze-Terontola-Perugia-Foligno-Terni-Orte-Roma. In secondo luogo, servizi locali di ambito territoriale e metropolitano effettuati con materiale rotabile treno-tram3, in grado di coniugare molteplici esigenze (economicità di gestione in rapporto alla domanda da servire, flessibilità di esercizio, progressivo sviluppo della rete anche mediante brevi penetrazioni in campo urbano): appartengono a questa categoria di servizi tutti i treni su rete FCU e quelli su rete RFI di medio raggio di collegamento con Magione, Terontola, Assisi e Foligno.Nelle stazioni di Ponte San Giovanni, nella nuova stazione di Perugia e in quella di Ellera-Corciano sono previsti i punti di raccordo orario per garantire il reciproco interscambio tra servizi
figura 7Quadro riassuntivo dei sistemi di trasporto integrato
prefigurati dall’ipotesi progettuale.
figura 8Schema esemplificativo del rendez-vous tra servizi
regionali e locali-metropolitani (RFI e FCU) in corrispondenza della stazione di Ponte San Giovanni.
regionali veloci e servizi locali. Questi ultimi, grazie a un’accresciuta capacità di distribuzione diretta ottenuta tramite la creazione di nuove fermate e alcuni rami di interconnessione-penetrazione urbana potrebbero compensare la penalizzazione rispetto alla situazione attuale costituita dall’obbligo di una “rottura di carico” per i passeggeri che, provenendo dai servizi regionali veloci debbono muoversi all’interno della città di Perugia. Una siffatta organizzazione avrebbe il pregio di rendere disponibile al segmento di domanda di gran lunga prevalente, costituito dagli spostamenti di scambio tra il nodo e le principali direttrici di traffico interne alla regione, un sistema in grado di effettuare una distribuzione diretta e sufficientemente capillare all’interno della città [figura 7].A titolo esemplificativo, nella figura 8 è riportata l’organizzazione del rendez-vous tra servizi regionali veloci (tracce in colore celeste e verde chiaro) e servizi locali–metropolitani su rete RFI e su rete FCU in corrispondenza della stazione di Ponte San Giovanni. La logica del modello di esercizio, resa possibile dagli interventi sul piano del ferro della stazione in corso di attuazione, prevede arrivi e partenze contemporanei dei treni su diversi itinerari attorno ai minuti 0’ e 30’ di ogni ora in modo da consentire tutti i possibili interscambi tra le diverse direttrici convergenti nel nodo. Questa modalità di organizzazione dell’esercizio rende estremamente competitivo il trasporto
ferroviario attraverso la creazione di un effetto rete che compensa il discomfort dovuto al trasbordo.
15
figura 9 Direttrici e instradamenti di un possibile assetto delle linee servite con modalità treno-tram nel nodo
di Perugia e loro integrazione con il minimetrò e il suo eventuale prolungamento verso Monteluce.
In base a questa proposta, la rete servita dal treno-tram all’interno del nodo è costituita da due linee
che presentano una serie di diramazioni terminali e alcune ipotesi di estensioni in campo urbano.
linea celeste(Foligno-Assisi)-Ponte San Giovanni-Pallotta-
Fontivegge-San Sisto-Ellera-(Magione-Terontola)
linea gialla(Rete FCU)-Ponte San Giovanni-Sant’Anna-San
Vetturino-nuova stazione di Perugia-Ellera
16
figura 10Lo sviluppo planimetrico del collegamento con caratteristiche tramviarie tra Pallotta e Fosso
dell’Infernaccio.
Il modello di esercizio trova la sua completa valorizzazione attraverso alcuni interventi complementari che sono di seguito elencati e brevemente descritti.
Collegamento con caratteristiche tramviarie tra Pallotta e Fosso dell’Infernaccio
Il collegamento è finalizzato a porre in connessione l’ansa ferroviaria RFI con la linea FCU Ponte San Giovanni-Sant’Anna; esso è dotato anche di due fermate, la prima a servizio della zona della Pallotta e la seconda a servizio della zona residenziale di via San Vetturino-via Borghetto di Prepo. I due bivi a stella in corrispondenza delle testate consentono di prevedere tutti gli itinerari possibili e funzionali a realizzare i collegamenti previsti dal modello di esercizio proposto [figura 10].
17
figura 11Lo sviluppo planimetrico della bretella di raccordo
tra il bypass e l’ansa ferroviaria.
Completamento del bivio est del bypass della linea RFI per convogli treno-tram
L’intervento prevede la realizzazione di una bretella di raccordo tra il bypass e l’ansa ferroviaria per consentire ai convogli treno-tram provenienti dalla nuova stazione di Perugia di imboccare l’ansa ferroviaria verso il centro storico della città [figura 11].
18
Nuova stazione di Ellera-Corciano
Il modello di esercizio ipotizzato assegna un ruolo rilevante alla stazione di Ellera-Corciano nella duplice veste di servizio a uno dei poli residenziali e produttivi più importanti dell’area e di interconnessione tra la rete dei servizi regionali veloci e dei servizi locali. Questa vocazione richiede il potenziamento dell’accessibilità pedonale, ciclabile e veicolare sia per il trasporto pubblico su gomma che per la mobilità privata anche con funzioni di nodo di interscambio. La proposta è quella di spostare la stazione attuale in una posizione tale da poter essere servita dalla nuova viabilità in corso di realizzazione, che la metterebbe in diretto collegamento con lo svincolo del raccordo autostradale Perugia-Bettolle. La vicinanza della stazione all’area commerciale di Ellera consentirebbe di prevedere un uso multifunzionale dell’offerta di sosta, configurando la nuova stazione come una vera e propria porta urbana in cui effettuare l’interscambio gomma-ferro.
figura 12Piano schematico della nuova stazione. In colore rosso i binari destinati all’esercizio ferroviario, in
colore giallo il binario di attestamento del servizio treno-tram. La collocazione della stazione si presta
anche a prevedere una eventuale successiva penetrazione del servizio treno-tram verso il centro
del quartiere Girasole che sarebbe così direttamente connesso con il centro storico di Perugia.
19
Penetrazione in campo urbano a Perugia
L’attestamento ferroviario di Perugia Sant’Anna si presta a prevedere ulteriori estensioni della rete treno-tram a servizio dell’area centrale urbana. Sono possibili numerose ipotesi di estensione tra cui quelle verso porta Pesa-Monteluce (in alternativa alla linea 2 del minimetrò) e verso porta Conca-Elce. In questa sede, a titolo assolutamente indicativo, viene proposto il tracciato di un percorso interamente in galleria che servirebbe via XIV Settembre e porta Conca, con possibile estensione sino a Elce[figura 13].
figura 13Lo sviluppo planimetrico del percorso treno-tram
Perugia Sant’Anna-via XIV Settembre-porta Conca.
20
ProsPettive di riqualifiCazione
lungo il Corridoio urbano
della linea ferroviaria esistente
Lo spostamento della stazione ferroviaria di Fontivegge e l’introduzione della tecnologia treno-tram prefigurata in questo studio ha come finalità indiretta anche la possibilità di ridisegnare tutta l’area circostante la ferrovia che va dal Fosso dell’Infernaccio a San Sisto. L’infrastruttura ferroviaria costituisce infatti una risorsa, ma anche un elemento che nel tempo ha condizionato l’organizzazione della città, le soluzioni infrastrutturali adottate e l’organizzazione stessa dei flussi automobilistici negli scambi tra la città a monte della ferrovia, la sua espansione occidentale e la viabilità extraurbana principale. La possibilità di reinterpretare radicalmente il rapporto tra trasporto su rotaia e altre componenti di traffico apre la strada a una serie di ipotesi che spaziano dalla riorganizzazione della rete stradale alla creazione di aree a forte vocazione pedonale che, tramite i servizi treno-tram da un lato e minimetrò dall’altro, si candiderebbero a divenire nuove centralità urbane di rango sovracomunale strutturalmente collegate al centro storico.
1 Cfr. Comune di Perugia, Nuovo Piano Regolatore Generale, Testo Unico delle Norme di Attuazione, 2014, art. 58.2 Il dato comprende spostamenti effettuati per qualunque scopo nell’arco della giornata e tiene conto in maniera separata di spostamenti che costituiscono elementi di una sequenza purché essi siano separati da una sosta di almeno 15’.3 La tecnologia treno-tram si fonda sull’impiego di un veicolo di tipo tramviario dotato di allestimenti e dispositivi che consentono la circolazione anche su linee ferroviarie ordinarie. L’obiettivo è quello di sfruttare le possibilità derivanti da un uso combinato di reti tramviarie urbane e linee ferroviarie convergenti sulle città, massimizzando l’impegno della capacità dell’infrastruttura ferroviaria. Questa opzione è risultata vincente in molti contesti europei caratterizzati da domanda non elevata e consente di prevedere brevi ma strategiche penetrazioni in campo urbano in grado valorizzare il trasporto su rotaia riducendo il discomfort connesso al trasbordo.
21
Nella città intelligente, la cosiddetta smart city, l’informazione si diffonde rapidamente e capillarmente raggiungendo tutti i luoghi e integrandosi nei servizi della città. Ma la capillare disponibilità d’informazioni, aggiornate in tempo reale, non è sufficiente a trasformare la città, renderla efficiente e quindi in grado di produrre un vantaggio competitivo per la comunità che vi abita.Nell’uomo il cervello e tutto il sistema nervoso sono essenziali per raccogliere e rielaborare le informazioni, ma se alla conoscenza e alla velocità di pensiero non è abbinata la velocità d’azione, la capacità di muovere in modo coordinato e preciso tutti i muscoli del corpo, l’organismo nel suo complesso non è efficiente. La rete di trasporto rappresenta per la città quello che il sistema muscolare è per l’uomo e deve quindi consentire ai cittadini, rispettando il contesto ambientale, di muoversi rapidamente e svolgere le diverse attività quotidiane impiegando al meglio il tempo e le risorse.Nel futuro saranno certamente disponibili sempre più informazioni per ottimizzare la gestione della mobilità cittadina; anche gli utenti avranno sui loro dispositivi mobili
La ZTS per il futuro della cittàEnrico Tombesi
indicazioni per individuare, in tempo reale, le soluzioni migliori per raggiungere rapidamente i diversi punti della città. Tutte queste informazioni non saranno però sufficienti a migliorare sensibilmente la qualità dei servizi se alla rivoluzione nel sistema informativo non si affiancherà un radicale cambiamento nella struttura dei servizi di trasporto pubblici. Una delle opportunità per attuare una profonda ristrutturazione della mobilità a Perugia è offerta dalla variante al percorso della ferrovia tra San Martino Delfico e San Sisto. Questa infrastruttura semplificherà il tracciato della rete ferroviaria a Perugia e scioglierà il nodo che costringe i treni a un lungo e lento percorso all’interno della città. L’effetto non sarà solo quello di velocizzare i collegamenti di Perugia con le altre città italiane e umbre, ma libererà un’importante risorsa strutturale, praticamente già pronta per essere convertita in una infrastruttura locale di superficie, integrata con il minimetrò e la Ferrovia Centrale Umbra. Tale infrastruttura ricucirà le zone periferiche ad alta densità abitativa e produttiva con il centro storico della città. Si creerà così un’ampia zona che copre, con servizi pubblici rapidi e frequenti, la città sviluppatasi negli ultimi decenni.Coerentemente con questa visione è possibile immaginare di creare un’ampia zona ad alta mobilità, che chiameremo Zona a Traffico Sostenibile (ZTS). Questa sostituirà e comprenderà, superandone i limiti, l’attuale Zona a Traffico Limitato
22
figura 1Ipotesi di ZTS a Perugia.
in blumetropolitana automatizzata
in verdetreno-tram
in rossominimetrò
in violaautobus
23
della domanda e l’integrazione dei mezzi di trasporto pubblico con quelli individuali. Per una città come Perugia, caratterizzata da un’estesa area a bassa densità abitativa, la presenza di una zona ZTS incrementa inoltre l’interesse per i servizi innovativi quali autobus a chiamata o car sharing rendendo ancora più sostenibile la mobilità. La zona ZTS consente di concentrare le risorse economiche disponibili per il trasporto pubblico nell’area dove è massimo il beneficio per la comunità e offre al contempo ai cittadini l’opportunità di muoversi più facilmente risparmiando tempo e risorse economiche. Il nuovo passante ferroviario, razionalizzando il percorso ferroviario veloce, rende disponibili i vecchi binari del percorso cittadino della ferrovia e offre così diverse opportunità per realizzare una zona ZTS a Perugia.Una possibile soluzione è illustrata in figura. Le stazioni di Fontivegge, Ponte San Giovanni e la nuova stazione FS di Sant’Andrea delle Fratte costituiscono i tre nodi principali, connessi tra loro mediante collegamenti ad alta capacità e frequenza come il treno-tram. Tra la nuova stazione FS, adiacente all’Ospedale Santa Maria della Misericordia, e Fontivegge è possibile adottare una soluzione di metropolitana automatizzata con treni piccoli e molto frequenti che, abbinata al minimetrò, collegherà con continuità questa importante area al centro storico. Anche chi viene a Perugia
in treno, praticamente nello stesso tempo risparmiato per arrivare alla nuova stazione FS grazie alla variante ferroviaria, può raggiungere Fontivegge, e quindi la stazione centrale del minimetrò, o qualunque altra stazione intermedia (San Sisto, Centova, Capitini, Stadio, Percorso Verde-Ingegneria, Santa Lucia, via Cortonese). Inoltre, con una nuova breve bretella, il treno-tram può collegare la linea FCU tra Sant’Anna e Ponte San Giovanni a Fontivegge e può muoversi in tutte le direttrici che hanno come centro Ponte San Giovanni, servendo un’ampia area che va da Ponte Felcino a San Martino in Campo e dall’Aeroporto San Francesco d’Assisi a Corciano. Le altre zone della ZTS come ad esempio San Marco, Elce, via Settevalli e Monteluce sono collegate alle linee principali attraverso autobus frequenti, o se si vuole attraverso nuove linee di treno-tram. Questo profondo ripensamento della rete dei trasporti pubblici a Perugia non si basa sulla costruzione di grandi opere, ma sulla valorizzazione delle infrastrutture esistenti, integrandole e adeguandole in modo che possano costituire una rete, interconnessa e omogenea, che adotta le soluzioni tecnologiche più contemporanee ed efficienti. Una rete quindi in grado di coniugare efficienza e flessibilità: requisiti fondamentali per sfruttare, anziché subire, il cambiamento continuo, che caratterizza l’epoca nella quale viviamo.
(ZTL). Nella ZTS non è vietato l’uso del mezzo privato, ma l’automobile, nella quasi totalità delle circostanze, risulterà meno pratica e conveniente rispetto alla combinazione di mezzi pubblici rapidi e frequenti con brevi percorsi a piedi o in bicicletta. Il tempo rappresenta un fattore fondamentale nella scelta del mezzo con cui muoversi in città. Le persone debbono avere la possibilità realistica di muoversi nelle diverse zone della città, raggiungendo tutte le destinazioni che scandiscono la giornata quotidiana (uffici, scuole, negozi, ristoranti, luoghi per attività culturali, sportive e ricreative) senza aver bisogno del mezzo privato e senza un incremento dei tempi di spostamento. Un’ampia Zona a Traffico Sostenibile, nella quale sia elevata la qualità del servizio, amplia il bacino d’utenza dei servizi pubblici rendendoli economicamente sostenibili; infatti, anche per chi abita all’esterno della zona ZTS, è allettante la prospettiva di lasciare la mattina il proprio mezzo privato nel parcheggio d’interscambio più vicino e quindi muoversi nella zona ZTS con i mezzi pubblici per riprendere l’auto solo al momento di tornare a casa. La gran parte dell’area a maggiore densità abitativa è compresa nell’area ZTS dove è applicato il modello TOD (Transit-oriented development). Tale modello consente di ottimizzare l’efficacia del trasporto pubblico collegando rapidamente tra loro le zone nelle quali la struttura urbanistica e funzionale favorisce la concentrazione
figura 2Il modello TOD.
26
Il toponimo Sant’Andrea delle Fratte identifica attualmente un recente insediamento suburbano, posto a sud-ovest della città storica di Perugia, urbanisticamente compreso tra le vie Pievaiola e Settevalli1. In età medievale, invece, tale denominazione indicava un nucleo fortificato (castrum Fractarum Sancti Andree), situato in posizione pianeggiante lungo il tracciato della Pievaiola2 e classificato amministrativamente sotto il contado di porta Santa Susanna che, insieme a quello di porta Sant’Angelo, era tra i cinque della città più ricco di insediamenti rurali, tanto da comprendere 67 ville e 16 castelli3. Attestato già nella più antica documentazione del Comune di Perugia, l’insediamento di Sant’Andrea delle Fratte è dapprima indicato come villa4 e la prima menzione come comunità organizzata risale al 12585. All’epoca, inoltre, la zona comprendeva anche le comunità facenti capo a villa Sancti Sosti (attuale San Sisto) e villa Lacognani (attuale Lacugnano).Un antico castrum fortificato a pianta quadrata, con muro di cinta e torri d’angolo, peraltro parzialmente giunto fino ai giorni nostri, era l’abitato più
L’area di Sant’Andrea delle FratteSimone Bori, Valeria Menchetelli
rappresentativo della zona, identificato dal toponimo Castello6; a questo si aggiungevano una serie di abitazioni sparse, in cui risiedeva la popolazione dedita alle attività agricole, e una chiesa parrocchiale (parrochialis ecclesia Sancti Andree de castro Fractarum7), di cui si hanno notizie a partire dal Trecento8, ubicata qualche centinaio di metri al di fuori dell’area murata, in corrispondenza del “trivio dell’antica viabilità”9. Nell’anno 1380, per la prima volta, l’insediamento in questione viene classificato nelle Riformanze come castrum Fractarum Sancti Andree10: non a caso Alberto Grohmann utilizza questa data come terminus post quem rispetto alla murazione dell’insediamento11. Sebbene ancora nel Quattrocento nelle fonti catastali la denominazione dell’insediamento oscilli fra castrum e villa12, appare particolarmente rilevante dal punto di vista delle vicende storiche e materiali dell’insediamento il verbale della seduta consiliare del 18 aprile 1408, nella quale si delibera l’exgravatio castri Fractarum Sancti Andree da parte del Comune di Perugia13.La condizione insediativa descritta si mantiene immutata, seppure con fisiologiche trasformazioni ed espansioni, dal Trecento fino a tutto l’Ottocento. Ciò è confermato sia dalla documentazione catastale più risalente, laddove la comunità di Sant’Andrea delle Fratte risulta allibrata tanto nei Catasti del I gruppo14 (impiantati alla metà del
27
Trecento e aggiornati per buona parte del secolo successivo) quanto in quelli del II15 (impiantati a partire dal 1470 e aggiornati fino agli inizi del Seicento), sia dai catasti geometrico-particellari, Chiesa prima (da cui risulta che la comunità di Sant’Andrea delle Fratte confinava con quelle di Boneggio, San Sisto, Lacugnano, San Mariano, Castel del Piano e Pila)16 e Gregoriano poi (che evidenzia la conformazione degli edifici costituenti il castello)17. Dall’analisi dei catasti storici novecenteschi si evince invece l’evoluzione dei progressivi ampliamenti che configurano l’assetto attuale del complesso insediativo.Nell’Ottocento, l’evento che inizia ad alterare gli equilibri dell’area è
rappresentato dalla realizzazione della linea ferroviaria che collega Foligno a Terontola, inaugurata nel 1866, e che compie un’ansa del suo tracciato proprio in corrispondenza del limite nord della zona di Sant’Andrea delle Fratte. Le potenzialità logistiche di questa infrastruttura si pongono alla base del trasferimento della fabbrica Perugina, avvenuto tra il 1961 (acquisizione dell’area) e il 1963 (inaugurazione del primo reparto) dall’area di Fontivegge all’area di San Sisto18. Questo evento porta necessariamente alla ridefinizione urbana dell’intera area, in cui l’abitato di San Sisto si trasforma da territorio rurale a quartiere residenziale, mentre quello di Sant’Andrea delle Fratte si riconverte a
zona industriale e produttiva.L’evento legato a questo mutamento così importante per la città è occasione anche per un ripensamento del futuro dell’intera area. Ed è proprio in questa occasione, in particolare durante la redazione della variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del 196219, che vengono ipotizzati sia la rettifica della linea (in gergo noto come “drizzagno”), che avrebbe accorciato le distanze ferroviarie tra Foligno e Terontola di ben 9 km oltre che alleggerito il traffico merci da Fontivegge per attestarlo tra San Sisto e Ponte San Giovanni, sia un raccordo autostradale di penetrazione verso la città storica.Con l’espansione della città attuata secondo le indicazioni riportate nel
PRG comunale e nelle varianti allo stesso susseguitesi nel tempo20, l’area su cui insistevano l’antico castello di Sant’Andrea delle Fratte e i relativi agglomerati rurali è stata inglobata in un contesto urbano caratterizzato da capannoni che, tra gli anni settanta e metà degli anni novanta, ospitavano aziende dedite alle attività industriali e produttive.Sul finire degli anni sessanta, inoltre, nell’area di Sant’Andrea delle Fratte viene prima prevista e poi intrapresa la realizzazione del nuovo Polo Unico Ospedaliero di Perugia (un tempo denominato Silvestrini e oggi Santa Maria della Misericordia) che contribuisce allo sviluppo insediativo e, con esso,
alla progressiva congestione delle aree limitrofe21, anche in conseguenza del completamento dell’area ospedaliera avvenuto con la realizzazione del complesso universitario dei dipartimenti dell’area medica (e dei relativi servizi per gli studenti) inaugurato nel 2010 a seguito del trasferimento imposto dalla trasformazione dell’area di Monteluce. Sempre nello stesso periodo inizia l’insediamento del quartiere residenziale di Case Nuove, pensato come ampliamento strutturato dell’edificato storico presente in forma sparsa nelle vicinanze di Ponte della Pietra. Un insediamento dall’impronta urbana razionale, come dimostrato dalle giaciture della viabilità interna di servizio, e caratterizzato architettonicamente da palazzine, villette e servizi di quartiere, sia pubblici che privati.Dal punto di vista infrastrutturale, inoltre, all’inizio degli anni Duemila, seguendo in superficie il tracciato del prefigurato bypass ferroviario ipogeo, nell’area è stata realizzata una nuova viabilità su gomma (viale Vittorio Trancanelli), che collega l’area di San Sisto a via Settevalli e da cui si stacca, in corrispondenza di una rotatoria posta circa a metà del percorso, un ramo stradale che consente un più razionale accesso alle zone destinate a parcheggio del Polo Unico Ospedaliero. Nello stesso punto, ma in direzione opposta, il tracciato è stato predisposto, inoltre, per ospitare l’innesto della viabilità di collegamento
28
che dovrebbe raggiungere il cosiddetto Nodo Perugia ovvero la variante stradale al raccordo autostradale Perugia-Bettolle che, aggirando la città, collega direttamente Ponte San Giovanni a Corciano.Viale Trancanelli si delinea quindi come nuovo asse di collegamento pensato per la città del prossimo futuro, ma al contempo anche come nuovo limite dell’area di Sant’Andrea delle Fratte. La sua posizione planoaltimetrica, infatti, ha interrotto fisicamente la continuità dei luoghi introducendo inoltre un ribaltamento della percezione consolidata nel tempo. Su questa nuova strada si sono venute ad affacciare quattro macroaree, precedentemente
contigue, fortemente eterogenee sia per destinazione che per caratteristiche figurative (l’area agricola degli orti e delle villette sparse, l’area residenziale di Case Nuove, l’area commerciale-produttivo-industriale di Sant’Andrea delle Fratte e l’area, non ancora attrezzata, destinata, in caso di calamità, a spazi per la protezione civile) che sono state collegate pedonalmente attraverso una pista e un cavalcavia ciclopedonale. In particolare, le facciate dei capannoni originariamente concepite come retro, in questa nuova prospettiva divengono improvvisamente nuovi fronti comunicativi dell’intera area, suggerendo la necessità di una revisione figurativa generale. L’immagine delle architetture che affacciano sull’intero
passante dovrebbe mutare anche in virtù delle variate esigenze delle attività insediate nell’area, che sono ora prevalentemente dedicate alle attività di servizi e terziarie.
1 cAvAllucci 1990.2 Una delle cinque strade maestre che solcavano il contado perugino. Cfr. cAlDeroNi 1983.3 Così risulta dall’analisi del primo degli elenchi completi delle località del contado perugino, compilato dagli ufficiali comunali nel 1282, cfr. grohMANN 1981, pp. 672 e 677.4 La villa, a differenza del castello, era un insediamento rustico privo di cinta muraria e fossati, con nuclei di popolazione legati alla produzione agricola su piccoli appezzamenti di terreno che coltivavano in posizione di rigida sudditanza. La villa non disponeva infatti di terre collettive e, in caso di guerra, gli abitanti dovevano rifugiarsi nel più vicino castello, al quale dovevano fare riferimento anche in materia giudiziaria. 5 Dal Libro dei bailitori o sindaci e procuratori dei castelli, delle ville e dei luoghi del contado di Perugia (ASPg, Giudiziario, Podestà, 1258, cc. 380r-415r) si desume infatti che tra i rappresentanti delle ville e dei castelli del contado perugino che si presentarono davanti al Podestà Rolando de Guidis Bovibus
di Parma o ai suoi giudici per farsi registrare nel libro del Comune compariva anche il sindaco della comunità di villa Sancti Martini et Sancti Andree de Fratis.6 grohMANN 1981, p. 971. Cfr. inoltre ASPiPg, CM 296, Memorie istoriche de castelli e ville del territorio di Perugia raccolte da Annibale Mariotti. Porta Santa Susanna: “Castello internamente quasi tutto diruto e del quale rimane di intero il solo circondario delle mura, di forma quasi quadra, con due torri, distante tre miglia da Perugia tra Ponente e Mezzogiorno” (p. 71).7 ASPg, Corporazioni religiose soppresse, Santa Giuliana, Pergamene, 128. La pergamena è data 18 giugno 1496.8 Cfr. grohMANN 1981, p. 814 e nota 816.9 cAvAllucci 1990, p. 2510 ASPg, ASCPg, Consigli e riformanze, 28, c. 135r: il 31 agosto 1380, infatti, i Priori delle Arti deliberano quod describantur hic omnia castra, omnes ville et omnia loca que quomodolibet reperiuntur nunc esse aut esse debere in comitatu et districtu civitatis Perusii (c. 134v), come risulta dall’elenco stilato porta per porta dal notaio Simone di ser Giacomo di Perugia.11 “La murazione deve essere stata effettuata nella seconda metà del Trecento, prima del 1380”, grohMANN 1981, p. 971.12 Cfr. Grohmann, che classifica i castelli del contado perugino in quattro sezioni: “toponimi che nella documentazione reperita appaiono sempre citati come castelli”; “centri che vengono indicati nella documentazione più antica come villa e successivamente come castello”; “insediamenti che appaiono prima qualificati come castello e poi come villa”; “località in cui la specificazione villa e castello appare in modo alternativo nella documentazione, indipendentemente dalla presenza o meno di una cinta muraria” (ivi, p. 915).13 Dal preambolo della riformanza risulta infatti che gli uomini del castello di Sant’Andrea delle Fratte avevano inviato una supplica al Luogotenente ducale, ai Priori e ai Camerari delle Arti volta a ricevere una qualche exgravatio focularis et aliorum gravaminum da destinare all’innalzamento della torre del castello, già cominciata. Il 18 aprile 1403
29
la supplica viene accolta con delibera positiva; ASPg, ASCPg, Consigli e riformanze, 48, c. 57r.14 ASPg, ASCPg, Catasti, I Gruppo, 63. Il registro contiene gli allibramenti dei residenti nei seguenti insediamenti del contado di porta Santa Susanna: castelli di Agello e San Mariano, ville di Lacugnana, San Sisto, Calcinara, San Manno, Bisciano, Fibille, Fratte di Sant’Andrea, Monte Frondoso, Valiano di San Fiorenzo.15 ASPg, ASCPg, Catasti, II gruppo, 65. Il registro contiene gli allibramenti dei residenti nei seguenti insediamenti del contado di porta Santa Susanna: castelli di Mugnano, Montale e Fratte di Sant’Andrea, ville di San Sisto e Lacugnana.16 ASPg, UTE, Catasto Chiesa, Mappe catastali, 75; Ivi, Mappe catastali ridotte, 282.17 ASPg, UTE, Catasto Gregoriano, Mappe catastali, 63, foglio XI.18 cAvAllucci 1990, pp. 41-61.19 ANtiNoro et alii 1993, pp. 116-117.20 Ivi, pp. 103-141.21 cAvAllucci 1990, pp. 65-83.
30
Il progetto MUTA Perugia prende spunto dall’accezione che oggi riveste la stazione ferroviaria, crocevia di culture e funzioni, e ha per idea base quella dell’integrazione stratificata di diversi sistemi di mobilità. In particolare, la mobilità ferroviaria nel livello ipogeo, quella pedonale al livello del parco lineare posto alla quota attuale del terreno, quella su gomma che ricalca l’attuale viabilità e quella del minimetrò al livello più elevato.L’area su cui pone l’attenzione il progetto è concentrata nel tratto posto a contatto tra la zona produttivo-commerciale (Sant’Andrea delle Fratte) e la zona residenziale (Case Nuove). Un parco lineare, che si sviluppa in direzione sud-nord e che proviene idealmente dall’area posta a sud del comparto di Sant’Andrea delle Fratte che presenta ancora i caratteri tipici del paesaggio rurale, disarticola i capannoni esistenti concentrandoli in un unico corpo di fabbrica (di cui diventa anche copertura verde praticabile). Tale architettura complessa è caratterizzata da una torre-landmark destinata a parcheggi (tradizionali nella parte basamentale e automatizzati nella restante parte), da un edificio ponte, che ospita attività di co-
MUTA PerugiaSimone Bori
working, di design, di artigianato-artistico e da un edificio di testata che funge da collettore dei sistemi di comunicazioni orizzontali e verticali di collegamento sia da e per la torre-parchegio sia da e per la stazione. In particolare quest’ultima viene raggiunta attraverso un percorso, che fa parte dell’edificio di testata, caratterizzato da rampe, scale e ascensori inclinati, in forma di percorso espositivo in cui viene valorizzata la produzione artistica locale. Tale percorso, inoltre, dalla conformazione complessiva molto articolata viene ipotizzato come rimando concettuale alla molteplicità dei sistemi di viabilità che identificano l’acropoli della città di Perugia. Dallo stesso percorso viene anche garantita la comunicazione con la stazione del minimetro pensata come terminal di una nuova linea che, passando in adiacenza al Polo unico Ospedaliero, si connette alla stazione di Fontivegge attraversando il tratto cittadino di via Settevalli.Il progetto prevede anche una via ferroviaria utilizzata come metropolitana di superficie alla scala urbana attraverso il recupero del percorso ferroviario tra San Sisto, Fontivegge e Montebello. L’edificio ponte è caratterizzato architettonicamente da una facciata in cui viene estroflessa la parte strutturale costituita da macro-travi reticolari metalliche che fungono anche da filtro per i percorsi pubblici longitudinali. La copertura, inoltre, prevista interamente a verde praticabile come estensione del
31
parco pubblico, è segnata da ampie corti che garantiscono l’illuminazione naturale delle parti poste al centro del corpo di fabbrica. Per ciò che riguarda l’edificio ponte, l’interno è adibito a parcheggio con sistema tradizionale nella parte bassa, rivestita da un carter metallico, e con sistema automatico in quella superiore, che va smaterializzandosi nel rivestimento con il crescere dell’altezza. In particolare nella parte automatizzata le auto, circa mille, sono smistate da una piattaforma centrale costituita da 4 pedane rotanti, divise in due settori semicircolari, che possono raggiungere una rotazione massima di 180° e in cui, grazie a una velocità della pedana di 120 metri al minuto, si può raggiungere un tempo di attesa competitivo pari al massimo a 5 minuti. L’edificio torre quindi, sia per l’altezza raggiunta sia per gli aspetti tecnologici sia per quelli figurativi, assume il ruolo di architettura simbolo dell’intera area presa in esame, configurandosi come un vero e proprio landmark territoriale.
33
MUTA PerugiatutorSimone BoristudentiLaura Marconi, Giulia Pelliccia,Maria Consuelo Taraddei, Laura Urbini
34
Il progetto della nuova stazione ferroviaria è parte di un ragionamento condotto alla scala urbana e territoriale, che ha consentito di individuare gli elementi strutturanti che definiscono la solida armatura capace di supportare il nuovo intervento, anche nel disordine dell’area periferica della città di Perugia. L’insediamento, costituito da tre elementi di grande dimensione che definiscono un impianto a “C”, s’inserisce con precisione tra il rilievo del quartiere di San Sisto, verso il quale si apre, quello del Polo Unico Ospedaliero, che costituisce un saldo ancoraggio, e la vasta area produttivo-commerciale di Sant’Andrea delle Fratte, verso il quale definisce un preciso limite. Oltre alla nuova stazione ferroviaria, che occupa la testata est, gli altri elementi sono un lungo edificio a destinazione terziaria e residenziale verso sud e un’alta torre-segnale posta all’estremità ovest, che indica la presenza del nuovo complesso e che stabilisce una relazione visiva preferenziale con il centro storico della città.Il progetto agisce concretamente sullo spazio fisico partendo soprattutto dalla definizione degli spazi aperti e si sviluppa intorno a un grande parco, che
...e quindi (ri)uscimmoa riveder le stelleAlessandro Bulletti
costituisce il “luogo centrale” in grado di conferire identità al contesto. All’esterno dell’insediamento una nuova viabilità perimetrale connette i nuovi edifici con il resto della città e con i principali assi viari. In particolare la stazione ferroviaria, dotata di nuovi parcheggi e del terminal del trasporto urbano, costituisce il luogo dell’interscambio tra i vari sistemi di trasporto pubblico e privato.L’edificio della stazione si pone in maniera ortogonale al di sopra del tracciato interrato del nuovo passante ferroviario, risolvendo al suo interno il dislivello tra la quota della città e quella inferiore delle banchine ferroviarie. È proprio dalla dimensione ipogea che prende avvio l’idea di progetto, immaginando uno spazio continuo scavato all’interno del suolo, definito dalla modularità e dalla ripetizione di una serie di cupole di diversa forma che coprono le banchine sulle quali transitano i viaggiatori. Questa parte dell’edificio è caratterizzata da forme archetipiche, che reinterpretano in chiave astratta la spazialità delle rovine di architetture del passato. È una creazione che rimanda all’atto primigenio e fondativo dell’architettura che assume un valore universale e atemporale. È uno spazio cavo, un vuoto segreto, una realtà concreta caratterizzata dalla consistenza della sua massa monomaterica che fa diventare il vuoto il vero centro del progetto. L’altra componente fondamentale è la luce, che riesce a tenere insieme materia e vuoto.
35
La luce proveniente dall’alto, attraverso i fori praticati sulle volte, agisce sulla consistenza della forma solida e sulle proporzioni della forma cava, facendo in modo che lo spazio interno muti costantemente nel lento trascorrere del tempo. Alla luce zenitale è demandato anche il ruolo fondamentale di guidare i viaggiatori in maniera naturale nel passaggio dal regime di luce molto controllato che caratterizza la dimensione ipogea a quello più intenso del grande atrio al piano superiore. Questo spazio monumentale, che contiene tutti i servizi per i viaggiatori, si apre in direzione ovest verso una nuova piazza lastricata che copre i parcheggi sottostanti e verso il parco. Dall’atrio si raggiunge facilmente il terminal del collegamento metropolitano che connette la stazione con il resto della città, sfruttando il tracciato della preesistente linea ferroviaria. Tale terminal è costituito da una galleria che lo percorre longitudinalmente e che ospita anche le attività commerciali.L’elemento che caratterizza l’edificio anche nella sua parte superiore è la grande copertura, formata da una successione di travi semicircolari risolte a unica campata, che liberano completamente il suolo da ulteriori sostegni. Questo movimento ondulatorio di grande forza plastica avvolge le persone, alternando spazi piccoli e raccolti ad altri più ampi e aperti. Anche l’esperienza dello spazio dell’atrio superiore è caratterizzata dal modo in cui
36
questo si relaziona con la luce zenitale. Vi è l’idea di realizzare un “cielo interiore”, come nelle volte affrescate da Giotto. Le coperture infatti presentano una vasta gamma di fori di luce che introducono all’interno delle vere e proprie “colonne luminose” che raggiungono il suolo e che proiettano riflessi sulla superficie stessa delle volte, generando uno spazio ricco, un’atmosfera capace di ritrovare la natura poetica dell’architettura.
37
... e quindi (ri)uscimmo a riveder le stelletutorAlessandro BullettistudentiElettra Bartolini, Sara Capitanucci, Alessio Mariucci,Marta Mencaroni, Luca Persichini
38
Delocalizzare la nuova stazione di Perugia significa affrontare un’operazione complessa, strategicamente significativa per l’intera struttura della città.Il principio insediativo che il progetto A TtRA VERSO Perugia ha messo in campo nasce dalla consapevolezza che lo spostamento della stazione stessa non può essere immaginato come una semplice risposta a una potenziale fattibilità tecnica/economica, ma occorre considerare soprattutto come un nuovo manufatto così determinante possa e debba condizionare la dimensione urbanistica e architettonica del contesto in cui è insediato. A ben vedere l’area di progetto individuata è un territorio di mezzo che si pone a metà tra l’immediata periferia della città che si sviluppa a nord-est fino al nuovo complesso del Polo Unico Ospedaliero, e tra il tessuto a bassa densità che si sviluppa a sud-ovest fino alla dolcezza dei crinali che defiscono la scena paesaggistica.Questo territorio, cresciuto senza regole lungo i pochi segni ordinatori, deve essere ridefinito da una figurazione complessiva in grado di fornire una nuova identità che ne rappresenti un’occasione di riscatto urbanistico e architettonico.
A TtRA VERSO PerugiaAndrea Dragoni
In base a questo presupposto il progetto cerca di immaginare la nuova stazione come una sorta di parte di città articolata su più livelli, costruita con forme ad alta densità (al di sopra dell’ipogeo piano del ferro) attraverso un sistema di spazi ed edifici che nella loro composizione generale reinterpretano il senso dell’identità di Perugia, avvistabile in lontananza nel suo profilo storico.L’idea è quella di lavorare su di un’area definita e circoscritta il cui sedime è sostanzialmente quello del sotterraneo parco ferroviario con le relative banchine di sbarco, una sorta di grande lingua rettangolare di circa 600x100 metri. Questo spazio è immaginato come una sorta di autonomo pezzo di città, un’enclave urbana il cui ruolo di forte centralità viene enfatizzato da un tessuto denso e compatto che viene solcato da un sistema di vie che riecheggia il tessuto di città storica, innestandosi all’interno del territorio come una parte di città analoga che appare come se fosse sempre esistita. Il disegno di Leonardo della città a molti livelli, chiusa nel suo recinto turrito ma saldamente legata al territorio extra moenia, è stato l’immagine guida del progetto, unità architettonica compiuta, formata da un’aggregazione di manufatti, complessa come una città.Su questa idea di antica città artificiosamente stratificata, si articola al livello del suolo lo spazio della stazione ponte che ospiterà tutti i servizi di
39
supporto ai viaggiatori, insieme a spazi commerciali e al grande parcheggio di sosta a ridosso dei binari, mentre al livello inferiore (alla quota dei binari) l’arrivo dei treni avviene in forma quasi completamente interrata non riuscendo quindi ad avere nessun tipo di rapporto visivo con lo skyline della città. Qui il sistema di elementi strutturali a grande complessità che sorreggeranno tutto l’impalcato soprastante è disegnato con l’intento di enfatizzarne il tema di grande spazio sotterraneo, figurandolo come una sorta di spazio ipogeo etrusco ad evocare il senso dell’identità storica del territorio.Al di sopra del piano della stazione, risalendo attraverso un sistema di collegamenti pubblici e privati, si potrà accedere al grande spazio “urbano” a cielo aperto che, sviluppandosi linearmente, verrà definito e scandito da un sistema di torri che ospiteranno le varie funzioni che faranno parte del nuovo pezzo di città: uffici, residenze, centri diagnostici, residence per studenti, spazi commerciali, residenze protette ecc., garantendo un social mix in grado di far vivere questi spazi con continuità durante tutto l’arco della giornata. Le torri si articolano su due allineamenti: l’uno, verso la città storica, è scandito in pianta e in alzato da un ritmo libero e scompaginato; mentre l’altro si apre verso la campagna secondo un ritmo regolare e ordinato.
41
A TtRA VERSO PerugiatutorAndrea DragonistudentiLaura Barbanera, Laura Becchetti, Giorgia Bellavita, Antonella Ciotti, Giulia Spigarelli
42
Il progetto inTRAMezzoVERDE assume l’ipotesi di rilocalizzazione dell’attuale stazione di Perugia (mediante lo spostamento dalla sede di Fontivegge all’area di Sant’Andrea delle Fratte) come spunto per compiere una riflessione approfondita a scala vasta sul territorio cittadino e sulla configurazione storica dell’assetto viario, al fine di valutare alcune delle possibili conseguenze che un intervento di tale entità potrebbe generare sulla conformazione futura dell’intera città, interpretandone le ricadute come altrettante opportunità.Dopo la realizzazione del Polo Unico Ospedaliero e l’insediamento dei nuovi edifici universitari, l’area di viale Vittorio Trancanelli tradisce con evidenza la propria natura di luogo irrisolto, in cui i percorsi carrabili prevaricano la fruibilità pedonale e lo sviluppo del tessuto abitativo: proprio a causa di queste conflittualità, l’area appare ineludibilmente vocata alla trasformazione in nuovo fulcro urbano. Da tali considerazioni nasce l’idea di inserire un elemento capace di scardinare lo status quo anche in maniera simbolica ed evocativa: il ruolo rigenerante è affidato al treno-tram, strategia capace
inTRAMezzoVERDEValeria Menchetelli,Giacomo Pagnotta
di conferire una forma coerente e unitaria a un’immagine visionaria per l’intera città, che non si limita ad agire esclusivamente in prossimità della nuova stazione, ma che estende la propria area d’influenza fino a coinvolgere un intorno territoriale più ampio, in considerazione delle strette relazioni innescate tra la nuova polarità urbana e il centro storico di Perugia attraverso i sistemi infrastrutturali. Lo spostamento della stazione diviene dunque il pretesto per una riorganizzazione complessiva della rete trasportistica pubblica, che si serve di tre azioni progettuali circoscritte ma sinergiche: il prolungamento del tratto di minimetrò esistente fino alla stazione di Sant’Anna, al fine di stabilire una connessione con le linee della ex Ferrovia Centrale Umbra; il ripristino del tracciato ferroviario dismesso Ellera-Chiusi, al fine di innervare le frazioni a sud-ovest del capoluogo integrandole nel nuovo polo urbano; l’inserimento di un nuovo segmento ferroviario dedicato al treno-tram, al fine di attuare un collegamento diretto con la nuova stazione attraverso via Sandro Penna e al contempo di nobilitare l’area industriale di Sant’Andrea delle Fratte in previsione del suo sviluppo futuro. In tale contesto, il treno-tram diviene simbolo di una mobilità pubblica innovativa, sostenibile e alternativa: un mezzo pubblico che trasporta persone, ma soprattutto un “veicolo di verde urbano” che, riutilizzando la sede dei vecchi binari, si dirama nella città e,
43
come nell’emblematico precedente rappresentato dalla High Line di New York, recupera spazi dimenticati riqualificandoli attraverso un parco lineare.L’ipotesi progettuale si propone di prefigurare lo sviluppo della città in un orizzonte temporale a lungo termine: se infatti la realizzazione di una stazione ha un tempo di ritorno di 40 anni, appare necessario immaginare una città mutata dal punto di vista delle esigenze, delle abitudini e della mobilità. In quest’ottica di complessiva evoluzione urbana si inserisce il progetto della nuova stazione di Perugia, che risente fortemente sia delle preesistenze dell’ospedale e della sede universitaria sia della presenza delle zone residenziale e industriale di Sant’Andrea delle Fratte. Il progetto si propone di affrontare le esigenze connaturate alle destinazioni d’uso previste nello scenario futuro: residenze per studenti, nuovi edifici commerciali, aree verdi pubbliche. In tal senso, il quartiere di San Sisto viene ampliato mediante un sistema di nuove residenze distribuite verso valle e attraverso la riconversione della cesura originaria generata dalla ferrovia in camminamento verde; le aree limitrofe sono previste destinate al potenziamento degli orti urbani (presenti nel territorio perugino in generale e nell’area d’intervento in particolare), che vengono provvisti di “cascine” modulari energeticamente autosufficienti orientate
44
all’ecosostenibilità. Il parcheggio dell’ospedale è previsto ricollocato più a nord al fine di inserire un’ampia zona verde terrazzata che, insieme a quella di Sant’Andrea delle Fratte, ribadisce la presenza e il ruolo del treno-tram.La stazione è concepita come sistema di spazi ipogei, chiusi e aperti, che dalla quota dei binari si sviluppano mediante l’articolazione in rampe, volumi di collegamento attrezzati e risalite verticali, fino a riemergere in superficie. La riconoscibilità esterna è affidata alla imponente copertura semitrasparente, la cui forma organica, attraverso il proprio carattere iconico, assurge a vero e proprio landmark del progetto. Planimetricamente il complesso della
45
stazione è racchiuso in una geometria rettangolare, orientata parallelamente al passaggio dei cinque binari previsti, e comprende una piazza ipogea al livello dei binari (che ospitano i servizi dedicati ai viaggiatori e le gallerie commerciali), tre volumi stereometrici di forma lineare (che includono ulteriori servizi, negozi e market) e un corpo cilindrico posto in superficie (che accoglie la caffetteria). La connessione tra gli spazi ipogei della stazione e la quota di superficie è garantita dai tre volumi fuori terra che, in maniera diversificata, la collegano non solo con l’area del Polo Unico Ospedaliero, ma anche con l’area di Sant’Andrea delle Fratte, attraverso una passeggiata sospesa che punta verso
Castel del Piano proiettandosi in direzione della futura espansione urbana.Il progetto della nuova stazione di Perugia nell’area di Sant’Andrea delle Fratte impone necessariamente una riflessione d’insieme e rappresenta un’occasione per ripensare la città nell’ambito di una visione unitaria, che trova il proprio elemento di ricucitura nel treno-tram, sistema verde di trasporto pubblico capace di trasformare un sistema di “non luoghi” autoreferenziati e sottoutilizzati in una rete interconnessa di spazi di socialità, da cui la città trae linfa vitale.Lo spostamento della stazione diviene un vero e proprio spostamento della città.
inTRAmezzoVERDEtutorValeria Menchetelli, Giacomo PagnottastudentiGianluca Grazieschi, Danilo Morosi, Gloria Palombi, Sabina Sellitri
47
Lo sviluppo del capoluogo umbro nell’ultimo lustro1 fa emergere un’importante variazione del baricentro urbano che, spostandosi dapprima verso la stazione e poi lungo i due assi della Cortonese e della Pievaiola, ha portato a una conurbazione con il territorio amministrato dal Comune di Corciano storicamente sempre legato a Perugia2. In particolare l’abitato di San Mariano3, a cavallo dei due tracciati citati, nell’ultimo ventennio ha assunto un ruolo nevralgico segnando un’inusuale crescita continua in termini di popolazione4 e, di pari passo, dell’edificazione. Contiguo al raccordo autostradale rivolto verso Firenze, ha la forma urbana disegnata5 dal tracciato ferroviario6 che ne raccoglie l’immagine7, connotato dalla stazione, oggi fuori dalla logica urbana, che venne inaugurata nel 18668 come snodo con il tracciato ferroviario Ellera-Tavernelle9, ideato a inizio Novecento, inaugurato nel 1953, chiuso all’esercizio nel 1960 e dismesso nel 196510.Il disegno del limite11 si correla alla dominante logica della zonizzazione12 che dagli anni ottanta in poi ha portato all’ideazione di quartieri distinti per funzioni. Dalla cima di quello che Crispolti
L’area di ElleraFabio Bianconi, Marco Filippucci
definiva “un sito naturale tutto di scogli e di pietre”13 in conformità alla geologia del territorio14, dal “castello”15 e dalla chiesa16 presenti già nelle elencazioni del 128217, l’aggregato urbano si è espanso attraverso lottizzazioni residenziali concentrate (in particolare i quartieri Girasole18 e Parco dei Tigli), antitetiche rispetto allo sviluppo storico19 documentato dalle prime mappe catastali20 e iniziato nell’Ottocento sul versante che giunge alla chiesa di Monticelli21.I rilievi collinari che si ergono sulle valli alluvionali afferenti all’ampio bacino idrografico del fiume Nestore sono sezionati dall’asse del raccordo autostradale22, principale ragione non solo dello sviluppo abitativo, ma anche produttivo e commerciale di poli noti in tutto il mondo23.L’area, infatti, è divisa in due proprio dal raccordo autostradale rialzato, che la ridefinisce24 dall’alto25 in velocità26 quasi come una sua pertinenza27. Da un lato è insediata l’ex sede Ellesse, il cui stabilimento industriale di 9500 metri quadrati28 risale al 196729, caratterizzato dagli splendidi giardini di Pietro Porcinai30 che ne mitigano l’impatto visivo e dal 1984 arricchito dal centro direzionale progettato da Bruno Signorini31; tale complesso è affiancato dal quartiere Il Rigo (progettato da Renzo Piano32 fra il 1978 e il 198233) e dall’aggregato commisto di Ellera34, centro della grande trasformazione dell’ultimo cinquantennio
48
da comune rurale ad area industriale35. Nell’altro versante, separata dall’area residenziale tramite la ferrovia, sorge la fabbrica IGI36, attiva dal 1976 con uno stabile di 11020 metri quadrati37, accanto alla quale nell’aprile del 2001 viene inaugurato il centro commerciale Gherlinda, polo attrattivo fra le prime strutture italiane dedicate esclusivamente all’intrattenimento38.In tale contesto s’inserisce il nuovo insediamento sviluppato da PAC 2000A39, posto in continuità con una porzione di città “che si fa rovina (…) rinnovando la poetica sublime del rudere nonché la seduzione del pittoresco”40. In prossimità dell’ex discoteca Quasar41, il nuovo centro commerciale di 29000 metri
quadrati42 riconfigura le gerarchie urbane ridisegnando una porzione di territorio anche attraverso nuove infrastrutture43, idrauliche e stradali44. È facile prevedere pertanto un’accelerazione del processo di rigenerazione urbana45 della porzione di terreno fra la ferrovia e il raccordo, già destinata ad attività produttive. In tal senso, l’adiacente polo di frantumazione degli inerti46, nato originariamente in un contesto isolato, svela oggi la sua vocazione alla trasformazione, proprio come il contiguo stabilimento ex Sicel (industria di carpenteria metallica fondata da Spartaco Ghini nel 197247 e estesa su 7132 mq48) attualmente in disuso e in progressivo degrado come altre realtà limitrofe49.
L’attrattività del luogo è arricchita da rinvenimenti reperiti durante gli scavi del cantiere50 che hanno portato alla luce resti fossili di mammut, ippopotami e oltre 200 esemplari di vertebrati del Quaternario51, principalmente appartenenti a grandi mammiferi52: per tali testimonianze dell’antico lago Tiberino53, connesse alla genesi dell’attuale configurazione geologica dell’area composta principalmente da calcari tufacei del pleistocene54, è ipotizzata una parziale esposizione nel centro commerciale55.I segni della storia si perpetuano nel tempo, con ritrovamenti56 anche importanti57 collegati a ipotesi sull’antica viabilità della via Amerina58 che si
protraggono dagli anni trenta59 a oggi60, con la correlata centuriazione dei territori in parte sopravvissuta61 e il riutilizzo del tracciato in età medievale62 e all’interno dell’itinerario bizantino63. L’area dove insiste il nuovo centro commerciale, posta in un piano bonificato nel Duecento64, ingloba una struttura a torre, poi trasformata in colombaria65, appartenente alla famiglia perugina Sciri66, proprietari terrieri67 legati alla prospiciente Chiugiana68.Le terre agricole, legate alle origini intorno all’anno 1000 del monastero di Farfa69 e successivamente in mano al ceto magnatizio70 fino al Novecento71, per l’orografia plano-collinare sono denotate da terreni di buona redditività72, ambiti
attrattivi73 di un “paesaggio sistemato” che dal Quattrocento arriva ai giorni nostri74, riconosciuto nel 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale “destinazione turistica d’eccellenza” per il turismo rurale75.Il riconoscimento del valore aggiunto delle qualità ambientali presenti, reso esplicito attraverso la tutela dell’area di monte Malbe classificata come Sito d’Interesse Comunitario (SIC)76, si connette agli sforzi intrapresi dall’Amministrazione Comunale nel tentare di cambiare la rotta della politica sociale77 e ambientale78, condizione che ha portato alla promozione di due proposte nell’ambito del bando europeo LIFE+ nel 201279 e nel 201380. Tali ricerche progettuali si sono interessate dell’ideazione di un polo per la valorizzazione ambientale mediante un parco sensoriale vocato all’accessibilità ubicato fra la ferrovia e l’altura del monte trasformato a bosco urbano. Preservando l’unico versante ancora parzialmente intatto, sormontato da un castelliere81, dall’edificazione di una strada prevista nel Piano Urbano della Mobilità (PUM), la proposta dell’intervento di disetaneità si è poi sviluppata nell’anno successivo in un sistema di corridoi verdi verso il lago Trasimeno tramite la valorizzazione del reticolo idrografico, secondo azioni combinate volte alla conservazione della biodiversità.
49
1 In relazione ai baricentri, sulla pianificazione dello sviluppo residenziale a Perugia nella seconda metà dello scorso secolo, cfr. Astengo 1964, pp. 57-60; M. Coppa, F. Zannetti, G. Grossi, B. Zevi, Piano Regolatore Generale del Comune di Perugia (Decreto del Presidente della Repubblica, 12/11/1958); Comune di Perugia, Secondo Stralcio di Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Perugia (Decreto del Presidente della Repubblica, 29/04/1964).2 Collesi 1990, pp. 1-72.3 San Mariano 2003.4 È interessante, ai fini della comprensione dell’area, evidenziare la crescita della popolazione (che passa da 7726 abitanti nel 1971, a 11123 nel 1981, a 13090 nel 1991, a 15256 nel 2001, a 20255 nel 2011) confrontando in particolare tale dato con il trend di crescita della vicina Perugia, che cresce nello stesso periodo del 25%. Il dato paradigmatico riguarda la crescita di San Mariano, da 2881 abitanti nel 1991 a 7566 nel 2008. BArro, levi 2013, pp. 3-33; sACChi 2008b; BArBieri 2008, pp.
57-61; storelli 2008, pp. 73-78.5 La città contemporanea risulta priva di una forma urbis, che deriva “dalla costante ricerca di una ricomposizione della propria struttura in un disegno a posteriori capace di farla rileggere come un’entità riconoscibile”. Purini 2008, pp. 59-66.6 BiAnConi 2011, pp. 114-115.7 FiliPPuCCi 2012.8 rAnieri 1970, p. 147.9 CioCi 1986.10 Decreto del Presidente della Repubblica n. 675, 12/04/1965.11 Sul rapporto fra il limite e l’esigenza di determinare unità distinte cfr. Arnheim 1993, p. 77; sulla città “per parti e non per pezzi” cfr. AlexAnder 1967.12 BArAttuCCi 2013.13 CrisPolti 1648, p. 198.14 BoilA 2003.15 CruCiAni 2003.16 Brozzi, FiAndrini 2003, pp. 85-92.17 grohmAnn 1981, p. 952.
18 Da notare come originariamente la massima espansione del quartiere prevedeva 1000000 metri cubi, ridotta dal PRG del 2007 a 740000 metri cubi. Piano Regolatore Generale del Comune di Corciano (Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Corciano n. 183, 28/10/2003).19 Collesi 1990, pp. 85-101.20 ASPg, UTE, Catasto Chiesa, Mappa di San Mariano, Centro storico (1729); ASPg, UTE, Catasto Gregoriano, Mappa di San Mariano, Centro storico (metà sec. XIX).21 Brozzi, FriAndini 2003, pp. 92-94.22 Decreto Ministeriale 10/03/1971.23 rAsPAdori 2008, pp. 114-119.24 BiAnConi 2011, pp. 17-29.25 lynCh 1985.26 APPleyArd, lynCh, myer 1964.27 soletti 2002.28 Alla sua edificazione lo stabilimento contava 430 dipendenti, 798 nel 1979 e 903 nel 1982. rAsPAdori 2008, p. 132.29 riCCi 2008.
30 Pietro Porcinai 2002, p. 44; Giardino Ex Uffici ELLESSE s.d., in fondazionevillafabri.org (luglio 2014).31 BelArdi 1987.32 BelArdi 2014; rossi 2012.33 PiAno 2005, p. 44.34 È da evidenziare come il Mulino di Ellera sia attivo dal 1952. Covino 2008, p. 32.35 sACChi 2008a.36 trAvAgliA 1972.37 rAsPAdori 2008, p. 136.38 mAzzAriol 2013, p. 170.39 L’intervento originario era inserito nel Piano attuativo 2006 (Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Corciano n. 84, 19/12/2006) “e precisamente nel Comparto 1C, insisteva su n. 3 lotti di terreno e prevedeva la realizzazione di un unico immobile, suddiviso in 3 unità immobiliari distinte per n. 3 attività commerciali (medie superfici). La superficie edificabile complessiva del comparto era di 19.550 mq con destinazioni CAI (sup. 17.500 mq) ed Fpr (2.550 mq). Le proprietà
erano due: Lotto 1: Butali s.p.a.; Lotto 2 e Lotto 3: Immobiliare campana s.r.l. Nel 2011 la PAC 2000A Soc. Coop., soggetto promotore ed attuatore del Piano attuativo, ha rilevato le proprietà di Immobiliare campana s.r.l., con i relativi titoli abilitativi. La stessa PAC 2000A sta realizzando, nel Comparto 1A un Centro commerciale, nel Comparto 1B due medie superfici e sta procedendo al recupero del casolare nel Comparto 1D. I terreni su cui insiste il Centro commerciale confinano con il Comparto 1a”. Variante in corso d’opera e richiesta revoca delle condizioni ai permessi di costruire N. 1466/2011, N. 1660/2011, N. 1661/2011 area ex Quasar di Ellera-Corciano, 18/04/2013, disponibile online in www.comune.corciano.pg.it (luglio 2014), p. 2.40 Purini 2002, p. 106.41 Da segnalare la sua dismissione nel 1998.42 Il progetto prevede 50 negozi, un ipermercato E. Leclerc Conad con 650 occupati per un investimento di 100 milioni di euro. Il centro adotterà fin da subito i più severi protocolli in termini di ecoefficienza: fotovoltaico, recupero del calore degli impianti interni, combinato con pannelli solari per riscaldare l’acqua, ampio utilizzo della luce naturale, corpi illuminanti a led, e dunque a basso consumo, colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Borrelli 2012.43 Variante in corso d’opera e richiesta revoca delle condizioni ai permessi di costruire N. 1466/2011, N. 1660/2011, N. 1661/2011 area ex Quasar di Ellera-Corciano, 18/04/2013, disponibile online in www.comune.corciano.pg.it (luglio 2014).44 Il Piano Urbano della Mobilità (PUM) 2010 ha apportato modifiche notevoli nel Comparto 1C, nella fascia compresa tra il retro degli edifici e la superstrada. La nuova sistemazione della viabilità e la conseguente modifica dei sottoservizi (fognature, pubblica illuminazione ecc.), sono state recepite dai soggetti attuatori con variante alle opere di urbanizzazione (Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Corciano n. 27, 30/4/2012), e di conseguenza del PRG (Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Corciano n. 28, 30/4/2012). Le opere di urbanizzazione hanno portato a un riassetto della viabilità in conformità
50
con il PUM 2010 e a un completamento della rete di smaltimento delle acque reflue dei quartieri residenziali limitrofi (L’ipermercato che verrà 2011).45 Cfr. Sbardella 2014 (Ikea) e Palmucci 2013 (Decathlon).46 Proprietà della ditta Gradassi.47 rAsPAdori 2008, p. 117.48 Alla sua edificazione lo stabilimento contava 172 dipendenti, 296 nel 1978 e 349 nel 1982. rAsPAdori 2008, p. 132.49 rAsPAdori 2009.50 I primi rinvenimenti sono stati segnalati nell’aprile 2011 dalla dott.ssa Tiziana Caponi, archeologa collaboratrice dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria; è poi intervenuto il supporto scientifico del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Perugia sotto la responsabilità del dott. Marco Cherìn e la supervisione della dott.ssa Maria Cristina De Angelis. Cfr. M. Cherìn, Descrizione campagne in Corciano (PG). Scavo paleontologico, [2013], in www.archeologia.beniculturali.it (luglio 2014).51 Cherìn 2013.52 Cherìn et alii 2012.53 Tali scoperte devono essere messe a sistema con i reperti emersi nel cantiere “ex Lancia De Poi”, sito riferibile al Villafranchiano superiore. Petronio et alii 2003; Argenti 2004.54 PAzzAgliA et alii 2013.55 Borrelli 2012.56 BrusChetti, tromBettA 2002; BrusChetti 2003; BrusChetti, tromBettA 2009; BrusChetti 2013.57 Come il noto carro di San Mariano scoperto nel 1812. von hoCkmAnn 1982; emiliozzi 1997, pp. 207-213; CiPollone 2002; BrusChetti 2003; BrusChetti, tromBettA 2013. 58 mArtinori 1930; Frederiksen, WArd Perkins 1957; CoArelli 2012.59 BAnti 1936, pp. 123-127; PAoletti 1933.60 tromBettA 2002, CAPoni 2014.61 CAPoni in corso di stampa, a; CAPoni in corso di stampa, b.62 grohmAnn 1981, pp. 653-654.63 menestò 1999; melelli, FAtiChenti 1999, p. 361.64 rigAnelli 1997, pp. 236-238.65 Ivi, p. 255.
66 nuCCiArelli 1989, pp. 135-137.67 grohmAnn 1981, p. 561; rigAnelli 1999, p. 46.68 rigAnelli 1997, p. 94; Collesi 1990, p. 126; ASPiPg, CM 295, Memorie istoriche de castelli e ville del territorio di Perugia raccolte da Annibale Mariotti. Porta Sant’Angelo, pp. 143-144.69 rigAnelli 1999, p. 28.70 Ivi, pp. 76-81. rigAnelli 2003, pp. 71-75.71 Covino 2008, pp. 22-27.72 Ivi, p. 27.73 Quali ad esempio la villa del Colle del Cardinale (BiAnChi 2012) e la pieve del Vescovo (mAnCini 2003).74 rigAnelli 1997, p. 25175 ginetti 2010.76 Area SIC IT5210021 “Monte Malbe”. Deliberazione della Giunta Regionale della Regione dell’Umbria n. 139, 04/02/2005, Linee di indirizzo regionali e disciplinare tecnico per la predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000; Deliberazione della Giunta Regionale della Regione dell’Umbria n.161, 08/02/2010, Piani di Gestione dei siti Natura 2000. Adozione delle proposte di piano e avvio della fase di partecipazione.77 Espressione di tale ricerca è il conferimento al Comune del Prix de l’Europe 2012. Corciano Prix de l’Europe [2012].78 Emblematica a riguardo l’attività del Comune di Corciano per l’Agenda 21 Locale “Corciano21” e il “Patto dei Sindaci per l’Energia e l’Ambiente”. www.comune.corciano.pg.it (luglio 2014).79 ECO-NatA LIFE PARK 2012.80 LIFESCAPE 2013.81 Sito Francovich (Comprensorio 3, Scheda n. 166) individuato al n. 22 della mappa “Aree e siti archeologici”, Delibera del Consiglio Provinciale della Provincia di Perugia n. 27, 14/3/2006, Documento Preliminare per la revisione programmatica in variante del Piano Territoriale di Coordinamento.
51
I contrasti fra edilizia popolare, rivoluzione industriale, preesistenze storiche, città diffusa, infrastrutture e ambiente si condensano nell’area di progetto: un luogo paradigmatico che esprime le sue necessità organiche di attenuare la veemenza dei mutamenti. La geometria, la linea, il tracciato, l’architettura diventano sequenza di spazi nel tempo, premessa, condizione e finalità di una strategia compositiva che così interviene nel tessuto elidendo logiche autoreferenziali di individualità architettoniche.Assumendo come base il futuro assetto dell’area (che comprende il centro commerciale, la stazione con il suo ramo rivolto verso il centro dell’area residenziale, il parco e il bosco urbano) il progetto, nel suo tentativo di riconnettere le diverse parti, può essere letto a partire dal quartiere Parco dei Tigli, collegato mediante un segno forte, che esalta il valore del tracciato ferroviario e che si dirige al percorso pedonale del Girasole, alla biblioteca e alla passerella che presto sarà in costruzione per connettere l’area con il centro commerciale Gherlinda. Il fatiscente centro aggregativo e il campo sportivo posti a valle dell’aggregato
greenmark stationFabio Bianconi, Marco Filippucci
residenziale sono inglobati in uno spazio ipogeo, ricavato grazie alla differenza di quota. Tali ambienti sono così posti in relazione con un nuovo asilo, sovrastato da un parco in continuità con il polo sensoriale che assume la forma del DNA.La connessione fra la residenza e l’area commerciale avviene per mezzo non di un passaggio puntuale, ma di una piastra verde, in virtù ancora del dislivello esistente, sovrastata dalla nuova stazione che vuole emergere per la sua stessa funzionalità, che risulta baricentrica fra i tre lotti e accessibile verso il quartiere anche dalla strada esterna attraverso un parcheggio di interscambio. Teca in vetro posta dentro una teca, la stazione è schermata esternamente con brise soleil in legno disegnati da geometrie frattali, mentre i treni viaggiano al di sotto del livello del piano di camminamento principale.In continuità con il tracciato del ferro si pone la stazione degli autobus, coperta da una piazza discretizzata all’estradosso da gradoni in legno, che digrada fino ad aprirsi sullo snodo centrale giungendo a una sinuosa frattura del terreno che diviene la quinta per esaltare i rinvenimenti paleontologici. Lo spazio semichiuso, sorretto da una foresta di pilastri ad albero che anche nell’ornamento tecnico esaltano l’architettura vernacolare umbra, è affiancato sul lato destro da un centro per la pet therapy, chiaramente legato alla continuità del verde, e sul lato
52
sinistro da spazi tecnici a servizio del retrostante terminal dei bus, centro di interscambio fra trasporto su gomma, su ferro e pedonale, che si apre in forma radiale verso le polarità architettoniche, lungo assi in parte meccanizzati per favorire l’accessibilità. Antipolo della stazione rispetto alla piazza è la torre, struttura tecnologica di un parcheggio meccanizzato che recupera i posti auto, anch’essa disegnata da geometrie frattali attraverso le schermature. La tipologia storica emerge come simbolo del ridisegno di un luogo capace di dominare l’età della macchina, spazio di condensazione e polo identificativo del luogo che si erge per indicare e orientare, in virtù del valore percettivo dal raccordo autostradale su tutta l’area, condizione posta a fondamento delle strategie progettuali. Su tale singolarità verticale si impernia l’asse orizzontale che si incunea fra i volumi esistenti polarizzandoli su una nuova gerarchia, coniugando geometria e natura nel disegno di un paesaggio organico che unisce, come parimenti mostra l’espediente del terrapieno fra i due poli commerciali. La stecca di collegamento è posta su due livelli e presenta lo spazio sottostante sviluppato come un camminamento aperto, predisposto anche per esposizioni, con teche di vetro che fuoriescono come serre dal volume della stecca, che trova alla prua un ristorante che si apre con un belvedere su Chiugiana e monte Malbe,
53
per proiettare lo sguardo verso la storia e l’ambiente. Ispirandosi al modello della High Line di New York e riproponendo la Rambla in un contesto già abituato a “fare un Corso”, un boulevard con corti interne aperte da cui fuoriescono alberi si dispone come una sequenza di piazze in un tracciato che idealmente vuole superare i limiti posti dalle infrastrutture per volgersi verso il territorio.Sul terzo lotto, ipotizzando la demolizione del capannone ex Sicel, un’architettura
ipogea è disegnata da una curva che bilancia le razionali geometrie riproponendo i segni ondulatori del paesaggio naturale che riveste la pelle architettonica. Internamente, riproponendo le forme delle tombe a camera etrusche presenti nel contesto territoriale, si dispongono i magazzini per le merci dei negozi, serviti da un corridoio dove può accedere un eventuale mezzo su ferro al fine di facilitare la connessione con lo stabilimento PAC 2000A di Ponte
54
Felcino. La curva crea una corte che si pone come un giardino segreto, spazio privilegiato su cui si aprono radialmente le stanze di un albergo e da cui parte, come un nastro di Moebius, un camminamento in legno lungo il crinale della lingua verde che connette la piazza all’asse ferroviario e al corridoio di biodiversità che tocca tutte le località del territorio comunale. Gradualmente così il costruito si diffrange nel paesaggio agrario denotato di una sua raffinata qualità, strategia di mediazione e inclusione di quella lava verde e viva che, ricoprendo senza nascondere, vuole aprire il luogo all’uomo.Greenmark station
tutorFabio Bianconi, Marco FilippuccistudentiFederica Baglioni, Lorenzo Baratti, Sofia Catalucci, Ledion Llupo, Caterina Miconi
55
L’ipotesi progettuale Connect Corciano prende le mosse dal fatto che l’intervento commerciale promosso da PAC 2000A è caratterizzato dalla grande scala dimensionale, al pari di altre aree produttive e commerciali che punteggiano l’asse trasportistico che connette il capoluogo umbro con il lago Trasimeno. Ciò negli anni ha enfatizzato la cesura determinata dalle infrastrutture stradale e ferroviaria, amplificandola con una fascia di edificato caratterizzato da una notevole attrattività in termini di utenti ma privo di caratteristiche connettive tra nord e sud. In questo senso nell’area di studio tale fascia isola le pendici collinari in cui si sviluppano i quartieri Parco dei Tigli e Girasole a sud e Chiugiana a nord.Al fine di rammagliare il tessuto urbano nel senso della connessione fisica (accessibilità) il progetto è costituito da tre piastre sorrette da un sistema di setti e pilastri che punteggiano le sistemazioni esterne del nuovo intervento senza comprometterne l’utilizzo, laddove la fluidità spaziale riecheggia gli schizzi di Zaha Hadid per il museo MAXXI a Roma, la volontà inclusivista la stazione Tiburtina a Roma di ABDR Architetti Associati e la tipologia sospesa via
Connect CorcianoLuca Martini
dell’Acquedotto a Perugia. In tal senso la piastra di maggiori dimensioni accoglie i flussi d’accesso pedonali provenienti da nord nei pressi della nuova rotonda prevista su via Antonio Gramsci, permette l’accesso al parcheggio principale dell’area commerciale scavalcando i tracciati stradali, e giunge alla nuova stazione di Ellera-Corciano prima e alle pendici verdi del parco dei Tigli poi. Il percorso si configura come un asse pedonale sopraelevato caratterizzato da piccoli box rivestiti di plexiglas colorato che ospitano spazi commerciali destinati a produzioni locali. Alla stessa quota una piastra più piccola disegna la piazza antistante l’ingresso della nuova stazione di Ellera-Corciano che risulta connessa per mezzo di collegamenti verticali automatizzati con un nuovo parcheggio dedicato e con il piano del ferro. La terza piastra ne segna la copertura e misura le banchine di distribuzione ai treni, che permettono anche l’interscambio con il tracciato treno-tram previsto verso il quartiere Girasole.Al fine di rammagliare il tessuto urbano nel senso della connessione figurativa (iconicità) le piastre si diramano secondo le giaciture proprie del contesto dalle pendici collinari a sud fino al tracciato stradale del raccordo Perugia Bettolle a nord, e segnano gli spazi aperti dell’area commerciale come coperture che configurano spazi di attesa protetti. Allo stesso tempo una texture site-specific multicolore decora le coperture
56
degli edifici commerciali sulla scorta dei Paintings for Satellites di Molly Dilworth, in modo tale da risignificarle come quinto prospetto, dato che risultano osservabili dalla quota delle piastre e dal tracciato sopraelevato superstradale, nonché dalle alture circostanti.Al fine di rammagliare il tessuto urbano nel senso della connessione culturale (sostenibilità) sulla parte ovest dell’area di intervento è ideato un centro di documentazione ambientale previsto come polo didattico, che ospita la ricicleria comunale, aule e spazi direzionali e risulta contrassegnato da una copertura a forma di superficie complessa che svetta sulla piazza antistante la nuova stazione. Allo stesso tempo la volontà di sensibilizzazione alla sostenibilità è ribadita dalle opere d’arte di oggetti riciclati allestite sulla stessa piazza, mentre le radure disegnate nell’area a bosco (pensata per la zona dell’attuale polo di frantumazione degli inerti) sono ideate al fine di ospitare una serie di pale eoliche ad asse verticale e allo stesso tempo come scenario per esposizioni artistiche temporanee, anche perché su di esse si affacciano le bucature composte nella piastra principale. Tali spazi potrebbero configurarsi come scenari complementari al centro cittadino nel periodo dell’Agosto Corcianese, anche al fine di ravvivare le riflessioni mai sopite, in modo particolare in Umbria, sulla musealizzazione della città storica e sull’espansione della città periferica.
57
Poiché appare quanto meno insolito che un contesto ambientale che attrae investimenti commerciali e acquirenti consapevoli rimanga sistematicamente impermeabile a investimenti culturali e utenti colti, spesso artatamente convogliati verso il contesto rassicurante del borgo turistico. Perciò l’intervento proposto intende ridisegnare le connessioni fisiche dell’area al fine di riallacciare quelle trame intellettuali che conferiscono un’identità percepibile a un luogo, in modo tale che si trasformi da semplice spazio frequentato a suggestivo ambiente condiviso.
58
Connect CorcianotutorLuca MartinistudentiGabriele Bartocci, Alberto Brogi, Mattia Mattioli, Marta Mazza, Simone Menichelli
60
La presentazione pubblica Nel pomeriggio del 21 febbraio 2014, presso l’Antiquarium di Corciano, si è svolta la presentazione pubblica degli esiti intermedi del progetto di ricerca. Contestualmente, sono state illustrate da parte degli studenti le proposte progettuali elaborate durante lo svolgimento dei corsi integrati di Progettazione digitale e Laboratorio di Progettazione digitale nell’anno accademico 2013-2014.Al termine della presentazione, le proposte sono state valutate in merito agli aspetti comunicativi dal grand jury, che ha ritenuto di premiare un progetto vincitore e due progetti segnalati secondo le seguenti motivazioni.
progetto vincitore...e quindi (ri)uscimmo a riveder le stelleper la capacità di caricare gli elaborati grafici di significati profondi e di rappresentare in termini emozionali il rapporto dell’uomo con la luce
progetto segnalatoMUTA Perugiaper l’efficacia del ritmo narrativo, sia visivo che musicale
progetto segnalatoConnect Corcianoper la rappresentazione contemporanea e accattivante, capace di esprimere valenze artistiche
62
AlexAnder 1967C. Alexander, Note sulla sintesi della forma, Il saggiatore, Milano 1967
Antinoro et alii 1993E. Antinoro, P. Ceccarelli, L. Di Nucci, R. Rossi, Mezzo secolo di urbanistica. Storia e società della Perugia contemporanea, Protagon, Perugia 1993 (La più grande Perugia)
APPleyArd, lynCh, myer 1964D. Appleyard, K. Lynch, J.R. Myer, The view from the road, MIT Press, Cambridge 1964
Argenti 2004P. Argenti, Plio-Quaternary mammal fossiliferous sites of Umbria (Central Italy), in “Geologica Romana”, 37 (2003-2004), pp. 67-78
Arnheim 1993R. Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano 1993
Astengo 1964G. Astengo, Documentazione sull’applicazione della 167. II serie. I piani di zona di: Alessandria, Novara, Novate
Fonti citate Milanese, Gorgonzola, Trieste, Padova, Rovigo, La Spezia, Savona, Piacenza, Arezzo, Prato, Pistoia, Pisa, Perugia, Taranto, in “Urbanistica”, 41 (1964), pp. 25-64
BAnti 1936L. Banti, Contributo alla storia ed alla topografia del territorio perugino, in “Studi Etruschi”, X (1936), pp. 97-127
BArAttuCCi 2013C. Barattucci, Zoning-mixité. Alle radici dell’urbanistica italiana e francese 1870-1945, Officina, Roma 2013
BArBieri 2008G. Barbieri, Modernizzazione economica e trasformazione sociale: alcuni elementi di analisi, in Corciano nella grande trasformazione da comune rurale ad area industriale 1950-1990, a cura di S. Sacchi, Ediesse, Roma 2008, pp. 57-72
BArro, levi 2013M. Barro, G. Levi, Corciano a confronto: 10 anni di trasformazione economico-sociale, Comune di Corciano, 2013, Rapporto di ricerca 24 giugno 2013, disponibile online in www.comune.corciano.pg.it (luglio 2014)
BelArdi 1987P. Belardi, La nuova sede Ellesse presso Perugia, in “L’Industria delle Costruzioni”, 184 (1987), pp. 6-13
63
BelArdi 2014P. Belardi, Il modulo abitativo di Renzo Piano e Peter Rice a Corciano, in NAU Novecento Architettura Umbria, a cura di P. Belardi, Il Formichiere, Foligno 2014, pp. 207-209
BiAnChi 2012La Tenuta Colle del Cardinale. La storia, l’archivio, la cartografia, a cura di A. Bianchi, Soprintendenza Archivistica per l’Umbria, Perugia 2012
BiAnConi 2011F. Bianconi, Tracciati della modernità. L’evoluzione dell’Umbria attraverso un secolo di immagini, Viaindustriae, Foligno 2011
BoilA 2003P. Boila, Geologia del territorio di San Mariano, in San Mariano. Frammenti di storia, Futura, Perugia 2003, pp.13-27
BonAmente 2012Augusta Perusia. Studi storici e archeologici sull’epoca del bellum Perusinum, a cura di G. Bonamente, Editrice Pliniana, Perugia 2012
Borrelli 2012M. Borrelli, All’ex Quasar 50 negozi ed un ipermercato, in “il Giornale dell’Umbria”, 18 luglio 2012, p. 12
Brozzi, FiAndrini 2003M.L. Brozzi, M. Fiandrini, Le strutture
religiose di San Mariano tra medioevo e età moderna, in San Mariano. Frammenti di storia, Futura, Perugia 2003, pp. 85-98
BrusChetti 1993P. Bruschetti, Corciano. Testimonianze archeologiche, Quattroemme, Perugia 1993
BrusChetti 2003P. Bruschetti, Il “territorio” di San Mariano in età antica, in San Mariano. Frammenti di storia, Futura, Perugia 2003, pp. 29-55
BrusChetti 2013P. Bruschetti, Il territorio di San Mariano. Archeologia e popolamento, in I principes di Castel San Mariano 1812-2012. Due secoli dopo la scoperta dei bronzi etruschi, a cura di P. Bruschetti, A. Trombetta, Effe Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 2013, atti di seminario, Corciano 29 settembre 2012, pp. 15-19
BrusChetti, tromBettA 2002Antiquitates. Testimonianze dal territorio di Corciano, a cura di P. Bruschetti, A. Trombetta, Effe Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 2002
BrusChetti, tromBettA 2009Corciano Antiquarium. Guida all’esposizione, a cura di P. Bruschetti, A. Trombetta, Effe Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 2009
BrusChetti, tromBettA 2013I principes di Castel San Mariano 1812-2012. Due secoli dopo la scoperta dei bronzi etruschi, a cura di P. Bruschetti, A. Trombetta, Effe Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 2013, atti di seminario, Corciano 29 settembre 2012
CAlderoni 1983A. Calderoni, Le vie regali e maestre negli statuti perugini, Guerra, Perugia 1983
CAPoni 2014T. Caponi, La via Amerina nel tratto Perugia Chiusi, Sapienza Università di Roma, Roma 2014, Tesi di Dottorato in Topografia Antica, tutor prof. M. Matteini Chiari
CAPoni in corso di stampa, aT. Caponi, Terreni apparentemente centuriati nella pianura di Monte Melino: un caso di studio, in “Thiasos. Rivista di archeologia e architettura antica”, in corso di stampa
CAPoni in corso di stampa, bT. Caponi, The ancient Amerina route in the territory near Perusia: early road system and centuriation, in Landscape Archaeology Conference, in corso di stampa, atti del convegno internazionale, Roma 17-20 settembre 2014, abstract of poster
CAvAlluCCi 1990F. Cavallucci, San Sisto. Da territorio a
quartiere, Protagon, Perugia 1990 (La più grande Perugia)
Cherìn 2013M. Cherìn, Systematic, paleoecological and biochronological study of some Quaternary mammal faunas from central Umbria (Italy), Università degli Studi di Perugia, Perugia 2013, Tesi di Dottorato in Scienze della Terra, tutor prof. M. Barchi
Cherìn et alii 2012M. Cherìn, R. Bizzarri, N. Buratti, T. Caponi, F. Grossi, T. Kotsakis, L. Pandolfi, F. Pazzaglia, M.R. Barchi, Multidisciplinary study of a new Quaternary mammal-bearing site from Ellera di Corciano (central Umbria, Italy): preliminary data, in “Rendiconti Online della Società Geologica. Italiana”, 21 (2012), pp. 1075-1077
CioCi 1986A. Cioci, Due ferrovie, una storia. Terontola-Foligno, Ellera-Tavernelle, Kronion, Bastia Umbra 1986
CiPollone 2002I carri etruschi di Castel San Mariano, testi a cura di M. Cipollone, Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Umbria, Perugia 2002
CoArelli 2012F. Coarelli, Perugia e la via Amerina, in Augusta Perusia. Studi storici e
archeologici sull’epoca del bellum Perusinum, a cura di G. Bonamente, Editrice Pliniana, Perugia 2012, pp. 101-106
Collesi 1990R. Collesi, Memorie storiche e amministrative del comune di Corciano, Immagine, Corciano 1990
Corciano Prix de l’Europe [2012]Corciano Prix de l’Europe 2012, Comune di Corciano, [2012], disponibile online in www.youblisher.com (luglio 2014)
Covino 2008R. Covino, La grande trasformazione di un comune rurale: il caso di Corciano, in Corciano nella grande trasformazione da comune rurale ad area industriale 1950-1990, a cura di S. Sacchi, Ediesse, Roma 2008, pp. 15-39
CrisPolti 1648C. Crispolti, Perugia augusta descritta da Cesare Crispolti perugino..., appresso gli Eredi di Pietro Tomassi, & Sebastiano Zecchini, Perugia 1648
CruCiAni 2003V. Cruciani, Il Castello di San Mariano dopo la ricostruzione trecentesca, in San Mariano. Frammenti di storia, Futura, Perugia 2003, pp. 109-121
de ruBertis 2002La città rimossa. Strumenti e criteri per
64
l’analisi e la riqualificazione dei margini urbani degradati, a cura di R. de Rubertis, Officina, Roma 2002
emiliozzi 1997Carri da guerra e principi etruschi, a cura di A. Emiliozzi, L’erma di Bretschneider, Roma 1997, catalogo della mostra, Viterbo 24 maggio 1997-31 gennaio 1998
FiliPPuCCi 2012M. Filippucci, Dalla Forma Urbana all’immagine della città. Percezione e figurazione all’origine dello spazio costruito, Sapienza Università di Roma, Roma 2012, Tesi di Dottorato in Scienze della Rappresentazione e del Rilievo, tutor prof. Roberto de Rubertis
Frederiksen, WArd Perkins 1957M.W. Frederiksen, J.B. Ward Perkins, The Ancient Road Systems of the Central and Northern Ager Faliscus (Notes on Southern Etruria, 2), in “Papers of the British School at Rome”, 25 (1957), pp. 67-203
ginetti 2010N. Ginetti, Nuovo riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Corciano - destinazione turistica europea d’eccellenza, [Corciano] 2010, comunicato stampa del 10 luglio 2010, disponibile online in www.comune.corciano.pg.it (luglio 2014)
grohmAnn 1981A. Grohmann, Città e territorio tra Medio Evo ed età moderna (Perugia, secc. xiii-xiv), I, La città, II, Il territorio, Volumnia, Perugia 1981, II
ECO-NatA LIFE PARK 2012ECO-NatA LIFE PARK_the green for all as strategy for reconnecting urban places in Corciano (PG), 2012, proposta LIFE12 ENV/IT/001112, Comune di Corciano (beneficiario coordinatore), Regione dell’Umbria, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, responsabile scientifico e coordinatore del progetto: ing. Marco Filippucci
L’ipermercato che verrà 2011L’ipermercato che verrà, in “Corciano Note”, 3 (2011), p. 21
LIFESCAPE 2013LIFESCAPE: biodiversity linear structure as strategy of connection and preservation of the common landscape in Umbria, 2013, proposta LIFE13 BIO/IT/001423, Comune di Corciano (beneficiario coordinatore), Regione dell’Umbria, Università degli Studi di Perugia, Direzione Regionale dei Beni Culturali, WWF progetti e ricerca, LIPU, Ufficio Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato, responsabile scientifico e coordinatore del progetto: ing. Marco Filippucci
lynCh 1985K. Lynch, L’immagine della città, Marsilio, Venezia 1985
lynCh 1990K. Lynch, Progettare la città. La qualità della forma urbana, ETAS libri, Milano 1990
mAnCini 2003Pieve del vescovo. Una residenza fortificata nel territorio di Perugia, a cura di F.F. Mancini, Edilprom, Perugia 2003
mArtinori 1930E. Martinori, Via Cassia (antica e moderna). E le sue deviazioni Via Clodia, Via Trionfale, Via Annia, Via Traiana Nova, Via Amerina, Tipografia SAPE, Roma 1930
mAtteini 2004Pietro Porcinai. Architetto del giardino e del paesaggio, a cura di M. Matteini, Electa, Milano 2004
mAzzAriol 2013R. Mazzariol, Demalling come opportunità di rilancio dell’offerta locale. Un progetto di riuso per il multiplex dismesso di Muggiò (MB), Politecnico di Milano, Milano 2013, Tesi di Laurea Specialistica in Architettura, relatore prof. Luca Tamini
melelli, FAtiChenti 1999A. Melelli, F. Fatichenti, Evoluzione e condizioni attuali dell’ambiente naturale
e antropogeografico del “corridoio Bizantino” (settore umbro), in Il corridoio bizantino e la via Amerina in Umbria nell’alto Medioevo, a cura di E. Menestò, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, Spoleto 1999, pp. 319-366
menestò 1999Il corridoio bizantino e la via Amerina in Umbria nell’alto Medioevo, a cura di E. Menestò, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, Spoleto 1999
nuCCiArelli 1989F.I. Nucciarelli, Perugia e le sue torri viste da un filologo, in F. Roncalli di Montorio, U. Nicolini, F.I. Nucciarelli, Mura e torri di Perugia, Istituto Italiano dei Castelli, Roma 1989, pp. 79-153
PAlmuCCi 2013S. Palmucci, Decathlon, passi avanti per il progetto, in “il Giornale dell’Umbria”, 10 dicembre 2013, p. 12
PAoletti 1933A. Paoletti, Perugia. Delimitazione del territorio archeologico, in “Bollettino della Regia Deputazione di Storia patria per l’Umbria”, I-II-III (1933), pp.119-142
PAzzAgliA et alii 2013F. Pazzaglia, M.R. Barchi, N. Buratti, M. Cherìn, L. Pandolfi, M. Ricci, Pleistocene calcareous tufa from the Ellera basin (Umbria, central Italy) as a key for an integrated paleoenvironmental and
tectonic reconstruction, in “Quaternary International”, 292 (2013), pp. 59-70
Petronio et alii 2003C. Petronio, P. Argenti, C. Caloi, D. Esu, O. Girotti, R. Sardella, Updating Villafranchian molluscs and mammal faunas in Umbria and Latium (Central Italy), in “Geologica Romana”, 36 (2003), pp. 369-387
PiAno 2005R. Piano, Giornale di bordo, Passigli, Firenze 2005.
Pietro Porcinai 2002Pietro Porcinai architetto del giardino e del paesaggio, Centro Stampa Provincia di Perugia, Perugia 2002, atti del ciclo di seminari sulla figura e sulle opere: 30 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo 2001
PisAni 2004Signorini architetture, a cura di M. Pisani, Librìa, Melfi 2004
Purini 2002F. Purini, La fine della città, in La città rimossa. Strumenti e criteri per l’analisi e la riqualificazione dei margini urbani degradati, a cura di R. de Rubertis, Officina, Roma 2002, pp. 105-116
Purini 2008F. Purini, Attualità di Giovanni Battista Piranesi, a cura di G. Neri, Librìa, Melfi 2008
65
rAnieri 1970U. Ranieri, Perugia della bell’epoca 1859-1915, Volumnia, Perugia 1970
rAsPAdori 2008P. Raspadori, Storie di imprese, in Corciano nella grande trasformazione da comune rurale ad area industriale 1950-1990, a cura di S. Sacchi, Ediesse, Roma 2008, pp. 105-145
rAsPAdori 2009P. Raspadori, Ascesa e declino del quarto capitalismo in un’area periferica dell’economia italiana: imprenditori e sviluppo economico a Corciano (1960-1990), in Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII-XX), a cura di F. Amatori, A. Colli, Egea, Milano 2009, atti del 6o convegno della Società italiana degli storici dell’economia, Milano 14-15 novembre 2008, pp. 346-374
riCCi 2008G. Ricci, Ellesse. Storia di un mito del made in Italy raccontata dai suoi protagonisti, Guerra, Perugia 2008
rigAnelli 1997G. Riganelli, Vicende insediative e assetto del territorio nell’età di mezzo. Una ricerca sull’attuale comune di Corciano, Effe Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 1997
rigAnelli 1999G. Riganelli, L’economia rurale nel
Medioevo. Un’indagine sulle comunità dell’attuale territorio di Corciano, Effe Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 1999
rigAnelli 2003G. Riganelli, Una comunità rurale nell’età di mezzo, in San Mariano. Frammenti di storia, Futura, Perugia 2003, pp. 57-75
rossi 2012C. Rossi, Corciano. Complesso residenziale “Il Rigo” (Renzo Piano, 1978-1982), in Da case popolari a case sperimentali. Un secolo di architettura nell’edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia, a cura di P. Belardi, V. Menchetelli, Effe Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 2012, pp. 191-197.
sACChi 2008aCorciano nella grande trasformazione da comune rurale ad area industriale 1950-1990, a cura di S. Sacchi, Ediesse, Roma 2008
sACChi 2008bS. Sacchi, Imprese e sviluppo locale in un comune satellite del capoluogo regionale: Corciano 1951-2001, in Corciano nella grande trasformazione da comune rurale ad area industriale 1950-1990, a cura di S. Sacchi, Ediesse, Roma 2008, pp. 41-55
San Mariano 2003San Mariano. Frammenti di storia, Futura, Perugia 2003
sBArdellA 2014M. Sbardella, Gli svedesi spiazzano le diplomazie, in “il Giornale dell’Umbria”, 7 marzo 2014, p. 8
soletti 2002A. Soletti, Nuovi metodi di ricerca dell’identità dei luoghi, in La città rimossa. Strumenti e criteri per l’analisi e la riqualificazione dei margini urbani degradati, a cura di R. de Rubertis, Officina, Roma 2002, pp. 161-165
storelli 2008M. Storelli, Dall’agricoltura all’industria: gli assetti territoriali, in Corciano nella grande trasformazione da comune rurale ad area industriale 1950-1990, a cura di S. Sacchi, Ediesse, Roma 2008, pp. 73-103
trAvAgliA 1972D. Travaglia, La I.G.I. di Ellera, in “Nuova Economia”, 5 (1972), pp. 5-10
tromBettA 2002A. Trombetta, Le vie di comunicazione, in Antiquitates. Testimonianze dal territorio di Corciano, a cura di P. Bruschetti, A. Trombetta, Effe Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 2002, pp. 99-104
von hoCkmAnn 1982U. von Hockmann, Die Bronzen aus dem Furstengrab von Castel San Mariano bei Perugia, Beck, Munchen 1982