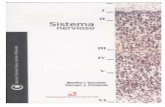L’ornato della collegiata nel quadro della prima arte federiciana
Colture alimentari della Valle del Fitalia
Transcript of Colture alimentari della Valle del Fitalia
G. Alibrandi N. Astone T. Barbagiovanni F. Barberi E. Betel
P. Biscuso P. Bovaro C. Cardaci A. D'Amico T. Fascetto I. FazioT. Gliozzo G. Gregorio L. Leone P. Mancuso G. Martines G. Miraudo
A. Passalacqua A. Pettignano F. Pinzone G. Raffaele G, Restifo B. RotelliS. Schepis A. Sindoni G. Stazzone L. Storniolo C. Teiranova S. Vicario
STORIA DEI NEBRODIa cura di Giuseppe Celona
@carra 7-8-9 agosto 19g6)
atoLegionale Beni Culturali,di Ficarra
EDITRICEPUNGITOPO- liarina di patti
dlimino"diMons.1591 Pag. 109
" (rz.b
" l3l
,' 135
siciliano del 1820
iuuwtguinos rivolta
IU0
" l3g
" 143
ùl l6i ol 1880 ,rffi
" l5l
ùlewimentodel" 157
ttdpimodopguena" 167
" l7g
" lg7
Hti come modello ,, 203
Giuseooe Restifoeolture olimentari della Volle del Fitalia
Ida FazioI contratti dotoli o Capizzi (1790-1826)
Giovanni RaffaeleCriminafitA nei Nebrodi nel 1800
Giangiacomo MartinesPeriferia ortistica
Pag. 215
22t
227
235
T
gy§LP"P-g BF§]I-ES
COLTURE ALIMENTARI DELLA VALLE DEL FITALIA
In una coltura alimentare fondata sul pane, sulle zuppe e pane, sui le-
gumi e il pane, il grano tiene il posto fondamentale sul piano della produ-
zione agricola. Più cresce la popolazione, più si deve estendere la coltiva-
zione granaria, per poterne soddisfare la domanda di nutrimento, precipua-
mente basata appunto sul pane.
Nel '500 in Sicilia la principale coltivazione è quella granaria: i campi
si estendono su gran parte del territorio isolano, si mettono a coltura nuove
terre, si produce a disboscamenti per far largo alla spiga; la spiga mangia
non solo gli alberi, ma anche le pecore, riducendo l'area dei pascoli con una
competetività forse non più conosciuta dall'epoca della dominazione romana,
quando la Sicilia era appunto il granaio di Roma.
Al culmine diluri' trend di ripresa dalla crisi della metà del XIV secolo,
I'Europa si presenta alle soglie del '500 con un forte carico demografico,
con città in espansione, quindi con una fortissima domanda alimentare. Le
città, e non solo quelle europee in generale, ma anche le siciliane come Pa-
lermo e Messina, che hanno scavalcato la soglia delle centinaia di migliaia
di abitanti, diventano il "mercato" per eccellenza della produzione grana-
ria. Centinaia di migliaia di bocche attendono con ansia ogni anno il rac-
colto del frumento: per molti cittadini del XVI secolo un cattivo raccolto
puo significare qualcosa di estremamente grave per la loro stessa esistenza.
A questa pressante domanda la Sicilia tenta di dare una risposta, ma
è meglio precisare i termini per non restare nel vago. In sintesi si potrebbe
dire: i grandi proprietari terrieri siciliani, spinti dal buon andamento dei prez-
zi del grano, si impegnano in trasformazioni agrarie e mettono a colture
anche terre fino ad allora sottratte alla spiga, per aumentare la produzione
e soprattutto l'esportazione. Le aree in cui questo processo si sviluppa con
maggior intensità si possono individuare pressochè in tutta Ia Sicilia, tranne
216 Giuseppe Restifu
che nell'attuale provincia di Messina caratterizzata in generale da una scar-
sa produzione granaria, tranne a sua volta delle brevi enclaves in cui la spi-ga torna vittoriosa sulle colture arboree e sul pascolo.
Nella geografia dei caricatori del grano l'area messinese presenta sol-
tanto due punti: Taormina e Tusa. La loro collocazione nelle parti termina-li è un'ulteriore riprova della non-centralità del Val Demone nella produ-zione del grano siciliano. I Nebrodi si possono far rientrare nel quadro diquesta perifericità produttiva: solo marginalrnente, sull'orlo occidentale incorrispondenza del caricatore di Tusa, si può ipotizzare un surplus di pro-duzione di frumento tale da poter esser commercializzato e pronto per I'e-sportazione. Ciò non vuol dire che non esistesse attività agricola indkizzataverso il grano: può accadere talvolta una sovrapproduzione granaria rispet-
to alle quantità richieste dall'autoconsumo. Un documento dell'archivio diSimancas contenente un "revelo" su "bisogno, mancamento et avanzo de
li frumenti", redatto per il raccolto del 1554, viene corretto da Cancila per
il Val Demone: nel corso dell'operazione lo studioso accenna al fatto che
a Longi "non si verifica mancamento ma avanzo".
Qualche esempio tuttavia di alta produttività non muta il quadro com-plessivo del rapporto fra i Nebrodi, in particolare quelli orientali, e il fru-mento. È chiaro che se gli abitanti di quest'area vogliono mangiar pane,
debbono inserirsi in un circuito di scambio e offrire per il grano sufficientea raggiungere le quantità necessarie per il consumo (sulla base di quello pro-dotto localmente) qualche altro prodotto agricolo.
Oppure (ed è un'altra ipotesi a cui sarebbe appassionante lavorare) si
ritraggono dal circuito di scambio, e più generalmente rifuggono dal parte-
cipare ai processi di per-mutazione in corso su altri grandi spazi. In questo
caso si avrebbe una forzatura della produzione per I'autoconsumo, e nel
complesso una sorta di auto-marginalizzazione o al massimo l'occupazionedi uno spazio interstiziale nel quadro del modello economico cinquecentesco.
Naturalmente si tratta qui di ipotesi, tutte da misurare sui dati realidella produzione e della commercializzazione, sulle specializzazioni produt-tive e sui circuiti monetari, sull'offerta di forza-lavoro in sede locale, sui
suoi eventuali spostamenti, sui suoi comportamenti demografici, sulla con-
sistenza del mercato di consumo locale e sulla domanda proveniente da mer-
cati di consumo non locali. Alcuni dati è possibile derivarli dagli studi già
Colture alimentori della Valle del Frtd'-
esistenti: possiamo qui accemnare -coltura, ma preliminarmente (Eqffi|di cui si parla. La regione dei l{cMmente dal punto di vista eeografudnegli studi odierni in diverse sub{!Éte, sempre alla ricerca di qudl'&riscontrare fra I'alta montagna e lrxte interrotte da crinali e fiumae-
Volendo dunque precisare cr fidiversificazione produttiva" ocoùrcFdei Nebrodi. Una valle ha si:ur-una superficie - per così dire sDoddei quali sono "altre" velli, "rLtitdi collegamento. A proPosito di qt- come è stato più volte sottolincehdelle fiumare siciliane come assifilrvalle e fra i centri della valle stcsrrc'litoranee o da attracchi mariuid; '
Sotto questo profilo la Yah ffmali e l'occasione di un caestrdlila una serie di problemi, Partedciqrin epoca moderna di una comrmll,rche ipoteticamente abbiemo ?fl
Gli attuali centri abitativi oc!ilCaprileone, Castell'Umberto, FraNaso, S. Marco d'Alunzio, S. Sffstono nel '500, non tutti occrpamia una vera e propria storia degli ùdievale e la contemporanea PGr illlÉtati cinquecenteschi. Per omoditl{sume una sua configurazionesol{ne del XIX la vecchia Castanie din un nuovo sito.
Nel '400I'area del FitdiacnÈmontuosa dei Nebrodi. Agli ini' dr
Giuseppe Restifu
in generale da una scar-delle brevi enclaves in cui la spi-
c sul pascolo.
I'area messinese presenta sol-ollocazione nelle parti termina-
del Val Demone nella produ-far rientrare nel quadro di
, sull'orlo occidentale iniptizzare un surplus di pro-
e pronto per l'e-attività agricola indirizzata
ione granaria rispet-Un documento dell,archivio di
mancamento et avanzo deviene corretto da Cancila per
studioso accenna al fatto che
non muta il quadro com-quelli orientali, e il fru-
'area vogliono mangiar pane,coffrire per il grano sufficiente
(sulla base di quello pro-
appassionante lavorare) sirifuggono dal parte-
sr altri grandi spazi. In questoper l'autoconsumo, e nel
o al massimo l'occupazioneeconomico cinquecentesco.
tutre da misurare sui dati realisulle speciali zzazioni produt-
in sede locale, suidemografici, sulla con-
domanda proveniente da mer-
Colture alimentari dello Valle del Filalia
esistenti: possiamo qui accennare alla diversificazione produttiva dell,agri-coltura, ma preliminarmente occorre delimitare in maniera più netta l,areadi cui si parla. La regione dei Nebrodi è tanto composita, anche semplice-mente dal punto di vista geografico-descrittivo, da farla scomporre ancoranegli studi odierni in diverse sub-regioni, o zone, o aree ancora più ristret-te, sempre alla ricerca di quell'elemento di unitarietà che certo non si puòriscontrare fra l'alta montagna e la marina, fra le diverse zone collinari tut-te interrotte da crinali e fiumare.
Volendo dunque precisare con chiarezza un problema, quale quello delladiversificazione produttiva, occorre puntare I'obiettivo su una parte soltantodei Nebrodi. Una valle ha sicuramente un dato unitario: il fatto di essereuna superficie - per così dire speculare - fra due catene di monti, al di làdei quali sono "altre" valli, "altri" fiumi, "altre" vie di penetrazione e
di collegamento. A proposito di quest'ultimo punto, è il caso di ricordare- come è stato più volte sottolineato da studi storici e geografici - il ruolodelle fiumare siciliane come assi di penetrazione e di percorsi all'interno dellavalle e fra i centri della valle stessa e l'esterno, sia esso costituito da stradelitoranee o da attracchi marittimi.
Sotto questo profilo la Vglle del Fitalia presenta caratteeristiche otti-mali e l'occasione di un case-study atto a contenere risposte precise rispettoa una serie di problemi, parte dei quali già enunciata e riguardante la storiain epoca moderna di una comunità, di uno spezzone della società siciliana,che ipoteticamente abbiamo appunto definito "interstiziale".
Gli attuali centri abitativi oggetto della ricerca sono: Capo d'Orlando,Caprileone, Castell'Umb erto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto,Naso, S. Marco d'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, Tortorici. Non tutti esi-stono nel '500, non tutti occupano i luoghi odierni; si dovrebbe procederea una vera e propria storia degli abbandoni e delle fondazioni fra l,età me-dievale e la contemporanea per avere lalocalizzazione esatta dei centri abi-tati cinquecenteschi. Per comodità diremo soltanto che Capo d,Orlando as-sume una sua configurazione soltanto all'inizio del XX secolo e che alla fi-ne del XIX la vecchia Castania cede il posto a Castell'Umberto edificatain un nuovo sito.
Nel '400 l'area del Fitalia era ricca di boschi, così come tutta la catenamontuosa dei Nebrodi. Agli inizi del '500 I'estensione appare ancora intatta,
2t7
derivarli dagli studi già
Giuseppe Restifu
ma in procinto di essere aggredita non solo dall'avanzata della spiga, ma
anche dallo sviluppo crescente dell'industria dello zucchero. Dei due grandi
boschi appartenenti alle Universita del Fitalia, quello di Tortorici e quello
di Naso, il secondo appare più esposto al pericolo di distruzione. Il primo,
essendo più a monte, è in certo senso più salvaguardato dall'aggressione
della produzione industriale dello zucchero e si può ricollegare più facilmente
al discorso sulla pastorizia. Ancora agli inizi del '500I'interno del Val De-
mone, in particolare i Nebrodi appare come un'area di forte resistenza dei
pascoli; sui terreni della montagna, misti di erbe e alberi, si attestano i gros-
si allevatori. Nei boschi soprawivono gli usi comuni, gli uomini delle Uni-versità situate alle quote più alte vi trovano occasioni produttive e opportu-nità per l'autoconsumo.
Nel resto della Sicilia "il disboscamento a favore della cerealicoltura
aveva come conseguenza anche la riduzione dei querceti e quindi degli alle-
vamenti dei suini. Ciò significa riduzione dei grassi animali e necessità diricorrere ai grassi vegetali". Da qui lo sviluppo dell'olivicoltura in determi-
nate zone siciliane, fra cui quella del Fitalia, in corrispondenza peraltro con
tutta I'area mediterranea; alla "domanda ovunque in aumento dei consu-
matori locali e della cucina mediterranea", individuata da Le Roy Ladurie,
seguiva una trasformazione colturale in grado di rispondere. Nel 1503 a Ca-
stania si impianta un trappeto per l'olio, a cura dei domenicani del conven-
to di S. Vincenzo, a ulteriore riprova della capacità di reagire agli stimolidel mercato non solo nel Val Demone in generale, ma anche nella Valle del
Fitalia. Anche in questo caso andrebbe sottolineata l'opportunità di proce-
dere a successive ricerche sulla produzione olivicola, cui processi di lavora-
zione, e soprattutto sulla commercializzazione dell'olio. I risultati conosci-
tivi aggiungerebbero elementi positivi di risoluzione dell'ipotesi anzidetta,
ovvero del ruolo giocato dall'economia e dalla società del Fitalia nel più
vasto ambito della sub-regione nebrodense e della regione siciliana.
Una coltura in espansione e sicuramente non connessa al mercato lo-cale è quella della canna da zucchero, diffusa agli inizi del '500 sulla costa
tirrenica siciliana da Trapani a Naso. Testimonianze della metà del XVI se-
colo affermano l'esistenza tra Partinico e Naso di undici trappeti per lo zuc-
chero: una riprova di duplice segno proviene dalla contabilità di un banco
genovese a Palermo che appunto li rileva nel 1570, ma che nello stesso tempo
Colture alimentari della Valle dcl Fitù
rimarca I'eterodirezione di qucLgper lo più in mano "di mercadic;Pt/i avevano in affitto". Non simdella canna a Naso, ma è certoùtè sviluppata e il traffico fra i Poùbastanza robusto. Un notai,o mricantari di zucchero, 6 dt dituicdi don Giovanni Sollima, barorfi(
La coltivazione e la lavoràcor agli inizi del secolo sucoesfror
il conte di Naso acquista CaPo d't(H
1659 viene registrato un invio c(Épasti sempre da Naso a Paler i INaso era stato Proficuo, anù I t
Quest'ultima sPedizione Pc Idirettrici di marcia della commadrna: si può prefigurare con Trasr:Ilquello di Palermo, e non solo Poqla seta. La zona del Fitalia Pro&llermo già nella seconda mcà dd {se del 1674-78, aPrendo una lin,
Si potrebbe owiare, giàslafcializzazione dei due prodotti sclat
rapporto esistente in età modcrn l
diversificazione produttiva crri dèrcittà, ma le diverse città con cd fiscambio. Un'iPotesi cui Prestareasarebbe meglio dire la Prog€ssincittà siciliana, a partire dalla fudfronti della campagna. L'ipotcihseguenti termini: "la seonda dsenza forza-lavoro, senza immtrnon si impiega, non si sfrutra Évale la pena: si Può sfruttare nct
f.i::::y:._R":!*
dall'avarzata della spiga, mazucchero. Dei due grandi
quello di Tortorici e quelloioolo di distruzione. Il primo,
dall'aggressionepuo ricollegare più facilmente
i dcl '500 I'interno del Val De-m'area di forte resistenza dei
e alberi, si attestano i gros-@muni, gli uomini delle Uni-
ioni produttive e opportu-
a favore della cerealicolturai querceti e quindi degli alle-grassi animali e necessità didell'olivicoltura in determi-
oorrispondenza peraltro conin aumento dei consu-
iduata da Le Roy Ladurie,di rispondere. Nel 1503 a Ca-
dei domenicani del conven-di reagire agli stimoli
ma anche nella Valle delI'opportunità di proce-cui processi di lavora-
dell'olio. I risultati conosci-ione dell'ipotesi anzidetta,società del Fitalia nel più
della regione siciliana.rxln connessa al mercato lo-aCli inizi del '500 sulla costaianze della metà del XVI se-
di undici trappeti per lo zuc-dalla contabilità di un banco
Colture olimentari della Valle del Fitalia
rimarca l'eterodirezione di quelle aziende. I trappeti dello zucchero eranoper lo più in mano "di mercanti e grossi imprenditori, spesso genovesi, che
/i avevano in affitto". Non si conosce la data d'impianto della coltivazionedella canna a Naso, ma è certo che gia a metà del XVI secolo la produzioneè sviluppata e il traffico fra i produttori locali e i mercanti a Palermo è ab-bastanza robusto. Un notaio messinese nel 1553 registra la vendita di 80
cantari di zucchero, 6 di radituri e di miele cotto, 20 di rottami da partedi don Giovanni Sollima, barone di Castanea e maestro razionale del Regno.
La coltivazione e la lavorazione della canna dovevano costituire, an-cor agli inizi del secolo successivo, un investimento attraente se nel 1612
il conte di Naso acquista Capo d'Orlando con il trappeto di Malvicino. Nel1659 viene registrato un invio consistente di pani, rottami bianchi e secondipasti sempre da Naso a Palermo, a riprova che l'investimento del conte diNaso era stato proficuo, anche se non sarà duraturo.
Quest'ultima spedizione pone la necessità di una riconsiderazione delledirettrici di marcia della commercializzazione dei prodotti dell'area nasita-na: si può prefigurare con Trasselli un abbandono del porto di Messina perquello di Palermo, e non solo per quanto concerne lo zucchero, ma anche
la seta. La zona del Fitalia produce anche seta e questa veniva inviata a Pa-lermo già nella seconda metà del '600 e ancora prima della rivolta messine-
se del 1674-78, aprendo una linea commerciale anche allo zucchero.Si potrebbe ovviare, già sulla base della questione posta dalla commer-
cializzazione dei due prodotti seta e zucchero, una direttrice di ricerca sulrapporto esistente in età moderna fra la zona del Fitalia, includendovi ladiversificazione produttiva cui s'è accennato, e la città, intendendo non unocittà, ma le diverse città con cui di volta in volta si intessono relazioni discambio. Un'ipotesi cui prestare enorme attenzione riguarda la capacità, masarebbe meglio dire la progressiva perdita di capacità d'attrazione che lacittà siciliana, a partire dalla fine del'500, è in grado di esercitare nei con-fronti della campagna. L'ipotesi lanciata da Gentil Da Silva è espressa neiseguenti termini: "la seconda metà del '500 vede le città senza industria,senza forza-lavoro, senza immigrazione di forza-lavoro si capisce; perchènon si impiega, non si sfrutta più la forza-lavoro in città? Diciamo, nonvale la pena: si può sfruttare nelle campagne, senza concentrare la massama che nello stesso tempo
220 .Giuseppe Restifu"
dei lavoratori in città, senza arrischiare insomma delle speranze "politiche",cittadinesche. Si può sfruttare: si può mobilizzare il valore senza il concor-so della forza-lavoro, senza produzione, tra I'esportazione delle materie pri-me e il deprezzamento dalla moneta usuale".
Tornando alla questione dello zucchero, la sua storia si chiude attornoal 1680: negli elenchi dei luoghi di produzione figura sempre Malvicino (o
Malivicini, o Malvicini), fin quando nel 1683 la Magna Regia Curia non
si sente dire da tre esperti convocati per esaminare il problema dello zuc-
cherificio dello Stato di Calatabiano "che era più conveniente fare ciò che
era stato fatto anche alla Roccella, a Malvicini, aFicarazzi e in altri trappe-ti, cioè, trasformare i terreni in semineri e risaie". Era finito così uno dei
rami della diversificazione produttiva della bassa Valle del Fitalia.
IDA FAZIO
I CONTRATTI DOTALI A CAPtrX
La posizione delle donne, chcè'cale in cui la produzione sp€tta atE EI'elemento femminile al centro di rsul contesto preso in considerazim,rsessuali e sulle sue conseguenze in r
Prendo in considerazione umùreticolo relazionale messo in aro ddtà. Quello relativo alla trasmissiretzione privilegiato sui gruppi di rqrdeterminante. Gli antropologi: tr-studiando - nelle società europee, -isione e le alleanze matrimoniali. Sclnomia della zappa", per la spÉ, 1t
è la famiglia del marito a pagare rn'può ereditare la proprietà (ed è quil gruppo parentale "spende" $Érltaggiose: si ha dunque un sistema rmico, centrato sulla dote.
Ma allo studio degli apportidcche una descrizione etnografica- Lc r
ve, l'atteggiamento dei singoli riprtprietà mutano col temPo, con lc sùtesigenze di soggeti, gruppi e comtnilnuta attività di definizione dei rryr
Lo studio dei contratti dorali e t
anni '20 dell'Ottocento è utile ad Lsuetudine riscontrata in uno dei d
$["o.Saggi di Giuseppe Alibrandi, NTito Barbagiovanni, FilippoPasqualino Biscuso, Pietro Boyaro, Earlo,Cardaci'Antonino D'Amico, Tommaso fascqàdddlzio, Totò Gliozzo,Gaetano Gregorio, Lucia Leone, Ei*p-iffincuso,Giangiacomo Martines, Giuseppe !§;g!Ub- Achille Passalacqua,
Antonello Pettignano, Francesco Èf,2òffi-Ciovanni Raffaele,
--GiuseppeR"e§!itg,BenedettoRotelli,SalvatoreSchepis,Angelo Sindoni, Salvatore Schepis, Luigi Storniolo, ...,,,.
Cono Terranova, §alvatore Vicario t
a/'
ili.