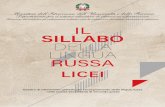Autoritratto del dissidente da giovane. Gli anni della formazione di Ubertino nel primo prologo...
Transcript of Autoritratto del dissidente da giovane. Gli anni della formazione di Ubertino nel primo prologo...
SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCANI
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI FRANCESCANI
UBERTINO DA CASALE
Atti del XLI Convegno internazionale
Assisi, 18-20 ottobre 2013
FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL’ALTO MEDIOEVOSPOLETO
2014
2014
FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDISULL’ALTO MEDIOEVO
SPOLETO
INDICE
Consiglio direttivo della Società internazionale distudi francescani e organi direttivi del Centrointeruniversitario di studi francescani ............ pag. VII
Programma del XLI Convegno internazionale ........ » IX
Relazioni ................................................... » 1
MARCO BARTOLI, Ubertino nella storiografia, e oltre ...... » 3
ANTONIO MONTEFUSCO, Autoritratto del dissidente dagiovane. Gli anni della formazione di Ubertino nelprimo Prologo dell’Arbor vitae ........................ » 27
MARINA SORIANI INNOCENTI, Ubertino da Casale, fer-vens praedicator evangelicae veritatis ............. » 83
CARLOS M. MARTÍNEZ RUIZ, Historia y proceso redac-cional del Arbor vitae ................................... » 113
RICCARDO PARMEGGIANI, Ubertino e lo Spiritus liber-tatis .......................................................... » 149
FRANCESCO VERDEROSA, Ubertino e le fonti francescane ... » 189
PAOLO VIAN, « Noster familiaris solicitus et discre-tus »: Napoleone Orsini e Ubertino da Casale ...... » 217
INDICEVI
ROBERTO LAMBERTINI, Ubertino contro la Comunità:argomenti e posta in gioco ................................ pag. 299
ALBERTO CADILI, L’“enigma” degli ultimi anni diUbertino da Casale ....................................... » 325
SYLVAIN PIRON, La réception de l’oeuvre et de la figured’Ubertin de Casale ....................................... » 403
INDICE DEI NOMI ................................................ » 443
ANTONIO MONTEFUSCO
Autoritratto del dissidente da giovane.Gli anni della formazione di Ubertino
nel primo Prologo dell’Arbor vitae
Il presente contributo propone una nuova ricostruzionedella biografia intellettuale di Ubertino da Casale nel periododella formazione. La fonte quasi esclusiva per tale ricostruzio-ne è una particolare porzione dell’Arbor vitae crucifixae Jesu, ecioè il cosiddetto “Primo Prologo”, così chiamato poiché esso,nella totalità dei testimoni finora consultati dagli studiosi,precede un ulteriore testo anch’esso chiamato “Prologo” edunque definito “secondo” per la sua posizione 1. I due brevi
* Per Emma, venuta alla luce durante le giornate assisane: ti auguro la forza,l’ostinazione e la caparbietà di Ubertino.
Hanno letto versioni parziali di questo saggio, dandomi consigli impagabili,Giulia Barone, David Burr, Jacques Dalarun, Giuliano Milani, Gian Luca Potestà,Sylvain Piron: li riunisco tutti in un unico ringraziamento, ribadendo, ove ve nefosse bisogno, che gli errori sono integralmente imputabili allo scrivente.
1 Ho consultato l’Arbor nell’incunabolo, nella copia conservata alla Bibliothè-que Nationale de France, Paris: HUBERTINUS DE CASALI, Arbor Vitae Crucifixae Iesu,Venetiis, 1485 (d’ora in avanti AV); per il primo prologo (d’ora in avanti 1Pro) hotenuto presenti i seguenti manoscritti: Assisi, Sacro Convento, 328; Città del Vati-cano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4139; Soria, Biblioteca publica delEstado en Soria, 28 H; Toulouse, Bibliothèque Municipale, 224. Ho consultato leversioni parziali in Liège, Bibliothèque du Grand séminaire 6. L. 18; Liège, Biblio-thèque du Grand séminaire 6. N. 1 e Paris, Bibliothèque nationale, 3178. Ho con-sultato anche varie versioni vernacolari italiane, tra le quali in particolare Roma,Biblioteca Vallicelliana, cod. B 131. Le altre opere di Ubertino sono citate dalleseguenti edizioni (se ne ricorderanno i soli titoli): ID., Sanctitati apostolice, ed. F.
ANTONIO MONTEFUSCO30
testi sono notevolmente differenti tra di loro: al secondo pro-logo, che costituisce una sorta di sommario in prosa dell’ope-ra, fa da contrappunto il 1Pro, nel quale prevale nettamente ilracconto autobiografico. Studiando il rapporto tra Ubertino eTommaso d’Aquino, p. Guyot non si limitò a avanzare perprimo la possibilità di una doppia redazione dell’AV, ma rile-vò anche la bizzarria della presenza di un doppio testo di pre-sentazione ipotizzando che il secondo sarebbe stato redattoquando la prima redazione dell’Arbor non era stata ancora con-clusa, mentre il primo sarebbe stato aggiunto una volta com-pletata l’opera sempre nella prima versione 2. Correggendo eprecisando l’ipotesi di Guyot, Martínez Ruiz ha precisamentedatato la seconda redazione al 1326-1329; questa integrale ri-strutturazione testuale è stata preparata per la prima volta inuna “minuta” (il borrador) realizzata tra 1312 e 1316 3. La ri-costruzione andrà messa alla prova del sensibile allargamentodel testimoniale e della sua distribuzione geografica, che sonostati messi in evidenza nel convegno 4. Pur mostrando con
EHRLE, in Archiv für Literatur und Kirchengeschichte, 2 (1886), pp. 377-416; ID., San-ctitas vestra, ed. F. EHRLE, in Ibid., 3 (1887), pp. 51-89; ID., Rotulus iste, ed. F. EHR-LE, ibid., pp. 93-135; ID., Declaratio, ed. F. EHRLE, ibid., pp. 162-195; ID., Reducen-do igitur ad brevitatem in C. T. DAVIS, Ubertino da Casale and his Conception of altissi-ma paupertas, in Studi Medievali, 3a s., 22, 1981, p. 1-56; ID., Super tribus sceleribus,ed. A. HEYSSE, in Archivum Franciscanum Historicum, 10 (1917), pp. 103-174; ID.Tractatus de altissima paupertate (richiamato con l’incipit Ego sum via) in G. L. POTE-STÀ, Ubertini de Casali tractatus de altissima paupertate Christi et apostolorum eius et vi-rorum apostolicorum, edizione critica, in Oliviana [En ligne], 4, 2012, mis en ligne le14 mars 2013, consulté le 17 février 2014. URL : http://oliviana.revues.org/478.
2 B. GUYOT, L’Arbor vitae crucifixae Jesu d’Ubertin de Casale et ses emprunts auDe articulis fidei de saint Thomas d’Aquin, in Studies Honouring Ignatius Brady FriarMinor, New York, 1976, pp. 293-307.
3 C.M. MARTÍNEZ RUIZ OFM, Il processo redazionale dell’Arbor vitae crucifixaeJesu di Ubertino da Casale, in Editori di Quaracchi 100 anni dopo. Bilancio e prospetti-ve. Atti del colloquio internazionale, a c. di A. CACCIOTTI, B. FAES DE MOTTONI, Roma,1997, pp. 275-278.
4 Vedi l’intervento di Sylvain Piron in questo stesso volume.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 31
esattezza (e non vi sarà alcun bisogno di tornarvi su) le corre-zioni apportate al secondo prologo in relazione al processo re-dazionale dell’AV, per quel che riguarda il 1Pro, lo studiosoha riproposto, ma senza sufficiente dimostrazione, l’idea diGuyot: esso sarebbe stato scritto una volta che l’opera era sta-ta completata alla Verna nel 1305 5.
A mio parere, il 1Pro continua a suscitare numerosi interro-gativi. Essi riguardano sia la veridicità degli avvenimenti ivi nar-rati e ricomposti in una sorta di autoritratto ideale, sia l’occasio-ne per la quale quel testo è stato redatto. Ho deciso dunque diindagare più a fondo la questione, mettendo a confronto le infor-mazioni del testo con il percorso “tipico” di un frate studiosodella seconda metà del Duecento, perlomeno nei limiti di quantoè ricostruibile e ipotizzabile per un frate entrato nell’Ordine pocoprima delle Costituzioni di Narbonne del 1260 6. I risultati del-l’indagine comportano due conseguenze importanti. Per quantoriguarda il testo, posso anticipare che alcuni elementi, di caratte-re contenutistico e filologico, mi inducono a considerarlo databilea un periodo seguente la (prima?) redazione dell’AV; le possibilidate sono individuabili in due periodi (tra 1308-1311 o 1317),durante i quali Ubertino è al centro di iniziative apologetiche ededitoriali legate alle travagliate vicende dell’Ordine 7. In merito,
5 ID., De la dramatizacion de los acontecimientos de la pascua a la cristología. Elcuarto libro del Arbor vitae Crucifixae Iesu de Ubertino de Casale, Roma, 2000, pp.46-52.
6 Constitutiones generales narbonenses anni 1260, in Constitutiones generales ordinisfratrum Minorum, 1 (saeculum 13.), cura et studio fratrum C. CENCIS R. G. MAIL-LEUX (Analecta Franciscana XIII, Nova serie, Documenta et studia, 1), Grottaferra-ta, 2007, pp.69-104.
7 Richiamo qui i titoli fondamentali per la ricostruzione delle vicende che an-dremo evocando, evitandone, dove possibile, un richiamo continuo, per non appe-santire l’apparato: mi riferisco, cioè, a G. BARONE, Da frate Elia agli Spirituali, Mi-lano, 1999, pp. 173-179; D. BURR, The Spiritual Franciscans: From Protest to Persecu-tion in the Century After Saint Francis, University Park, 2001; G. G. MERLO, Nel no-me di san Francesco. Storia dei frati Minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVIsecolo, Milano, 2003; S. PIRON, Censures et condamnations de Pierre de Jean Olivi. En-
ANTONIO MONTEFUSCO32
invece, al percorso di formazione del frate, nel ricostruirne la pa-rabola in una nuova proposta di sistemazione dei dati a disposi-zione, mi si è posto il problema del posizionamento del frate al-l’interno della galassia “spirituale”. Proprio negli anni che qui siconsiderano, il casalense non partecipò, come, al contrario, il suocoetaneo Pietro da Fossombrone, al trauma ingenerato dalla pre-parazione e lo svolgimento del Concilio di Lione 8. Mi pare dipoter segnalare, a tal proposito, l’emergere di un tratto “genove-se” o “ligure” nella personalità di Ubertino, che si precisò pro-prio durante la sua prima formazione, negli anni intorno a Lionesicuramente (1273-1276) ma forse anche nei primi anni ’80. Sep-pure gli elementi per valutare lo studium locale siano scarsissimi,alcune fonti permettono di delinearne, in negativo, un profilo nelquale ha un’importanza decisiva il rapporto del convento e delsuo studium con il ministro generale Giovanni Buralli di Parma,figura chiave nella catena memoriale che dagli “spirituali” risale aFrancesco 9. A significare probabilmente che il tratto “ligure”della personalità di Ubertino forse influenzò anche il suo “spiri-tualismo”, caratterizzato da una peculiare nostalgia che si tradus-se, prima, nella tenace difesa e attualizzazione della tradizione deisocii negli anni della magna disceptatio per approdare, infine, in unaffascinante impasto di polemica e fedeltà, alle posizioni pessimi-stiche del trattato sull’altissima povertà Ego sum via 10.
quête dans les marges du Vatican, in Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge,118 (2006), pp. 313-373.
8 Non è un caso, infatti, se la recente « biografia parallela » di Ubertino e An-gelo Clareno, proposta in P. VIAN, Angelo Clareno e Ubertino da Casale: due itineraria confronto, in Angelo Clareno francescano. Atti del XXXIV Convegno internazionale(Assisi, 5-7 ottobre 2006), Spoleto, 2007, pp. 165-225, cominci dal 1294, e cioèdalle dimissioni di Celestino V.
9 Si veda A. MAIERÙ, Buralli, Giovanni, in Dizionario biografico degli Italiani,15, Roma, 1972, pp. 381-394, e A. C. CADDERI, Il beato Giovanni da Parma, settimoministro generale dei frati Minori dopo san Francesco, Villa Vecchio (RN), 2004.
10 Per l’approdo finale di Ubertino, è particolarmente importante richiamareDAVIS, Ubertino da Casale cit. (nota 1), pp. 7-41; ID., Le pape Jean XXII et les Spiri-tuels. Ubertin de Casale, in Franciscains d’Oc. Les Spirituels ca. 1280-1324 (Cahiers de
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 33
1. CRONOLOGIA E FORMAZIONE : UNA TRAPPOLA ERMENEUTICA
« L’uomo dipende innanzitutto dal suo ambiente e dal suopassato, sia che la sua vita segua un corso uniforme sia che su-bisca sussulti capricciosi. Le prime impressioni lasciano spessodelle profonde tracce nell’animo, il sogno dorato dell’adole-scente contiene in germe il piano d’azione dell’uomo esper-to. » 11 Con queste parole si apre il primo capitolo della mo-nografia che il cappuccino Frédégand Callaey dedicò alla figu-ra di Ubertino da Casale nel 1911. Nel far convergere per laprima volta gli elementi della precedente (e già non sparutis-sima) bibliografia sul frate francescano in una monografiacomplessiva organizzata secondo lo schema classico della bio-grafia post-romantica, Callaey dedicava al periodo della “for-mazione” di Ubertino un intero capitolo, nel quale gli anniche andavano dall’ingresso nell’ordine al confino forzoso allaVerna diventavano l’incunabolo del maturo alfiere dello spiri-
Fanjeaux, 10), Toulouse – Fanjeaux, 1975, pp. 268-270; A. TABARRONI, « PaupertasChristi et apostolorum ». L’ideale francescano in discussione (1322-1324), Roma, 1990,pp. 65-70; G. L. POTESTÀ, Ubertino da Casale e la altissima paupertas, tra GiovanniXXII e Ludovico il Bavaro, in Oliviana [En ligne], 4, 2012, mis en ligne le 14 mars2013, consulté le 17 février 2014. URL : http://oliviana.revues.org/471.
11 F. CALLAEY, L’idéalisme franciscain spirituel au XIVe siècle. Etude sur Ubertin deCasale, Louvain 1911, p. 1: « L’homme est avant tout tributaire de son milieu etde son passé, que sa vie suive un cours uniforme ou se cabre en soubresauts capri-cieux. Les premières impressions laissent d’ordinaire des traces profondes dans l’â-me humaine, le rêve d’or de l’adolescent porte fréquemment en germe le plan d’ac-tion de l’homme réfléchi [...] Ainsi la jeunesse d’Ubertin de Casale est le miroir deson âge mûr. Le voyant du Monte Alverne, le porte-parole éloquent des revendica-tions rigoristes au Concile de Vienne, a grandi, enfant à peine revêtu de la bure,dans une atmosphère surchauffée de mysticisme joachimite, écoutant avec émotionsla parole tour à tour menaçante et plaintive de plus illustres franciscains spirituelsde l’époque : Jean de Parme, Pierre de Jean Olivi et Conrad d’Offida. [...] L’adap-tation [à la culture du fanatisme évangélique] fut si complète que plus tard, à l’heuredes grandes luttes, Ubertin fut l’homme qui incarna le plus fidèlement la mentali-té de son parti et en devint le défenseur le plus tenace ».
ANTONIO MONTEFUSCO34
tualismo francescano 12. Nell’enucleare per la prima volta que-sta sorta di micro-oggetto di studio nella bibliografia uberti-niana, Callaey proponeva anche un ripensamento della crono-logia che gli studiosi avevano fin lì delineato; non solo: egliposizionava e costringeva quasi, sotto l’etichetta – un pocoambigua, per la verità – di « formation spirituelle » un tren-tennio circa della vita di Ubertino 13. Per quanto l’operazionefosse, a suo modo, discutibile (per lo meno dal punto di vistadell’etichettatura e della mancata problematizzazione, comevedremo, di un complesso andirivieni tra biografia scientificae auto-narrazione da parte del coltissimo frate originale di Ca-sale s. Evasio, oggi Casale Monferrato) 14, il dado era tratto, enel giro di pochi anni la questione ebbe modo di trasformarsiin piccola fiammata polemica, con gli interventi di MichaelBihl del 1911 15 e Adolfo Martini 16 due anni dopo, i qualirespinsero con decisione le conclusioni dello studioso belga. Ildibattito allungò la sua ombra fin dentro la bibliografia piùrecente: Gian Luca Potestà, infatti, inizialmente in disaccordo
12 Si veda dunque l’intero capitolo del Callaey, alle pp. 1-24, intitolato in ma-niera significativa: Jeunesse d’Ubertin de Casale. Sa formation spirituelle (1259-1298).
13 Mi riferisco soprattutto agli studi di J. Ch. HUCK, Ubertin von Casale und des-sen Ideenkreis. Ein Beitrag zum Zeitalter Dantes, Freiburg im Breisgau, 1913 e E.KNOTH, Ubertino von Casale. Ein Beitrag zur Geschichte der Franziskaner order Wendedes 13. und 14. Jahrunderts, Marburg, 1903. Una discussione di queste opere, insie-me a quella del Callaey, è in G. L. POTESTÀ, Un secolo di studi sull’Arbor vitae. Chie-sa ed escatologia in Ubertino da Casale, in Collectanea Franciscana, 1977, pp. 217-267,in particolare rispettivamente alle pp. 219-22 (Huck); 222-225 (Knoth); 225-228(Callaey), ma si tenga presente l’intero contributo, insieme a Storia ed escatologia inUbertino da Casale, Milano, 1980; ID., Aspetti e implicazioni della mistica cristocentricadi Ubertino da Casale, in Abenländische Mystik im Mittelalter, Symposion Kloster Engel-berg 1984, a cura di K. RUT, Stuttgart, 1986, pp. 286-299.
14 Ricorda l’antico nome di Casale Monferrato A. CADILI, Ubertino da Casale dopoil 1325: un possibile itinerario, in Franciscan Studies, 69 (2011), pp. 257-283: p. 263.
15 Bibliographia, in Archivum Franciscanum Historicum, 4 (1911), pp. 597-99.16 A. MARTINI, Ubertino da Casale alla Verna e la Verna nell’Arbor Vitae, in La
Verna, 11 (1913), pp. 273-344.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 35
con la proposta di Callaey 17, ne ha sposato poi, in occasionedella voce biografica pubblicata per il Dictionnaire de Spiritua-lité, le ragioni 18, a cui ulteriore forza è stata data, su basesquisitamente ecdotica, nella recente monografia di MartínezRuiz, che ha anche ricostruito il dibattito 19.
Le due sistemazioni cronologiche propongono tre differen-ze sostanziali 20. Innanzitutto, andrà sottolineato che, nellaprima sistemazione, Ubertino sarebbe stato inviato precoce-mente (1275-76?) a Parigi all’indomani del noviziato (1273-74), e lì avrebbe soggiornato per nove anni (fino al 1284); se-condo Martini, ai 5 anni di studio passivo, sarebbero seguiti 2anni di lettura cursoria e 2 di lettura passiva delle Sententie 21;per Callaey, questo periodo sarebbe stato integralmente tra-scorso nel convento di Genova 22. In secondo luogo, il periodofiorentino del 1285-1289 è da considerare dedicato all’attivitàdi insegnamento e preceduto dall’incontro congiunto con Gio-vanni da Parma e Angelo da Foligno nella prima ipotesi,mentre nella seconda Ubertino avrebbe completato il periododi studio a Firenze, il cui studium generale era abilitato ad am-mettere gli studenti al lettorato della Bibbia e delle Senten-ze 23. Ne consegue che per Callaey i nove anni parigini si tra-sferirebbero al periodo 1289-1298, al termine del quale l’in-
17 G. L. POTESTÀ, Un secolo di studi sull’« Arbor vitae ». Chiesa ed escatologia inUbertino da Casale, in Collectanea franciscana, 47 (1977), pp. 217-267, in part. p.225; vedi anche la Nota biografica in Storia ed escatologia.
18 Ubertin de Casale, in Dictionnaire de Spiritualité, 16 (1994), pp. 3-1519 C. M. MARTINEZ RUIZ, De la dramatizacion de los acontecimientos de la Pascua a
la cristologia. El cuarto libro del Arbor vitae crucifixae Iesu de Ubertino de Casale, Ro-ma, 2000, pp. 31-36 per la discussione del 1Pro; pp. 24-30 per la discussione del-le posizioni degli studiosi precedenti.
20 Vedi Tabella 1 nell’Appendice.21 MARTINI, Ubertino da Casale alla Verna cit. (nota 16).22 CALLAEY, L’idéalisme franciscain spirituel cit. (nota 11), p. 723 HUCK, Ubertin von Casale und dessen Ideenkreis cit. (nota 13), p. 21; KNOTH,
Ubertino von Casale. Ein Beitrag cit. (nota 13), p. 3; BIHL, Bibliographia cit. (nota15), p. 597; POTESTÀ, Storia ed escatologia cit. (nota 13), p. 22.
ANTONIO MONTEFUSCO36
contro con Angela sarebbe stato decisivo per convincere Uber-tino a dedicarsi definitivamente alla predicazione 24. Infine sideve ricordare che, per Callaey, quest’ultima attività, che sisarebbe svolta in Umbria, Marche e Toscana, si sarebbe inter-rotta forzosamente con l’esilio alla Verna 25, mentre nella pri-ma ipotesi, il periodo di predicazione sarebbe stato molto piùlungo, principiando all’indomani del soggiorno fiorentino incui Ubertino aveva incontrato e collaborato con il teologoprovenzale Pietro di Giovanni Olivi 26.
Questa sensibile divaricazione può senz’altro sorprendere,se consideriamo che alla base di questa differenza di opinioni,si colloca il 1Prol, breve tranche testuale che provoca precoce-mente un “circolo vizioso” tra fonte e biografia: questa diffe-renziazione critica infatti trova ragion d’essere essenzialmentenel modo in cui interpretiamo un preciso e definito manipolodi passaggi del testo e il loro rapporto tra di loro, al quale glistudiosi hanno dato significati più o meno differenti 27.
Un primo passo fa riferimento all’ingresso nell’Ordine mi-noritico e lo colloca al quattordicesimo anno d’età: « Ex deci-moquarto anno vite mee, cum multis preambulis desideriis, adsue vite sacratissimum ordinem per seraphicum virum Franci-scum ab ipso Iesu mire institutum mirabiliter me adduxit, apatre et matre oblatum » 28. La chiarezza e l’unanimità dellalezione tràdita da questo passaggio è già messa in discussionenel passo seguente, che è costituito dalla frase conclusiva dellungo excursus testuale in cui Ubertino trascrisse l’eserciziodevozionale di riflessione “biblica e cristologica” organizzatosu base bi-settimanale, e che qui viene contrapposto a un pe-
24 CALLAEY, L’idéalisme franciscain spirituel cit. (nota 11), pp. 15-18; POTESTÀ,Ubertin de Casale cit. (nota 18), p. 3.
25 Ibid., pp. 14-15.26 MARTINI, Ubertino da Casale alla Verna cit. (nota 16), p. 249.27 Vedi Tabella 2.28 AV, f. 1a
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 37
riodo di esercizi, invece, forinseca, cioè “esterni” a Gesù; questoperiodo è di 14 anni, o un po’ meno nelle varianti:
« In primis quoque exercitiis sic quasi per XIV annos 29 circa forinseca Iesu mesuus spiritus occupabat, nondum me introducens ad altas suas sue mentis per-fectiones et inestimabiles cordis sui dolores. Sed tunc romana sanctuaria visi-tans et ad angelum faciei Iesu vere sanctissimum Ioannem de Parma ad ru-pem deveniens letus [sic, lege Grecii] et, ab ipso confortatus absolutus et in-structus, in die indulgentie, secunde diei Augusti, intravi ecclesiam beate Ma-rie de Portiuncola de Assisio, et iuxta eam pernoctavi » 30.
Secondo Martini, questo periodo comprendeva per interol’impegno scolastico di Ubertino, svoltosi, tra 1275 e 1289 a Pa-rigi e Firenze. Il riferimento alla visita romana e il passaggio aGreccio e Assisi si collocano durante il suo svolgimento, neglieventuali spostamenti dello studente, prima, e insegnante, poi 31.Per Callaey, invece, il pellegrinaggio suddetto indica una rotturarispetto alla formazione esclusivamente genovese del frate 32.
Il riferimento al soggiorno in Tuscia sub titulo studii e il ri-cordo all’incontro con Olivi, pur fugace (“modico tempore”), èunanimemente collocato al quadrienno 1285-1289, anche perchésappiamo da altre fonti della nomina del teologo provenzale allostudium santacrociano per l’intervento di Matteo d’Acquaspartanel 1287: 33 « Nam ad provinciam Tuscie veniens sub titulo studii, in-veni in multis viris virtutis spiritum Iesu fortiter ebulire. Interquos, vir Deo plenus Petrus de Senis, pectenarius, et devotissima
29 XIV annos] .xiii. vel .xiv. annos in alcuni mss.30 AV, f. 1va.31 MARTINI, Ubertino da Casale alla Verna cit. (nota 16), p. 250.32 CALLAEY, L’idéalisme franciscain spirituel cit. (nota 11), p. 19.33 D. BURR, L’histoire de Pierre Olivi, franciscain persécuté, Fribourg, 1997, p. 196;
vi ritorna in più sedi Piron, di cui si veda anzitutto, anche in relazione alla crono-logia ubertiniana, le pagine dedicate al 1Prol, nella tesi di dottorato: S. PIRON,Parcours d’un intellectuel franciscain. D’une théologie vers un pensée sociale : l’oeuvre dePierre de Jean Olivi (ca. 1248-1298) et son traité De contractibus, Paris, 1999 (tesidi dottorato EHESS), vol. 1 ad indicem.
ANTONIO MONTEFUSCO38
virgo Cecilia de Florentia [...] Affuit tunc, cum predictis magi-stris praticis seraphice sapientie, doctor speculativus et Christi vi-te defensor precipuus, Deo kharissimus, frater Ioannes [sic] Olivi,qui nunc felici transitum ut spirito regnat in celis. Qui me modi-co tempore spiritum Iesu preveniente sic introduxit ad altas perfec-tiones anime dilecti Iesu et sue dilectissime matris et ad profun-da scripture et ad intima tertii status mundi et renovationis viteChriste » 34.
Poco più in là segue il riferimento a uno spazio di nove an-ni nel quale Ubertino avrebbe insegnato e sarebbe stato a Pa-rigi; a questo passo si lega il riferimento all’incontro con An-gela da Foligno. Il brano, com’è noto, è afflitto da un proble-ma di varianti assai complesso. Eccolo nelle tre versioni:
Prima redazione Borrador 35 Seconda redazione
Vigesimoquinto autem annoetatis mee, et modo quempretereo, ad reverende matriset sanctissime Angele de Ful-gineo vere angelice vite interris me adduxit notitiam,cui sic cordis mei defectus etsua secreta beneficia revelavitIesus, ut dubitare non possemipsum esse qui loquebatur inilla. Et sic omnia dona pro-pria per meam malitiam per-dita in immensum multipli-cata restituit: ut iam ex tuncnon fuerim ille qui fui.
Vigesimoquinto anno religio-nis mee, miro modo quempretereo, ad reverende matriset sanctissime Angele de Ful-gineo vere angelicam vitamin terris me adduxit noti-tiam, cui sic cordis mei de-fectus et sua secreta beneficiarevelavit Iesus, ut dubitarenon possem ipsum esse quiloquebatur in illa. Et sic om-nia dona propria per meammalitiam perdita in immen-sum multiplicata restituit, utiam ex tunc non fuerim illequi fui.
Vigesimoquinto anno religio-nis mee deformatae, miromodo quem pretereo, ad re-verende matris et sanctissimeanime Angele de Fulgineovere angelicam vitam in ter-ris me adduxit notitiam, cuisic cordis mei defectus et suasecreta beneficia revelavit Ie-sus, ut dubitare non possemipsum esse qui loquebatur inilla. Et sic omnia dona pro-pria per meam malitiam per-dita in immensum multipli-cata restituit, ut iam ex tuncnon fuerim ille qui fui.
34 AV, f. 1vb.35 Così perlomeno nella testimonianza di Toulouse, Bibliothèque municipale
224, ma l’indagine va assolutamente allargata: potrebbe trattarsi semplicemente dilacuna.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 39
Nella prima redazione si parla di 25° anno di età di Uberti-no (che dunque andrebbe a cadere nel 1284-1285); nel borrador enella seconda redazione si fa riferimento a un 25° anniversario« religionis », che gli studiosi hanno interpretato come anniversa-rio dall’ingresso nell’Ordine: l’incontro veniva a cadere, dunque,in un 1298 che sembrerebbe più compatibile con la biografia diAngela. È Potestà, che pure in una prima fase era stato propensoa raccogliere le forti perplessità di Bihl sulla ricostruzione di Cal-laey 36, a dare poi a questo passaggio un’importanza “decisiva”per sciogliere la questione della ricostruzione cronologica aderen-do infine alla seconda ipotesi 37. Qual è il motivo? Si era datataal 1285 (più precisamente alla fine dell’anno) la conversione diAngela: la data era stata stabilita da Ferré, e confermata, ma conqualche cautela, dagli editori Thier-Calufetti nell’edizione del1985 38. A dire di Potestà la questione è risolutiva: l’incontro (omeglio, l’averne avuto notizia) è del 1298, a 25 anni della con-versione. Martínez Ruiz ne sposava le conclusioni, aggiungendovila constatazione che non si tratta di lezione erronea della princepsma piuttosto di errore d’autore, poi corretto in sede di secondaredazione 39. Da par suo, Bihl, che pure rigettava l’ipotesi di Cal-laey, avanzava, senza ulteriore spiegazione, l’anno 1289 per que-sto episodio: si tratta di un refuso per 1298? 40
36 BIHL, Bibliographia cit. (nota 13), pp. 596-598.37 POTESTÀ, Ubertin de Casale cit. (nota 10), p. 3.38 Secondo Ferré la conversione sarebbe avvenuta a fine 1285, quando il vesco-
vo folignate ha finalmente un cappellano francescano: cfr. M.J. FERRÉ, Les principalesdates de la vie d’Angèle de Foligno, in Revue d’histoire franciscaine, 2 (1925), pp. 21-34:30; questa invece la posizione degli editori: « noi non rigettiamo, avvertendo peròche non è strettamente concludente »: Il libro della beata Angela da Foligno, a c. diL. THIER, A. CALUFETTI, Grottaferrata, 1985, p. 29, n. 14. Per le questioni inerentila biografia di Angela, è però importante richiamare J. DALARUN, Angèle de Folignoa-t-elle existé?, in « Alla signorina. » Mélanges offerts à Noëlle de la Blanchardière, Ro-me, 1995, pp. 59-97.
39 MARTINEZ RUIZ, De la dramatizacion de los acontecimientos cit. (nota 19).40 « occursum B. Angelae assignaret anno 1289 », BIHL, Bibliographia cit. (nota
13), p. 597.
ANTONIO MONTEFUSCO40
Abbastanza consequenzialmente, il passo sul quadriennium diinsegnamento, che con tutta evidenza precede l’abbandono dellostudio per la predicazione, è considerato una precisazione delladurata del periodo fiorentino in Martini, mentre in Callaey è,senza spiegazione alcuna, collocato a cavallo del’300, prima diuno striminzito biennio di campagna di predicazione, 41 interrot-ta poi alla Verna, dove, nel 1305, Ubertino avrebbe alla luce,dietro le insistenze dei confratelli, l’Arbor Vitae nel 32° anno del-la sua conversione 42.
Un addentellato importante della autobiografia ubertinia-na si ritrova, invece, nel Libro V dell’Arbor, in particolarenella parte centrale di esso, laddove Ubertino sviluppa il temadella storia dell’Ordine francescano all’interno della fase dellastoria della Chiesa apertasi con la venuta di Francesco. Nel ca-pitolo III, in cui il frate attinge a piene mani alle fonti fran-cescane, perché impegnato a collocare la storia dell’Ordine inquesto contesto escatologico, emerge un lungo passaggio suGiovanni da Parma su cui tornerò. Per ora mi soffermo al ri-cordo della visita e della profezia di Giovanni sul destino delfrate di Casale:
41 « Et circa quadriennium tamen legi, et post hec omnia priora reliquens soli Iesupredicationi intendi. In qua super admirando Dei beneficio propter testimoniumveritatis quam coram clero et popul multitudine perusina pluries predicando expo-sui semiplene quam in hoc libro plenius expressi sub cuiusdam persecutionis titu-lo, predicationis imposito silentio, ad solitudinis locum deductus sum sacrum quidicitur Mons Alvernae. ». AV, f. 2a.
42 « Tamen potissimum adiutorium et confortamentum in scribendo [AV] se-cure fuit vere dicate amori Iesu duce prudentissime virginis vere sponse Christi deCivitate Castelli. [...] Et dum infirmarer de febre et crederem libri per hec impedi-ri scripturam, sic ad eius promissionem ex parte Iesu convalui subito quod mihistatim preparato optimi fratris et nuncii auxilio fere medietatem huius libri, etquasi totam difficultatem in ultimo trium predictorum mensium compilavit spiri-tus Iesu Christi. Et iuxta quod ipsa predixit dans mihi terminum mensis septem-bris: illo mense terminavi in vigilia Michaelis archangeli anni presentis. M. CCC.V . a felicissimo ortu veri solis Iesu. A mea in vero vili conversione annoXXXII ». AV, f. 2vb.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 41
« Nam et ego tunc iuvenis qui semper contremui in meis transgressioni-bus de inobservantia status promissi quarto anno ante eius [i. e. di Giovan-ni da Parma] felice transitum expressum verbum audivi ab eius ore san-ctissimo, intuens in eius angelicam faciem, « Vade » ait, « secure fili, quiaante quattuor annos Deus tibi expresse ostendet quem debeas sequi et cuius verita-tis verbum debeat inviolabiliter observari. » Erat in loco Gieci [sic, recteGreci], ubi angelicus vir angelicam vitam ducens in festo beati Iacobi oc-tavo kalendas augusti eum conquerebar, postquam omnia peccata mea con-fessus fueram quod nesciebam quem sequi deberem, quia tam prelati ec-clesie quam prelati ordinis hanc relaxationem vite non solum sustinebant,sed etiam imponebant. Ipse vero eis omnino contraria loquebatur et tuncmihi lachrymanti ad sanctos pedes eius ut credo genuflectenti in recessiprotulit verbum prefatum. Quarto vero anno postea XX, ut credo, diemarcii, in predicte doctrine continuatione feliciter migravit ad celos. Etdum ego in remotis agerem, et in multis distractionibus et mestitiis vive-rem propter status imperfectionem lectionis officio pressus, in die penteco-stes subito dum ad aliam tenderem, Frater Salomon minister Marchie ve-nit ad locum afferens sanctum dei Ioannem decessissem. [...] Et licet mensmea esset ad alia intenta, et nullum cogitaret de hiis que a sancto audive-rat, subito ac si lancea penetrasset cor meum ad spiritus Christi veritatemsequendam, omnia predicta mihi revocantur ad mentem » 43.
L’incontro viene dunque datato precisamente al 1285,quattro anni prima della morte di Giovanni a Camerino. AGreccio, Giovanni dice che dopo un quadriennio il giovane,che tremava di fronte a tale esempio di santità, avrebbe com-preso finalmente quale strada intraprendere. All’epoca dellamorte dell’ex ministro generale, poi, egli era impegnato nel-l’attività didattica, e quindi, preso da distrazioni, non si rendeconto del significato della notizia portatagli dal ministro dellaMarca frate Salomone. Ma subito una lancia trafigge il cuoredell’ambizioso frate e lo costringe a seguire la veritatem Christi.L’episodio è ricondotto, agiograficamente, nel novero dei mi-racoli in morte di Giovanni, esempio di santità non canoniz-
43 AV, V, III, f. 422b.
ANTONIO MONTEFUSCO42
zata 44. Lasciamo un attimo in sospeso quest’ultimo passo, chegli studiosi non hanno valorizzato, e rileviamo che Callaeyleggeva erroneamente, nel brano, lectionis officio promissus al po-sto di pressus: lo ricordo perché è su questa fragilissima base(poi corretta giustamente da Bihl) che egli fondava la sua ipo-tesi di ricostruzione: se alla morte di Giovanni Ubertino erainfatti destinato al lettorato, ciò significa che il quadriennio fio-rentino precedente era stato di studio, e che il novennio pari-gino si sarebbe collocato negli anni ’90! 45
2. DISSINNESCARE LA TRAPPOLA
In tutta onestà, entrambe queste interpretazioni ci lascianoinsoddisfatti, poiché ci pongono notevoli problemi di varianatura, che risultano tra loro estremamente intrecciati. Proce-do dal generale al particolare, sollevando dunque una primariserva di natura contestuale: il curriculum studiorum è assai biz-zarro. Difatti, sia che si ipotizzi un lungo periodo a Genova,seguito da Firenze e poi Parigi per nove anni, per ritornare aFirenze; sia che si ipotizzi immediatamente Parigi (all’indo-mani del noviziato, per nove anni), poi Firenze, e poi un lun-go periodo di predicazione, in entrambe le soluzioni vanno ri-levate delle difficoltà 46.
La prima: è abbastanza difficile ipotizzare che uno studen-te che veniva dalla provincia facesse immediatamente un pe-riodo di studio così lungo nello studium parigino 47. Sono le
44 Cfr. G.L. POTESTÀ, Ideali di santità secondo Ubertino da Casale ed Angelo Clarenoin Santi e santità nel secolo 14. Atti del 15° Convegno internazionale della Societàinternazionale di studi francescani, Perugia, 1989. pp. 105-131.
45 CALLAEY, L’idéalisme franciscain spirituel cit. (nota 11), p. 16; ma vedi la corre-zione di BIHL, Bibliographia cit. (nota 13), p. 597.
46 MARTINEZ RUIZ, De la dramatizacion de los acontecimientos cit. (nota 5), pp. 31ss. rileva che in entrambi i casi permangono delle difficoltà.
47 Sulla situazione della formazione e dello studio nella storia dell’Ordine dei
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 43
costituzioni narbonesi del 1260 a informarci che, prima che ilcapitolo provinciale approvasse l’invio di studenti nella doppiaformula de gratia e de debito, essi dovevano ottenere un buonbackground filosofico da guadagnarsi in un bienno-trienno nelproprio convento (« exerceantur tribus vel duobus annis postnovitiatum in aliquo studio suae provinciae vel vicinae, nisiadeo fuerint literati, quod post novitiatum possint mitti ») 48
per poi essere spediti a Parigi per un programma di studioche permetteva l’accesso al lettorato, in seguito a una decisio-ne seguita alla selezione operata dal capitolo che teneva pre-senti le esigenze delle varie custodie. Sempre le narbonesi (e aseguire anche le costituzioni di Assisi del 1279 e quelle pari-gine del 1292) stabilivano questo periodo abbastanza precisa-mente a 4 anni: « Studeant quattuor annis ad minus, nisiadeo fuerint provecti, quod merito iudicentur idonei ad lecto-ris officium exequendum » 49.
La seconda difficoltà consiste nell’obbligo di ritornare nel-la propria provincia ad insegnare a cui erano sottoposti coloro
frati minori, mi limito a citare D. BERG, Armut und Geschichte: Studien zur Geschichtedes Bettelorden im Hohen und Spätend Mitellalter, Münster, 1977; Le scuole degli Ordinimendicanti (secoli 13.-14.), Todi, 1978; G. BARONE, La legislazione sugli Studia deipredicatori e dei minori (originariamente edito in ibid.) in EAD., Da Frate Elia agliSpirituali, Milano, 1999, pp. 99-128; P. MARANESI, Nescientes litteras: l’ammonizionedella Regola francescana e la questione degli studi nell’Ordine (sec. 13.-16.), Roma,2000; B. ROEST, A history of Franciscan education: c. 1210-1517, Leiden, 2000; Stu-dio e studia: le scuole degli ordini mendicanti tra 13. e 14. secolo. Atti del XXIX Con-vegno internazionale (Assisi, 11-13 ottobre 2001), Spoleto, 2002; N. SENOCACK,The poor and the perfect. The rise of learning in the Franciscan Order, 1209-1310, Ithacaand London, 2011.
48 Constitutiones Narbonenses anni 1260 ed. cit. (nota 3), VI.12, p. 83 (cfr. ancheStatuta Aquitaniae, p. 474). Giulia Barone, Studio e Studia, 1978, p. 224.
49 Constitutiones Narbonenses anni 1260 ed. cit. (nota 3), VI.13, p. 83; Constitutio-nes Generales Assisienses (1279), in Constitutiones generales ordini fratrum Minorum cit.(nota 3), pp. 109-148: VI,12-13, p. 125; il passaggio torna inalterato nelle Argen-tinenses, ibid., p. 181; nelle Mediolanenses (1285), ibid., p. 240 e nelle Parisienses(1292, ma con aggiornamenti assisani tre anni dopo), ibid., p. 315.
ANTONIO MONTEFUSCO44
che erano diventati lectores 50. Dotato del titolo, infatti, il fratetornava al proprio convento di origine con un documento chene attestava la condotta, redatto dal guardiano; il capitoloprovinciale lo assegnava quindi a un convento della propriaprovincia dove la sua attività di insegnamento sarebbe poi sta-ta giudicata successivamente 51. In seguito egli poteva conti-nuare la sua attività didattica in un altro studium oppure ri-prendeva il suo percorso universitario in uno studium generalisprincipalis per diventare baccalaureus e eventualmente avviarsial magisterium; mi chiedo però se la formula utilizzata daUbertino per il periodo perigino (« legi et Parisius fui ») pos-sa riassumere davvero le attività richieste per un eventualebaccalaureato di cui probabilmente avremmo anche altre evi-denze. Per non dire poi della resistenza a credere che il casa-lense abbia davvero potuto soggiornare così a lungo nello stu-dium generale francese, visto e considerata la feroce critica cheegli esprime in più sedi (e massimamente nella Responsio e nelRotulus iste) contro la moltitudine di frati “inadatti” che vole-vano andare a Parigi per pura ambizione di potere (poiché lapresa dei lettori sui posti di comando di molti conventi del-l’Ordine era pressappoco totale) o per il gusto dell’onorificen-za (e anche con una puntata polemica rivolta probabilmente a
50 A. CALLEBAUT, Acta capituli generalis Mediolani celebrati an. 1285, in ArchivumFranciscanum Historicum, 22 (1929), pp. 284-291: p. 288: « Item teneantur studen-tes in generalibus studiis reportare secum, cum ad suas provincias redeunt, litterastestimoniales gardiani et lectoris loci, in quo studuerunt de sua conversatione etprofectu in scientia, quas suis ministris ostendere teneantur ».
51 Sulla legislazione, cfr. BARONE, La legislazione degli Studia cit. (nota 46); suiprogrammi cfr. W.J. COURTENAY, The Instructional Programmes of the Mendicant Con-vents at Paris in the Early Fourteenth Century, in The Medieval Church: Universities,Heresy, and the Religious Life. Essays in honour of Gordon Leff, ed. by P. Biller, B.Dobson, Woodbridge, 1999, pp. 77-92; e infine vedi ROEST, A history of the Franci-scan education cit. (nota 47), p. 91-ss., con le integrazioni di SENOCACK, The poor andthe perfect cit. (nota 47), p. 231.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 45
quella fascia di studenti che erano in grado di pagarsi da soligli studi) 52.
Come si intuisce facilmente, nessuna delle due ipotesi ri-cordate finora risulta compatibile con tale percorso tipizzato;il solo Callaey si era posto il problema di un eventuale rientrodi Ubertino in uno studium. Come mai però si pensa a unrientro a Firenze e non a Genova, dove pure per il cappuccinoegli aveva passato un lungo periodo di tirocinio? 53 L’invio dilettori in province diverse dalla propria si giustifica piuttostoper carenza di insegnanti, ciò che mi parrebbe più probabile aGenova che a Firenze (dove invece i lettori e magistri abbon-davano, seppure in un’ottica più di carriera che di amore dellostudio, come anch’esso ampiamente denunciato a suo tempodallo stesso Ubertino).
Oltre a questa difficoltà di natura contestuale, vanno se-gnalati almeno due problemi di lettura dei passi del 1Pro im-plicati nella ricostruzione della biografia del casalense, la cuianalisi ci risulta assai utile ai fini dell’individuazione dellecoordinate cronologiche. Il primo, assai importante, è quelloche riguarda l’incontro con Angela da Foligno, poco sopra ri-
52 Responsio, ed. cit. p. 73-74: « Et quia non multi sunt ingeniosi et apti adsubtilia et tamen, ut honorentur, volunt mitti ad studia et habere nomen lectoris,licet parum sciant. »; Sanctitas vestra, p. 73-74: « Et omnes dissensiones quasi, quesunt in provinciis multis ordinis, sunt propter ambicionem promocionis ad studia,ut sint lectores et prelati et alias dominentur. Quod autem hiis moveantur potiusquam amore scientie, patet, quia de facto videmus eos invite legere, quando pos-sunt preesse, et postquam habent nomen, quod fuerint lectores, et de Parysius re-deunt, parum curant postea de studio, sed sive legant sive non, in provinciis Ytalieet eciam alibi, ut plurimum soli lectores Parysienses dominantur »; Rotulus, p. 118:« Causa tamen quare est tanta ambitio et sepe turbe inter fratres propter studia,maxime propter Parisiense, esse videtur, quia quasi ubique per ordinem soli magi-stri et lectores dominantur »; Responsio, p. 74: « Quale est illud, quod nunc Pari-siense studium emitur a pluribus ». In generale, SENOCACK, The poor and the percetcit. (nota 47) pp. 188-214; sull’ipotesi di una terza fascia, che non arrivava al li-vello di lector, ma che si manteneva tramite l’apporto dei parenti, p. 198.
53 CALLAEY, L’idéalisme franciscain spirituel cit. (nota 11), p. 16.
ANTONIO MONTEFUSCO46
portato nelle tre versioni. Questo passaggio pone diversi pro-blemi. La lezione più “antica”, collocando l’incontro con An-gela al 1284-1285, presenta secondo me una difficoltà menodecisa di quanto gli studiosi abbiano voluto vedere. Se è veroche difficilmente nella realtà Ubertino può aver avuto notiziadi Angela immediatamente dopo la sua conversione, mi sem-bra anche innegabile che qui non si parla di un incontro madi una notitia con aspetti soprannaturali 54. A ciò aggiungoche la lezione del borrador è tuttavia più difficoltosa: cosa si-gnifica, infatti, il 25° anno della mia religio (« vigesimoquintoanno religionis mee »)? Posto che la traduzione sia “vita reli-giosa”, l’espressione si complica ulteriormente in sede di se-conda redazione: « vigesimoquinto anno religionis mee defor-mate. » Il sintagma religio deformata è hapax privo di qualsiasioccorrenza nei fontes franciscani come altrove; né mi pare dirintracciarla altrove nello stesso lessico ubertiniano 55. Mi ren-do conto che collocare l’avvenimento al 1297-1298 sarebbemolto suggestivo: di poco precedente, infatti, è la lettura diuna fase redazionale non definitiva del Liber (forse il solo Me-moriale) da parte di Giacomo Colonna, che verrà poi incorpo-rata nella testificatio del testo, che prende forma presumibil-mente intorno al 1304-1306 56. Ma come non ha avuto tortoa rilevare Giulia Barone, siamo così sicuri che Giacomo, pri-ma dello scontro con Bonifacio, sia già in contatto col mondospirituale francescano? Quella di Giacomo, all’epoca della let-tura, sembra più una « umana curiosità per un’esperienza reli-
54 Gesù rivela a Angela i difetti di Ubertino: l’elemento è di qualche significa-to se pensiamo che è proprio una visione notturna, però di Francesco, propiziare laconversione angelana: Il libro della beata Angela da Foligno cit. (nota 38), p. 132.
55 Ovviamente la constatazione è problematica fino a quando non avremo unaedizione del testo. Ma faccio anche notare che, nella stessa sede del prologo, Uber-tino fa riferimento all’ingresso nell’Ordine con la parola conversio: perché più in làUbertino avrebbe dovuto utilizzare un’espressione così sibillina?
56 M. P. ALBERZONI, L’approbatio: curia romana, ordine minoritico e Liber, in Angè-le de Foligno: le dossier, éd. par G. Barone et J. Dalarun, Rome, 1999, pp. 293-318.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 47
giosa che al cardinale dovette ricordare quella di sua sorellaMargherita » 57, intorno alla quale – è bene ricordarlo – si eraraccolta una comunità che nel 1285 avrebbe poi occupato ilmonastero di San Silvestro in Capite a Roma, adottando la re-gola moderata di Isabella di Francia 58. A parte queste conget-ture, tuttavia, io credo che, di fronte a due lezioni così divari-cate, sia assolutamente necessario interrogarsi sulla genesi del-l’errore, se di errore si è trattato per la prima redazione, senzaescludere che quella divaricazione non sia piuttosto il prodot-to di una lezione “d’autore” che i copisti hanno travisato inentrambi i casi. Ancora più importante, poi, è invece afferma-re che questo passaggio non è utilizzabile a scopo di datazionee cronologia, in nessuna delle due versioni.
Il secondo, e più piano, esempio di “lettura disinvolta”concerne il riferimento al soggiorno parigino, nel quale « qui-bus legi et Parisius fui » Su questo passaggio, allo stato attua-le delle conoscenze, la tradizione è unanime; ma ciò che vorreibanalmente sottolineare è che in esso l’idea di un soggiorno dinove anni integralmente trascorso a Parigi non è scontato: se dia-mo la giusta importanza alla congiunzione “et”, la lettura piùcorretta del passo indica piuttosto che, all’interno di un perio-do di nove anni, Ubertino ha trascorso un periodo a Parigi(probabilmente quattro anni) e un periodo di lettorato (presu-mibilmente, tenuto conto di quanto detto sopra, nella propriaprovincia di origine).
Messo da parte il problema, abbastanza classico quando sicristallizza una sorta di mini-tradizione critica che consistenella lettura “isolata” dei passi al di fuori del loro contesto,poiché non ha alcuna conseguenza sul nostro discorso 59, sto
57 G. BARONE, Il valore storico del Liber, in ibid., pp. 373-384: 382.58 EAD., Margherita Colonna, in Roma. Anno 1300, pp. 799-805.59 Si prenda il riferimento al soggiorno a Firenze: si parla in realtà di Tuscia;
ma la citazione di Cecilia, del senese Pier Pettinaio e di Pier di Giovanni Olivi ciinducono evidentemente nella città, sede di Studium generale. Il passaggio (« Nam
ANTONIO MONTEFUSCO48
per arrivare a tirare le conclusioni. È bene tuttavia arrestarsiprima su una questione di metodo generale: per quanto abbiatentato di fare un po’ ordine nelle notizie, ci si pone sempre ildilemma se leggere le notizie biografiche nell’ordine propostoda Ubertino nel 1 Pro, oppure individuarne più esattamente ipunti fermi, dando loro poi un significato di carattere “inter-pretativo”. A questo punto, propendo per la seconda ipotesi;prima però di praticarla bisogna auscultare più a fondo il qua-dro testuale in cui questo cumulo di informazioni ci vienefornito, cioè il 1Pro, per capire in che direzione e fino a chepunto i dati siano, nella sostanza, manipolati dal suo autore.
Nel 1Pro, infatti, gli elementi autobiografici, pur riportaticon dovizia di dati numerici (su cui, tuttavia, come si è visto,
ad provintiam Tuscie veniens sub titulo studii inveni in multis viris virtutis spiri-tum Iesu fortiter ebulire [...] Sciunt qui me audierunt quia benignus Iesus non mepermisit in legendo et predicando frivola et curiosa sectari. » AV, f. 1vb) è dunque ca-ratterizzato da un sibillino sub titulo studii; anche questa a me pare onestamenteespressione ambigua. Si considerino però due elementi: il primo è che, subito do-po, nella lotta quasi psicomachica tra impegno nello studium e naturale predisposi-zione cristologica di Ubertino (vi tornerò), sembrerebbe essere collocata a questoperiodo (uno dei pochissimi sicuri, dunque, collocabile ripeto al 1285-1289) un’at-tività di predicazione e lettorato, sotteso probabilmente al dittico legendo et predi-cando; in secondo luogo, si legga il ricordo del momento in cui il frate ha abban-donato l’attività di insegnamento (che appunto bisogna capire se collocare al 1289o al 1298): qui Ubertino utilizza sub titulo persecutionis con un significato piano(tradurrei con “con argomento”). Ciò mi induce a una massima cautela rispetto allostudio del lessico ubertiniano, in mancanza assoluta, tra l’altro, di strumenti di in-dagine su di esso: il tasso metaforico, con passaggi da un campo concettuale a unaltro, sono sempre in agguato, come dimostra in maniera flagrante un altro passag-gio nel quale il primo periodo di conversatio con gli altri frati studenti è “compen-sato” dal fatto che Gesù lo teneva occupato, nel cuore, in artibus vitae suae. « Licetautem inter vanos studentium cursos secundum huius temporis maliciam fuerimconversatus ac sepe philosophicis studiis deditus, spiritus tamen bene dicti Iesu su-per me impulit ista contenere. [...] A novitiatus principio in totum cor meum occuparevellet in artibus vite sue ». (Ibid., f. 1a)
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 49
si è accumulato qualche slittamento erroneo della tradizione),sono inseriti in un tessuto che definirei di “costruzione di unio esemplare”, in un processo parallelo a quanto avviene nellacoeva produzione letteraria latina e volgare (penso a Jean deMeung, autore del Roman de la Rose e ovviamente penso aDante; a me pare non estraneo a questo anche un autore dellafibra intellettuale di Iacopone da Todi) 60. Nel contesto fran-cescano, e in un quadro apocalittico, c’è una particolare “pro-gettualità escatologica”, che per esempio in Olivi e Iacoponesi traduce nella figura del cristiano – miles armatus degli ulti-mi tempi; l’intenzione di Ubertino non vi è completamenteestranea 61. Tutto il 1Pro è in realtà una traduzione, in termi-ni biografico-esemplari, di una lunga lotta, quasi una psico-machia, ingaggiata dalla naturale predisposizione cristologicadel giovane – il quale già « ab uberibus matris » era spinto al« vestigia Christi sequi » – con le condizioni ambientali. Inquesto quadro lo stesso ingresso nell’Ordine è un fattore che,sia per le generali condizioni di relaxatio sia per la spinta ine-vitabile allo studium, tende a soffocare e combattere questa na-turale predisposizione. È in questo quadro che viene delineatae ribadita una vita sempre « sacrilega » che rendeva « indi-gnus » il « pauperculus » Ubertino in quanto « rebellis » allo« spiritus Iesu ». Tutta l’esemplarità dell’io costruito paziente-mente nell’AV si gioca in questa triangolazione tra un cristo-centrismo installato nel cuore di un’anima comunque indegna,
60 Cfr., su questo tema, A. MINNIS, Medieval theory of authorship: scholastic literaryattitudes in the later Middle Ages, Philadelphia, 1989; specificamente su Dante, A.R.ASCOLI, Dante and the Making of a Modern Author, Cambridge, 2008.
61 Su questo tema, e in particolare sull’escatologismo in Ubertino, vedi R.MANSELLI, Pietro di Giovanni Olivi e Ubertino da Casale (a proposito della Lectura superApocalipsim e dell’Arbor vitae crucifixae Jesu), in Studi medievali, 6 (1965), pp. 95-122, e POTESTÀ, Storia ed escatologia cit. (nota 13), passim ma soprattutto pp. 142-167. Sul rapporto tra Iacopone e Olivi, e sul tema del miles armatus, mi permettodi rinviare al mio volume Iacopone nell’Umbria del Due-Trecento. Un’alternativa france-scana, Roma, 2006, pp. 82-105.
ANTONIO MONTEFUSCO50
costretta a combattere la carnalitas di una situazione ambien-tale. Ecco le parole di Ubertino:
« Ego mente servi legi Dei, et credo quod dico et ea facere licet semiplenedesidero; carne autem servi legi peccati, quod ex malitia mea super omnesalios quantum sentio crucior continuo dolore; mihi ipsi displiceo, et contrameipsum ago. Armor contra dilectum Iesum qui me indignum in terraper spiritum suum inhabitare dignatur » 62.
Su questa base, Ubertino costruisce un percorso di svolte edrammatiche distrazioni, in cui lo schema generale non può nonfar sospettare continuamente qualcosa di costruito, di artificialese non di artificioso: una risistemazione che la memoria suggellaesemplarmente con la completio di Cristo (finis et forma del libro, siricordi): « sed novit Iesus qui librum istum ut arbitror comple-bit » 63. La formula, applicata a un volume che viene presentatocome un prodotto della memoria dell’ispirazione cristologica delsuo autore, ha il sapore del registro notarile, e lo avvicina alle va-rie testificationes delle esperienze delle religiosae mulieres coeve 64. Inquesto percorso, la carnalitas prende costantemente le sembianzedella vana sapientia (ed è qualcosa che non sorprende, se pensiamoall’Ubertino degli scritti durante la magna disceptatio): il frate è co-stretto allo studio e all’insegnamento, sopraffatto nel suo pur inde-gno tentativo di far fluire la mirra dello « spiritus Iesu » costan-temente unito a quello della « sanctissima mater »: affissa già findall’inizio del prologo, si tratta di una coppia che ritroveremoanche alla sommità della descensio, nella Croce che compie l’itine-rario del Verbo. L’impressione è che proprio questa coppia ri-compaia costantemente, pur mantenendo una gerarchia maschile– femminile, in tutto il disegno autobiografico delineato nel1Pro. Così, appena quattordicenne, Ubertino è oblato da madre epadre per entrare nell’Ordine in cui Francesco e Chiara erano sta-
62 AV, f. 2a63 AV, f. 2b.64 Vedi di nuovo ALBERZONI, L’approbatio: curia romana cit. (nota 56), passim.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 51
ti generati da Maria per riprodurre la vita di Cristo; così, in ma-niera che davvero sorprende, durante il periodo fiorentino, la cop-pia di Cecilia da Firenze e Pier Pettinaio allo stesso tempo affian-cano e fanno da contrappeso, in qualità di « magistri pratici » al« doctor speculativus et Christi vitae defensor » Pietro di Gio-vanni Olivi (ma su questo punto ritornerò). In questo gioco dispecchi – maschile / femminile versus studium / relaxatio – ri-marrebbe isolato l’episodio dell’incontro con Giovanni da Parma,il quale non è precisamente datato nel Prologo, ma collocato inposizione centrale tra la visita ai santuari romani e l’arrivo a San-ta Maria della Porziuncola. Questo incontro possiamo datarlo al1285 per deduzione, ripeto: lo sappiamo dal V libro, come sap-piamo che esso si colloca 4 anni prima della morte dell’ex gene-rale; sempre dallo stesso quinto libro sappiamo che Giovannipredice a Ubertino che dopo 4 anni saprà quello che deve fare etroverà finalmente la sua strada. La tentazione di accostarlo alpassaggio nel prologo in cui, dopo un quadriennio di insegna-mento, Ubertino decide finalmente di dedicarsi alla predicazione« omnia priora reliquens » è fortissima, bisogna ammetterlo. Mase così fosse, questa ulteriore svolta rimarrebbe priva della suacontroparte “mistica”: unico caso, tanto più eccezionale se anchela stessa “scrittura” dell’AV – perché quindi anche la scrittura,nel sistema teorico ubertiniano, si colloca saldamente sul latodella sapientia – risulta accompagnata e bilanciata dalla presenzadi Margherita da Città di Castello. Viene spontaneo, dunque, po-sizionare la notitia della penitente folignate alla fine del quadrien-nio da lector predetto da Giovanni da Parma: ciò che, a conti fat-ti, porterebbe al 1289 (e chissà che il Bihl non avesse pensato atale evenienza!), ma ci porterebbe anche non solo su un terrenoincompatibile con le date (il famoso 25° anniversario di qualcosache ci sfugge inevitabilmente), ma soprattutto di nuovo su quel-lo delle congetture.
Riprendiamo le fila, e proponiamo una conclusione prov-visoria sulla cronologia. In un testo di questa natura, la fictioesemplare prevale assolutamente sulla verità autobiografica:dunque i dati andranno scelti con cura certosina. Gli unici
ANTONIO MONTEFUSCO52
certi sembrerebbero il 1305, anno della composizione dell’AV;il 1273, 32 anni prima, in cui egli entra nell’ordine. Si trattadi una situazione un po’ fuori dalle regole, perché siamo inepoca post-narbonesi, che prescrivevano un’età di 18 anni perl’ingresso nell’Ordine, e Ubertino ha solo 14 anni. Prendiamoper buono il dato, e collochiamo infine la sua nascita al 1259.Fin qui i dati sicuri; poi abbiamo le deduzioni, derivate o daaltre fonti o da altri passaggi dell’AV. Si tratta di due ele-menti: l’incontro con Giovanni da Parma, nel 1285, e quellocon Olivi, nel 1287, da cui calcoliamo un quadriennio a Fi-renze, dove egli ha “letto”, ha esercitato cioè la funzione dilector. Il resto della parabola biografica è solo ricostruibile invia ipotetica: dai dati interni sappiamo che c’è stato un perio-do di 9 anni, in cui Ubertino ha soggiornato anche a Parigi; epoiché gli studenti ottenevano il lettorato in quattro anni, èprobabile che questo quadriennio parigino abbia anticipato unquinquennio di insegnamento nella propria provincia di origi-ne; non c’è alcun motivo di escludere che essa sia Genova, maponiamo anche che essa sia potuta essere Firenze. Impossibileda sciogliere, secondo me, il nodo dell’incontro con Angela;così come sfuocato e insicuro resta il dato del momento del-l’abbandono del curriculum scolastico per la predicazione; deltutto inutile, invece, il nodo dei 14 anni dedicati ad esercizi“forinseca Iesu” (sui quali tra l’altro pende un problema note-vole da un punto di vista ecdotico) 65.
3. UN’IPOTESI DI DATAZIONE PER IL 1PRO
Il 1Pro si è dimostrato un testo dalla ricchezza inattesa; lasua valenza ermeneutica non si limita alle informazioni crono-logiche, sibillinamente racchiuse in una struttura autobiografi-
65 Per la mia ipotesi, vedi la tabella 3, in cui propongo, data la vicinanza conla prima ipotesi cronologica, una cronologia 1 bis.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 53
ca. Il testo in sé può fornire, se analizzato in quanto porzionetestuale legata ma anche indipendente dall’AV, qualche utiledato per la ricostruzione della biografia ubertiniana anche ol-tre il periodo della formazione. Ciò si scontra, beninteso, conil limite di una indagine ancora incompleta e ben lontana dal-la razionalizzazione nel campo della trasmissione testuale.Raccolgo di seguito, dunque, alcune piste di interpretazione apartire da un corpus ridottissimo di testimonianze manoscritte,che verranno opportunamente segnalate. Tali piste andrannonecessariamente sottoposte alla verifica esaustiva della collatiocodicum che si spera realizzata in un momento non così lonta-no nel tempo.
Parafrasando un fortunato pamphlet pubblicato nel 2007dal filosofo francese Alain Badiou in seguito alla seconda vit-toria elettorale del presidente neogollista Nicolas Sarkozy chescioccò letteralmente l’opinione pubblica gauchiste, mi sonochiesto, di fronte a un simile testo, « di che cosa il primoPrologo è il nome? » Per rispondere, andranno allineati alcunidati problematici ma di certo interesse. Dobbiamo innanzitut-to constatare che non mi pare di riscontrare, nella trasmissio-ne di questa porzione di testo, una dinamica strutturata indue redazioni inframmezzata da un borrador sovrapponibile aquella dell’AV; lo stesso Martínez Ruiz si limita ad alludere auna tale situazione: non l’afferma mai con nettezza 66. In altritermini: se consideriamo il testo nella sua autonomia – ciò
66 MARTÍNEZ RUIZ, De la dramatizacion cit. (nota 5), p. 32-33, ove si fa riferimento adue casi di varianti erronee attribuite al 1Pro laddove quest’ultimo è accorpato alla pri-ma redazione; in entrambi i casi, tuttavia, siamo ben distanti da una tipologia ricondu-cibile a (eventuale) revisione in sede di nuova redazione del testo: propendo per questaspiegazione sia nel caso della inesatta individuazione della terza crux attribuita erronea-mente al capitolo Iesus excruciatus invece che cruce ditatus, e l’esatto riferimento cronolo-gico alla conversione di Angela, a cui abbiamo già fatto riferimento. Resta da stabilire,cioè, se semplicemente, a fronte di una tale varianza, non vi sia anche da aggiungere,cioè, la constatazione che la prima redazione non sia anche stata una versione afflitta daerrori ben più che quella definitiva.
ANTONIO MONTEFUSCO54
che mi permetto di consigliare operativamente al futuro edi-tore – le differenze saranno da addossare a problemi di copiapiù che di integrale revisione; sembra semmai che, laddove iltesto è accorpato alla cosiddetta prima redazione, esso risultitrascritto in maniera più scorretta o condivida un nucleo divarianti che possono essere ulteriore conferma di una divisioneper famiglie della tradizione, come suggerito da Piron in que-sto stesso volume, piuttosto che farci propendere per una indi-mostrata “prima redazione” di esso 67.
Unitario nella trasmissione non significa altrettanto unita-rio nella struttura: sempre rimanendo ancorati al punto di vi-sta materiale della tradizione manoscritta, si rileva piuttostouna divaricazione tra una trasmissione del testo nella sua uni-tarietà e la trasmissione di un suo brano particolare, che assu-me precocemente una certa autonomia: si tratta degli exercitiaspiritualia su base giornaliera che Ubertino pratica fin dalprincipio del noviziato. Nella narrazione autobiografica questiesercizi assumono il significato di un contrappunto dell’attivi-tà peccaminosa dello studio filosofico, come viene dimostratodal fatto che essi hanno una durata di 14 giorni (e vengonopuntualmente descritti su base quotidiana, dalla meditazionedel lunedì sulla caduta di Adamo a quella del martedì sull’e-pisodio di Maria a casa di Zaccaria e così via) e vengono pra-ticati durante i 14 anni di studio da parte del frate. Vero eproprio opusculum spirituale sul modello di quelli esemplati efatti circolare dall’entourage di Olivi in latino e in volgare 68,esso ebbe una sua tradizione autonoma; in una versione breve,esso si limita all’enumerazione degli esercizi giornalieri 69; in
67 Vedi l’articolo di S. Piron in questo volume.68 Mi permetto di rinviare, su questo, al mio Structure and Tradition of Pierre de
Jean Olieu’s opuscula: inner experience and devotional writing, in Franciscan Studies, 69(2011), pp. 1-22.
69 Si tratta della versione trasmessa, ad esempio, nel ms. Liége, Bibliothèque duGrand séminaire 6. L. 18, f. 138r-139v.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 55
una più lunga, viene riassunta la prima parte del 1Pro, macon un annacquamento dei riferimenti biografici: così, peresempio, il riferimento al noviziato è una metafora (« quasi anovitiatus principio ») 70. L’opusculum è chiuso, in entrambe leversioni (breve e lunga) da un explicit leggermente differentedal passaggio finale inserito nel 1Pro nella versione unitaria:nella tradizione “spicciolata” è assente il riferimento preciso ai14 anni di studio 71; il brano si conferma, dunque, sganciatodall’autoritratto che è elemento necessario di costruzione te-stuale nel testo con cui è in rapporto.
Allo stato attuale dell’esplorazione, la cautela è d’obbligo;tuttavia, tenendo presente la nuova sistemazione della tradi-zione in famiglie, è da sottolineare che la diffusione del branosembrerebbe significativa in area fiamminga, ove Ubertino ri-ceve, assieme a Angela, un’attenzione particolare da parte delmovimento della devotio moderna, come aveva già mostratoEmore Paoli 72: in questo quadro il brano può essere stato“estratto” dal 1Pro e trasformato in testo devozionale a poste-riori. Questa operazione è resa possibile dal fatto che il testosembrerebbe il risultato dall’accorpamento di materiali diffe-renti, forse redatti in epoche diverse, e a un certo momento(cercherò di avanzare un’ipotesi per stabilirlo) cuciti insiemein un organismo nel quale il leit-motiv è costituito dall’intrec-cio strettissimo tra autobiografia e puntuale descrizione dellamiracolosa redazione dell’AV.
Ci si ripropone la domanda che affiggevo all’inizio del pa-ragrafo: di che cosa si parla quando si parla del 1Pro? La ri-
70 Così avviene nel ms. di Liége, Bibliothèque du Grand séminaire 6. N. 1, ff.188r-190r.
71 La versione integrale è « In primis quoque exercitiis sic quasi per XIV annos circaforinseca Iesu me suus spiritus occupabat nondum me introducens ad altas suas suementis perfectiones et inestimabiles cordis sui doloris. » Quella parziale: « Sic quasiper xiii. Annos pro forinseca exercitia Iesu me suus spiritus occupabat nondum me in-troducens ad altas suas sue mentis perfectiones et desiderabiles cordis sui doloris ».
72 E. PAOLI, Le due redazioni del Liber: il perché di una riscrittura in Angèle de Foli-gno cit. (nota 56), pp. 29-70: 69-70.
ANTONIO MONTEFUSCO56
sposta dovrà essere innanzitutto negativa: non certo si trattadel prologo dell’AV, che infatti una prefazione d’autore, rea-lizzata senza dubbio durante la redazione dell’opera e non infase finale e definitiva (perlomeno nella versione che conoscia-mo derivata dalla princeps), ce l’aveva già 73. Per la risposta af-fermativa bisognerà, al contrario, entrare nel campo dell’ipote-si. Il 1Pro propone qualche affondo sulla materia dell’AV solocome sotto-materia di un argomento principale, che è il lentomaturarsi della redazione del libro sotto il segno di Cristo,« actor et materia finis et forma » di esso. « Nihil enim inhoc libro intenditur nisi Iesu Christi notitia et dilectio visce-rosa et imitatoria vita », insiste Ubertino, sottolineando anco-ra di più, se possibile, la “spontaneità cristologica” dell’ope-ra 74. Tale constatazione, se possibile, ricolloca la costruzionedell’autoritratto in un intreccio complesso (e anch’esso nonisolato nell’air du temps) con la scrittura: così facendo, l’AV di-venta il prodotto, terminato in maniera significativa alla Ver-na su precisa richiesta dei compagni e dell’« uterinus frater »ma con l’intercessione di Margherita da Città di Castello – inun dittico tra ordo e religiosae mulieres che abbiamo già indicatoquale fattore operativo nella costruzione dell’autoritratto – diun tormentato processo di redazione che nasce a ridosso delnoviziato, cristallizzandosi primariamente nel misterioso fasci-culus myrrhae. Quest’ultimo, presentato come l’incunabolo del-l’AV, procede parallelo (o forse addirittura coincide) con gliesercizi spirituali di cui sopra abbiamo discusso; sarebbe mol-to importante capire esattamente il rapporto tra fasciculus eesercizi, ma mi pare impossibile avanzare ipotesi, se non forseinsistere sul fatto che proprio quel brano devozionale potrebbeforse costituire un nucleo testuale molto antico, poi superatodall’avanzamento del progetto, e infine recuperato in un’epoca
73 MARTINEZ RUIZ, De la dramatizacion de los acontecimientos cit. (nota 5), pp.46-52.
74 AV, f. 1a.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 57
tarda, all’epoca della compilazione del 1Pro. La devotio modernaavrebbe fornito inconsapevolmente nuova vita a un testo cheera nato “autonomo”.
D’altronde, a prescindere da quest’ipotesi, è indubbio cheil vero nucleo dell’AV, che diventerà poi il IV libro, è posi-zionato piuttosto indietro nel tempo, e che la sua redazioneattraversa l’intero periodo della formazione (continuamente indialettica con l’impegno mistico e devozionale). I « versicoli »sono dunque la base di lavoro e di riflessione del frate, l’equi-valente degli exercitia nel prosieguo della sua parabola esisten-ziale; sono i confratelli a insistere perché essi diventino un or-ganismo unitario (« molestatus » è l’ingeneroso vocabolo riser-vato alle amorevoli insistenze dei frati), che, com’è noto, assu-merà la forma di richieste differenti (un commentario all’Apo-calisse, un sermonario, un volume sulla passione), ma è dinuovo, nell’anno alla Verna, l’intervento miracoloso di Gesù adare la forma necessaria all’opera. Ubertino utilizza addiritturala formula della completio notarile (« sed novit Iesus qui librumistum ut arbitror ipse complebit »), ma in questo passaggiocruciale del 1Pro, se si vuole, tocchiamo con mano il farsi del-l’AV nella modalità dell’amplificazione del « parvulum libel-lum » (il IV libro?) in un organismo nuovo e complesso, tra-scritto in sette mesi circa con l’ausilio della memoria e dell’i-spirizione cristica, grazie a un movimento di allargamento te-matico – dalla passione si passa a trattare la vita di Gesù (II eIII libro), poi i mali della Chiesa (III e IV), Gesù nella suaeternità (I) e infine l’Apocalisse (il V), in un processo più di-sordinato di come lo stia riassumendo – e di organizzazionestrutturale – i 5 libri, infine chiamati Arbor vitae crucifixae Jesusono presentati come il risultato della costrizione dei 149 ver-sicoli in 101 capitoli, con qualche ripetizione che Ubertino ri-tiene comunque necessaria al lettore. All’editore spetterà disbrogliare tale processo in un’ipotesi razionale eventualmenterispecchiata nella traditio; a me interessa sottolineare come cisi trovi di fronte a un testo cruciale, perché inteso a esplicita-re struttura e ispirazione di un’opera che per una certa fase ha
ANTONIO MONTEFUSCO58
avuto una trasmissione clandestina; in esso ha probabilmentetrovato posto – o almeno, così vuol far credere Ubertino alsuo (ai suoi?) lettore – un antico nucleo forse all’origine dellastessa opera.
Il 1Pro, in definitiva, è parte del paratesto dell’AV, un pa-ratesto presumibilmente necessario per una precisa comunitàdi lettori. Esso è probabilmente derivato dall’accorpamento dimateriali differenti, che sono stati uniti insieme nell’occasionedell’edizione e della diffusione dell’opera. Questo testo dovevaessere di natura epistolare, come mostra il suo incipit che è atutti gli effetti un protocollo fornito anche di intitulatio, chein questo caso, dunque, assume un rilievo straordinario su cuiconverrà tornare: nella formula « pauperculus et indignissimusIesu Christi et sue sanctissime matris et olim virginum inuti-lis servuus Frater Ubertinus, magis nomine quam re, ordinisbeati Francisci professus », la così forte asserzione di un’appar-tenza all’ordine magis nomine quam re – non poi così distantedalla più celebre autopresentazione di Dante « florentinus na-tione non moribus » – ha bisogno di ulteriore analisi. Per ora,basta rilevare due caratteristiche del testo che, a mio parere, cipossono permettere di datarlo con qualche precisione.
La prima riguarda l’explicit del 1Pro, in cui Ubertino, cheaffida il testo alla Chiesa, intima a chiunque di non mutarlo:
« Et nullus presumat in hoc libro aliquod immutare vel ipsum occultarevel quomodolibet impedire: quin pure et integre sacrosante sedi apostoliceemendandus et approbandus celeriter presentetur. Inquam plene et integresua sanctissimam auctoritatem transfundit omnipotens redemptor Deushomo Christus Iesus cui librum committo: qui de seipso ipsum ut sperocompilabit per spiritum suum dictum » 75.
Il tono è completamente diverso rispetto al finale del libroV dell’AV, vero explicit dell’opera, ove si afferma che il volu-
75 AV, f. 3b.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 59
me verrà sottoposto alla emendatio della Chiesa soltanto unavolta che quest’ultima sarà liberata dalle fauci della bestia:
« Adhuc vivo paratus sum correptione suscipe. Si autem piissimi Ihesu ve-lox vocatione me subtraxerit ex hac luce, romana ecclesia cui per spiritumIesu datum est universale magisterium postquam fuerit a faucibus trucu-lente bestie expurgata, cui, si qua indigna esse perspexerit, dignetur obse-cro emendare. Cui soli et eius correptioni librum et me plene submitto, etsolius sedis apostolice, in cuis fide me vivere profiteor examinationi, emen-dationi et protectioni relinquo omnia que in huius libro continentur » 76.
È evidente che il 1Pro è redatto in un momento differenterispetto al completamento dell’AV (si ricordi infatti che il Vlibro è l’ultimo a essere composto); in questo momento Uber-tino doveva sentirsi particolarmente “vicino” al papato.
Il secondo elemento significativo è rappresentato senz’altrodal passaggio riguardante Pietro di Giovanni Olivi. Il quadroelogiativo del teologo provenzale sembra non resistere a unalettura più approfondita del 1Pro. Interpreto, cioè, in manieranettamente attenuativa rispetto all’autorità di Olivi l’accosta-mento con Cecilia e Pietro di Siena, che vengono qui convoca-ti in quanto esemplari di un tipo di figura “contemplativa”:nell’economia del testo, essi rappresentano dunque il positivodi un quadro in cui il negativo è rappresentato costantementedallo studio. Di quest’ultimo è in questo caso specifico rap-presentante Pietro di Giovanni Olivi, « doctor speculativus »vagamente in secondo piano rispetto ai « magistri pratici ».Parlo, sia chiaro, di una curvatura critica, di qualcosa chesembrerebbe incrinato in un’ammirazione che doveva essere erestare, comunque, cospicua, ma non incondizionata (com’era,tra l’altro, nelle stesse indicazioni del maestro provenzale, teo-rico di una critica costruttiva dei teologi e finanche dei filoso-fi) 77. Ma è solo in questo modo che si può spiegare quella fi-
76 Ibid., f. 488.77 Sylvain Piron propone di interpretare le “perplessità” di Ubertino tenendo
ANTONIO MONTEFUSCO60
nale citazione dell’Ars poetica oraziana che sembra, appunto,mettere una definitiva pietra sopra l’idea di una adesione tota-le: « Non tamen hunc perfectum doctorem, quem tantum co-mendo in aliquibus dictis suis sequor, quia aliquando bonusdormitat Homerus, nec omnia omnibus data sunt » 78. Noncredo che una tale formula si possa spiegare con il singolodissenso su punti quale quello dell’abdicazione di Celestino(tra l’altro realizzato tramite la paradossale manipolazione ditesti oliviani) né con presunti motivi di dissimulazione (chenon trovo mai operativi in Ubertino). Di nuovo, siamo difronte a un momento assai differente da quando Ubertino ave-va chiuso la prima redazione dell’AV, un momento dunqueposteriore alla redazione dell’opera; ma oltre a una questionecronologica, si può qui indicare anche un elemento interpreta-tivo che riguarda una sopraggiunta posizione di pessimismorispetto al sistema di compromesso basato sulla Exiit qui semi-nat che non esclude, tuttavia, la possibilità di un’azione per-suasiva a favore dell’usus pauper da parte della Chiesa. In que-sto modo, il 1Pro si configura come una sorta di misurata “ar-ringa” - più che un pamphlet - a favore di una soluzione delconflitto tra “spirituali” e “comunità”, che spinga lo spazio
presente che, già dopo il 1299, citare esplicitamente Olivi era segno di profondocoraggio, e che diverrà temerario dopo la censura: vedi PIRON, Censures et condamna-tions de Pierre de Jean Olivi cit. (nota 7); le critiche a Olivi sarebbero espresse congli stessi strumenti concettuali con cui Olivi criticava i maestri aristotelici, ciò checontribuirebbe ad attenuare la portata. Credo però che il fatto che Ubertino utiliz-zi profondamente Olivi anche nel criticarlo non diminuisca in sé la portata dellacritica; ciò detto, bisogna intendersi: è senz’altro profondamente oliviano, in uncerto senso, pensare di poter applicare quel pensiero a un contesto cambiato man-tenendone lo spirito. Cfr. su questo F. DELORME, Fr. Petri Joannis Olivi Tractatus deperlegendis philosophorum libris, in Antonianum, 16 (1941), pp. 31-44, sul quale alme-no D. BURR, Petrus Ioannis Olivi and the Philosophers, in Franciscan Studies, 31(1971), pp. 41-71 e S. PIRON, The Formation of Olivi’s Intellectual Project , in Oliviana[En ligne], 1⏐2003, mis en ligne le 31 décembre 2003, consulté le 01 mars 2014.URL: http://oliviana.revues.org/8.
78 AV, f. 1vb.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 61
negoziale eventualmente aperto in curia a favore dei primi;per rafforzare questa posizione, nel testo si apportano due ele-menti fondamentali: l’esperienza esemplare di Ubertino, leadere uno dei portavoci della posizione dissidente, e la scritturadell’AV come prodotto della ispirazione di Cristo.
Tirando le fila: se teniamo presente che l’AV circolò inmaniera molto limitata, in quanto non venne coinvolto nelladenuncia di Ubertino durante il pontificato di Benedetto XIné lo stesso Giovanni XXII sembrerebbe conoscerlo, il 1Profotografa un momento peculiare della sua storia. Si tratta mol-to probabilmente di un momento in cui l’autore ne cura un’e-dizione, forse con l’intenzione di inserirlo in un dibattito pub-blico o più probabilmente per indirizzarlo a una comunità (gli“spirituali”) in un passaggio particolare di quel dibattito, pas-saggio in cui Ubertino doveva sentire particolarmente forte lanecessità di raccogliere testimonianze scritte, ma anche di of-frire la propria biografia come esemplare, nella consapevolezzadi un traguardo decisivo.
Ora: l’esigenza di raccogliere e dare una nuova veste edito-riale a corpora testuali giudicati importanti è attività che si èrecentemente restituita, con argomenti convincenti, a Uberti-no, ed è stato Jacques Dalarun a indicare due momenti crucia-li in cui proprio il frate di Casale s. Evasio sarebbe all’originedi iniziative del genere 79. La prima riguarda l’edizione dellaCompilatio assisiensis al margine del Concilio di Vienne. Syl-vain Piron ha definitivamente dimostrato che la Compilatioconsiste nell’edizione e la mise à jour dei famosi rotuli o dellefiches di frate Leone 80; Dalarun ha approfondito il dossier rap-
79 Mi riferisco soprattutto alle ipotesi avanzate in J. DALARUN, Plaidoyer pourl’histoire des textes. À propos de quelques sources franciscaines, in Journal des Savants,2007, pp. 319-358, e ID., Pourquoi le Miroir de perfection fut achevé le 11 mai 1317,in Etudes franciscaines, 4 (2011), pp. 29-48.
80 Cfr. S. PIRON, Introduction, in François d’Assise. Écrits, Vies, témoignages, dir. J.DALARUN, Paris, 2010, pp. 2677-2683; ma si veda, sul tema dei materiali leonini,
ANTONIO MONTEFUSCO62
presentato dai manoscritti 572 et 342 della biblioteca del sa-cro convento di Assisi e il 1046 della Biblioteca comunale diPerugia, originariamente parte di un codice unico, testimonidi un’antologia testuale comprendente il Liber di Angela daFoligno accanto alla Compilatio, al De contemptu mundi di Isaccodi Ninive e un corpus di bolle pontificie riguardante l’ordinefrancescano 81. Tenendo presenti gli spostamenti di Ubertinotra Avignone e l’Umbria in questo periodo, si può ipotizzareche la raccolta venisse pensata e commissionata, probabilmen-te, ai copisti che operavano nel Sacro Convento nel 1308, iquali poi la terminarono prima del 1310. Ubertino ebbe pro-babilmente la possibilità di tornare a consultare il volume pri-ma del 1311, perché nell’agosto di quest’anno ricorda, nellaDeclaratio, che un libro di Frate Leone è conservato in un ar-madio del sacro convento di Assisi, mentre i rotuli sono final-mente con lui a Vienne 82. Potrebbe questo essere individuatocome un momento in cui Ubertino propone una edizione del-l’AV, probabilmente destinata agli “spirituali”; diversi ele-menti contribuiscono a rendere l’ipotesi suggestiva: un gruppodi copisti era impegnato già in attività di trascrizione in unluogo ove era possibile reperire materiale librario utile 83; l’u-
A. BARTOLI LANGELI, Gli autografi di frate Francesco e di frate Leone, Turnhout, 2000(Corpus christianorum. Autographa Medii Aevi, 5), pp. 99-100.
81 ID., Il codice di Assisi, ovvero il “Liber sororis Lelle” in Angèle de Foligno. Le dos-sier cit. (nota 55), pp. 7-27; P. STIRNEMANN, Les livrets associés au Liber sororis Lelle,in Revue d’histoire des textes, 32 (2002), pp. 285-286; DALARUN, Plaidoyer pour l’hi-stoire des textes cit. (nota 72), pp. 336-345.
82 Così Dalarun interpreta, cautelativamente, il passaggio della Declaratio in cuisi fa per la prima volta riferimento a un liber di Leone: « Omnia tamen patent persua verba expressa que per sanctum virum Leonem eius sotium tam de mandatosancti patris quam etiam de devotione predicti fratris fuerunt solempniter con-scripta in libro, qui habetur in armario fratrum de Assizio et in rotulis eius, quosapud me habeo, manu eiusdem fratris Leonis conscriptis, in quibus optime beatiFrancisci intentio quoad paupertatem regule declaratur contra omnes abusiones ettransgressiones ». Si tratta forse dell’edizione dei rotuli nel ms. 1046 di Perugia.
83 Sull’esistenza di un cripto-scriptorium, che avrebbe realizzato materiale come
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 63
tilizzo di termini “redazionali” nel 1Pro (dal « fasciculus » al« parvuum libellum ») troverebbero nuova luce in questo con-testo di impegno editoriale; così anche il riferimento a Angelada Foligno, ma a tutte le figure contemplative mobilitate nel-la costruzione biografica del 1Pro, si arricchiscono in concre-tezza se affiancate alla copia del Memoriale e delle Instructionesdi Angela nel manoscritto assisano 342.
Ma poiché siamo nel campo dell’indiziario, bisogna tenereaggiuntivamente presente anche che il 1308-1311 non è l’u-nico periodo in cui Ubertino è impegnato in questa attività dicopia e raccolta di materiale francescano; aggiungo poi un ele-mento che mi pare renda la datazione a questo periodo diffi-coltoso: la critica a Olivi, che nel 1Pro mi pare diversa, perargomenti e tono, dalla sua apologia nella Sanctitati apostolice.
Su questo punto mi permetto di sviluppare un’ulterioreipotesi che prendo in prestito sempre da Dalarun: precisamen-te nel 1317 si realizza una nuova iniziativa editoriale, che ri-guarda questa volta la redazione dello Speculum perfectionis sta-tus fratris minoris (il cosiddetto Speculum majus). Di nuovo, die-tro l’operazione potrebbe profilarsi l’attività di Ubertino, co-me mostra la consonanza dello Speculum – che consiste, ingran parte, in una rielaborazione della Compilatio – con le ideedello “spirituale”. Si può anzi affermare che queste idee foto-grafate al 1317 sono sovrapponibili alla tessitura ideologicadel 1Pro: mi riferisco innanzitutto al concetto di “speculum”come modello di comportamento del vero frate minore, chenel 1Pro è sottintesa all’immagine retrospettiva dell’Ordinequale agente di soffocamento e corruzione dell’ispirazione cri-stologica invero innata in Ubertino. Si tratta di una peculiare
il Memoriale di Angela, in N. GIOVÉ MARCHIAROLI, Il codice francescano. L’invenzione diun’identità, in Libri, biblioteche e letture dei Frati mendicanti (secoli XIII-XIV). Atti delXXXII Convegno internazionale (Assisi, 7- 9 ottobre 2004), Spoleto, 2005 (Attidei Convegni della Società internazionale di studi francescani e del Centro interu-niversitario di studi francescani, Nuova serie, 15), pp. 376-424.
ANTONIO MONTEFUSCO64
declinazione della dialettica tra perfectio e infectio che è pervasi-va nello Speculum, tanto più nei punti in cui viene manipolata,con tecnica a intarsio, la fonte principale, cioè la Compilatio,per mostrare il pericolo insito nel tradimento della regolaoperato soprattutto dai cattivi prelati e soprattutto dai fratistudiosi 84: sono due temi che coincidono, effettivamente, conla visione e il programma di Ubertino.
Se è possibile dare un rinforzo a quest’ultima possibilità(che, delle due, è quella che più convince lo scrivente), è benericordare di nuovo l’ipotesi di Dalarun, per il quale è alla vi-gilia (e non in risposta) della emanazione della Sancta Romana(30 dicembre 317) e della Gloriosam ecclesiam (23 gennaio1318) che ambienti probabilmente vicini a Ubertino ripropo-sero un lavoro editoriale comparabile a quello realizzato all’e-poca di Vienne, addirittura accorpando un materiale che, asso-ciando gli opuscula di Francesco e testi leonini e dei compagni,riunivano per la prima volta i materiali inviati dai 3 compa-gni nel 1246. Ubertino è ormai considerato il frate specializ-zato nel raccogliere materiale utile per le ragioni degli “spiri-tuali” e aggiornarlo opportunamente al momento dato: inquesto caso si tratterebbe delle speranze suscitate all’indomanidel conclave di Lione e all’inizio del pontificato di GiovanniXXII (eletto nell’agosto del 1316), quando cominciarono leconsultazioni che condussero al pronunciamento pontificio an-ti-spirituale. Proprio in questo momento, Ubertino e Angelosembrano « molto vicini » 85, come attesta la lettera 14 dell’e-pistolario del Clareno, databile al 1317. In essa, si fa riferi-mento al fatto che, durante il conclave di Lione, alcune letteree suppliche rivolte ai cardinali in curia non erano state pre-sentate al papa, per evitare problemi; esse però erano stateconservate da Ubertino, che si profila dunque come il frate
84 ANONIMO DELLA PORZIUNCOLA, Speculum perfectionis status fratris Minoris, I, éd.D. SOLVI, Florence, 2006 pp. XXX-XXXV.
85 VIAN, Angelo Clareno e Ubertino da Casale cit. (nota 8), p. 186.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 65
deputato non solo alla selezione accorta del materiale, ma an-che alla sua conservazione: « Littere vero viri sancti dominiPhilippi [Filippo di Maiorca, ndr] [...] statim date fuerunt etreliquas frater Ubertinus retinuit » 86. Ciò significa che, anchese Ubertino era in curia e lo Speculum perfectionis era stato com-pilato alla Porziuncola, esso poteva inserirsi in questo febbrilecontesto di contatti e progetti che, per un momento, unificòil mondo dello spiritualismo francescano.
Come che sia, importa sottolineare un ultimo elemento:anche la lettera 14 di Clareno è una lettera di natura “auto-biografica”, com’è noto: è lì che si colloca, secondo la feliceformula di Potestà, la “svolta” di Angelo per il quale, final-mente in maniera esplicita, non conta più il « nomen » fran-cescano, ma la « res ». Per avvalorare la contrapposizione, èaddirittura convocato Francesco in persona: « Propheta igiturfuturorum Franciscus sciebat se reprobandum a suis nominesed non re. [...] Unde magistros principaliter et prelatos nomeoridinis pro pallio assumpturos ad suis sensus nequitiam con-tra veritatem celitus sibi date Regula convelandam intelligens,[Franciscus, ndr] nomen ordinis non amabat. Nec voluit quodsua religio vocaretur ordo minorum, sed vita minorum » 87.Direi che è su questo sfondo di consonanza ideale che si puòleggere l’incipit del 1Pro. Come abbiamo detto, qui Ubertinosi presenta come « magis nomine quam re, ordinis beati Fran-cisci professus », piegando la dittologia clareniana in un sensodi umiltà, ma aderendovi completamente. Si tratta di unaconsonanza piuttosto limitata nel percorso dei due leaders de-gli “spirituali”, i quali, come si sa, proprio sul tema dell’ap-partenenza all’Ordine erano apparsi divisi fin dal 1294; invecequesta vicinanza quasi fino alla sovrapposizione si può datare
86 ANGELI CLARENI Epistula fratri G. et fratri N. et omnibus eorum sotiis [n. 14], inID. Opera, I, Epistole, éd. par L. VON AUW, Roma, 1980, pp. 76; G. L. POTESTÀ, An-gelo Clareno. Dai Poveri Eremiti ai Fraticelli, Roma. 1990, pp. 128-137.
87 ANGELI CLARENI Epistola cit. (nota 79), 14, p. 74.
ANTONIO MONTEFUSCO66
unicamente in una fase che va dal 1312 al 1317 (data a parti-re dalla quale Ubertino scompare dall’epistolario clareniano).Anzi: secondo Paolo Vian la cancellazione dell’invettiva controla rinuncia di Celestino V e l’elezione di Bonifacio VIII – pre-sente ancora in AV 4,36 – nel borrador risalente al 1312-1316sarebbe motivata proprio dall’intenzione di cancellare quel si-billino richiamo al gruppo di chi all’epoca sbagliò (« quasiomnes erramus »), chi tacendo (lo stesso Ubertino), chi fug-gendo (il gruppo di Angelo), quindi in qualche modo per as-sottigliare le differenze 88. In definitiva, il 1Pro e l’epistola 14di Angelo sono due pezzi coevi del medesimo programma,perseguito coi testi e con l’autobiografismo, per una volta inpiena consonanza; in questa battaglia Ubertino intervenne congli strumenti che egli aveva utilizzato all’epoca di Vienne, ecioè il materiale biografico risalente ai compagni e in partico-lare a Leone. Dopo averlo ritoccato ampiamente negli anni diClemente V e della vacanza papale, anche l’AV venne licenzia-to (per la prima volta) per la pubblicazione, ristretta al mondo“spirituale” a cui si rivolgeva anche Angelo con la lettera 14,e al quale Ubertino mostrava la sua opera e ne spiegava la ge-nesi (anti-intellettuale) esattamente nel 1317.
Dopo le bolle anti-spirituali, una pagina di storia si chiu-de, e le vicende dei due si dividono. Se già a partire dal 1 ot-tobre (quindi addirittura prima della Sancta romana), Ubertinoè assegnato, come benedettino, al monastero di S. Pietro diGembloux, vicino Liegi (e mi chiedo se dopo quella data eglipoteva ancora definirsi professus dell’Ordine dei Minori, addi-rittura insistendo sul nomen), egli tuttavia manterrà addiritturaun certo appeal sul papa; questa situazione si interrompe conla fuga di Ubertino da Avignone nel 1325. In questo periodoche va dal 1317 al 1325, l’approdo del frate sembra quello di
88 VIAN, Angelo Clareno e Ubertino da Casale cit. (nota 8), p. 183 e 187.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 67
un totale pessimismo rispetto alla riformabilità dell’Ordine 89.Questa posizione appare accennata nel 1Pro, ma si accentueràsempre di più fino alla finale concettualizzazione nell’Ego sumvia, ove tuttavia verranno mobilitati materiali e citazioni rac-colti e fatti trascrivere durante le iniziative editoriali del1308-1311 o del 1317: basta ricordare il De contemptu mundidi Isacco di Ninive 90.
4. LO SPIRITUALISMO DI UBERTINO: UN TRATTO “GENOVESE”?
Prima di concludere, passo a studiare un altro e ultimoaspetto legato al periodo di formazione di Ubertino. GiuliaBarone aveva posto la questione già tempo fa: a partire daquando e come Ubertino può essere considerato uno “spiritua-le”, visto e considerato che la sua esperienza è del tutto diffe-rente rispetto a quella di Angelo Clareno 91? La domanda èimportante, e si inserisce nel tema, classico peraltro negli stu-di francescani, riguardante la più generale lettura del fenome-no religioso della dissidenza francescana del ‘200, sulla qualela letteratura scientifica è nettamente divisa fra chi sottolineala compattezza del gruppo, e chi invece si avvia a proporneuna interpretazione più individualizzata e contestualizzata. Daparte mia, credo che i due approcci non vadano eccessivamen-te divaricati: le differenze ci furono, e le personalità che le in-terpretarono ebbero parabole assai diverse; tuttavia va sottoli-neato che l’unità di questo mondo, per quanto possa apparireil frutto di una distorsione della storia e delle sue lettureideologiche, è nondimeno il prodotto di un impressionante
89 DAVIS, Ubertino da Casale cit. (nota 1), passim e in generale gli interventi cita-ti in nota 10.
90 Almeno una decina le citazioni ricordate nella recedente edizione di POTESTÀ,Ubertini de Casali tractatus de altissima paupertate cit. (nota 1), passim.
91 BARONE, Il valore storico del Liber cit. (nota 56), p. 80.
ANTONIO MONTEFUSCO68
meccanismo di repressione del dissenso da parte dell’Ordine,messo in atto piuttosto precocemente 92. Proprio per questo,l’esatta collocazione storica dei protagonisti contribuisce adaumentare la nostra consapevolezza rispetto agli slittamentidella tradizione storica e scientifica.
Rispetto a quanto detto finora, bisogna rilevare che, nel1Pro, la leggera depressione del ruolo di Olivi ha un fortecontrappeso nel ruolo invece centrale concesso a Giovanni daParma. Ricordo di nuovo il lungo brano a lui dedicato nel ca-pitolo III del libro V, dove Ubertino tesse una sorta di legendadel Buralli: la forma adottata si riveste, com’è noto, di un si-gnificato altamente polemico poiché, nonostante il gran nu-mero di miracoli, l’ex ministro non venne mai canonizzato.Ubertino colloca la sua glorificatio nei cieli, polemizzando evi-dentemente verso una chiesa carnale, che non fu in grado diriconoscerne la santità. Vorrei qui ricordare un brano che mipare utile allo scopo di comprendere il peso del personaggioper il casalense: poco prima di ricordare l’incontro con il mi-nistro generale a Greccio, Ubertino afferma che l’identificazio-ne di Francesco con l’angelo del sesto sigillo venne avanzatada Giovanni prima addirittura di quella operata da Bonaven-tura 93. Se la memoria dell’identificazione di Bonaventura era
92 Sulla questione degli spirituali, si vedano i titoli già richiamati, a cui si ag-giunga tuttavia almeno R. MANSELLI, Spirituali e beghini di Provenza, Roma, 1959 eil richiamo ai tre volumi collettivi in Picenum Seraphicum, 9 (1974); Franciscainsd’Oc. Les Spirituels, ca. 1280-1324, Toulouse, 1975; Chi erano gli Spirituali. Atti delIII convegno internazionale, Assisi, 1976. Insiste sulla grande libertà nei rapportitra i leaders anche L. VON AUW, Angelo Clareno et les Spirituels italiens, Roma,1979. Sulla repressione dei movimenti di dissidenza e l’uso della prigione, mi per-metto di rinviare al mio Repenser les “Spirituels”. Auto-exclusion, répression et identitédissidente dans la tradition monastique et franciscaine, in Words and images in Exiles, inpress.
93 « Hic autem plenissime asserebat, sicut et ego auribus meis indignis ab eiussancto ore audivi, quod sextum signaculum in Francisco et eius statu accipiat or-tum et quod in confusione vite et regule sue per transgressores filios et eius faven-tes malos prelatos debebat iniquitas ecclesia consumari. » AV, V, 3, f. 422.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 69
ricordata attingendo a piene mani dalla Lectura super Apocalip-sim di Olivi, in questo caso la fonte è diretta per Ubertino,che dice di aver ascoltato la cosa con le sue orecchie inde-gne: 94 trovo questo passaggio di grande significato, perchésembrerebbe nuovamente posizionare in parallelismo due cop-pie, Olivi-Bonaventura, da una parte, e dall’altra lui stesso inrapporto con Giovanni da Parma.
A mio parere, questo si può definire come un tratto tipi-camente “genovese” del casalense. Nella mia proposta di rico-struzione biografica, il convento ligure che per primo accolseUbertino tra le sue mura acquisisce nuovamente un’importan-za forte nella formazione del frate. Esso, tuttavia, oggi nonesiste più: situato in località Castelletto, a Genova, il più an-tico convento francescano genovese è stato quasi totalmentedistrutto a inizio secolo. Non solo: rispetto a casi ben più for-tunati (e che riguardano il nostro Ubertino, come Santa Crocea Firenze, per esempio), di questo convento e del suo studiumnon abbiamo alcuna traccia in termini di patrimonio librario;il fondo manoscritto, infatti, che dovette essere trasferito allaUniversitaria di Genova in epoca di soppressioni napoleoniche,è purtroppo andato completamente disperso 95.
94 POTESTÀ, Ideali di santità in Ubertino e Angelo cit., pp. 103-137: 114-115; sitenga presente che nella seconda redazione il testo su Giovanni scompare quasi deltutto: cfr. MARTINEZ RUIZ, De la dramatizacion de los acontecimientos cit. (nota 5), chetuttavia non ne fornisce alcuna spiegazione, p. 165, n. 46; peraltro, il paragrafo suGiovanni da Parma ne sottolinea ampiamente l’importanza.
95 Per la storia del convento, si veda A. CASINI, Cento conventi: contributi alla Sto-ria della provincia Franciscana Ligure, Genova, 1950, pp. 319-325; notizie più ag-giornate, con riferimenti allo studium e ai ministri, in J. R. H. MOORMAN, MedievalFranciscan Houses, Franciscan Institute, St Bonaventure, 1983, e soprattutto L. PEL-LEGRINI, Insediamenti francescani nell’Italia del Duecento, Roma, 1984, s.v. Per la storiacontemporanea, la soppressione e la storia del fondo librario, vedi G. ABATE, Mano-scritti e biblioteche francescane del Medioevo, in Il Libro e le biblioteche. Atti del primocongresso bibliologico francescano internazionale (Roma, 20-27 febbraio 1949),Roma, 1950, II, pp. 111, n. 56. Per il contesto librario e culturale genovese dell’e-poca, cfr. G. PISTARINO, Libri e cultura dei monasteri genovesi (sec. XIV-XVI), Barcel-
ANTONIO MONTEFUSCO70
Ciò è molto deludente, da una parte perché si vorrebbecapire di più e meglio se il convento fosse o meno significati-vo, per insediamento e rapporti con la città. La delusione ètanto più forte perché si vorrebbe collocare tale luogo e la suarete intellettuale e sociale nel contesto della Liguria duecente-sca, che fu sede di un rinnovamento letterario in latino dienorme spessore. Si dovrà guardare alla produzione annalisticadi un Caffaro, a quella poetica del notaio di Sestri Ursone e alcapolavoro della letteratura religiosa di Iacopo da Varrazze percomprendere più compiutamente la scrittura di un’opera comel’AV 96. Se messo a confronto con questi prodotti ad essa qua-si contemporanei (ciò che imporrebbe, per inciso, una rinno-vata attenzione al testo anche con strumentazione squisita-mente letteraria), si apprezzerà meglio quanto esso risulti ca-ratterizzato da una lingua complessa e da un’architettura“moderna”.
Se questo ci è, allo stato attuale, precluso, non è inveceimpossibile ricostruire un profilo dello studium del convento ametà Duecento: un quadro che è caratterizzato da elementiche contribuiscono almeno in parte a enucleare una tradizione
lona, 1978, e G. PETTI BALBI, Libri e biblioteche in Liguria (secc. XIII-XIV). Ricogni-zioni delle fonti e tipologia, in Libri, lettori e biblioteche dell’Italia medievale (secc. IX-XV). Fonti, testi, utilizzazione del libro, Roma, 2000, pp. 441-454. Nessuna infor-mazione trovo in W.H. HUMPHREYS, The book provisions of the mediaeval friars, 1215-1400, Amsterdam, 1964, così come anche negli attuali strumenti di interrogazionedel patrimonio manoscritto sia italiano (mi riferisco in particolare al database Ma-nus, in via di incremento e oggi consultabile on-line: http://manus.iccu.sbn.it/) siain particolare genovese. La destinazione naturale sarebbe stata quella della Bibliote-ca Universitaria della città, ma nessun codice ivi conservato risale al convento, sul-la quale si veda almeno E. CELESIA, La Biblioteca Universitaria di Genova. Cenni storicidalle origini fino al 1883, Genova, 1884, e U. MONTI, Biblioteca Universitaria, inL’Università di Genova, Genova, 1923.
96 A. BELTRAMI, Gli scrittori latini della Liguria medievale, in Il Comune di Genova,III (1923), pp. 651-653; A. GIUSTI, Lingua e letteratura latina in Liguria, in Storia diGenova, II, Milano, 1941, pp. 329-346 e più recentemente Storia di Genova. Medi-terraneo, Europa, Atlantico, a cura di D. PUNCUH, Genova, 2003.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 71
intellettuale che dovette avere un’importanza particolare per ilnostro Ubertino. Informazioni preziosissime vengono da Sa-limbene da Parma, che trascorse a Genova quasi un anno, ri-cevendo qui l’ordinazione sacerdotale. Il soggiorno ligure delfrate si colloca nel 1249, ed è il punto di approdo del famosoviaggio che il frate parmense intraprese all’età di 26 anni, in-viato in Francia dal proprio ministro provinciale presumibil-mente per motivi di studio (anche se il passaggio per Parigifu per lo più di natura “turistica”). Il concittadino Giovannida Parma, incontrato a Tarascona durante questo viaggio, de-cise di inviare Salimbene e un altro manipolo di frati al con-vento genovese 97. Si trattava di decisione meditata, motivatadal fatto che Giovanni aveva un rapporto privilegiato non solocon il convento (ove, pochi anni prima, si era svolto un capi-tolo generale), ma anche con il suo studium. Lo dimostra il ca-so del lector Stefano d’Inghilterra, che aveva incontrato Gio-vanni a Beaucaire (ove era anche Salimbene) e gli avevaespresso il desiderio di essere inviato come lettore allo studiumdi Roma. A causa però di una carenza di insegnanti a Genova,fattagli presente da due frati del convento, il ministro genera-le decide di inviare Stefano in Liguria, dove il lettore inglesearriverà a piedi, al contrario di Salimbene che aveva optatoper un più comodo viaggio via mare 98.
97 J. PAUL, Il viaggio, in ID., MARIANO D’ALATRI, Salimbene de Parma, Roma,1992, pp. 147-163.
98 « [Il ministro generale Giovanni da Parmai, ndr] visitaverat Angliam, Franciamet Burgundiam, et Provinciam et Hyspaniam visitare volebat. [...] Et invenimuseum Tarasconi. [...] In crastinum [...] cumque ibi [a Beucaire] essemus, supervene-runt duo fratres ex Anglia, scilicet frater Stephanus lecotr, qui puerulus intraveratOrdinem beati Francisci, et erat pulcher homo et spiritualis et litteratus et opti-mus in consiliis dandis et cotidie paratus ad predicandum clero [...] Huic promise-rat frater Iohannes de Parma, generalis minister, cum Angliam visitasset, quodmitteret eum Romam ad legendum pro consolatione sua . [...] Supervenerunt duoalii fratres rogantes generalem ut provideret coventui Ianuensi de uno bono lectore.[...] Tunc generalis [...] fratri Stephano dixit: “[...] Si placeret vobis ire illuc ad le-gendum, multum haberem pro bono; et ego, cum illuc venero, mittam vos Ro-
ANTONIO MONTEFUSCO72
Il lettore è descritto dal cronista come « pulcher homo etspiritualis et litteratus et optimus in consiliis dandis et coti-die paratus ad predicandum clero. » L’espressione optimus inconsiliis dandis ne fa una sorta di “doppio” di Giovanni, alquale è spesso attribuita nella Cronaca 99. Stefano, infatti, è ungrande predicatore, che diventerà famoso, a Genova, per averpiù e più volte attaccato coraggiosamente e frontalmente ilvescovo locale ma anche altri grandi prelati perché amanti dellusso: la sua figura sembra, in questo, prendere una curvatura“rigorista” 100. Il quadretto a lui dedicato nel De adventu fra-trum in Anglia di Tommaso da Eccleston conferma quest’im-pressione, legando la sua vocazione alla predicazione alla figu-ra Petrus Hispanus, la cui predica agli uccelli convince il giova-ne Stefano a rimanere nell’Ordine; nel testo di Tommaso sem-bra quasi ristabilita una catena carismatica che risale fino a unfrate che incarna la tipologia del compagno di Francesco nellalontana provincia inglese 101.
mam.” Cui respondet frater Stephanus: “Pater, consolatorie et libenter paratus sumobedire vobis.” [...] Per totum diem navigamus et [...] intravimus portum Ianuen-sem.[...] Et letati sunt fratres, quando viderunt nos et specialiter frater StephanusAnglicus, qui erat lector; quem postea generalis minister misit Romam, sicut pro-miserat sibi; et fuit lector in conventu Romano et ibi obiit cum socio suo fratreIocelino, propterquam compleverunt desiderium suum ut Romam et sanctuariaRome viderent. » SALIMBENE DE ADAM, Cronica, edidit G. SCALIA, Turnholti,MCMXCVIII, I, pp. 453-455, 480.
99 Cfr. Ibidem.100 Si pensi al sermone rivolto contro il vescovo di Rieti perché aveva preteso
che i frati si inginocchiassero di fronte a lui durante il pranzo: in questo caso, ilfrate, utilizzando le risorse della retorica a scopi edificanti, sembra incarnare a tuttigli effetti un’idea di scientia del tutto sovrapponibile a quella attribuita da Salim-bene al ministro parmense. Cfr. ibid., p. 455 ss.
101 « Venit quoque in Angliam Frater Petrus Hispanus, qui fuit postea gardia-nus Northamtonae, qui lorica utebatur ob carnis illecebras edomandas. Hic novi-cium quendam in conventum suo habuit, qui temptabatur exire ordinem: a quovix tandem obtinuit ut ad ministrum secum ire vellet. Cum igitur incederent perviam incepit Frater Petrus praedicare ei de virtute sanctae obedienatiae; et ecceavis quaedam silvestris praecessit eos ambulantes in via. Dixit ergo novicius, Ste-
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 73
La predilezione del Buralli per il convento di Genova non èsorprendente, se pensiamo al fatto che la candidatura e l’elezionedi Giovanni a generale realizzata nel capitolo generale di Lionedel 1247 fu sostenuta soprattutto da « lombardi ministri », comeci avverte il solito ben informato Salimbene (intendendosi, conl’espressione, molto probabilmente i ministri dell’Italia centro-settentrionale) 102. L’invio di Stefano presso lo studium ligure el’attenzione a esaudire un suo desiderio di raggiungere Romapossono invece trovare una spiegazione nel particolare apprezza-mento che il generale esprimeva per quella provincia inglese « ri-tenuta esemplare » 103. Ma messo da parte il quadro dell’attivitàdi un generalato che non a caso si caratterizzò per un tentativodi equilibrio tra le anime francescane ultra e citra montane, ciòche più mi preme suggerire è l’esistenza di una tradizione intel-lettuale, presumibilmente cristallizzata in memoria locale, che glieventi post-1274, e i suoi interpreti spirituali, potevano aver in-terpretato come una sorta di avatar, di antecedente di una certainterpretazione dell’eredità francescana. In un gioco di specchi, ilministro generale parmense, sempre prodigo di consigli per isuoi frati, torna a farlo dal suo ritiro a Greccio per Ubertino, do-po avergli indicato l’esatta interpretazione escatologica di France-sco d’Assisi, e con la sua morte consente al casalense di superarele sue incertezze e di prendere una direzione decisiva. In questa
phanus nomine, ad fratrem Petrum, “Pater, si sic est, ut dicis, praecipe per virtu-tem obedientiae ut capiam avem hanc silvestrem, ut ipsa expectet me”. Qui cumsic fecisset, statim stetit avis, et accessit novicius, et tenui team et tractavit sicutvoluit: et statim sedata est omnis temptatio sua, et immutavit ei Deus cor aliud,et rediit statim Northamtonam, et professus est perseverare, et postea factus estpraedicator egregius, sicut ipse vidi ». Tractatus fr. Thomae vulgo dicti de Eccleston Deadventu fratrum minorum in Angliam, edidit notis et commentario illustravit A. G.LITTLE, Paris, 1909, pp. 98-99.
102 SALIMBENE, Cronica cit. (nota 91), p. 803.103 G. G. MERLO, Questioni intorno a frate Giovanni da Parma, in Giovanni da Par-
ma e la grande speranza. Atti del 3. Convegno storico di Greccio, a c. di A. CACCIOTTI,M. MELLI, Milano, 2008, pp. 58-59.
ANTONIO MONTEFUSCO74
decisione sembra agitarsi il fantasma di Stefano d’Inghilterra,umile peccatore che diventa fustigatore dei prelati e desidera unsoggiorno romano che lo stesso Ubertino aveva attraversato perarrivare a Greccio. L’incontro con Olivi fornirà un costrutto teo-rico solido, seppure estremamente legato alla situazione duecente-sca, che permetterà a quel tratto “genovese” di chiarificarsi inuna peculiare lettura dello “spiritualismo” francescano, la quale,nella esperienza ubertiniana, si allaccerà definitivamente ai “pre-cedenti” di quella lotta, sia nelle figure (con Giovanni) sia nelladocumentazione (e penso qui alle iniziative editoriali di Uberti-no), contribuendo a proiettarla fino alle origini francescane.
In questo quadro, Genova, seppur apparentemente perife-rica, sembrerebbe diventare, per il tramite di Giovanni, unasorta di contrappunto rispetto agli altri due grandi centri fre-quentati da Ubertino. Parigi è senz’altro il luogo dove i fratifrequentano lo studium per poter scalare le carriere nell’Ordine,e non per amore del sapere; in quel contesto - descritto conestrema precisione da Courtenay - caratterizzato da uno spac-cato sociale di natura fortissimamente selettiva, i frati, dotatidi camera propria e socius, imparavano ad odiare, letteralmen-te, l’usus pauper, fermentando quindi la relaxatio rispetto alprogetto originario di Francesco 104. Ma se il centro universita-rio francese diventava così, essenzialmente, l’obiettivo di unapolemica tutta rivolta al ruolo della scientia nell’Ordine, l’e-sperienza fiorentina – ben distante dal modello irenico de-scritto da Manselli – aveva tutti gli aspetti del trauma 105. Ilconvento toscano è il vero obbiettivo, negli scritti del 1310-1311, di una sorta di “campagna” di Ubertino, che aveva rite-nuto i tentativi di riforma a opera del generale Gonsalvo nel
104 COURTENAY, The instructional programme of the Mendicant Convents at Paris cit.(nota 51); ID., The Parisian Franciscan Community in 1303, in Franciscan Studies, 53(1993), pp. 155-173.
105 R. MANSELLI, Firenze nel Trecento: S. Croce e la cultura francescana, in Clio, 9(1973), pp. 325-342, poi in ID., Scritti sul Medioevo, Rome, 1994.
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 75
1304 troppo deboli per cambiare una situazione che si dimo-strava, ai suoi occhi ma anche alla realtà, caratterizzato da unaserie così lunga di infrazioni alla regola da istituirsi quasi co-me un anti-convento per eccellenza. Nelle parole di Ubertinodunque si affiancano le accuse di appropratio locorum completa-mente contrario allo spirito francescano, perché rafforzato tral’altro da un rapporto con i propri parenti che si mantenevaforte e che rendeva Santa Croce un luogo in cui si riproduce-vano le divisioni socio-politiche della città; per non dire poidella “malattia della pietra”, che qui prese la forma di unaconcorrenza coi domenicani di Santa Maria Novella, producen-do uno dei più grandi conventi dell’Italia due-trecentesca, lacui magnificenza non trovava ragion d’essere nella eventualepresenza della sepoltura di santi. E infine il carrierismo legatoagli studi, che a Firenze produceva un’élite inamovibile senzaalcuna, come diremmo oggi, produttività scientifica 106.
Non è un caso, infatti, che i fiorentini non ricambierannoUbertino con una grande simpatia. Durissimo, come si sa, sa-rà Dante, unendo nella stessa condanna due frati che ebberouno stretto rapporto con la città. Per questo motivo, oltre allemotivazioni dottrinali invocate da ultimo da Ovidio Capitani,sarà anche da pensare a un sottofondo fiorentino nell’accennodel Paradiso 107. Vale la pena infatti di interrogarsi se l’Ali-ghieri non abbia avuto motivo di rimostranze verso Ubertinoproprio in ragione di quel preciso attacco al convento in cuiera frate il nipote Bernardo Riccomanni, che era rimasto unodei pochi legami attivi in città per il rientro del bandito 108.La memoria del frate come “campione” degli spirituali nel
106 L’articolo di riferimento è S. PIRON, Un couvent sous influence. Santa Croce au-tour de 1300, in Économie et religion. L’expérience des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècle),éd. par N. BÉRIOU, J. CHIFFOLEAU, Lyon, 2009, pp. 321-355.
107 O. CAPITANI, L’allusione dantesca a Matteo d’Acquasparta, in Matteo d’Acquaspar-ta francescano, filosofo, politico. Atti del XXIX Convegno storico internazionale (To-di, 11-14 ottobre 1992), Spoleto, 1993, pp. 291-310.
108 Renato Piattoli avanzò l’identificazione del pater a cui è rivolta l’epistola XII
ANTONIO MONTEFUSCO76
complesso e ricchissimo corpus di scritture volgari da far risali-re ai fraticelli fiorentini della fine del Trecento è probabil-mente frutto di una tradizione risalente agli “spirituali” e nonautoctona 109.
5. CONCLUSIONE
Se è lecito proporre alcune parole conclusive, bisogna quitirare le somme di una serie di prospettive che secondo mevale la pena ancora approfondire. La formazione “giovanile” diUbertino è apparso un oggetto opaco, sul quale l’auto-narra-zione del frate ha profondamente complicato la ricostruzionebiografica. Sicuramente il completamento dell’edizione criticaci dirà di più e meglio sul testo che questa auto-narrazionetrasmette: resta però forte l’esigenza di un forte tasso di iudi-cium nel trattamento dei dati che vi emergono. Fra essi, l’enu-clearsi, sia pure deduttivo, di un’importanza del soggiorno ge-novese mi sembra sicuramente il dato che più attende un ap-profondimento: magari soprattutto in vista di una più com-
di Dante, proprio con il nipote, vedi la voce Amico fiorentino, in Enciclopedia dante-sca, Roma, 1970, s.v.
109 Faccio riferimento al ms. Firenze, Biblioteca Nazionale centrale, Magl.XXXIV.76 [XIV sec. ex.], parzialmente pubblicato in F. TOCCO, Studi francescani,Napoli, 1909, passim, ove non solo si ricorda (testimone unico in volgare; la versio-ne latina è in München, Staatsbibliothek, Lat. 10546, fol. 144v-145v; un fram-mento è presente nel codice Paris, BnF, Lat. 14195) la Responsio orale di Ubertinoa Giovanni XXII (ff. 29-30). Vi si afferma anche: « Per non tractare troppo lungo,lasceremo tucti gli altri spirituali e oservatori della Regola evangelica ch’erano spar-ti per l’Ordine in diversi luoghi e parleremo alcuna cosa de’ discepoli di fra PierGiovani Olivi da Nerbona e de’ suoi adoctrinati i quali furono i principali defenso-ri della doctrina evangelica e aiutatori a cavare gli altri perfecti e spirituali oser-vanti d’essa Regola e doctrina dal diluvio delle eresie del mistico Anticristo e suafatta. [...] De’ quali [...] frate Ubertino da Casale che molto stava in corte per ledecte cagioni era avuto in tanta estimatione che molto era riguardato e però sem-pre stava per principale loro campione » (f. 110).
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 77
piuta, accurata collocazione di un’opera come l’AV, questo en-ciclopedico Roman de la Rose francescano, nel panorama lettera-rio dell’epoca.
Restando ancorati a questo orizzonte genovese, lo spiritua-lismo di Ubertino mi è sembrato, perlomeno nella sua versio-ne originaria, fortemente ancorato a una tradizione locale: le-gato a figure come Giovanni da Parma, il frate diventerà co-sciente di un progetto di “applicabilità” di un francescanesimorigorista a contatto con Olivi, portando con sé l’eredità, forse,di una sconfitta (quella del Buralli) e quindi di un pessimi-smo che si andrà acuendo sempre di più durante la quaestiopaupertatis e allo stesso tempo contribuendo in maniera decisi-va alla proiezioni fino all’origine della religio dello scontro chetormentò l’Ordine dopo Lione. Ubertino contribuì con questospecifico bagaglio memoriale alla battaglia degli “spirituali”,specializzando il suo impegno in operazioni editoriali di gran-de importanza, che a un certo punto si intrecciarono anchecon la (ancora poco chiara) vicenda redazionale dell’AV. Lostile “compilatorio” di Ubertino permetterà a quella cultura(nella sua integrità di memoria di testi e di dottrine) una po-sterità dissidente significativa. Una delle strade più interessan-ti per misurarne l’importanza è senza dubbio alcuno costituitodal complesso delle scritture dei fraticelli, soprattutto quellevolgari che, spesso trascurate dagli storici, sono invece unaminiera inesauribile per ricostruire storia e geografia del mo-vimento dissidente del Trecento fino all’Osservanza.
ANTONIO MONTEFUSCO78
APPENDICE
Tavola 1: LE DUE IPOTESI CRONOLOGICHE
Prima ipotesi 110 Seconda ipotesi 111
1259 Nascita Nascita
1273 Ingresso nell’ordine e noviziato. Ingresso nell’ordine e noviziato
1275-6? Parigi (9 anni) Genova
1285 Firenze: insegnamentoIncontro con Angela da Foligno e Gio-vanni da Parma
Firenze: studioIncontro con Giovanni da Parma
1287 Incontro con Olivi Incontro con Olivi
1289 Predicazione Parigi (9 anni)
1298 Predicazione Incontro con AngelaRientro a Firenze e insegnamento
1302 Predicazione Predicazione
1304 Soggiorno alla Verna Soggiorno alla Verna
110 HUCK, Ubertin von Casale und dessen Ideenkreis cit. (nota 13); KNOTH, Ubertinovon Casale. Ein Beitrag cit. (nota 13); BIHL, Bibliographia cit. (nota 15); MARTINI,Ubertino da Casale alla Verna cit. (nota 16); POTESTÀ, Storia ed escatologia cit. (nota 12).
111 CALLAEY, L’idéalisme franciscain spirituel cit. (nota 11); POTESTÀ, Ubertin de Casalecit. (nota 18); MARTINEZ RUIZ, De la dramatizacion de los acontecimientos cit. (nota 5).
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 79
Tavola 2: CORRISPONDENZE TRA LE DUE CRONOLOGIE E I PASSI DEL 1PRO
Prima ipotesi Seconda ipotesi
Ex decimoquarto anno vite mee, cum multispreambulis desideriis, ad sue vite sacratissimum or-dinem per seraphicum virum Franciscum ab ipsoIesu mire institutum mirabiliter me adduxit, a pa-tre et matre oblatum.
1273 1273
In primis quoque exercitiis sic quasi per .xiiii. an-nosa circa forinseca Iesu me suus spiritus occupabat,nondum me introducens ad altas suas sue mentisperfectiones et inestimabiles cordis sui doloris. Sedtunc romana sanctuaria visitans et ad angelum fa-ciei Iesu vere sanctissimum Ioannem de Parma adrupem deueniens letus [sic, recte Grecii] et, ab ipsoconfortatus absolutus et instructus, in die indul-gentie secunde diei augusti intravi ecclesiam beateMarie de Portiuncola de Assisio, et iuxta eampernoctavi.
a .xiiii. annos] .xiii. vel .xiv annos
1276-1289di cui 9 a Parigi
(vedi sotto)1285 (Roma –Greccio – Assisi)
1273-1285a Genova
Nam ad provinciam Tuscie veniens sub titulo stu-dii, inveni in multis viris virtutis spiritum Iesufortiter ebulire. Inter quos, vir Deo plenus Petrusde Senis, pectenarius, et devotissima virgo Ceciliade Florentia [...] Affuit tunc, cum predictis magi-stris praticis seraphice sapientie, doctor speculativuset Christi vite defensor precipuus, Deo kharissimus,frater Ioannes [sic] Olivi, qui nunc felici transitumut spirito regnat in celis. Qui me modico temporespiritum Iesu preveniente sic introduxit ad altasperfectiones anime dilecti Iesu et sue dilectissimematris et ad profunda scripture et ad intima tertiistatus mundi et renovationis vite Christe.
1285
1287-1289
1285
1287-1289
ANTONIO MONTEFUSCO80
Prima ipotesi Seconda ipotesi
Nam novem annorum spatio quibus legi et Parisiusfui, sic totam reformationem fedaveram, quod piis-simi Iesu mihi per somnium terribiliter apparentisdure iusticiam prouocavi, qui semper invenit et fa-cit causas miserendi mihi. Vigesimoquinto autemanno etatis meae, et modo quem pretereo, ad reve-rende matris et sanctissime Angele de Fulgineo ve-re angelice vite in terris me adduxit notitiam.
a Vigesimo ... meae] Vigesimo quinto anno religio-nis mee, (borrador); Vigesimo quinto anno religionismee deformatae (II red.)
1276?-1285Parigi1285
Angela da Foligno(sed Bihl: 1289)
1289-1298Parigi1298
Angela da Foligno
Et circa quadriennium tamen legi, et post hec om-nia priora reliquens soli Iesu predicationi intendi.In qua super admirando Dei beneficio propter te-stimonium veritatis quam coram clero et populmultitudine perusina pluries predicando exposui se-miplene quam in hoc libro plenius expressi subcuiusdam persecutionis titulo, predicationis imposi-to silentio, ad solitudinis locum deductus sum sa-crum qui dicitur Mons Alvernae.
1285-1289et post 1289
1304
1298-1302et post 1302
1304
Tamen potissimum adiutorium et confortamentumin scribendo secure fuit vere dicate amori Iesu duceprudentissime virginis vere sponse Christi de Civi-tate Castelli [...] Et dum infirmarer de febre et cre-derem libri per hec impediri scripturam, sic ad eiuspromissionem ex parte Iesu convalui subito quodmihi statim preparato optimi fratris et nuncii auxi-lio fere medietatem huius libri, et quasi totam dif-ficultatem in ultimo trium predictorum mensiumcompilavit spiritus Iesu Christi. Et iuxta quod ipsapredixit dans mihi terminum mensis septembris:illo mense terminavi in vigilia Michaelis archangelianni presentis. M. CCC. V . a felicissimo ortu verisolis Iesu. A mea in vero vili conversione anno .xxxiii.
1305, 32° dellaconversione
1305, 32° dellaconversione
AUTORITRATTO DEL DISSIDENTE DA GIOVANE 81
Tavola 3: CRONOLOGIA 1 BIS
1259 Nascita
1273-1276 Genova
1276-1280 Parigi (o Firenze)
1280-1285 Genova (o Parigi)
1285 Giovanni da Parma
1285-1289 Firenze
1285? 1289? 1298? Angela
1304 La Verna






























































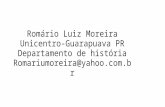

![2-[Eva Fedi]-Formazione “Aree Comuni” Operatori Sportivi [Eva Fedi]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63209e83c5de3ed8a70dcef1/2-eva-fedi-formazione-aree-comuni-operatori-sportivi-eva-fedi.jpg)