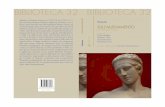Arnoldus-Huyzendveld A., 2005 - Il paleoambiente storico di Grosseto.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Arnoldus-Huyzendveld A., 2005 - Il paleoambiente storico di Grosseto.
62
7. IL PALEOAMBIENTE STORICO DI GROSSETO
Il presente contributo propone una ricostruzione morfologica e paesag-gistica del luogo della città di Grosseto, in base ai dati geologici, pedologici ed archeologici a disposizione. Varie pubblicazioni trattano gli aspetti geologici dell’area1, mentre il testo di Stea e Tenerini del 1996 offre un quadro esau-stivo dell’ambiente naturale della piana di Grosseto e della sua evoluzione a partire dalla preistoria.
Una serie di nuovi dati ci consentono di proporre una ricostruzione della morfologia originaria della città più dettagliata di quanto finora possibile, ed inoltre, di formulare un’ipotesi relativa ad alcuni aspetti paleoambientali dell’area della città. Si tratta di nuovi dati relativi alle quote del substrato del centro storico, raccolti in occasione degli scavi archeologici effettuati tra 1998 e 2005, ed inoltre della Carta dei Suoli della piana di Grosseto di SEVINK et al. 1986, un lavoro non considerato nei testi precedenti.
Come risulta dalle carte geologiche e topografiche2, ma anche da un sem-plice sopralluogo, il centro storico di Grosseto si trova su una modesta altura, posta ad una quote di alcuni metri sopra il fondovalle del fiume Ombrone e direttamente ad esso adiacente. Il substrato geologico dell’area è composto da un conglomerato sciolto di origine fluviale3, che costituisce un terrazzo lievemente ondulato, esteso fino ai piedi di Poggio Moscona e dei rilievi di Montepescali. Verso ovest e sud il terrazzo scende di quota da ca. 15 a 5 m slm, quindi non sempre è sollevato rispetto ai depositi lagunari e fluviali che lo circondano. In direzione del mare, l’unità morfologica si stringe sensibil-mente, fino a formare l’allineamento del Querciolo e del Poggiale4, posti a quote poco superiori della piana costiera circostante.
1 MOTTA 1969, BRAVETTI, PRANZINI 1987, BELLOTTI et al. 1999, BELLOTTI 2000, BELLOTTI et al. 2004, SGHERRI, COSTANTINI 2004.
2 Foglio 128 Grosseto in scala 1:100.000 del Servizio Geologico d’Italia; carte topogra-fiche dell’I.G.M. in scala 1:25.000; C.T.R. della Toscana in scala 1:10.000.
3 Probabilmente del tipo conoide alluvionale. La formazione è contrassegnata dalla sigla acg sul foglio geologico Grosseto, ed inclusi tra i «sedimenti alluvionali ed eluviali, attuali e recenti», MOTTA 1969, p. 56. BRAVETTI, PRANZINI 1987, p. 90, considerano probabile una loro attribuzione al Pleistocene superiore.
4 Secondo BRAVETTI, PRANZINI 1987, pp. 88-89, forse fino a Pingrosso.
© 2005 Edizioni all’Insegna del Giglio s.a.s., vietata la riproduzione e qualsiasi utilizzo a scopo commerciale
63
In occasione degli scavi archeologici si è potuto notare che il substrato su cui poggia la città è composto dal cosiddetto cecino, un termine che si riferisce ad un terreno indurito e ricco di concrezioni calcaree. Nelle note illustrative della citata carta dei suoli, i terreni direttamente intorno alla città5 vengono descritti come profondi, di colore giallastro, con presenza di noduli carbonatici, a tessitura fine, molto duri quando asciutti e poco permeabili. L’orizzonte superiore può variare in colore da giallastro e marrone scuro6. Si verifica quindi una notevole concordanza tra il cecino riscontrato negli scavi urbani ed i suoli descritti al di fuori della città. Solo che il cecino degli scavi sembra non tanto corrispondere allo strato organico del suolo originario, ma piuttosto all’orizzonte direttamente ad esso sottostante. Allo scavo della chiesa di San Pietro è stato in un caso effet-tivamente riscontrato, sopra il cecino, un sottile strato7 con materiale archeolo-gico riferibile ad un ampio lasso di tempo, che, a nostro avviso, potrebbe ben rappresentare l’orizzonte superficiale del terreno, cioè la superficie di calpestio e/o di coltivazione dei tempi prima della costruzione della chiesa.
La ricostruzione morfologia di un sito urbanizzato è un’impresa ardua, visto la distribuzione irregolare dei dati riferiti al centro urbano stesso. Ma vale la pena tentare, perché la disponibilità di un modello della forma del terreno su cui poggia la città ci offre non solo l’opportunità di poter interpretare la distribuzione dei siti nelle varie epoche in chiave paesaggistica, ma ci consente anche di prevedere, con una discreta precisione, la situazione stratigrafica in corrispondenza dei nuovi scavi previsti.
Generalmente, la segnalazione dello strato geologico alla base dello scavo ci offre un termine supra-quem per la superficie pre-urbana, dovuto alla concreta possibilità che il substrato geologico sia stato intaccato dall’attività antropica. Il riconoscimento invece dello strato che in epoca pre-urbana ha ospitato la vegetazione, appunto il suolo, come è il caso nella maggior parte degli scavi effettuati a Grosseto, ci offre un indizio più preciso sulla forma originaria del territorio, senza scarti di quota verso l’alto, o con uno scarto comunque stimabile. Nella ricostruzione morfologica altre indicazioni possono generalmente derivare dalla natura (durezza, stratificazione) delle formazioni geologiche locali, che hanno determinato, in antagonismo all’erosione da parte della rete fluviale, la forma e l’inclinazione del terreno. In ultima analisi si può applicare l’analogia con la forma di una porzione del paesaggio con condizioni litologiche paragonabili, posta al di fuori del contesto urbano, possibilmente ad integrazione con quanto ancora intuibile, nell’ambiente urbano stesso, della morfologia di partenza.
5 Trattandosi di un rilevamento dei suoli ai fini agricoli, la carta non si estende all’interno dell’area urbana. SEVINK et al 1986, unità cartografiche G2 e G1b, pp. 77-78.
6 SEVINK et al. 1986 ribadiscono che il colore più scuro potrebbe essere dovuto all’in-fluenza dell’acqua altamente calcarea delle vicine sorgenti.
7 US 12243. Si veda il testo di Vanni infra.
© 2005 Edizioni all’Insegna del Giglio s.a.s., vietata la riproduzione e qualsiasi utilizzo a scopo commerciale
64
Nel caso di Grosseto, il riconoscimento del cecino alla base di molti scavi urbani, interpretato come l’orizzonte intermedio del suolo del territorio rurale, e nello scavo di San Pietro addirittura il riconoscimento del probabile orizzonte superficiale, ci consente di affrontare con un ragionevole grado di fiducia la trasformazione dei dati puntiformi del terreno vergine in curve di livello8, e la successiva trasformazione delle ultime in termini di unità morfologiche.
Per quanto riguarda l’ultimo punto dell’analisi proposta, si osserva quanti dislivelli, lievi ma evidenti, ci riservano ancora oggi le strade del centro della città.
Nella Tav. 8 sono raffigurate le curve di livello del terreno vergine, come risultante dall’interpolazione dei dati puntiformi, che coprono un range compreso tra ca. 4 e 11 m s.l.m. In base alle curve di livello, calcolate con un’equidistanza di 0,50 metri, per primo sono state tracciate i probabili percorsi delle vallate. Successivamente è stata applicata, all’interno di un confine dettato dall’estensione dei dati disponibili, una suddivisione secondo l’altimetria e l’inclinazione delle porzioni del territorio risparmiate dall’inci-sione fluviale (Tav. 9). Nella lettura delle curve di livello in termini di unità di paesaggio, la distinzione di due separate “alture” (unità A) al culmine del pianoro sommitale (S) sembra essere d’obbligo, anche se la loro delimitazione è tuttaltro che certa9. Una presenza indiscutibile crediamo essere quella delle due zone pianeggianti (qui definite come gradoni, unità G) che interrompono le fasce di terreno lievemente inclinate (R) interposte tra il pianoro sommitale e le vallate (V). L’inclinazione dei gradoni è dell’ordine di 0-2%, delle unità sommitali (A/S) di 1-3% e della fascia di raccordo (R) di 2-4%, con valori più alti nella zona occidentale: 4-6%. Si tratta quindi comunque di valori di pendenza molto bassi.
Secondo il modello morfologico che qui si configura, e che conside-riamo per il momento la migliore approssimazione possibile in base ai dati a disposizione, il pendio occidentale del rilievo di Grosseto risulta solcato da almeno tre incisioni laterali, che hanno inizio in corrispondenza dei gradoni. La loro netta espressione sul terreno, cioè la loro leggibilità sulla carta delle curve di livello, (a significare una certa profondità di incisione) suggerisce la possibile presenza di piccole sorgenti a monte. Considerando la relativa ripidità del lato ovest del rilievo, i fossi di queste vallecole sono state inter-pretate come affluenti di un fosso maggiore con direzione di flusso verso sud, di cui appunto la discesa sarebbe il versante sinistro. In base alle curve di livello ricostruite per tutta l’area, si può presumere che quest’ultimo fosso
8 In ogni saggio di scavo dove è stato possibile raggiungere il suolo vergine è stata presa una quota sul livello del mare. In totale abbiamo rilevato 47 punti. Successivamente abbiamo applicato un’interpolazione (Kriging isotropico).
9 Si potrebbe anche considerare, senza forzatura dei dati di partenza, la possibilità di unire le due cime distinte.
© 2005 Edizioni all’Insegna del Giglio s.a.s., vietata la riproduzione e qualsiasi utilizzo a scopo commerciale
65
Tav. 8 – Punti quotati e curve di livello del suolo vergine del centro storico di Grosseto.
trovi la sua origine al di fuori dell’ingombro del centro storico e continui poi verso sud-ovest10.
I lati est e sud del rilievo su cui sorge la città presentano due incisioni vallive con una minore espressione sul terreno, e che potrebbero confluire verso sud-est. Mancano i dati per ricostruire la morfologia della sommità ver-so nord, cioè verso il corpo del terrazzo di Grosseto. Considerando le quote indicate sulla C.T.R.11 e la continuità della formazione sulla carta geologica, è ragionevole presumere che, direttamente a nord del centro storico, i livelli della superficie non riscendono tanto quanto verso sud.
10 Per questo motivo nella figura indicata con una linea tratteggiata.11 Per evidenziare, in fase di elaborazione dei dati, i dislivelli della fascia costiera di
Grosseto, è stata costruito un TIN (triangular irregular network) in base a tutti i punti quotati indicati sulla C.T.R.
© 2005 Edizioni all’Insegna del Giglio s.a.s., vietata la riproduzione e qualsiasi utilizzo a scopo commerciale
66
Tav. 9 – Unità di paesaggio del centro storico di Grosseto. Legenda: A, “alture”; S: pianoro sommitale; R: pendii lievemente inclinati; G: “gradoni”; V: incisioni vallive.
Una giustificazione della forma complessiva del rilievo di Grosseto non è problematica: si tratta evidentemente di una parte alta – certamente tra le più alte direttamente confinanti con la valle dell’Ombrone12 – del terrazzo pleistocenico, probabilmente già originariamente ondulato visto la sua natura di conoide alluvionale, e successivamente rimodellato dalla rete idrografica capillare. In tal senso, lo stile proposto per la rete fluviale e la morfologia ipotizzata per il rilievo di Grosseto (ma non così la quota e la sua posizione rispetto al fondovalle dell’Ombrone) si ripetono molte volte nell’ambito del-lo stesso territorio. La presenza dei gradoni lungo i margini del rilievo della città è invece un elemento la cui spiegazione è meno immediata: si potrebbe
12 L’altura di San Martino raggiunge quote di circa 2 metri inferiori rispetto alla quota massima del suolo di Grosseto.
© 2005 Edizioni all’Insegna del Giglio s.a.s., vietata la riproduzione e qualsiasi utilizzo a scopo commerciale
67
trattare dell’espressione morfologica di uno strato orizzontale più resistente all’interno della stratigrafia, oppure dell’espressione di una fase di stasi nella storia – geologica – dell’incisione della valle dell’Ombrone, in quel caso di relitti di un vero e proprio terrazzo fluviale.
Il modello morfologico qui proposto è stato sviluppato essenzialmente in base alle quote del terreno vergine misurate in occasione degli scavi, ed alle altre considerazioni esposte precedentemente, ma senza tener conto dei dati archeologici. Interessante è l’aver riversato questo quadro paesaggistico sul complesso dei dati archeologici e di aver sondato fino a che punto, e come, il modello abbia potuto contribuire ad una più chiara lettura degli stessi, oppure sia emersa dal confronto la necessità di una revisione. Nel confronto con i dati archeologici sono effettivamente venute fuori varie coincidenze e novità (si rimanda ai testi di Vanni e Citter infra, in particolare il capitolo 8).
Appurata per il centro storico di Grosseto la forma di dolce altura, con tutte le articolazioni qui sopra esposte, rimane da affrontare almeno un altro punto essenziale: il suo rapporto, non tanto con il fondovalle dell’Ombrone (a cui è direttamente confinante), quanto con il fiume stesso. Questo tema verrà trattato più elaboratamente nel primo volume dell’edizione finale degli scavi dedicato appunto a Grosseto nel contesto territoriale13, ma si vuole ac-cennare qui brevemente l’ipotesi che si sta configurando. Nelle Tav. 10 e 11 è stato tracciato l’attuale percorso del fiume nei pressi della città, sovrapposto ad una carta del paesaggio elaborata, per l’occasione, dalla carta dei suoli. La tradizione vuole che Grosseto si trovava, prima dell’alluvione del 1333 o del 131814, direttamente lungo il fiume. Si è ora giunti ad un’ipotesi ricostruttiva del corso dell’Ombrone prima di questo evento, in base alle seguenti consi-derazioni: – che ci sono due elementi morfologici che costringono il percorso dell’Om-brone nel tratto a sud di Grosseto: lo stretto di Istia ed il sottile lembo del terrazzo in località Gorarella, direttamente a sud della città, posto in direzione trasversale alla valle, individuabile sulla carta dei suoli;– la distanza di circa 1 km dell’allontanamento del fiume dalle mura di Gros-seto menzionata in Venerosi Pesciolini 1925;– che il regime idraulico dell’Ombrone era all’epoca probabilmente a meandri (come attualmente), e non a “canali intrecciati” come nel secolo XVIII15;
13 ARNOLDUS HUYZENDVELD, CITTER (a cura di), c.s., in particolare cap. 2 curato dalla scrivente.
14 VENEROSI PESCIOLINI 1925, p. 226, menziona i forti danni provocati dall’alluvione del 1318 a Campagnatico, e ribadisce «Gravissime inondazioni generali per tutta la Toscana furono anche nel 1333. È quasi certo che appunto in una di queste inondazioni, e specialmente nella prima, l’Ombrone mutasse corso allontanandosi di circa un chilometro dalle mura di Grosseto (…)».
15 Particolarmene chiaro sulla carta di Ximenes, 1759. La forma a meandri segna gene-ralmente un equilibrio nell’apporto solido del fiume, la forma a “canali intrecciati” una sovrab-
© 2005 Edizioni all’Insegna del Giglio s.a.s., vietata la riproduzione e qualsiasi utilizzo a scopo commerciale
Tav. 10 – a) Ipotesi del percorso del fiume Ombrone nell’area prossima a Grosseto prima del XIV secolo; b) L’Ombrone nel 1759 (tavola disegnata da Leonardo Ximenes nel 1759). Legenda: A: depositi alluvionali; C: depositi colluviali e conoidi; T: terrazzo di Grosseto; M: colline del “macigno”.
a
b
© 2005 Edizioni all’Insegna del Giglio s.a.s., vietata la riproduzione e qualsiasi utilizzo a scopo commerciale
Tav. 11 – a) Il percorso del fiume Ombrone nel 1823 (tratto dal Catasto del 1823 – comunità di Grosseto) b) Il percorso del fiume Ombrone alla fine del XX secolo. Legenda: A: depositi alluvionali; C: depositi colluviali e conoidi; T: terrazzo di Grosseto; M: colline del “macigno”.
a
b
© 2005 Edizioni all’Insegna del Giglio s.a.s., vietata la riproduzione e qualsiasi utilizzo a scopo commerciale
70
– una probabile analogia con la forma del meandro a nord di Istia, che si conosce prima e dopo il salto naturale avvenuto in occasione dell’alluvione del 1966 (Tav. 12)16.
L’ipotesi sul percorso del meandro dell’Ombrone all’altezza di Grosseto, poco prima del salto naturale avvenuto nel secolo XIV, è di un’ansa a forma simile a quella di Istia fino al 1966, e che tocca il margine meridionale del rilievo di Grosseto, per poi voltare e passare ad est del lieve dosso della Go-rarella. Per i secoli precedenti è ipotizzabile uno spessore maggiore del collo
Tav. 12 – Il meandro a nord di Istia prima del salto del 1966, sovrapposto alla carta geologica; con una linea piena è indicato il percorso attuale del fiume.
bondanza dello stesso. La prevedibile relazione tra il regime idraulico del fiume e la velocità di accrescimento della linea di costa - nel secolo XIII ancora lento e nei secoli XIV-XVII molto veloce, ci porta a sostenere l’ipotesi di un regime a meandri nel secolo XIII.
16 Si ringrazia Mariagrazia Celuzza per questo suggerimento. Si veda ad esempio STRAHLER 1984, fig. 25.17, p. 394. Si confronti inoltre la forma del corso del Tevere in località Fiume Morto ad Ostia (Roma), prima e dopo il salto del meandro avvenuto in occasione dell’alluvione del 1557; ARNOLDUS-HUYZENDVELD, PELLEGRINO 2000.
© 2005 Edizioni all’Insegna del Giglio s.a.s., vietata la riproduzione e qualsiasi utilizzo a scopo commerciale
71
dell’ansa, che sarebbe andato stringendosi di alluvione in alluvione17, fino al giorno del taglio decisivo. In base alla forma ricostruita del corso del fiume Ombrone è probabile una sua navigabilità fino alla città.
Si configura così, per il periodo della costruzione della prima chiesa di San Pietro, la seguente relazione del luogo di Grosseto con il fiume: una lieve altura, rilevata di pochi metri sopra il livello del fondovalle dell’Ombrone e pertanto protetta dalle alluvioni, direttamente adiacente al fiume, probabil-mente ancora navigabile fino a questo punto.
Rimane infine da considerare la relazione storica di questo luogo con il mare, con la laguna e con le saline18. Gli eventi storici della linea di costa sono stati elaborati in particolare da BELLOTTI et al.19. Il quadro complessivo è di un avanzamento non lineare nel tempo del delta dell’Ombrone e della fascia dunare: lento a partire dal periodo etrusco fino all’alto medioevo, una succes-siva intensificazione dell’avanzamento con il colmo tra i secoli XV e XVII20, una fase di avanzamento minore – ma ancora di notevole entità – nei secoli successivi, ed infine il graduale ritiro della linea di costa nell’ultimo secolo. Per quanto riguarda le saline precedenti a quelle note riferibili al basso Medioevo (si veda testo Citter infra, al capitolo 8), e quindi coeve alla costruzione della prima chiesa di San Pietro, non possiamo al momento escludere che fossero ubicate in aree più prossime al centro abitato di Grosseto.
Si assiste pertanto nel basso medioevo/rinascimento ad un complesso di cambiamenti ambientali incisivi: il rapido avanzamento della linea di co-sta, il salto del meandro di Grosseto, il parziale interro/impaludamento della laguna con i sedimenti delle alluvioni, probabilmente il rialzo del fondovalle dell’Ombrone e la trasformazione progressiva delle acque lagunari residue da salmastre in dolce. Questi processi si collocano sotto il profilo cronologico nel periodo IV/2 della periodizzazione generale dello scavo (vedi Citter infra, al cap. 1) e quindi coincidono con un sensibile degrado della città e del suo territorio.
ANTONIA ARNOLDUS-HUYZENDVELD
17 Sembra che anche l’ansa a nord di Istia abbia subito un simile ristringimento tra 1823 e 1966, come risulta dal Catasto Lepoldino, foglio F,sez. 3,4.
18 Vedi riferimento alla nota 13.19 BELLOTTI et al. 1999, 2004, BELLOTTI 2000.20 Secondo i calcoli di Bellotti et al. 2004, durante gli ultimi 800 anni si è sedimentato
circa il ¾ del volume del delta dell’Ombrone. BRAVETTI, PRANZINI 1987 ipotizzano che si siano verificate anche fasi erosive.
© 2005 Edizioni all’Insegna del Giglio s.a.s., vietata la riproduzione e qualsiasi utilizzo a scopo commerciale