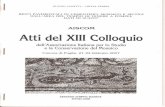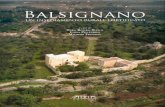Analisi dei resti faunistici provenienti da i pozzi nn. 6, 7 e 11 di Vallerano (Roma-I-II sec....
Transcript of Analisi dei resti faunistici provenienti da i pozzi nn. 6, 7 e 11 di Vallerano (Roma-I-II sec....
Claudia Minniti*
Analisi dei resti faunistici provenienti da tre pozzi (nn. 6, 7, 11) della Tenuta di Vallerano (Roma, i-ii secolo d.C.)Faunal remains from the pits (nos. 6, 7 and 11) in the Tenuta di Vallerano (Rome, 1st-2nd cent. A.D.)
Vengono analizzate le faune di tre pozzi (nn. 6, 7 e 11) appartenenti ad un insediamento rurale di età imperiale (I-II secolo d.C.) situato nella Tenuta di Vallerano a pochi chilometri a sud di Roma. La fauna sembrerebbe il frutto di piccoli accumuli creatisi in modo abbastanza repentino e limitato nel tempo dopo il loro abbandono. I resti ossei recuperati all’interno dei pozzi appartengono prevalentemente alle principali categorie di animali domestici (bovini, caprovini, suini e pollame). La selvaggina al contrario contribuiva minimamente alla dieta. Accanto a questi si trovano pochi resti di animali abitualmente non utilizzati per uso alimentare (cani e cavalli). Di particolare interesse è il rinvenimento in uno dei pozzi di una spina pettorale appartenente ad un pesce gatto del genere Clarias. Questi pesci sono presenti attualmente in tutta l’Africa, ma la distribuzione di uno di questi, il Clarias gariepinus, continua nel Levante fino alla Siria settentrionale e alle zone adiacenti della Turchia. La spina di questo pesce pone particolari interrogativi circa la sua presenza nel pozzo di Vallerano.
Results of the analysis of the faunal remains from three pits of a rural settlement in the Tenuta di Vallerano are presented. The site was located near Rome and dated to the Roman Period (1st-2nd cent. A.D.). The pattern of the pits is typical of a garbage dump used for a short time, where meal refuse (cattle, sheep, pig and chicken) was dropped in together with animals usually not employed for subsistence (horse and dog). Wild animals are rare. In the faunal assemblage from a pit a remain of a catfish was identified. Most probably it could be attributed to Clarias gariepinus. This species is now present in Africa and in the Levant, up to northern Syria and Turkey. Its presence in the roman pit could be very interesting.
Parole chiave: Roma, pozzo, periodo imperiale, insediamento rurale, alimentazione, pesce gatto.Keywords: Rome, pit, Imperial Period, rural settlement, diet, catfish.
*Collaboratrice del Laboratorio di Archeozoologia, Soprintendenza Archeologica di Roma.
Atti 3° Convegno Nazionale di Archeozoologia (Siracusa, 2000), pp. 419-432.
420 C. Minniti
Introduzione
Le faune analizzate in questo lavoro provengono da tre pozzi (nn. 6, 7 e 11) appartenenti ad un insediamen-to rurale di età imperiale (I-II secolo d.C.) nella tenuta di Vallerano, pochi km a sud di Roma.
Di solito i campioni provenienti da contesti urbani sono dovuti all’accumulo graduale nel tempo di elementi pro-venienti da numerosi animali e sono utili statisticamen-te soprattutto per evidenziare particolari modelli di alle-vamento o determinate abitudini alimentari. Al contra-rio la fauna proveniente dai tre pozzi sembrerebbe il frut-to di piccoli accumuli creatisi in modo abbastanza repen-tino e limitato nel tempo dopo il loro abbandono. Que-sti campioni quindi, a parte alcuni dati di tipo economi-co e sociale, sono più indicativi di un particolare momen-to di vita.
Il campione
I resti ossei recuperati all’interno dei pozzi apparten-gono prevalentemente alle principali categorie di anima-li domestici (bovini, caprovini, suini e pollame). Accan-to a queste si trovano pochi resti di selvaggina e di ani-mali abitualmente non utilizzati per uso alimentare (cani e cavalli).
Nel pozzo 6 (tab. 1) tra gli animali domestici prevalgo-no i resti di bue, appartenenti a 7 individui (sei adulti e un subadulto), cui seguono in ordine d’importanza i resti di maiale, riferibili a 4 individui (un subadulto, due giovanili e un feto) e quelli di pollo, appartenenti a 2 individui (un adulto e un subadulto). Sono stati rinvenuti anche parte degli arti posteriori di un cavallo di età adulta e lo sche-letro quasi integro di un puledro in età neonatale. Sono inoltre presenti alcuni frammenti di corno di cervo, con evidenti tracce di lavorazione, i quali potrebbero rappre-sentare scarti della lavorazione del corno piuttosto che il residuo di qualche banchetto.Il pozzo 7 (tab. 1) ha restituito scarsi resti di pasto, rife-
ribili alle tre principali categorie di animali domestici (bue, pecora/capra e maiale). Il bue è rappresentato da
un unico frammento appartenente a un individuo adul-to, i caprovini sono invece presenti con 3 individui, di cui 2 adulti e un subadulto, mentre i resti suini appar-tengono ad un unico individuo giovanile. Numerosi sono invece i resti equini, che rappresentano lo scheletro quasi completo di un cavallo adulto e parte dell’arto anteriore destro di un puledro di età neonatale. Sono inoltre pre-senti resti appartenenti a tre cani adulti e un frammento di tibia di lepre di età adulta.Anche nel pozzo 11 (tab. 1) prevalgono i resti ossei di
cavallo, appartenenti ad almeno 4 individui: due adulti, un subadulto e un giovanile. Tra i resti di pasto sono presen-ti: i caprovini, con almeno 7 individui (quattro adulti, un subadulto e due giovanili); i bovini con un vitello in età neonatale; i suini con un individuo adulto, un giovanile e uno di età neonatale. Il pollame è invece presente con poche ossa appartenenti ad almeno due polli, un adulto e un giovanile. Numerosi resti di cane testimoniano la pre-senza di almeno 4 individui, tutti adulti. Tra gli animali selvatici sono presenti i resti di due lepri adulte e una spina caudale riferibile a un pesce gatto, del genere Clarias.
Tab. 1. Numero dei resti (NR) e relativo numero minimo di individui (NMI) dei resti ossei rinvenuti nei pozzi.
TaxaPozzo 6 Pozzo 7 Pozzo 11
NR NMI NR NMI NR NMI
Cavallo (Equus caballus) 49 2 41 2 84 4
Bue (Bos taurus) 101 7 1 1 14 1
Pecora/Capra (Ovis/Capra) - 12 58
Pecora (Ovis aries) - - 2 3 6 7
Capra (Capra hircus) - - 5
Maiale (Sus scrofa) 17 4 8 1 7 3
Cane (Canis familiaris) - - 10 3 39 4
Pollo (Gallus gallus) 3 2 - - 4 2
Cervo (Cervus elaphus) 4 - - - - -
Lepre (Lepus europaeus) - - 1 1 4 2
Pesce (Clarias sp.) - - - - 1 1
Totale 174 75 222
Coste 30 37 81
Vertebre 15 27 54
Indeterminabili 67 19 128
Resti faunistici dalla Tenuta di Vallerano 421
Considerazioni
Anche se lo studio delle testimonianze animali prove-nienti da alcune aree di Roma ha contribuito a mette-re a fuoco alcuni aspetti dell’allevamento e dell’approvvi-gionamento della comunità urbana, è difficile stimare in base ai dati zooarcheologici quanto consumo quotidiano di carne si facesse, poiché non tutti gli alimenti lasciano resti che si conservano nel tempo; tuttavia è possibile sta-bilire in che proporzione ogni specie animale abbia con-tribuito nell’ambito della sola alimentazione carnea.
La quantità di frammenti ossei riferibili alle tre princi-pali forme di animali domestici di Vallerano sembra con-fermare, in termini di numero minimo di individui, un prevalente consumo di agnelli, capretti e maiali rispet-to ai bovini, ma il quadro cambia se consideriamo que-sti dati in base alla massa corporea degli animali. I bovi-ni verrebbero così a contribuire per circa due terzi alla produzione di carne (fig. 1). È chiaro che i valori estrapo-lati sono solo indicativi, ma da questi si può vedere come l’importanza di una determinata specie nell’economia non è sempre direttamente confrontabile con il numero di resti o il numero minimo di individui.I resti bovini (tab. 2), quasi tutti provenienti dal pozzo
6, testimoniano sia i residui di qualche banchetto, come evidenziato da estese bruciature su alcuni di questi, sia scarti di macelleria. Sono infatti numerosi quegli elemen-ti anatomici delle estremità degli arti, come metapodi e falangi, che sono riferibili alla macellazione di parti cor-poree che forniscono scarsissime quantità di carne. In base alla fusione delle epifisi articolari delle ossa lunghe (tab. 3), stimata secondo il metodo di Silver (1969), è stato possibile determinare l’età di morte per i resti bovini rin-venuti nei pozzi 6 e 11. Per il primo contesto si può nota-re che la maggior parte degli individui è stata macellata in età matura, compresa tra i 36 e i 42 mesi, mentre un solo individuo risulta macellato prima di aver raggiunto i 36 mesi di età. Nel pozzo 11 invece si trovano i resti di un vitello di età inferiore ad un anno.
I resti bovini presenti in altri campioni faunistici di età romana, provenienti da scavi condotti nell’area urbana, sono di solito riferibili ad individui anziani, che furono
avviati al macello solo dopo essere stati utilizzati per altri scopi, come i lavori agricoli, la produzione del latte o la riproduzione. La presenza di alcune ossa integre (soprat-tutto metapodi) e in ottimo stato di conservazione nel pozzo 6 ha permesso di prendere tutte le misure dovute. È stato così possibile valutare in base ai coefficienti di Matol-csi (1970) l’altezza al garrese di questi bovini (tab. 4): essa variava da un minimo di cm 118,6 ad un massimo di cm 135,6 con una media di cm 127,4. Nel complesso si tratta di animali appartenenti ad una razza di statura modesta.Tuttavia il calcolo dell’altezza al garrese non tiene conto
della forte variabilità dimensionale dovuta alla differen-ziazione sessuale. Sono stati proposti numerosi criteri
Tab. 2. Elementi anatomici dei bovini.
Elemento anatomicoPozzo 6 Pozzo 7 Pozzo 11
NR NR NR
Neurocranio 29 - -
Mascellare e/o incisivo 2 - -
Denti superiori 1 - -
Mandibola 3 1 2
Denti inferiori 3 - -
Osso ioide 3 - -
Scapola - - 1
Omero 2 - 1
Radio 1 - 3
Ulna 2 - -
Ossa carpali 6 - -
Metacarpali 8 - -
Coxale 2 - 1
Femore 2 - 2
Tibia 7 - 2
Calcagno 2 - -
Astragalo 2 - -
Metatarsali 10 - 1
Metapodi - - 1
Falange I 8 - -
Falange II 5 - -
Falange III 3 - -
422 C. Minniti
Fig. 1. Rapporto percentuale tra le tre principali categorie di animali domestici (bovini, caprovini e suini) a Vallerano in base al numero dei resti (NR), al numero minimo di individui (NMI) e alla resa carnea.
Resti faunistici dalla Tenuta di Vallerano 423
per tentare di separare gli individui maschili, femmini-li e castrati, questi ultimi soprattutto in base alla morfo-logia delle corna o del bacino o alle dimensioni delle ossa lunghe. I metapodi sono a questo scopo particolarmen-te adatti, in quanto nei depositi archeologici si conserva-no meglio delle altre ossa. La loro scarsa frammentarietà è dovuta alla robustezza dell’osso e alle tecniche di macella-zione, che risparmiano la parte terminale degli arti perché povera di carne e di scarso contenuto midollare.
I principali caratteri di distinzione dei gruppi sessua-li nelle ossa risiedono nelle proporzioni della lunghezza massima e della larghezza delle epifisi articolari (Zalkin, 1960). I metapodi sono preferibili agli altri elementi sche-letrici perché raggiungono precocemente la loro gran-dezza definitiva a causa della loro posizione anatomica che facilita la fusione delle epifisi. A riguardo Guilbert e Gregory (1952) hanno verificato in un campione di bovi-ni attuali che la lunghezza massima dei metacarpi era già raggiunta nell’87% dei casi a 19 giorni dalla nascita. Si deve a Nobis (1954) l’elaborazione di alcuni indici, in funzione rispettivamente della larghezza prossimale (Bp) o distale rispetto alla lunghezza massima dell’osso (GL), per separare i diversi raggruppamenti sessuali.
Dai dati relativi ai resti in esame (tab. 5) si evince che la maggior parte dei reperti è riferibile a tori e castrati, a lungo utilizzati per i lavori agricoli e quasi tutti macellati in età matura. Questi dati trovano conferma nella forte divaricazione dei condili articolari, alcuni dei quali non
Tab. 3. Mortalità dei bovini in base alla saldatura delle epifisi.
Tab. 4. Altezza al garrese dei bovini.
Tab. 5. Suddivisione dei metapodi in base all’indice di Nobis.
Elemento anatomico mesiPozzo 6 Pozzo 11
NF-F NF-F
Omero dist. 12-18 0-2 1-0
Radio pross. 12-18 - 2-0
Falange I 18 0-7 -
Falange II 18 0-5 -
Metacarpo dist. 24-30 0-4 -
Tibia dist. 24-30 0-2 2-0
Metatarso dist. 27-36 0-10 -
Calcagno 36-42 1-1 -
Femore pross. 42 2-0 2-0
Femore dist. 42-48 - 2-0
Tibia pross. 42-48 3-0 2-0
Omero pross. 42-48 1-0 1-0
Elemento anatomico
H al garrese
Elemento anatomico
H al garrese
Omero 132,6 Metatarso 135,1
Radio 129 Metatarso 125,2
Metacarpo 135,6 Metatarso 131,8
Metacarpo 120,5 Metatarso 122,5
Metacarpo 123,6 Metatarso 123,0
Metacarpo 127,3 Metatarso 127,9
Metacarpo 127,9 Metatarso 126,3
Metacarpo 119,8 Metatarso 118,6
Metacarpo 135,3 Metatarso 135,6
Metacarpo 122,9 Media 127,4
Elemento anatomico Indice Nobis Sesso
Metacarpo sin 30,9 Toro o Castrato
Metacarpo sin 31,3 Toro o Castrato
Metacarpo sin 34,2 Toro
Metacarpo sin 32,0 Toro
Metacarpo dx 32,2 Toro
Metacarpo dx 34,6 Toro
Metacarpo dx 31,0 Toro o Castrato
Metacarpo dx 34,3 Toro
Metatarso sin 22,2 Vacca o Castrato
Metatarso sin 24,7 Toro
Metatarso sin 22,6 Castrato
Metatarso sin 24,6 Toro
Metatarso dx 24,3 Toro
Metatarso dx 21,8 Vacca o Castrato
Metatarso dx 23,8 Toro o Castrato
Metatarso dx 25,1 Toro
Metatarso dx 22,7 Castrato
424 C. Minniti
proprio in perfette condizioni fisiche e nei diversi casi di processi infiammatori riscontrati a carico delle falangi.
Scarsi sono i resti riconducibili ad individui femmini-li che possono essere stati utilizzati per la produzione di latte e/o per la riproduzione.I resti di caprovini (tab. 6) sono presenti soltanto nei
pozzi 7 e 11. Le ossa sono riferibili ad almeno 10 individui (un individuo molto vecchio, cinque adulti, due non anco-ra completamente maturi e due giovani).
Di 86 resti determinati soltanto per 13 frammenti è stato possibile separare i due generi in base alle osser-vazioni di Boessneck e colleghi (Boessneck et al., 1964). Nel pozzo 7 è stata individuata la presenza di almeno una pecora adulta, mentre nel pozzo 11 erano presenti almeno
due pecore adulte e due capre adulte e, tra queste, alme-no un maschio ed una femmina.
Nella tabella 7 sono mostrati i dati sulla mortalità rica-vati dall’analisi della saldatura delle epifisi (Bullock, Rackham, 1982); si può notare che la maggior parte degli individui adulti aveva raggiunto almeno i 4 anni di vita, mentre solo due individui risultano macellati prima di aver raggiunto i tre anni e, infine, due giovanili non ave-vano ancora superato il primo anno di vita.Anche dall’analisi dell’eruzione, la sostituzione e l’usura
dei denti (tab. 8) secondo il metodo di registrazione pro-posto da Payne (1973), risulta che circa il 71% degli ani-mali era stato ucciso tra i due e i tre anni, cioè quando una maggior quantità di carne viene resa con i più bassi costi di produzione, il 28% circa raggiungeva o superava i 4 anni e quindi era mantenuto in vita per la produzione di latte o lana. È chiaro che queste stime sono solo indica-tive in quanto non sono distinti le capre dalle pecore o i maschi dalle femmine, che senza dubbio avevano un dif-ferente destino nell’allevamento.Anche negli altri contesti urbani di Roma la mortalità
degli ovicaprini indica un allevamento il cui scopo pri-mario sembra essere la produzione di carne.
Tab. 6. Elenco dei resti caprovini suddivisi per elemento anatomico.
Elementoanatomico
Ovis/Capra Ovis aries Capra hircus
Pozzo 7
Pozzo 11
Pozzo 7
Pozzo 11
Pozzo11
NR NR NR NR NR
Corna - - - - 1
Neurocranio - 6 - 1 -Mascellare e/o incisivo - 1 - - -
Denti superiori - 3 - - -
Mandibola 3 9 - - -
Denti inferiori 1 5 - - -
Denti indet. - 1 - - -
Atlante - 1 - - -
Scapola - 2 - 2 -
Omero - 5 - - -
Radio - 1 - 2 -
Ulna - 1 - - -
Metacarpali 3 2 - - 1
Coxale - 6 - - -
Femore 1 5 - - -
Tibia 3 6 1 - -
Calcagno - 3 - - -
Metatarsali 1 1 1 - 1
Falange I - - - 1 -
Tab. 7. Mortalità dei caprovini in base alla saldatura delle epifisi.
Elemento anatomico Età in mesiPozzo 7 Pozzo 11
NF-F NF-F
Omero dist. - 12 - 0-2
Radio pross. -12 - 0-2
Coxale - 12 - 1-0
Scapola 12 - 0-3
Falange I 14-35 - 0-1
Tibia dist. 35 0-1 1-1
Femore pross. 36 - 1-1
Femore dist. 48 - 2-0
Metatarso dist. 48 0-1 0-2
Metacarpo dist. 48 1-0 0-2
Tibia pross. 48 0-2 2-0
Calcagno 48-60 - 1-2
Resti faunistici dalla Tenuta di Vallerano 425
Per quanto riguarda la statura di questi animali, soltan-to in tre casi si è potuto calcolarne l’altezza, applicando i coefficienti di Teichert (1975) ad un metacarpo e due metatarsi, probabilmente appartenenti a capre: questa variava da un minimo di cm 65 ad un massimo di cm 85,2 con una media di 77,1 cm.I resti di suini sono presenti in tutti e tre i pozzi (tab. 9).
Dalla stima della mortalità (Bull, Payne, 1982) effettua-
ta in base alla saldatura delle epifisi delle ossa lunghe (tab. 10), e dall’analisi dell’eruzione, usura e sostituzione dei denti sia mandibolari che mascellari (tab. 11), si nota che a parte un individuo adulto dal pozzo 11, del quale si sono conservati un incisivo e un frammento di molare inferiore, e due individui allo stato neonatale rinvenuti nei pozzi 6 e 11, gli altri erano tutti giovanissimi.I dati sulla mortalità, ottenuti in base alla fusione delle
epifisi articolari delle ossa lunghe e dell’eruzione, sosti-tuzione e usura dei denti mascellari e mandibolari (Bull, Payne, 1982) mostrano che gran parte dei suini era macel-lata entro i primi anni di vita, in due momenti distin-
Tab. 8. Mortalità dei caprovini in base all’eruzione, usura e alla sostituzione dei denti.
Ovis vel Capra (Pozzi 7 e 11)Grado di
usura Età in mesi % % retrocumulata
A 0-2 - 100
B 2-6 - 100
C 6-12 - 100
D 12-24 31,1 68,9
E 24-36 40,5 28,4
F 36-48 - 28,4
G 48-72 20 8,4
H 72-96 4,1 4,3
I 96-120 4,1 0
Tab. 9. Elenco dei resti suini suddivisi per elemento anatomico.
Elemento anatomicoPozzo 6 Pozzo 7 Pozzo 11
NR NR NR
Denti superiori - - 1
Mandibola 5 - 1
Denti inferiori 1 - 2
Scapola 1 - -
Omero 2 1 -
Metacarpali - - 2
Coxale 3 2 -
Femore 1 2 -
Tibia 1 2 -
Fibula 1 - -
Metatarsali 2 - -
Metapodi - - 1
Falange II - 1 -
Tab. 10. Mortalità dei suini in base alla saldatura delle epifisi.
Elemento anatomico Età in mesi
Pozzo 6 Pozzo 7 Pozzo 11
NF-F NF-F NF-F
Scapola 11 1-0 - -
Omero dist. +11 1-0 1-0 -
Falange II +11 - 1-0 -
Coxale 7-11 3-0 - -
Tibia dist. 19-23 1-0 1-0 -
Metatarso dist. 19-23 2-0 - -
Metapodio dist. 19-23 - - 1-0
Metacarpo dist. 19-23 - - 2-0
Fibula dist. 24-30 1-0 - -
Femore dist. 31-35 1-0 - -
Omero pross. +36 2-0 1-0 -
Femore pross. +36 1-0 - -
Tibia pross. +36 1-0 1-0 -
Tab. 11. Mortalità dei suini in base all’eruzione, usura e sostituzione dei denti.
Sus scrofa Pozzo 6 Pozzo 11
Età NR NR
-7 mesi 2 -
7-11 mesi 3 1
12-18 mesi - -
19-23 mesi - -
24-30 mesi - -
31-35 mesi - -
+36 mesi - 1
426 C. Minniti
ti, che si collocano grosso modo l’uno tra i 12 e i 24 mesi e l’altro tra i 18 e i 30 mesi. Solo una piccola parte (circa il 15%) era macellata prima del compimento del primo anno di vita – il c.d. porcellus lactans o porcellus lacte pastus – mentre solo una parte (il 10% circa) oltrepassava i 36 mesi. Questi probabilmente rappresentano gli animali tenuti per la riproduzione.
È interessante notare che nei campioni di resti animali rinvenuti in tutti i contesti urbani di Roma, tra il I e il II sec. d.C., vi è sempre un’alta percentuale di resti di suini, rispetto agli altri animali domestici.Infatti, il consumo di carne suina, sebbene risulti già
alto nei secoli VIII-VI a.C., tende ad aumentare progres-sivamente in epoca repubblicana sino a raggiungere il suo apice in pieno periodo imperiale.
Questo fenomeno trova una spiegazione nell’aumen-to demografico della città e in una maggiore richiesta di carne, alla quale si può sopperire solo con l’allevamento di un animale molto prolifico e di bassi costi di produzio-ne, quale il maiale (De Grossi Mazzorin, 1989; 1995; 1996; 1998; Tagliacozzo, 1993).
Al contrario nei pozzi di Vallerano il maiale rappresenta solo il 14% circa dei resti delle tre principali categorie di animali domestici. Questo denota uno scarso consumo di carne suina delle comunità suburbane rispetto a quelle urbane e lascerebbe ipotizzare che la maggior parte della produzione suina fosse esportata verso la città.I maiali che giungevano sui mercati di Roma presen-
tavano caratteristiche abbastanza omogenee nei diversi campioni: l’altezza alla spalla si aggirava intorno ai 70 cm di media (Mackinnon, 2001). Dalle misure dei crani si nota una caratteristica abbastanza accentuata del proces-so di domesticazione, la riduzione della regione naso-fac-ciale. Il profilo del cranio era quindi abbastanza concavo rispetto a quello del cinghiale; una buona rappresentazio-ne di questo tipo di suini è mostrata nei celebri Plutei di Traiano nel Foro Romano. Nei particolari di questa raf-figurazione si può notare anche la presenza di una con-sistente peluria che si manifesta come una specie di cre-sta sul dorso dell’animale. È questo un carattere primiti-vo presente ancora oggi in razze di maiali non particolar-mente selezionate.
Nel campione faunistico proveniente da Vallerano è documentato anche il pollame con pochi resti rinvenu-ti nei pozzi 6 e 11. La più antica attestazione del gallo domestico in Italia è segnalata in una tomba a incinera-zione della prima età del Ferro (Bartoloni et al. 1987), ma è durante il periodo etrusco che si ha la più ampia diffu-sione di questo animale. Percentuali abbastanza alte per il periodo romano sono registrate a Roma nell’area della Meta Sudans (De Grossi Mazzorin 1995), nella villa di Set-
Tab. 12. Elenco dei resti equini suddivisi per elemento anatomico.
Elemento anatomicoPozzo 6 Pozzo 7 Pozzo 11
NR NR NR
Neurocranio 7 1 3
Mascellare e/o incisivo - 2 2
Denti superiori 6 - 17
Mandibola 2 3 16
Denti inferiori 2 2 14
Atlante 3 1 1
Epistrofeo 1 1 1
Scapola - 2 4
Omero 2 3 5
Radio 4 3 3
Ulna - 2 1
Ossa carpali - - 1
Metacarpali 3 2 2
Coxale 1 2 1
Osso sacro - 1 -
Femore 4 2 2
Tibia 3 2 2
Calcagno - 2 1
Astragalo 2 - 1
Ossa tarsali - - 1
Metatarsali 4 2 3
Metapodi 2 - -
Falange I 1 4 2
Falange II - 1 1
Falange III - 3 -
Indeterminabili 2 - -
Resti faunistici dalla Tenuta di Vallerano 427
tefinestre (King et al. 1985) e in quella dei Quintili a Mon-teporzio (De Grossi Mazzorin 1987).
Numerosi sono i resti di cavallo (tab. 12) in tutti e tre i pozzi, riferibili ad otto individui, rinvenuti perlopiù inte-gri e senza tracce di macellazione.
Due pozzi (6 e 7) hanno restituito entrambi i resti di un cavallo adulto, dei quali uno sicuramente di sesso femmi-nile, e di un puledro appena nato o addirittura allo stato fetale, mentre nel pozzo 11 si trovavano le ossa apparte-nenti ad almeno quattro individui, dei quali due adul-ti, un individuo non ancora completamente maturo e un giovanile.
Degli esemplari adulti è stato possibile calcolare l’al-tezza al garrese applicando i coefficienti di Kiesewalter (1888) o di May (1985); tali valori sono riportati nella tabel-la 13. Questa variava, a seconda se calcolata col metodo di Kiesewalter o di May, rispettivamente da un minimo di
137,3/129,5 cm ad un massimo di 143,3/145,6 cm con una media di 139,6/137,9 cm.
Questi valori corrispondono alla statura media stimata in genere per altri cavalli del periodo romano e del tardo-antico in Italia di cui si è potuta ricostruire la taglia, valutata rispettivamente di 137 e 141 cm circa (De Grossi Mazzorin et al. 1998). In questi periodi l’altezza dei caval-li, che nell’età del Ferro era di circa 133,2 cm, è sicuramen-te condizionata dal cosiddetto “cavallo militare” romano, ottenuto con incroci selettivi da cavalli di tipo “orienta-le”, di cui un’ottima rappresentazione è data dal cavallo della statua equestre di Marco Aurelio.
Un’altra delle caratteristiche degli equini che si è in grado di valutare dai resti ossei è la snellezza degli arti. Brauner (1916) ha tentato una classificazione degli arti da forme molto snelle a forme robuste in base all’indice dato dal rapporto percentuale della diafisi dei metacarpi rispetto alla lunghezza dell’osso (tab. 14).
Da diversi contesti archeologici italiani si è potuto sta-bilire che fino a tutta l’età del Bronzo i cavalli sono carat-terizzati da arti compresi tra le categorie “molto snelli” e “medi”. Nell’età del Ferro compaiono i primi arti “leg-germente robusti” anche se percentualmente la maggior parte sono “snelli o leggermente snelli”. Nei periodi suc-cessivi, dal pieno periodo romano al medioevo, invece i cavalli sono caratterizzati da arti più robusti, in genere
“medi” o “leggermente snelli”, e se da un lato compaio-no gli arti “robusti” dall’altro scompaiono i cavalli “snel-li” o “molto snelli”. Anche questi ultimi dati confermano la presenza in Italia di cavalli più alti e particolarmente robusti, probabilmente frutto di particolari incroci per il loro uso bellico.
Per quanto riguarda il campione in esame è stato possi-bile calcolare l’indice di snellezza soltanto per tre meta-carpi: due provenienti dal pozzo 7 si presentano “medi” (indici 15,8 e 15,7), mentre un metacarpo dal pozzo 11, probabilmente appartenente ad un individuo non ancora completamente maturo, risulta “snello” (indice 13,7).In genere i resti di cavallo che si rinvengono nei cam-
pioni archeozoologici non appartengono ad animali che venivano abitualmente consumati; di solito si nota se non l’assenza almeno la scarsità dei loro resti e, quando si rin-
Tab. 13. Altezze al garrese dei cavalli in base ai coefficienti di Kiesewalter (HK) e di May (HM).
Elemento anatomico
Pozzo 6 Pozzo 7 Pozzo 11
HK HM HK HM HK HM
Omero dx 138,5
Radio sin 132,7
Metacarpo dx 138,4 135,7 141 138,5
Metacarpo sin 138,4 135,4
Femore dx 129,5
Tibia 140,8 134,1 137,3 145,6
Metatarso dx 143,3 143,5 137,5 139,3 139,3
Metatarso sin 143,9 141,9 137,5 139,3
Tab. 14. Variazione del grado di snellezza dei metacarpi equini in base agli indici di Brauner.
Categoria Indice
Arti molto snelli meno di 13,5
Arti snelli 13,6-14,5
Arti leggermente snelli 14,6-15,5
Arti medi 15,6-16,5
Arti leggermente robusti 16,6-17,5
Arti robusti oltre 17,5
428 C. Minniti
vengono, le ossa sono perlopiù integre e non presenta-no mai tracce di macellazione e cottura. Tutto ciò è da interpretarsi con il fatto che questo animale svolgeva un ruolo determinante nella trazione o come cavalcatura e quindi non era usato per scopi alimentari. Ciò non signi-fica che tali animali non fossero mai consumati; proba-bilmente quando determinate circostanze lo richiedeva-no venivano macellati anch’essi, ma sicuramente questo era un fatto eccezionale. Nel mondo romano vi fu una forte avversione a cibarsi di carne equina e questo si può notare indirettamente anche nei testi antichi. Numero-si scritti confermano che gli eserciti antichi mangiavano cavallo solo quando erano minacciati dalla fame. Tra questi basti citare l’esempio degli abitanti di Pete-
lia, nel Brutium, che essendo assediati e avendo esauri-to i viveri, si nutrirono “di ogni sorta di quadrupedi” prima di ridursi a mangiare erba e a masticare cuoio (T. Livio, XXIII, 30, 3), quello della rivolta di Civilis, in cui i solda-ti consumarono “gli animali da soma, i cavalli, e anche tutti gli animali che la necessità costringe ad usare, anche quelli che erano immondi e disgustosi” (Tacito, Hist., IV, 60). Dal con-sumo di carne equina dei soldati affamati non si può trar-
re la conclusione che la carne di cavallo comparisse cor-rentemente sulle tavole. Proprio perché li consideravano casi eccezionali, gli autori antichi hanno annotato questi esempi di ippofagia.Anche i resti di cane, come quelli di equini, si rinven-
gono perlopiù integri e privi di tracce di macellazione e cottura, come nel caso dei pozzi 7 e 11 di Vallerano (tab. 15), anche se del resto sappiamo dagli autori antichi che le carni dei cuccioli erano assai stimate nelle cene sacre dei Romani (Festo XXXIX, 8) e nella cucina ordi-naria ancora in età repubblicana (Plin., Nat. Hist. XXIX, 14, cfr. Plauto in Paul Diac., ecc., s.v. cutilinam carnem). I resti di Vallerano appartenevano ad almeno sette indivi-dui, tutti adulti.In base ai coefficienti di Koudelka (1884) e di Harcourt
(1974) è stata calcolata l’altezza al garrese per almeno due dei cani del pozzo 11 (tab. 16): questi erano di dimensioni simili, alti da un minimo di 58,2/59,5 cm ad un massimo di 61,4/61,7 cm, con una media di 60,1/61,2 cm.
Dal rapporto tra l’altezza al garrese, calcolata in base ai coefficienti di Harcourt e gli indici di snellezza sono stati confrontati il radio sinistro di due individui dal pozzo 11 con quelli di alcune razze attuali. Si è potuto notare in questo modo che i cani di Vallerano corrispondono ai valori più bassi valutati per cani di grosse dimensioni o ipermetrici. La statura di questi animali ha subito un aumento medio delle altezze al garrese dall’età del Bron-zo fino ai tempi storici. Al contrario la creazione delle razze canine sembra essersi sviluppata soltanto a parti-re dall’età romano-imperiale. L’analisi dimensionale dei resti faunistici provenienti da diversi contesti italiani di età protostorica e storica indica che nell’età del Bron-zo la maggior parte dei cani è riconducibile a una taglia media, mentre nella successiva età del Ferro risulta un
Tab. 15. Elenco dei resti di cane suddivisi per elemento anatomico.
Elemento anatomicoPozzo 7 Pozzo 11
NR NR
Neurocranio - 2
Mascellare e/o incisivo - 5
Mandibola 5 1
Epistrofeo 1 -
Scapola - 2
Omero 3 7
Radio - 5
Femore - 3
Tibia 1 6
Fibula - 1
Astragalo - 1
Ossa tarsali - 1
Metatarsali - 4
Metapodi - 1
Tab. 16. Altezze al garrese dei cani in base ai coefficienti di Koudelka (HK) e di Harcourt (HH).
Elemento anatomico HK HH
Radio sin 58,2 59,5
Radio sin 60,5 61,7
Tibia dx 61,4 62,4
Tibia dx 60,4 61,3
Resti faunistici dalla Tenuta di Vallerano 429
aumento generale nelle dimensioni. Con i periodi roma-no e tardo-antico si registra un ulteriore aumento dimen-sionale, con taglie che si avvicinano a misure ipermetri-che ed una maggiore variabilità, con la comparsa di razze di cani molto piccoli, con arti brachimelici, presenti sia a Roma nell’area della Meta Sudans (De Grossi Mazzorin, 1995) che a Classe (Farello, 1995).
Infine di particolare interesse è la presenza della spina caudale di pesce gatto a Vallerano, del genere Clarias, in quanto non autoctono in Italia. Diverse sono le ipotesi circa l’utilizzazione di questo pesce e del modo in cui sia giunto a Roma (De Grossi Mazzorin, 2000). Infatti que-
sto pesce può esser stato portato vivo oppure dopo esser stato salato per uso alimentare. Inoltre si può ipotizzare che fosse usato a scopo terapeutico per guarire o allevia-re particolari malattie, date le diverse menzioni di Plinio a riguardo. A tale fine potrebbe essere giunta soltanto la spina, dopo essere stata disarticolata.
D’altra parte il suo ritrovamento potrebbe essere stret-tamente connesso alla presenza nelle vicinanze di una necropoli (I-III secolo), dove si trovava la tomba di una giovane donna probabilmente di origine siriaca e nume-rose tombe contenenti anfore di produzione africana (Bedini, 1995; Bedini, Testa, 1995).
Bartoloni G., Buranelli F., D’Atri C., De Santis A., 1987. Le urne a capan-na rinvenute in Italia, Roma, p. 229.
Bedini A., 1995. Mistero di una fanciulla. Ori e gioielli della Roma di Marco Aurelio da una nuova scoperta archeologica. Skira, Roma.
Bedini A., Testa C., 1995. Roma - Un sepolcreto di epoca imperiale a Val-lerano. Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica, 23: 319-331.
Boessneck J., Muller H.H., Teichert M., 1964. Osteologische Unter-scheidungsmerkmale zwischen Schaf (Ovis aries L.) und Ziege (Capra hircus L.). Kühn Archiv, 78: 1-129.
Brauner A., 1916. Materiali k poznaniju domashnickh zhivotnykh Ros-sii. 1. Loshad kurgannikh pogrebenij Tiraspolskogo uezda, Hersonskoj gubernii, Equus goschkewitschi, mihi. Zapisk. Imper. Obshch. Selsk. Hozj. Juzhn. Ross., 86, 1:1-252.
Bull G., Payne S., 1982. Tooth eruption and epiphysial fusion in pigs and wild boar. In “Ageing and Sexing Animal Bones from
Archaeological Sites”. A cura di B. Wilson, C. Grigson, S. Payne. B.A.R. British Series, 109: 55-72.
Bullock D., Rackham J., 1982. Epiphysial fusion and tooth eruption of feral goats from Moffatdale, Dumfories and Galloway. In
“Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites”. A cura di B. Wilson, C. Grigson, S. Payne. British Archaeo-logical Reports, British Series, 109: 73-80.
De Grossi Mazzorin J., 1987. La fauna. In “La villa dei Quintili a Monte-porzio”. A cura di G. Ghini. Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica, 14: 1-57.
De Grossi Mazzorin J., 1989. Nota preliminare sulla fauna. In “Curia, Forum Iulium, Forum Transitorium”. A cura di C. Morselli, E. Tortorici. Lavori della Soprintendenza Archeologica, 14: 340-347.
De Grossi Mazzorin J., 1995. La fauna rinvenuta nell’area della Meta Sudans nel quadro evolutivo degli animali domestici in Ita-lia. In “Atti del 2° Convegno Nazionale di Archeozoologia”. Asti 14-16 novembre. ABACO, Forlì, pp. 309-318.
De Grossi Mazzorin J., 1996. I resti faunistici. In “Aqua Marcia. Lo scavo di un tratto urbano”. A cura di R. Volpe, Firenze, Edizioni all’Insegna del Giglio, pp. 203-214.
De Grossi Mazzorin J., 1998. L’analisi dei resti ossei animali. In “IV. - Roma. Saggio di scavo nell’aula di S. Isidoro in Thermos”. A cura di D. Candilio. Notizie degli Scavi di Antichità, VII-VIII (1996-97): 203-214.
De Grossi Mazzorin J., Riedel A., Tagliacozzo A., 1998. Horse remains in Italy from the Eneolithic to the Roman period. Proceed-ings of the XIII International Congress of Prehistoric and Pro-tohistoric Sciences, Forlì (Italia) 8-14 september 1996, vol. 6, tome I, pp. 87-92.
De Grossi Mazzorin J., 2000. Etat de nos connaissances concernant le traitement et la consommation du poisson dans l’an-tiquité à la lumière de l’archéologie. MEFRA, Tome 112, 1: 155-167.
Driesch A. von den, 1976. A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Peabody Museum Bulletin, 1: 1-138.
Farello P., 1995. I cani tardo-antichi rinvenuti in un condotto fogna-rio di Classe (RA). In “Atti del 2° Convegno Nazionale di
Archeozoologia”. Asti 14-16 novembre. ABACO, Forlì, pp. 377-380.
Guilbert H.R., Gregory P.W., 1952. Some features of growth and devel-opment in Hereford cattle. Journal of Animal Science, 11: 3-16.
Harcourt R.A., 1974. The Dog in Prehistoric and Early Historic Bri-tain. Journal of Archaeological Science, 1: 151-175.
Kiesewalter L., 1888. Skelettmessungen am Pferde, Diss., Leipzig, pp. 1-88.King A.C., Rhodes P.A., Rielley K., Thomas K.D., 1985. I resti animali.
In “Settefinestre. Una villa schiavistica nell’Etruria romana. La villa e i suoi reperti, III”. A cura di A. Ricci, Modena, pp. 278-306.
Koudelka F., 1884. Das Verhaltnis der ossa longa zur Skeletthöhe bei den Saugetieren. Verhandl. d. Naturforsch. ver. Brünn, 24: 127-153.
Mackinnon M., 2001. High on the Hog: Linking Zooarchaeological, Literary, and Artistic Data for Pig Breeds in Roman Italy. American Journal of Archaeology, 105: 649-73.
Bibliografia
430 C. Minniti
Matolcsi J., 1970. Historische Erforschung der Körpergrösse des Rindes auf Grund von Ungarischem Knochenmaterial. Zeitschr. f. Tier-züchgt. u. Zücthgsbiol., 87, 2: 89-137.
May E., 1985. Widerristhöhe und Langknochenmasse bei Pferden-ein immer noch aktuelles Problem. Z. Säugertierkunde, 50: 368-382.
Nobis G., 1954. Ur- und frühgeschichtliche Rinder Nord- und Mittel-deutschlands. Zeitschrift fur Tierzüchgt. und Zücthgsbiologie, 63: 155-194.
Payne S., 1973. Kill-off patterns in sheep and goats: the mandibles from Asvan Kale. Anatolian Studies, 33: 281-303.
Silver I., 1969. The ageing of domestic animals, In “Science in archaeology”. A
cura di D. Brothwell, E.S. Higgs, London, pp. 283-302.Tagliacozzo A., 1993. I reperti faunistici. In “Caput Africae I. Indagini
archeologiche a Piazza Celimontana (1984-1988). La storia, lo scavo, l’ambiente”. A cura di C. Pavolini, Roma, pp. 251-278.
Teichert M., 1975. Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widderisthöhe bei Schafen. In Archaeozoological Stud-ies. A cura di A.T. Clason, Amsterdam, Oxford, New York, pp. 51-69.
Zalkin V., 1960. Metapodial variation and its significance for the study of ancient horned cattle. Biulleten Moskovskoe obshchestvo ispytatelei prirody otdel denii biologischeskei, NS 65: 109-126.
Pozzo 6 us 67
Equus caballusCoxale
1. LA = 59,5; LAR = 64* Tibia
1. GL = 340; Ll = 323; Bp = 87*; SD = 36,2; DD = 26,5; Bd = 67,7; Dd = 41
Metatarso 1. GL = 274,5; GLl = 271; Ll = 270; Bp = 49,5; Dp = 44,2; SD = 28,5;
DD = 23,5; Bd = 47; Dd = 36,4 2. GL = 274; Ll = 269; Bp = 49; SD = 28; DD = 23,9; Bd = 46,5;
Dd = 36,5
Bos taurusMascellare
1. (21) = 77Mandibola
1. (3) = 122; (7) = 136*; (8) = 88,5; (9) = 47; (10) = 37,2/14,2; (15a) = 72,3; (15b) = 52,2; (15c) = 41,9
2. (3) = 122,5; (7) = 140*; (8) = 90; (9) = 48,5; (10) = 37,5/14,5; (13) = 151*; (15a) = 72,5; (15b) = 49,5; (15c) = 41
Omero1. GLC = 278; Bp = 104; Dp = 114; Bd = 89; BT = 76*
Radio1. GL = 300; Bp = 85; BFp = 77,5; Dp = 45,5; SD = 45; DD = 25,5; Bd
= 78,7; Dd = 47; BFd = 72 Cuboscafoide
1. GB = 632. GB = 613. GB = 59,74. GB = 62
Metacarpo1. GL = 219,5; Bp = 68; Dp = 40; SD = 40,4; DD = 27,8; Bd = 68,5;
Dd = 36,22. GL = 195; Bp = 61,2; Dp = 41,5; SD = 36,7; DD = 23*; Bd = 66,8
Dd = 34,1
3. GL = 200; Bp =68,5; Dp = 40,7; SD = 37,2; DD = 23,1; Bd = 72,2; Dd = 37,4
4. GL = 206; Bp = 66; Dp = 39,5; SD = 41,5; DD = 23,8; Bd = 67; Dd = 33,8
5. GL = 207; Bp = 66,7; Dp = 39,3; SD = 41,7; DD = 24; Bd = 68,7; Dd = 33
6. GL = 194; Bp = 67,3; Dp = 40,7; SD = 38,4; DD = 23,2; Bd = 65,3; Dd = 33,5
7. GL = 219*; Bp = 68; Dp = 39,2; SD = 40,4; DD = 26,7; Bd = 68; Dd = 34
8. GL = 199; Bp = 68,3; Dp = 40,3; SD = 37; DD = 22,8; Bd = 71,5; Dd = 31,9
Tibia1. Bd = 69,5; Dd = 53,52. Bd = 68,2; Dd = 49,43. Bp = 113; Dp = 109
Calcagno1. GL = 149,5
Astragalo1. GL = 65,8; GLm = 62; Dl = 37,9; Dm = 37,4; Bd = 44,22. GL = 70,5; GLm = 66,5; Bd = 47*
Metatarso1. GL = 247; Bp = 55; Dp = 51,3; SD = 35,1; DD = 28,9; Bd = 62,8;
Dd = 35,22. GL = 229; Bp = 56,6; Dp = 52; SD = 30,9; DD = 28,1; Bd = 67,5;
Dd = 363. GL = 241; Bp = 54,5; Dp = 51; SD = 34,1; DD = 27,1; Bd = 62,5;
Dd = 334. GL = 224; Bp = 55,2; Dp = 48; SD = 31,7; DD = 26,5; Bd = 61;
Dd = 335. GL = 225; Bp = 54,8; Dp = 47,5; SD = 30,8; DD = 26; Bd = 61,5;
Dd = 336. GL = 234; Bp = 51,1; Dp = 47,7; SD = 33,8; DD = 26,8; Bd = 63;
Dd = 33,27. GL = 231; Bp = 55; Dp = 52; SD = 31; DD = 28,5; Bd = 71; Dd = 36,58. GL = 217; Bp = 54,5; SD = 30; DD = 25,5; Bd = 60,5; Dd = 339. GL = 248*; Bp = 56,3; Dp = 54; SD = 32,5; DD = 29,5; Bd = /;
Dd = 36*
Appendice
Le misure, espresse in mm, sono state prese secondo il metodo proposto da A. von den Driesch (1976).
Resti faunistici dalla Tenuta di Vallerano 431
10. Bp = 55; Dp = 50,8; SD = 31,5
Gallus gallusOmero
1. Bp = 21,5Ulna
1. Bp = 10; Dp = 14
Pozzo 7 us 63
Equus caballusCranio
1. (34) = 77; (36) = 35; (37) = 38,5Mascellare
1. (24) = 89*; (25) = 39x25,5; (26) = 27x26,5; (27) = 26x26,3; 2) (25) = 39x25; (26) = 27,3x26,8; (27) = 25x26,8; (28) = 22,5x26; (29) = 23,7x24,9
Mandibola1. (3) = 112,5; (7) = 80; (10) = 27x18,5; (11) = 25,5x18; (12) = 23,5x16;
(13) = 23,2x15,5; (14) = 33x13; (19) = 230; (22a) = 99; (22b) = 78; 2) (19) = 231; (20) = 217
M2 inferiore1. (12) = 24,3x15,4
M3 inferiore1. (14) = 32,4x13,3
Epistrofeo1. SBV = 45,4; Bpacd = 62
Scapola1. GLP = 93,5; LG = 58; SLC = 58,12. GLP = 92,5; LG = 57,5; BG = 49,5; SLC = 58*
Omero1. GLC = 278; SD = 34,2; DD = 40,4; Bd = 81; Dd = 80; BT = 74*2. Bd = 82; Dd =81; BT = 73,8
Radio1. Bp = 79,5; BFp = 74,5; Dp = 48,8; SD = 35,1; DD = 29,12. Bp = 81; BFp = 72,8; Dp = 51; Bd = 75*; Dd = 44,5; BFd = 64,2
Ulna1. BPC = 42,3; DPA = 64; SDO = 47,12. BPC = 42,5
Metacarpo1. GL = 222; Ll = 216; GLl = 220; Bp = 51,5; Dp = 33,5; SD = 35,2; DD
= 20,2; Bd = 50,4; Dd = 35,22. GL = 222,5; Ll = 216; GLl = 220; Bp = 52,3; Dp = 33,5; SD = 35;
DD = 20; Bd = 50,7; Dd = 35,6Femore
1. Dp = 114; SD = 39,62. GLC = 360; DC = 58,5; SD = 38,3; Bd = 94; Dd = 1213. Bp = 96,7; SD = 39,5; DD = 32,4; Bd = 74,2; Dd = 47,54. GL = 369; Ll = 315; Bp = 93,6; SD = 41,5; DD = 30,2; Bd = 74,6;
Dd = 47Metatarso
1. GL = 266; GLl = 262,5; Ll = 258; Bp = 50,1; Dp = 43,5; SD = 32,8; DD = 25,5; Bd = 48,7; Dd = 37,5
2. GL = 266; GLl = 263; Ll = 258; Bp = 50,4; Dp = 46; SD = 32,2; DD = 24,7; Bd = 49,9; Dd =36,8
Calcagno1. GL = 113,6; GB = 522. GL = 114,8
Falange I1. GL = 84,5; Bp = 55,8; BFp = 53; Dp = 37,8; SD = 36; Bd = 48,5;
BFd = 45,42. GL = 84,5; Bp = 55,9; BFp = 53; Dp = 37,3; SD = 35,8; Bd = 47,6;
BFd = 44,63. GL = 88,5; Bp = 56,7; BFp = 52; Dp = 36,3; SD = 35,6; Bd = 47,5;
BFd = 464. GL = 86,5; Bp = 53,7; BFp = 51; Dp = 35,4; SD = 37; Bd = 51,9;
BFd = 45,8Falange II
1. GL = 48,2; Bp = 54,4; BFp = 47,5; Dp = 32,4; SD = 45,2; Bd = 47,4Falange III
1. GL = 55; LF = 28*; BF = 48,5; Ld = 46,2; HP = 39,52. GL = 48; LF = 28*; BF = 49,5; Ld = 41; HP = 383. LF = 28*; BF = 48,5.
Ovis vel CapraMandibola
1. (7) = 62; (8) = 43; (9) = 18; (10) = 21,5x?; (15b) = 21,9Metacarpo
1. Bp = 22; Dp = 15,52. Bp = 23,7; Dp = 17
Tibia1. Bp = 40,5; Dp = 37,32. Bp = 45*
Metatarso1. Bp = 22,5; Dp = 23.
Canis familiarisEpistrofeo
BF cr = 27,9; SBV = 20,5Mandibola
1. (11) = 35,5; (12) = 30,5; (10) = 36,5*; (15) = 9x6,1; (20) = 19,3; (17) = 11; (8) = 69*; (9) = 64*
2. (13) = 20,5x8,7; (15) = 9,5x7; (17) = 11,2; (19) = 23,83. (11) = 37,4; (12) = 32; (10) = 28,7; (13) = 18x7,5; (14) = 17,3; (8) = 66;
(9) = 614. (10) = 34; (13) = 20x8,8; (14) = 19,5; (15) = 9,5x6,85. (8) = 68,4; (9) = 63; (10) = 34,5; (13) = 22,5x8,5; (14) = 20,5; (15) =
9x6,3; (17) = 10,8; (19) = 25,2; (20) = 18,3M3 inferiore
1. (13) = 17,7x6,9Omero
1. Bd = 22,2; Dd = 25*2. Bp = 28*; Dp = 37; SD = 12,5; DD = 13
Lepus europaeusTibia
1. Bp = 19,1; Dp = 13.
Pozzo 11
Equus caballusM2 superiore
1. (25) = 35,5x25,32. (25) = 37,6x25,53. (25) = 35x23,5
Mandibola1. (9) = 33,2x15,3
432 C. Minniti
P2 inferiore1. (9) = 30,7x15,3
Atlante1. BFcd = 77
Epistrofeo1. BFcr = 76
ScapolaGLP = 83,5; LG = 51,5
Omero1. GLl = 277*; GLC = 263; Dp = 88; SD = 28,4; DD = 39,3; Bd =
73; Dd = 73Radio
1. GL = 323; Bp = 73,6; BFp = 67; Dp = 42,2; SD = 32; DD = 25,82. Bp = 73; Bfp = 67,1; SD = 32,6; Dp = 42,9; DD = 24,5 Bd = 70,6;
BFd = 60; Dd = 39Metacarpo
1. GL = 227; GLl = 225; Ll = 220; Bp = 48,7; Dp = 33; Bd = 48,3; Dp = 35,3; SD = 31,2; DD = 20,7
2. Bp = 46; Dp = 30Coxale
1. LA = 61,7*Femore
1. Bp = 106; DC = 50,3; SD = 36,2; DD = 41,72. GL = 370; SD = 32,4; DD = 43,3; Bd = 86; Dd = 108
Tibia1. Bd = 68,2; Dd = 42,2; SD = 33,4; DD = 27,62. Bd = 69,5; Dd = 42; SD = 33,8; DD = 27,2
Metatarso1. Bp = 46; Dp = 39,72. Bd = 46,5; Dd = 35,93. GL = 266; Sd = 27,4; DD = 21,8; Bp = 47,3; Dp = 41,8
Astragalo1. GH = 55,8; LmT = 55,3; GB = 61; BFd = 47,9; GLl = 56,2
Calcagno1. GL = 102; GB = 43
Scafoide tarsale1. GB = 47,6.
Prima falange1. GL = 82; Bp = 50,5; BFp = 45,5; SD = 29,6; Bd = 42; BFd = 40,2;
Dp = 32
Ovis vel CapraMandibola
(10) = 24,3x8,9; 2) (8) = 42,4; (10) = 21,4x8; 3) (10) = 24,2; 4) (10) = 22x8,2; 5) (10) = 22,5x8,1
OmeroSD = 16,7; DD = 15,3; 2) BT = 28,2
MetacarpoBp = 23,3; Dp = 15,6; 2) Bp = 28,1; Dp = 19,8; SD = 16
Femore1. DC = 25,3
Tibia1. Bd = 32,1; Dd = 25; SD = 17,9; DD = 14,3
Metatarso1. Bp = 21,4; SD = 11,8; DD = 10,3
Ovis ariesScapola
1. SLC = 19,2
2. SLC = 18,3Radio
1. Bp = 38,8; Dp 19,62. Dp = 18,2
Capra hircusMetacarpo
GL = 133; Bp = 27,5; Dp = 19,7; Sd = 18,4; DD = 11,7; Bd = 31; Dd = 19,4
Metatarso1. Gl = 189*; Bp = 25,8; Dp = 24,9; SD = 14,5; DD = 13*; Bd = 29,8;
Dd = 19,92. GL = 180; Bp = 26,2; Dp = 24,9; Sd = 14,5; DD = 12,9; Bd = 29,4;
Dd = 20,4
Canis familiarisMascellare
1. (18) = 18,9x10,2; (20) = 13*x15,5*; (21) = 7,8x102. (18) = 17x9,1; (21) = 6,9x8,43. (15) = 72,3; (16) = 18; (17) = 56,6
Scapola1. GLP = 31,5; BG = 17,8; SLC = 25
Omero1. Dp = 47; GLC = 177*; Bd = 35*; SD = 14,9; DD = 15,92. Bd = 36,1; DD = 29,4; SD = 14,9; DD = 15,63. Bp = 34,6; Dp = 46,14. Bd = 32,9; DD = 26,7; SD = 12,8; DD = 135. Dp = 40,9
Radio1. GL = 181*; SD = 15,6; DD = 8,8; Bd = 27,9; DD 15*2. GL = 188; SD = 15; DD = 7,8; Bd = 27,1; Dd = 15,23. Bp = 14,8; Dp = 9; SD = 11,6; DD = 64. Bd = 27,6; Dd = 15,7
Femore1. Bd = 37;2; Dd = 372. DC = 20,3
Tibia1. Bp = 38,7; Dp = 42,52. Bd = 21,6; Dd = 163. Bd = 25,8; Dd = 18,94. GL = 210,5; Bp = 40,5; Dp = 40,5; SD = 15; DD = 13,7; Bd = 24,6;
Dd = 18,85. GL = 207; Bp = 37; Dp = 42,5; SD = 15,1; DD = 14,9; Bd = 25;
Dd = 18,6IV metatarso
1. GL = 85,22. GL = 86,8
V metatarso1. GL = 75*
Astragalo1. GL = 29,8
Lepus europaeusFemore
1. Bp = 23,1; DC = 8,9
Gallus gallusScapola
1. Dic = 11,8




















![I resti faunistici [Il villaggio medievale di Geridu (Sorso, SS)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321608b0c12e1161503c46b/i-resti-faunistici-il-villaggio-medievale-di-geridu-sorso-ss.jpg)