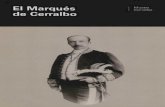I resti faunistici dell’insediamento eneolitico di Briatico (VV)
Transcript of I resti faunistici dell’insediamento eneolitico di Briatico (VV)
Claudia Minniti*
I resti faunistici dell’insediamento eneolitico di Briatico (Vibo Valentia)Faunal remains from the Chalcolithic settlement of Briatico (Vibo Valentia)
Vengono analizzati i resti faunistici rinvenuti nell’insediamento di Briatico contrada Gaio (Vibo Valentia), datato all’Eneo-litico finale in base alla morfologia delle forme vascolari e alla presenza della ceramica decorata a squame documentata nell’intera sequenza stratigrafica. I resti determinati appartengono principalmente alle specie domestiche. Tra queste prevalgono gli ovicaprini cui seguono in ordine d’importanza i suini e i bovini. A queste specie si aggiungono pochi resti di cane, di cervo, di tartaruga terrestre e di volpe. Pur nella sua esiguità e nel suo cattivo stato di conservazione, l’analisi del campione dei resti ossei di Briatico permette di trarre alcune considerazioni generali sull’economia di allevamento nel periodo considerato.
The paper discusses the results of the study of the archaeozoological remains from the Chalcolithic settlement of Briatico (Vibo Valentia). Sheep and goat, cattle and pig contributed mainly to the diet of the inhabitants of Briatico. Among the three main kinds of domestic animals, the majority of remains belongs to sheep and goat in all phases, while pig and cattle are respectively less represented. Dog is also present. Wild species would only have had an accessory role. Among these, red deer, turtle and fox are present. In spite of the low number of identified remains, this sample provides additional information about the animal economy and husbandry in this period.
Parole chiave: Eneolitico, Calabria, insediamento, allevamento, economia.Keywords: Chalcolithic, Calabria, settlement, husbandry, economy.
*Laboratorio di Archeozoologia, Soprintendenza Archeologica di Roma.
Atti 3° Convegno Nazionale di Archeozoologia (Siracusa, 2000), pp. 241-250.
242 C. Minniti
Introduzione
L’insediamento eneolitico di Briatico contrada Gaio (Vibo Valentia), messo in luce durante i lavori di sban-camento per la costruzione di una strada, è stato oggetto di indagini da parte della Soprintendenza Archeologica della Calabria nel 1995.
La morfologia del territorio di Briatico è caratterizzata da una serie di terrazzi marini di formazione miocenica, incisa da numerosi corsi fluviali a regime torrentizio. Il giacimento di contrada Gaio si trova alla base della fale-sia rocciosa denominata Piano del Salvatore, ed è posto proprio nel punto in cui ha origine il declivio vallivo della fiumara Murria (comunicazione personale della dott.ssa G. Grandinetti).
Il sito è datato all’età del Rame in base alla morfologia delle forme vascolari e alla presenza della ceramica deco-rata a squame, documentata nell’intera sequenza strati-grafica.Il deposito era costituito da 11 livelli di frequentazione,
testimoniati da reperti archeologici (ceramica, industria litica e resti faunistici) adagiati sul terreno su piano oriz-zontale, da frammenti di intonaco anche di grosse dimen-sioni e da frequenti aree di fuoco con chiazze cenerogno-le e nerastre, a volte delimitate da pietre. I livelli di fre-quentazione, pur essendo intervallati da brevi periodi di abbandono corrispondenti a strati di terreno sterile spes-si in genere 5 o 6 cm, sono attribuibili tutti alla stessa facies culturale.
Il campione
Il campione faunistico esaminato è composto da 1053 resti, di cui 398 sono stati determinati a livello speci-fico, mentre 160 sono riferibili a coste, 17 a vertebre e 478 sono frammenti per i quali non è stato possibi-le effettuare la determinazione nemmeno a livello ana-tomico.
I resti determinati appartengono principalmente alle tre principali forme di animali domestici (bovini, capro-vini e suini), che costituiscono circa il 97% (tab. 1).
Tra gli animali domestici prevalgono gli ovicaprini rappresentati dal 52% dei resti, mentre i suini e i bovi-ni costituiscono rispettivamente il 39% e il 9% del cam-pione. Le proporzioni si mantengono simili, anche se più equilibrate, se consideriamo il numero minimo di indivi-dui, calcolato tenendo conto della suddivisione stratigra-fica in 11 differenti piani di frequentazione (fig. 1). In que-sto caso si registra un leggero aumento in termini percen-tuali dei bovini (15%), in concomitanza di un leggero calo degli ovicaprini (45%).I resti di caprovini sono presenti in tutti i livelli di fre-
quentazione del sito (tab. 2). I dati sulla mortalità stimati in base alla fusione delle
epifisi articolari delle ossa lunghe (tab. 3), secondo il lavo-ro di Bullock e Rackham (1982), indicano la prevalen-za di individui che avevano raggiunto la piena maturità, anche se non mancano animali giovani. Anche dall’esa-me dell’eruzione, della sostituzione e dell’usura dei denti, effettuato applicando il metodo di Payne (1973), si verifi-ca che la metà degli animali raggiungeva i 4 anni, men-tre dei rimanenti la gran parte veniva uccisa tra il primo
Fig. 1. Percentuali delle tre principali categorie di anima-li domestici (bovini, caprovini e suini) in base al numero dei
resti (a) e del numero minimo di individui (b).
L’insediamento eneolitico di Briatico (Vibo Valentia) 243
Tab. 1. Numero dei resti (NR) e relativo numero di individui (NMI) degli animali identificati e resti indeterminati.
Elemento anatomicoLivelli
I II III IV V VI VII VIII IX XICorna 1Cranio 2Mascellare 1 1Denti superiori 2 3 5 3 5 4 2 1 2Mandibola 2 1 1 8 2 2 2 3 3Denti inferiori 6 1 3 8 7 2 1 1 2Denti indeterminabili 1Ioide 1Scapola 2 1 2 1 1 1Omero 1 3 2 3 3 2 1Radio 3 1 1 5 1 2 1 1 5Radio+ulna 1 1Ulna 1 1 1Ossa carpali 1 1Metacarpo 2 2 1Coxale 3 1 1 1 2Femore 1 1 3 1 1 1 1Tibia 1 3 1 3 2 3Astragalo 1Calcagno 1 1Metatarso 1 2 2 1 3Falange I 1 1 1Falange III 1Totale 18 11 20 31 29 17 22 13 6 23
Taxa NR NMI
Bue (Bos taurus) 34 10
Pecora o Capra (Ovis vel Capra) 186
Pecora (Ovis aries) 2 30
Capra (Capra hircus) 2
Maiale (Sus scrofa dom.) 143 26
Cane (Canis familiaris) 21 7
Cervo (Cervus elaphus) 1
Tartaruga (Testudo hermanni) 6 4
Volpe (Vulpes vulpes) 3 3
Totale determinati 398
Indeterminati
Coste 160
Vertebre 17
Frammenti non determinabili 478
Totale complessivo 1053
Tab. 2. Elenco dei resti dei caprovini suddivisi per elemento anatomico.
Tab. 3. Mortalità degli ovicaprini in base alla fusione delle epifisi (NF=non fuse; F=fuse).
Elemento anatomico Età NF-F
Omero dist. <12 mesi 0-3
Coxale <12 mesi 0-1
Scapola 12 mesi 0-2
Falange I 14-35 mesi 1-1
Tibia dist. 35 mesi 0-2
Femore pross. 35 mesi 0-2
Metatarso dist. 48 mesi 0-2
Radio dist. 48-60 mesi 1-1
Calcagno 48-60 mesi 1-0
244 C. Minniti
Elemento anatomicoLivelli
I II III IV V VI VII VIII IX XI
Cranio 4 2 3 1 1 1 1 2
Mascellare 1 1 3 4 1
Denti superiori 2 4 1 2 1 1 3
Mandibola 1 1 4 1 3 1 2 4
Denti inferiori 4 1 1 1 1 2 1 3
Denti indeterminabili 1 1 1 1
Scapola 1 1 1 1 1 1 3
Omero 2 1 1
Radio 1 2 1 1 1
Ulna 1 1 1
Metacarpali 2 1 1 2 2
Coxale 1 1 1
Femore 1
Rotula 1
Tibia 1 1 1 4 1 1
Fibula 1 2 2 1 1
Calcagno 2 1
Metatarsali 1 1 1
Metapodiali 1 2 1
Falange I 1 1 1 1 1 1
Falange II 1
Falange III 1
Totale 17 13 13 18 7 16 14 9 15 21
Tab. 4. Elenco dei resti di suini suddivisi per elemento anatomico.
Stadio di usura NR
<7 mesi 4
7-11 mesi 3
19-23 mesi 2
24-30 mesi 3
31-35 mesi 4
>36 mesi 1
Totale 17
Tab. 5. Mortalità dei suini in base all’eruzione, usura e sosti-tuzione dei denti mandibolari e mascellari.
Elemento anatomico Età NF-F
Scapola 7-11 mesi 0-2Coxale 7-11 mesi 0-2Radio pross. +11 mesi 1-4Omero dist. +11 mesi 0-2Falange II 12-18 mesi 1-0Tibia dist. 19-23 mesi 1-0Falange I 19-23 mesi 3-3Metacarpo dist. +23 mesi 3-1Metapodio dist. +23 mesi 2-1Tibia pross. +36 mesi 1-0Calcagno +36 mesi 1-1
Tab. 6. Mortalità dei suini in base alla saldatura delle epifisi.
L’insediamento eneolitico di Briatico (Vibo Valentia) 245
e il terzo anno di vita (tab. 4). La presenza di individui giovanissimi, in età neonatale, è indicata soltanto da un terzo molare deciduo poco usurato e da alcune ossa lun-ghe (un omero, un radio e una tibia) di cui si è conserva-ta la diafisi.
È chiaro che queste stime sono solo indicative sia per il basso numero di resti analizzati, sia per la mancata distinzione tra capre e pecore o tra maschi e femmine, che senza dubbio avevano un differente destino nell’alle-vamento. Probabilmente la pastorizia era volta sia al con-sumo di carne che alla lavorazione di altri prodotti (latte, lana, ecc.), anche se non abbiamo dati sufficienti per sta-bilire in quali termini percentuali.
Per quanto riguarda la statura degli ovicaprini, soltan-to in 2 casi si è potuto calcolarne l’altezza, che è risulta-ta rispettivamente di 56,3 e di 59,8 cm applicando i coef-ficienti di Teichert (1975) ad un metatarso di pecora e ad un astragalo.Anche i resti suini sono distribuiti in tutti i livelli di fre-
quentazione (tab. 4).
In base alla fusione delle epifisi articolari delle ossa lun-ghe e dell’eruzione, sostituzione e usura dei denti (Bull, Payne, 1982), si può notare che la maggior parte dei resti appartiene a individui macellati entro i primi due anni di vita, anche se almeno due emimandibole rivelano la presenza di individui sia giovanissimi che senili (tabb. 5-6). L’allevamento del maiale doveva svolgersi in modo da sfruttare al meglio le attitudini della specie. Infatti il maiale perché possa rendere il massimo di carne in rap-porto al consumo, deve essere macellato tra il primo e il secondo anno di età. Inoltre è necessario ai fini della riproduzione mantenere in vita un certo numero di indi-vidui adulti.
Per un terzo metacarpo e un calcagno è stata stimata l’al-tezza al garrese, applicando i coefficienti di Teichert (1969), che è risultata rispettivamente di 72,8 e di 74,7 cm.
L’allevamento bovino doveva essere secondario a quel-lo ovino e suino; infatti questa specie è rappresentata da un numero piuttosto basso di resti in tutti i livelli di fre-quentazione del sito (tab. 7).
Elemento anatomicoLivelli
I II III IV V VI VII VIII IX XICranio 1 1 1 2Mascellare 1Denti superiori 1 1 1 1Mandibola 2 1 1Denti inferiori 1Denti indeterminabili 1Atlante 1Scapola 1Omero 2Ulna 1Ossa carpali 1 1Metacarpo 1Femore 1 1Tibia 1 1Astragalo 1Falange I 1Falange II 1 1 1Falange III 1Totale 6 1 6 1 3 1 3 4 9
Tab. 7. Elenco dei resti bovini suddivisi per elemento anatomico.
246 C. Minniti
Questo animale doveva essere utilizzato soprattutto per lo sfruttamento dei prodotti secondari e come forza lavoro. Infatti dai dati sulla mortalità, ottenuti in base alla fusione delle epifisi articolari delle ossa lunghe (Sil-ver, 1969), si può dire che i resti appartenevano tutti ad animali di età adulta.Accanto alle tre principali categorie di animali dome-
stici sono presenti alcuni resti di cane (tab. 8), un osso di cervo, pochi frammenti di carapace e di piastroni di tar-taruga terrestre e tre resti di volpe (tab. 1).
Considerazioni
Pur nella sua esiguità l’analisi del campione permette di trarre alcune considerazioni sulle strategie di allevamen-to nel periodo considerato. L’economia dell’insediamen-to di Briatico è volta soprattutto verso la pastorizia, cui segue in ordine d’importanza l’allevamento suino. L’al-levamento bovino sembra invece avere scarsa incidenza sull’economia del sito.
Nel resto della penisola e in particolare modo nell’Ita-lia meridionale, i dati archeozoologici disponibili per il periodo considerato sono scarsi.
Nella tabella 9 sono riportati i siti eneolitici dell’Ita-lia centrale e meridionale di cui si dispongono i dati fau-nistici. Da questa tabella è stato ricavato il grafico della figura 2, in cui ogni lato del triangolo rappresenta la scala percentuale relativa ai bovini, caprovini e suini ed ogni sito si posiziona nel punto d’intersezione dei tre valori. I dati che ne derivano indicano una distinzione tra i due versanti, tirrenico e adriatico, e tra aree centrale e meri-dionale della penisola. Tuttavia si deve considerare che si stanno confrontando campioni faunistici provenienti da contesti diversi tra loro (abitato all’aperto, grotte) e che il più del volte sono piuttosto piccoli e non completamente attendibili da un punto di vista statistico.
Sul versante tirrenico la maggior parte dei siti presenta-no economie basate soprattutto sulla pastorizia. L’alleva-
Tab. 8. Elenco dei resti di cane suddivisi per elemento anatomico.
Elemento anatomicoLivelli
I II III IV VI VII XICranio 1Mascellare 1 1Mandibola 1 1 1Denti inferiori 1Denti indeterminabili 3 2 1Atlante 1Omero 1 1Ulna 2Coxale 1Femore 1Metatarsali 1Totale 1 2 10 5 1 1 1
Fig. 2. Percentuali delle principali categorie di animali dome-stici di alcuni siti eneolitici dell’Italia centrale e meridionale.
L’insediamento eneolitico di Briatico (Vibo Valentia) 247
mento prevalente di caprovini è infatti attestato nell’abi-tato di Poggio Olivastro presso Canino (VT) (Bulgarel-li et al., 1993), a Maccarese-Fianello (Curci, Tagliacozzo, 1995), negli insediamenti situati nel territorio di Roma, Quadrato (De Grossi Mazzorin, Minniti, 1995) e Pisci-na di Torre Spaccata (RM) (Clark, 1984) e S. Giovanni in Campo Marzio (Marconi, Minniti, 1997) e nell’area meridionale a Grotta Cardini (Tagliacozzo et al., 1989) e Latronico (Sorrentino, 1978). Solo a Sesto Fiorentino (Sarti et al., 1987-88) l’allevamento bovino prevale sulle altre forme di allevamento animale. Il quadro così deli-neato per questi insediamenti si diversifica per quanto
riguarda il rapporto percentuale tra allevamento bovino e quello suino. Infatti nell’Italia centrale i bovini sembra-no avere maggiore importanza rispetto ai suini, mentre nell’area meridionale a grotta Cardini e Latronico grot-ta 3, l’allevamento del maiale prevale su quello bovino e a Latronico grotta 2 le due percentuali si equivalgono.
Sul versante adriatico a Conelle (Wilkens, 1999), ad Attiggio (Wilkens, 1985) e a Cava Giacometti (Siracusa-no, 1994), è attestata un’economia basata prevalentemen-te sull’allevamento del maiale e su quello bovino, men-tre ad Ortucchio (Wilkens, 1991) l’economia sembra più equilibrata tra le diverse forme di allevamento con una
Tab. 9. Percentuali delle principali categorie di animali domestici di alcuni siti eneolitici dell’Italia centrale e meridionale.
Sito BibliografiaBue Capra/Pecora Maiale
NR % NR % NR %
Versante tirrenico
1. Sesto Fiorentino Sarti et al., 1987-88 28 47,5 17 28,8 14 23,7
2. Poggio Olivastro Bulgarelli et al., 1993 30 28,5 64 60,9 11 10,4
3. Maccarese-Fianello Curci,Tagliacozzo, 1995 29 11,7 131 53 87 35,2
4. Quadrato di Torre Spaccata De Grossi Mazzorin, Minniti, 1995 19 34,5 31 56,3 5 9
5. Piscina di Torre Spaccata Clark, 1984 36,7 49,4 13,8
6. S. Giovanni in Campo Orazio Marconi, Minniti, 1997 11 33,3 15 45,4 7 21,2
7. Grotta Cardini (tagli 7 e 10) Tagliacozzo et al., 1989 40 17,1 118 50,6 75 32,1
8. Briatico 34 9,2 190 51,8 143 38,9
9. Latronico 2 Sorrentino, 1978 19 15,2 87 69,6 19 15,2
10. Latronico 3 Sorrentino, 1978 38 10,5 187 52 134 37,3
Versante adriatico
11. Conelle fase E Wilkens, 1999 80 48,4 18 10,9 67 40,6
12. Conelle fase D Wilkens, 1999 102 35 44 15,1 145 49,8
13. Conelle fase C Wilkens, 1999 364 26,7 220 16,1 777 57
14. Conelle fase B Wilkens, 1999 610 24,1 455 17,9 1465 57,9
15. Cava Giacometti Siracusano, 1994 5 33,3 6 40 4 26,6
16. Attiggio IV Wilkens, 1985 32 26,8 27 22,6 60 50,4
17. Grotta dei Piccioni Cremonesi, 1976 2 6,8 14 48,2 13 44,8
18. Ortucchio Wilkens, 1991 20 37 20 37 14 25,9
19. Grotta S. Angelo Wilkens, 1996 8 17,4 21 45,6 17 36,9
20. Grotta Chiusazza str. IVc Villari, 1995 20 24,7 55 67,9 6 7,4
21. Grotta Chiusazza str. IVb Villari, 1995 33 20,5 100 62,1 28 17,4
22. Grotta Chiusazza str. IVa Villari, 1995 47 14,3 156 47,4 126 38,3
248 C. Minniti
Bulgarelli G.M., D’Erme L., Pellegrini E., Petitti P., Tagliacozzo A., 1993. L’insediamento preistorico di Poggio Olivastro (Canino, Viterbo). In Atti del Convegno “Preistoria e Protostoria in Etruria”, 1: 285-294.
Bull G., Payne S., 1982. Tooth eruption and epiphysial fusion in pigs and wild boar. In “Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites”. A cura di B. Wilson, C. Grigson, S. Payne. British Archaeologi-cal Reports, British Series, 109: 55-72.
Bullock D., Rackham J., 1982. Epiphysial fusion and tooth eruption of feral goats from Moffatdale, Dumfories and Galloway. In
“Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites”. A cura di B. Wilson, C. Grigson, S. Payne. British Archaeolo-gical. Reports, British Series, 109: 73-80.
Clark G., 1984. Sintesi dei dati faunistici di Piscina di Torre Spaccata. In “Preistoria e Protostoria nel territorio di Roma”. A cura di A.M. Bietti Sestieri, De Luca Editore, Roma, p. 159.
Cremonesi G., 1976. La Grotta dei Piccioni di Bolognano nel quadro delle culture dal Neolitico all’età del Bronzo in Abruzzo, Giardini, Pisa.
Curci A., Tagliacozzo A., 1999. Analisi preliminare della fauna. In “Scavi nel sito eneolitico di Le Cerquete-Fianello (Maccarese). Risultati preliminari”. A cura di A. Manfredini, G. Carboni, C. Conati Barbaro. Quaderni AEI, 23, pp. 358-360.
De Grossi Mazzorin J., Minniti C., 1995. I resti faunistici dell’insedia-mento di Quadrato di Torre Spaccata nel contesto delle economie di allevamento del Neolitico finale ed Eneoliti-co in Italia centrale. Origini, XIX: 287-295.
Driesch A. von den, 1976. A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Peabody Museum Bulletin, 1: 1-138.
Marconi N., Minniti C., 1997. Strategie di sussistenza ed attività eco-nomiche delle comunità preistoriche del Lazio. Annali dell’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia, Anno XV, 1: 57-63.
Payne S., 1973. Kill-off patterns in sheep and goats: the mandibles from Asvan Kale. Anatolian Studies, 33: 281-303.
Sarti L., Birtolo R., Corridi C., Foggi B., Magi M., Martini F., 1987-88. Il tumulo eneolitico di via Bruschi a Sesto Fiorentino. Rivista Scienze Preistoriche, XLI: 139-198.
Silver I., 1969. The ageing of domestic animals, In “Science in Archaeology”. A cura di D. Brothwell, E.S. Higgs, London, Thames and Hudson, pp. 283-302.
Sorrentino C., 1978. La fauna delle grotte n. 2 e n. 3 di Latronico (nota preliminare). Atti della XX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria: 219-226.
Tagliacozzo A., Scali F., Cassoli P.F., 1989. La fauna della Grotta Cardini. In “La Grotta Cardini (Praia a Mare-Cosenza): giacimento del Bronzo”. A cura di L. Bernabò Brea. Memorie dell’Istituto ita-liano di Paleontologia Umana, 4: 213-257.
Teichert M., 1969. Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widderisthöhe bei vor- und frühgeschictlichen Schweinen. Kühn Archiv, 83, 3: 237-292.
Teichert M., 1975. Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widderisthöhe bei Schafen. In Archaeozoological Stu-dies. A cura di A.T. Clason, Amsterdam, pp. 51-69.
Siracusano G., 1994. Le faune dell’insediamento stratificato di Cava Giacometti (Arcevia, Ancona). In “Il sito stratificato di Cava Giacometti (Arcevia, Ancona) nel quadro degli sviluppi culturali dell’Italia centro-settentrionale dal Neolitico all’età del Bronzo”. A cura di A. Cazzella, M. Moscoloni. Quaderni del Museo Archeologico Etnologico di Modena, 1, pp. 89-119.
Villari P., 1995. Le faune della tarda preistoria nella Sicilia orientale, Siracusa, Ente Fauna Siciliana.
Wilkens B., 1985. La fauna dei livelli neolitici ed eneolitici di Attiggio. Picus, V: 203-214.
Wilkens B., 1991. Resti faunistici ed economia preistorica nel bacino del Fucino. In “Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità”. Atti del Convegno di Archeologia, Avezzano 10-11/11/1989, Roma, pp. 147-153.
Wilkens B., 1996. Le faune. In “La Grotta S. Angelo sulla Montagna dei Fiori (Teramo)”. A cura di T. Di Fraia, R. Grifoni Cremo-nesi. Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, pp. 277-293.
Wilkens B., 1999. I resti faunistici. In “Conelle di Arcevia. Un insediamen-to eneolitico nelle Marche, I. Lo scavo, la ceramica, i manufatti metalli, i resti organici”. A cura di A. Cazzella, M. Moscoloni, Roma, pp. 213-260.
leggera predominanza di bovini e ovini. La pastorizia invece raggiunge valori alti alla grotta dei Piccioni (Cre-monesi, 1976) e alla grotta S. Angelo (Wilkens, 1996), ma la natura di questi ultimi contesti influisce notevolmen-te sui dati faunistici. Si tratta infatti di grotte frequenta-te sporadicamente o stagionalmente dai pastori durante la transumanza.
In Sicilia scarsi dati si hanno dalla Grotta della Chiu-sazza (Villari, 1995), dove in due livelli (strato IVc IVb) prevale la pastorizia seguita in ordine d’importanza dal-l’allevamento bovino, mentre nel terzo livello (strato IVa) l’allevamento suino sembra acquistare maggiore impor-tanza.
Bibliografia
L’insediamento eneolitico di Briatico (Vibo Valentia) 249
Astragalo GLl GLm Dl Dm Bd54,3* 52,3 31,9 27,2 35
Ovis vel Capra Mascellare 1947,2
Mandibola 7 8 9 10 15a 15b 15c70,7 48,2 21,5 21,8x7,6 36,4 19,2 13,974,7 50,1 21,1 21,2X8,1 19,1 13,672,4 49,4 21,6 22,3x8,7 33 11,570,7 49,2 20,8 22,9x8,9 17,3 14,4
48,1 22,7x8,2 31,8 15,4M3 inf. 10
21,5x8,421,9x8,2
Scapola GLP BG SLC29,6 19,3 19,8
18,818,214,4
Radio Bd Dd SD DD25,3 19,1 13,1 10,9
12,5 6,5 14,3 7,7
Ulna BPC16
Metacarpo Bp Dp22 15,3
Coxale LA22,9
Femore DC19,2
Tibia Bd Dd SD DD25,3 19,6 14 12,1
12,3 10,3Metatarso GL Bp Dp Bd Dd SD DD
125* 20,3 19,7 16* 10,2 9,5 Ovis aries?22 20,2 14,1 11,4
22,4 15,422,3 22,1
Astragalo GLl GLm Dl Bd26,4 25 15,6 16,9
Appendice
Le misure, espresse in mm, sono state prese secondo il metodo proposto da A. von den Driesch (1976).
250 C. Minniti
Sus scrofa dom. Cranio 21 2239,5* 23,4
Mandibola 1029,5x12,333,9x16,3
Scapola GLP BG SLC31,1 20,3 1931,8 24,2 20,4
21,8*Omero Bd Dd SD DD
39,1 34,6* 16,6 25,436,3 35,8 16,2
Radio Bp Dp SD DD28,8 18,5 16,9 11,127,4 19,1 15,736,3 18,2 14,9 9,8
Metacarpale III GL68
Calcagno GL GB80 20
Canis familiaris Mascellare 16 18 18a 20 2115,3 18,4 10,8 9,1x13,1 5,3x9,1
Mandibola 13 14 1518,8x8 18,3 7,7x5,3
Coxale LA19,8
Vulpes vulpes Femore DC11,6.














![I resti faunistici [Il villaggio medievale di Geridu (Sorso, SS)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321608b0c12e1161503c46b/i-resti-faunistici-il-villaggio-medievale-di-geridu-sorso-ss.jpg)