I resti vegetali delle miniere di Usseglio (val di Viù, Torino
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of I resti vegetali delle miniere di Usseglio (val di Viù, Torino
Terre rosse, pietre verdi e blu cobalto
Miniere a Usseglio Seconda raccolta di studi
A cura di Maurizio Rossi e Anna Gattiglia
2013 Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti»
Usseglio
Terre rosse, pietre verdi e blu co-balto. Miniere a Usseglio. Seconda raccolta di studi / a cura di Mauri-zio Rossi e Anna Gattiglia. – Usse-glio: Museo Civico Alpino «Arnal-do Tazzetti», 2013. – 291 p.; ill.; 30 cm (Letture dal Museo Civico Alpino; 10) 1. MINIERE POLIMETALLICHE – Usseglio 2. MINIERE POLIME-TALLICHE – Geologia, storia e archeologia 622.34 ISBN 978-88-905076-4-9
Volume edito con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Caster-none, Comune di Usseglio.
Prima edizione italiana (testo aggiornato al 14 agosto 2013). Copyright © 2013 Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti», Piazza Cibrario, I-10070 Usseglio. Collana diretta da Maurizio Rossi. Proprietà letteraria riservata. Qualsiasi forma di riproduzione o trasmissione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fo-tostatico, magnetofonico o altro, e qualsiasi forma di utilizzazione in contesto pubblico sono consentite esclusi-vamente a fini scientifici, didattici e critici e solo previa autorizzazione scritta del Museo Civico Alpino. Esse re-stano comunque subordinate alla menzione completa dei seguenti dati: cognome e nome degli autori, titolo del-l’opera, luogo e data di edizione, nome dell’editore; nonché alla fornitura gratuita di una copia di ogni eventuale prodotto in cui l’opera sia stata, anche parzialmente, riprodotta. Qualsiasi forma di utilizzazione remunerativa di quanto eventualmente concesso è vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e degli art. 2575-2582 del Codice Civile. In prima di copertina: trincea mineraria medioevale con copertura di lastroni lapidei nel settore Lucellina (strut-tura L1-401; foto Maurizio Rossi 2011), sullo sfondo del territorio di Usseglio alla metà del XVIII secolo (estrat-to da Valle di Lanzo, Archivio di Stato di Torino, Sezione I, Carte topografiche dell’archivio segreto, Lanzo 18.A.II rosso; scala originaria circa 1:28.800, scala di stampa circa 1:34.200; autorizzazione prot. n. 1570/28.28.00 del 15 marzo 2013). In quarta di copertina: trincea mineraria con lastroni lapidei di copertura crollati all’interno e corridoio d’ingres-so di un ricovero ipogeo nel settore Lucellina (strutture L1-101 e L1-502; foto Maurizio Rossi 2009 e 2011).
Indice
Elenco degli autori p. 7 Ringraziamenti 8 MAURIZIO ROSSI Per suonare il pianoforte ci vogliono dieci dita 9 MAURIZIO ROSSI & ANNA GATTIGLIA L’inventario delle strutture minerarie arcaiche: il filone della Lucellina (l’Uzlin-a) nell’alto vallone di Arnàs (Usseglio) 11 GREGORIO SILVESTRO Droni radiocontrollati: le nuove tecnologie al servizio dell’archeologia 33 ANNA GATTIGLIA & MAURIZIO ROSSI Minatori, fonditori, cavatori: reperti di cultura materiale medioevale nelle collezioni del Museo Civico Alpino di Usseglio 45 RENATO NISBET I resti vegetali delle miniere di Usseglio (val di Viù, Torino) 61 MARIA STELLA SIORI Nota su alcune faune medioevali delle Terre Rosse (Usseglio, Torino) 74 ELISA CONZ, DIEGO BERNINI, GISELLA REBAY & MARIA PIA RICCARDI La pietra ollare nelle valli di Lanzo: approccio metodologico non invasivo per lo studio di caratterizzazione 75 LAURA VASCHETTI Lo studio della pietra ollare in Piemonte: proposte metodologiche e nuove indagini nelle valli di Lanzo 85 LUCA PATRIA Locus ipse prontior et idoneor est ad artes et merchancias quam ad agriculturam: il distretto siderurgico di Avigliana tardomedievale 107 GIOVANNI DONATO Problemi della pietra verde nella scultura e nel decoro architettonico tra medioevo e rinascimento: valli di Lanzo e arco alpino occidentale 145 MAURIZIO ROSSI & ANNA GATTIGLIA San Bernardo di Malciaussìa e dintorni 165
6 Indice
FRANCA PORTICELLI Iconografia mineraria e metallurgica in una cinquecentina pliniana della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (libro XXXIII, Metallorum naturae, e libro XXXIV, Aeris metalla) p. 175 ANNA GATTIGLIA & MAURIZIO ROSSI con la collaborazione di GUIDO GENTILE La miniera del Masòc (1515-1772) 181 PIERGIORGIO ROSSETTI & DANIELE CASTELLI con la collaborazione di ANNA GATTIGLIA & MAURIZIO ROSSI Nuovi ritrovamenti di mineralizzazioni e di lavori minerari nei valloni di Servìn e del Masòc (Usseglio, valli di Lanzo): primi dati geologico-petrografici e microanalitici 215 MAURIZIO GOMEZ SERITO La Fabbrica dell’Azzurro a Usseglio: lettura stratigrafica dell’edificio 229 MARTINA FERRARI Il mantice da forgia del Villaretto di Usseglio: un caso di studio 237 ANNA GATTIGLIA, FRANCESCA MARINO & MAURIZIO ROSSI con la collaborazione di ROBERTO CASTALDI & PIERGIORGIO ROSSETTI Prospezioni e sondaggi in miniere cobalto-nichelifere e in opifici metallurgici di Usseglio tra le due guerre mondiali (1920-1937) 253 CLAUDIA GIACOMELLI Gli ultimi minatori della Corna 279 CLAUDIA CHIAPPINO Miniere ad alta quota: osservazioni di un ingegnere minerario del XXI secolo 287 Sigle degli archivi storici AATO = Archivio Arcivescovile di Torino AOM = Archivio dell’Ordine Mauriziano ASCU = Archivio Storico del Comune di Usseglio AST = Accademia delle Scienze di Torino ASTOI = Archivio di Stato di Torino - Sezione I ASTOR = Archivio di Stato di Torino - Sezioni Riunite BNUTO = Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino BRTO = Biblioteca Reale di Torino
Elenco degli autori BERNINI Diego, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia,
Via Ferrata 1, I-27100 Pavia ([email protected]). CASTALDI Roberto, Istituto Tecnico Industriale di Stato, Via Lirelli 17, I-13011 Borgosesia
([email protected]). CASTELLI Daniele, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino e CNR,
Istituto di Geoscienze e Georisorse, Sezione di Torino, Via Valperga Caluso 35, I-10125 Torino ([email protected]).
CHIAPPINO Claudia, consigliere dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, membro della Commissione Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana, Corso Emilia 38, I-10152 Torino ([email protected])
CONZ Elisa, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia, Via Ferrata 1, I-27100 Pavia ([email protected]).
DONATO Giovanni, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, Via Accademia delle Scienze 5, I-10123 Torino (giovanni.donato@ beniculturali.it).
FERRARI Martina, Scuola di Alta Formazione e Studio Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, Via XX settembre 18, I-10078 Venaria Reale ([email protected]).
GATTIGLIA Anna, conservatore della sezione di archeologia mineraria e storia delle risorse economiche del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti», Piazza Cibrario, I-10070 Usseglio ([email protected]).
GENTILE Guido, già Sovrintendente Archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Torino. GIACOMELLI Claudia, collaboratrice del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti», Frazione
Pianetto, Via Antica 1, I-10070 Usseglio ([email protected]). GOMEZ SERITO Maurizio, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture del Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, I-10129 Torino ([email protected]).
MARINO Francesca, Biblioteca Civica di Chivasso, Piazzale 12 maggio 1944 n. 8, I-10034 Chivasso ([email protected]).
NISBET Renato, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Viale della Rimembranza 7, I-10066 Torre Pellice ([email protected]).
PATRIA Luca, presidente del Centro Ricerche di Cultura Alpina di Torino, Via Servais 194, I-10146 Torino ([email protected]).
PORTICELLI Franca, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Responsabile dell’Ufficio Manoscritti e Rari, Piazza Carlo Alberto 3, I-10123 Torino (franca.porticelli@ beniculturali.it).
REBAY Gisella, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia, Via Ferrata 1, I-27100 Pavia ([email protected]).
RICCARDI Maria Pia, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia, Via Ferrata 1, I-27100 Pavia ([email protected]).
ROSSETTI Piergiorgio, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino, Via Valperga Caluso 35, I-10125 Torino ([email protected]).
ROSSI Maurizio, direttore del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti», Piazza Cibrario, I-10070 Usseglio ([email protected]).
SILVESTRO Gregorio, Silvertech.Air Servizi aerei con droni, Via Bove 5, I-10070 Robassome-ro ([email protected]).
SIORI Maria Stella, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino, Via Accademia Albertina 13, I-10123 Torino ([email protected]).
VASCHETTI Laura, Via Rossini 4, I-10023 Chieri ([email protected]).
Ringraziamenti I curatori del presente volume desiderano ringraziare, oltre che gli autori degli studi qui pubblicati, tutti coloro che hanno contribuito in vario modo alla realizzazione delle ricerche:
– Elena Borgi, Accademia delle Scienze di Torino – Domenico Buratti, collaboratore del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» – Gianni Castagneri, Barmes News, Balme – Annamaria Castrale, conservatore della sezione di Scienze naturali e ambientali del Museo Civico
Alpino «Arnaldo Tazzetti» – Luisa Cibrario, collaboratrice del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» – Gianmaria Cuniglio, collaboratore del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» – Lucia Dellabernardina, collaboratrice del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» – Marziano Di Maio, Centro Studi Documentazione Memoria Orale, Giaglione – Aldo Fantozzi, Sindaco di Usseglio – Franco Ferro Famil «Voulpòt», collaboratore del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» – Silvio Ferro Famìl – Italo Ferro Tessior – Andrea Franciscono – Luisa Clotilde Gentile, Archivio di Stato di Torino – Guido Giacoletto – Cecilia Laurora, Archivio di Stato di Torino – Tiziano Mannoni, Istituto di Storia della Cultura Materiale, Genova – Silvia Marchisio, Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti», responsabile per la storia contempora-
nea – Rosanna Moroni conservatore della sezione di Vita, cultura, lingua e tradizioni locali del Museo Ci-
vico Alpino «Arnaldo Tazzetti» – Maria Paola Niccoli, Archivio di Stato di Torino – Abbondanza Nicolazzi, Archivio di Stato di Torino – Antonio Perino, già consigliere comunale di Usseglio – Danilo Perino, collaboratore del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» – Domenico Perino Bert, Vice Sindaco di Usseglio – Anna Perino Chin Chin, collaboratrice Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» – Johannes van der Plicht, Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen – Battista Re Fiorentin, collaboratore del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» – Ennio Re Fiorentin, collaboratore del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» – Giacomo Re Fiorentin, Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti», responsabile per le scienze geolo-
giche – Franco Rubiola – Gianni Sacchetti, Archivio Arcivescovile di Torino – Vincent Serneels, Département de Géosciences, Université de Fribourg – Savino Suppo – Gianpiero Viviano, Archivio di Stato di Torino
I resti vegetali delle miniere di Usseglio (val di Viù, Torino)
RENATO NISBET
Introduzione Lo studio di resti organici in contesti archeologici di alta montagna, così come quelli
minerari, fornisce notoriamente l’occasione di abbracciare un ampio spettro di interessanti problemi di archeologia ambientale. L’alta quota e l’ambiente ipogeo, rallentando l’attività degli agenti biologici demolitori, consentono spesso la buona conservazione della cellulosa, fornendo indicazioni di prima mano sull’uso del legno e di altri tipi di materiale vegetale al-trimenti distrutto in contesti meno favorevoli. Si possono così presentare concrete possibilità di molteplici e disparate analisi, che vanno dalla dendrocronologia alle osservazioni di tecno-logia mineraria, alla stagione di abbattimento delle piante, allo stato di maturazione della pianta (età), all’eventuale selezione legata a diversi processi operativi nel lavoro estrattivo, al-lo studio delle zone di approvvigionamento del legno, all’analisi dei segni di taglio. Oltre alle possibili osservazioni sulla selezione di determinate essenze, su alcuni aspetti tecnologici (di edilizia, ma anche di pirotecnologia in rapporto alle tecniche estrattive minerarie lungo tutta la catena operativa), sono inoltre da prendere in considerazione, soprattutto in ambienti alpini attualmente scoperti o denudati, le possibili variazioni altimetriche, anche di età storica, del limite superiore delle foreste, laddove si sono verificati importanti utilizzi economici legati alla pastorizia o, come nel caso di Punta Corna, all’attività estrattiva prolungata.
Un recente esempio delle potenzialità di questi studi in ambiente paleometallurgico si può vedere nell’eccellente serie di lavori eseguiti nei distretti minerari medioevali di Freissi-nières e di l’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes, Francia)1.
Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto interessante iniziare lo studio dei materia-li botanici che si sono conservati in quantità non trascurabile (di fatto rappresentano la catego-ria più abbondante di resti organici) all’interno e nelle vicinanze delle strutture ipogee e delle escavazioni che costellano il versante nel complesso minerario, la cui età, valutata sulla base della documentazione storico-archeologica, si colloca tra il XII secolo e l’inizio del XVI, mentre si sono presi in considerazioni resti relativi alle attività estrattive successive solamente in quantità ridottissima (Taglio del Ferro T1-302, Aoutour A4-101, galleria del Masòc).
Materiali e metodi Tutti i siti oggetto di analisi antracologica si trovano sul versante sinistro del vallone di
Arnàs, prevalentemente esposto a Sud e Sud-Ovest, nella regione dei pascoli (frequentemente interrotti da falde detritiche e da corsi d’acqua) al di sopra del limite forestale superiore, tra i 2250 e i 2850 metri.
La vegetazione legnosa è rappresentata in prevalenza dall’alneto arbustivo, che risale lungo gli impluvi e nei canaloni fino attorno ai 2000 metri. Sui versanti alla stessa quota è dif-fuso il lariceto. Più in basso, nella fascia valliva (1100-1300 metri) i boschi mesofili della fag-geta rappresentano l’elemento forestale più esteso, alternandosi localmente, nelle aree più a-
1 V. PY, 2006; 2010.
62 Renato Nisbet
perte, con le betulle. Ancora più in basso, a partire da 700 metri circa, troviamo le formazioni a latifoglie più termofile, con sviluppo del castagneto e del querceto (Rovere).
La struttura mineraria da cui proviene la maggior parte dei resti (distribuiti su 10 m , per uno spessore massimo di 33 cm) è, al momento, quella indicata con il nome di Terre Ros-se R1-203. Il sito si trova a 2410 metri di altitudine, a una quarantina di metri da un tratto del filone mineralizzato R1. Presenta alcune strutture murarie e materiali di discarica; tutto il ma-teriale vegetale è costituito da legno carbonizzato, generalmente con evidente aspetto di car-bonella. Resta da stabilire se tali forti concentrazioni rispondano a qualche attività puntiforme di combustione, o non rappresentino aree di accumulo parziale della carbonella. Nel suo in-sieme, la struttura R1-203 ha fornito oltre il 90% del materiale vegetale analizzato e descritto nel presente contributo; esso era probabilmente, per la massima parte, relativo al funziona-mento di una forgia. I materiali fittili e metallici associati indicano che la presenza umana si colloca con una maggiore probabilità tra XII e XIII secolo2; una data radiocarbonica indica una data precedente, ma che bene si accorda, per le ragioni indicate più sotto, con la datazione archeologica.
L’altro sito analizzato più in dettaglio, Lucellina L1-501, si trova a una quota sensi-bilmente maggiore (2722 m) e presenta aspetti insediativi e funzionali molto diversi rispetto a R1-2033. Esso contribuisce con oltre l’8% al totale dei materiali, ma si tratta, in questo caso, quasi esclusivamente di legno pertinente a strutture di tipo abitativo. La rimozione del pietra-me di crollo della copertura in lastroni di un piccolo ricovero ipogeo ha portato alla luce una superficie utilizzabile di poco più di 2 metri quadrati, su cui poggiavano travetti, assi e ramet-ti. Le condizioni di conservazione, di dimensione, di contesto escludono che i materiali stu-diati abbiano anche solo in parte un’origine secondaria; si tratta certamente dei prodotti sinse-dimentari del degrado di strutture in posto. Lo confermano le dimensioni di travi e travetti, al-cuni dei quali con segni di taglio, usati forse per conferire maggiore stabilità alle pareti e alla copertura del ricovero, oppure collocati nell’angusta struttura in attesa di essere utilizzati al-trove (la struttura aveva diretto accesso a un pozzo o galleria discendente). Una parte delle schegge lignee sparse sulla superficie deve provenire dalla graduale demolizione di questi e-lementi strutturali. In questo caso non vi sono altri materiali archeologici associati ai resti ve-getali, ma la struttura è in stretta relazione topografica e funzionale con l’estrazione mineraria medioevale.
Piccole quantità di materiali xilologici e antracologici (complessivamente rappresenta-no solo l’1% del totale) provengono dalle strutture Terre Rosse R1-303 (a soli 8 metri da una galleria discendente del filone R1, 2452 m4, carboni e carbonella associati con materiali del XII-XVI secolo), Taglio del Ferro T1-108 (discariche medioevali, 2369 m, carboni), Taglio del Ferro T1-401 (discariche medioevali, 2413 m, carboni), Taglio del Ferro T1-302 (alloggio per minatori dell’inizio del XIX secolo, 2368 m5, carboni), Aoutour A4-101 (alloggio per mi-natori dell’inizio del XIX secolo, 2430 m6, carboni e legna), nonché dalla galleria mineraria del Masòc (1440 m, legno, seconda metà XVIII secolo7) e dalla località I Seti (focolare con
2 A. GATTIGLIA, M. ROSSI, C. SANNA, 2011, n. 09/08/1 e 09/08/2; A. GATTIGLIA, M. ROSSI, 2013, p. 46-48.
3 M. ROSSI, A. GATTIGLIA, 2013, p. 22, 24-27 (fig. 8), 29 (fig. 11). 4 M. ROSSI, A. GATTIGLIA, 2011, p. 178 (fig. 9). 5 M. ROSSI, A. GATTIGLIA, C. BALAGNA DENA, 2011, p. 144-145 (n. 32), 157 (i ruderi dell’edifi-
cio, irreperti sino al 2011, sono stati riconosciuti successivamente). 6 M. ROSSI, A. GATTIGLIA, C. BALAGNA DENA, 2011, p. 144-145 (n. 31), 157. 7 A. GATTIGLIA, M. ROSSI, G. GENTILE, 2013.
I resti vegetali delle miniere di Usseglio 63
carboni concentrati entro suolo sepolto, verso il Colle Àoutaret, 2126 m, età ignota, ma nella zona dell’alpeggio medioevale di Perafica8).
I materiali vegetali presenti si collocano entro tre tipi diversi: legni (per lo più materia-li strutturali di abitazioni, ricoveri, gallerie; ma sono presenti in piccola quantità rami e cor-tecce); carboni (in massima parte si tratta di carbonella usata nelle forge; quantità minori sono formate da frustoli piccoli, più fragili, e provengono da fuochi d’uso domestico); frutti (molto rari).
Complessivamente si sono analizzati 3022 elementi, che rappresentano un totale di 14 taxa (tab. 1, 2 e 3). Il carbone è costituito prevalentemente da Fagus sylvatica L.; in quantità nettamente inferiore sono Larix decidua Mill. e Alnus sp.. Sono presenti in modo significativo anche Quercus sp., Acer sp., Laburnum sp., mentre sono occasionali Betula sp., Viburnum sp., Fraxinus excelsior L. e Corylus avellana L.. Se dal conteggio totale si esclude il Faggio, so-vrarappresentato per ragioni di uso selettivo legato alla presenza di forge, risulta che le asso-ciazioni a Conifere della fascia montana e quelle termofile a latifoglie contribuiscono in modo pressoché equivalente alla composizione generale del campione.
Il taxon Pinus sp. si riferisce nella sua totalità a Pinus sylvestris L., oggi presente sui versanti anche se in modo discontinuo. L’attribuzione a Larix decidua Mill. (fig. 1/1), specie la cui anatomia è difficilmente distinta da quella del peccio, viene fatta anche tenendo conto delle condizioni ecologiche del versante, della distribuzione attuale della specie ed è sicura-mente confermata dall’occasionale presenza di un brachiblasto appartenente al Larice. Il ge-nere Quercus non è stato studiato a un livello di specie, per le note difficoltà soprattutto nel-l’esame dei carboni. La maggior parte di essi presenta anelli regolari; ma non è infrequente il caso di gravi disturbi nella crescita, con soppressione delle cerchie tardive (fig. 1/2), possibile esito di qualche forma di gestione del querceto (ceduazione, uso delle fronde come foraggio o altro). Fagus sylvatica L. (fig. 1/3) è di gran lunga l’essenza più usata nelle forge (senza e-scludere un suo possibile ma occasionale uso come combustibile nei focolari o per riscalda-mento «domestico»). Di particolare interesse è il taxon Alnus, che comprende Ontani ripariali di ambiente vallivo o planiziale, come pure l’Ontano verde della fascia montana. Teoricamen-te la differenziazione dei due gruppi è resa possibile dall’assenza, nel secondo, dei raggi ag-
gregati sempre presenti nel primo (fig. 1/4). In pratica, una sicura attribuzione è resa spesso pro-blematica dalle ridotte dimensioni delle superfici di indagine nei frustoli di carbone. Tuttavia l’analisi farebbe ritenere possibile l’attribuzione ad Alnus viridis DC. di parte almeno del contesto di forgia relativo a Terre Rosse R1-203, ciò che pone la questione se venisse effettivamente uti-lizzato legno di questa specie per la produzione di Fig. 1. Terre Rosse R1-203, fotomicrografie di carboni (lu-ce riflessa, piani trasversi). 1 = Larix decidua Mill.. 2 = Quercus sp.. 3 = Fagus sylvatica. 4 = Alnus sp. (non Alnus viridis). Ingrandimento: tutti 30x (foto Renato Nisbet 2013).
8 A. GATTIGLIA, M. ROSSI, L. PATRIA, 2011, p. 63-75.
64 Renato Nisbet
carbonella, o almeno per riparazioni occasionali degli strumenti da scavo dei minatori. Carbo-ni di Alnus viridis DC. compaiono nel diagramma antracologico del sito minerario di Fangeas VI (Freissinières, Hautes-Alpes)9, ma sono attribuiti a un periodo postmedioevale e comunque a un contesto abitativo («cabane» in pietra), probabilmente come elementi di un focolare10. D’altra parte l’uso di questa pianta come legna da ardere nelle Alpi è piuttosto consueto ove siano meno accessibili piante d’alto fusto11; è anche documentato l’antico uso dei rami dell’arbusto, da parte dei pastori, come combustibile per la produzione di prodotti caseari12. È indiscutibile che l’Ontano verde mal si presta per una produzione estesa di carbone, come pe-raltro già osservato13. Sembra tuttavia non potersi del tutto escludere, nei siti metallurgici d’alta quota di Punta Corna, una sua utilizzazione anche più che occasionale, data la presumi-bile locale abbondanza della pianta.
Considerazioni sui principali contesti Data l’esiguità delle ricerche sugli altri siti, si prendono al momento in considerazione
solo le strutture Terre Rosse R1-203 e Lucellina L1-501. Breve menzione verrà fatta degli in-teressanti materiali lignei dalla miniera del Masòc, rimandando alla tabella 3 i dati analitici relativi agli altri siti, su cui dovranno effettuarsi future indagini.
Terre Rosse R1-203 La totalità dei resti è costituita da materiale carbonizzato, proveniente da tronchi o
grossi rami; le proprietà meccaniche dei carboni, riferibili alla carbonella, inducono a ritenere che essi fossero presenti nel sito per un impiego all’interno di una forgia.
Può essere significativo osservare, per una migliore comprensione dei meccanismi di formazione del contesto antracologico, che nelle due unità sedimentarie superiori (SKBpd e LSKBc) i carboni sono dispersi, anche se in maniera variabile, su tutta la superficie; nelle due unità inferiori (LSMclr e TSKRlc sono invece concentrati in pochi metri quadrati; fig. 2)14.
Lo spettro antracologico (fig. 3 e tab. 1) comprende 14 taxa, con netto prevalere del Faggio.
Il campione risente in modo decisivo dell’intervento selettivo. Tuttavia esso mostra con sufficiente chiarezza l’esistenza di almeno tre distinte fasce altimetrico-climatico-vegeta-zionali: il piano montano a latifoglie, relativamente temperato (fino a 1000-1200 metri: Ca-stagno, Ontani varii, Aceri, Frassini...); il piano montano microtermico xerofilo (Pino silve-stre) e mesofilo oceanico (Abete bianco e Faggio); e quello subalpino, per la presenza del La-rice e per la attendibile determinazione, entro il taxon Alnus, di Alnus viridis DC.. Con ciò non è tuttavia dimostrato in via definitiva l’utilizzo esclusivo delle foreste locali, dal momento che non sono per ora noti documenti relativi ai diritti di concessione dell’uso dei boschi di Usseglio15. D’altra parte sembra molto probabile che talune essenze più facilmente reperibili in prossimità dei siti minerari, come l’Ontano verde e il Larice, siano state oggetto di sfrutta-mento e di carbonizzazione in posto. Lo stesso probabilmente può affermarsi per la fascia in-feriore a latifoglie presenti, ben rappresentata nello spettro antracologico. Fonti del XIV seco-
9 V. PY, B. ANCEL, 2007, p. 94. 10 Cf. K. WALSH, F. MOCCI, J. PALET-MARTINEZ, 2007. 11 J.-C. RAMEAU, D. MANSION, G. DUMÉ, 1993. 12 G.P. MONDINO, 2007, p. 276. 13 A. GATTIGLIA, M. ROSSI, L. PATRIA, 2011, p. 71. 14 Cf. anche A. GATTIGLIA, M. ROSSI, 2013, p. 46 (fig. 1). 15 Devo questa osservazione a Maurizio Rossi, che ringrazio.
I resti vegetali delle miniere di Usseglio 65
Fig. 2. Terre Rosse R1-203, distribuzione ponderale (in grammi) dei carboni nelle unità sedimentarie (elabora-zione Maurizio Rossi 2013).
66 Renato Nisbet
Fig. 3. Terre Rosse R1-203, spettro antracologico (elaborazione Renato Nisbet 2013). lo16 inducono a ritenere che la carbonella venisse prodotta almeno in parte a Forno di Lemie (poco sotto i 1000 metri e a circa 6 chilometri in linea d’aria da Usseglio, 12 chilometri dai principali siti estrattivi) e v’è ragione di ritenere che si trattasse dell’uso delle latifoglie locali: è per tradizione e per necessità – quando non espressamente vietato da locali disposizioni co-munali – che le carbonaie fossero costruite e accese all’interno o ai margini dei boschi da cui il legname veniva estratto17. Nel caso della valle di Viù l’ipotesi viene rafforzata dall’esisten-za negli Statuti del 1351 di norme emanate allo scopo di proteggere i boschi dal loro eccessi-vo sfruttamento18. In ogni caso i carboni prodotti in fondovalle dovevano essere portati sul luogo di utilizzo superando dislivelli di 1000 e più metri, lungo percorsi oggi non più eviden-ti.
Tra i taxa presenti, vanno segnalati i carboni di Castagno, sia pure molto rari. La storia della pianta, presente sulle montagne piemontesi nella preistoria e diffusa a partire dall’età romana, è tuttavia poco nota nei suoi dettagli19. Perciò sono molto interessanti i documenti che, oltre a confermare l’analisi antracologica, menzionano la raccolta di castagne a Usseglio durante la prima metà del XIV secolo20. La rarità di carboni di castagno nell’uso minerario potrebbe appunto avvalorare l’ipotesi che la pianta fosse coltivata per la raccolta dei frutti e non utilizzata come ceduo.
16 R. FRESIA, 1996, p. 106. 17 D. MUSSET, 1996. 18 G. CHIARLE, 2008, p. 60. 19 R. NISBET, 2000. 20 ASTOR, Camera dei Conti, Piemonte, Conti delle Castellanie, Art. 41-Lanzo, Paragr. 1, Mazzo 2, roto-
lo 8, 5 settembre 1328 - 15 agosto 1329; Mazzo 3, rotolo 15, 15 novembre 1343 - 17 marzo 1345. Ringrazio An-na Gattiglia per la segnalazione di questa fonte.
I resti vegetali delle miniere di Usseglio 67
Tab. 1. Terre Rosse R1-203, dati analitici. C = Carboni. Dal campione 132:7 è stato estratto un frammento di carbone di Faggio, per una data-
zione radiocarbonica. Essa doveva servire per risolvere un problema relativo all’età di alcuni manufatti in pietra ollare. La datazione ottenuta è GrA-56663: 970±30 uncal BP (anni radio-carbonici), cioè 1021-1150 cal AD a 1 , 1016-1155 cal AD a 2 (anni di calendario; si veda
68 Renato Nisbet
Fig. 4. Terre Rosse R1-203, curva di calibrazione del campione 132:7 (elaborazione Tiziano Fantuzzi 2013). fig. 4)21. Per valutare il significato più preciso di questa data, da considerarsi come un termi-nus post quem, va tenuto conto di un possibile old wood effect («effetto legno vecchio»), lega-to alle dimensioni piuttosto grandi del frustolo analizzato, che proviene da una zona interna del durame. L’età reale di deposizione del carbone andrebbe perciò aumentata dei decenni che prendano in considerazione la crescita dell’albero successiva alla formazione della porzione datata e l’intervallo di tempo tra il taglio della pianta, la carbonizzazione, il trasporto in quota e la finale sedimentazione. Tutto ciò può aumentare l’età di taglio della pianta (e successive operazioni) di diversi decenni, confermando la datazione archeologica (XII-XIII secolo AD).
21 Le date radiocarboniche, ossia ottenute in laboratorio mediante determinazione del rapporto quantitati-vo tra l’isotopo 14 (radioattivo) e quello 12 (stabile) del Carbonio, vengono espresse in anni before present (= uncal. BP), intendendosi con present il 1950 d.C., anno a partire dal quale le esplosioni termonucleari hanno profondamente modificato quel rapporto nell’atmosfera terrestre. La data 970±30 uncal. BP corrisponde quindi all’anno 980 d.C. (980 = 1950-970) ed esprime da un lato il margine di imprecisione nella taratura degli stru-menti di laboratorio, dall’altro il margine statistico legato al fatto che la radioattività atmosferica non è stata co-stante nel tempo. In questo caso il margine di errore è di 30 anni in più o in meno (= periodo 950-1010 d.C.). Dal momento che nel corso degli ultimi 20000 anni si sono prodotte fluttuazioni note del tenore di radioattività nel-l’atmosfera terrestre, i valori ottenuti in laboratorio vanno calibrati sulla base di una apposita curva di «dendro-regolazione» che utilizza gli anelli di crescita di alberi molto vecchi. Tali valori vengono espressi in anni «cal BC» (BC = avanti Cristo) o «cal AD» (AD = dopo Cristo) a seconda della loro antichità: in base alle epoche, lo scarto tra le due curve (quella radiocarbonica e quella esatta dendrocronologica) può essere rilevante (secoli). A causa della forma irregolare della curva di dendroregolazione, una data radiocarbonica può presentare più punti di «aggancio», per cui essa viene espressa indicando un intervallo di calendario la cui percentuale di probabilità può essere del 68% (1 ) o 95% (2 ). Nel caso in esame ciò significa che vi è il 68% delle probabilità che il car-bone analizzato provenga da una serie di anelli di legno risalenti al periodo 1021-1150 d.C. e il 95% delle proba-bilità che provenga da una serie di anelli di legno risalenti al periodo 1016-1155 d.C..
I resti vegetali delle miniere di Usseglio 69
Lucellina L1-501 Si presentano qui i primi risultati che emergono dalle analisi del settore Lucellina e più
precisamente della struttura L1-501, un ricovero ipogeo per minatori contiguo all’ingresso di un pozzo o galleria discendente oggi ostruito, che aveva una funzione abitativa e non produtti-va22.
La maggior parte dei resti è costi-tuita da legno solo parzialmente degradato, che ha mantenuto uno stato di conserva-zione tale da consentire l’analisi al micro-scopio a luce riflessa sui tre piani di taglio senza ulteriori preparazioni speciali. Lo stesso può dirsi per i frustoli carbonizzati (un centinaio di frammenti, alcuni di di-mensioni centimetriche) che si concentra-no prevalentemente nel settore Nord-Est del ricovero (probabile focolare). Una ter-za categoria di resti, limitatamente alla metà Ovest del ricovero, è fornita da mate-riale vegetale non carbonizzato, fortemen-te compresso, parzialmente commisto con sedimento. Un’ultima categoria è rappre-sentata, in minima quantità, da resti di pa-sto (tab. 2). Tab. 2. Lucellina L1-501, dati analitici. C = Car-boni. L = Legno.
I legni originano tutti da tronchi o grossi rami di Larice (Larix decidua Mill.). Alcuni frammenti più sottili (spessi 10-11 millimetri), provenienti da una nicchia nella zona Nord-Est della struttura (100:3), presentano evidenti segni di assottigliamento apicale, la cui funzione non è chiara. È stato possibile operare una sorta di riassemblaggio di una decina di tali scheg-ge. Forma tabulare, dimensioni e collocazione fanno pensare alla possibile esistenza di una sorta di mensola o piccola piattaforma per stivare qualche oggetto fuori dal contatto con il ter-reno (fig. 5 e 6/A). Gli elementi maggiori hanno un diametro compreso tra i 7 e i 10 centime-tri, una lunghezza superiore a 50 centimetri. In alcuni casi si sono contate serie di oltre venti anelli di crescita: si tratta quasi certamente di elementi di natura strutturale (fig. 6).
I carboni provengono certamente dalla combustione – non è inverosimile l’ipotesi del-l’accensione di fuoco per riscaldare l’ambiente o per cottura di cibi – di legni trasportati sul luogo per quegli scopi e, soprattutto, per un loro utilizzo in una forgia per ora irreperta, della cui esistenza costituiscono un indizio. È interessante osservare che di oltre 130 frustoli analiz-zati solo un terzo è rappresentato da Larice, gli altri sono di legno di Faggio (Fagus sylvatica L.). Sul versante questa essenza oggi è presente solo in una fascia altimetrica ed ecologica piuttosto distante dal sito minerario. Mentre legno di Larice poteva essere facilmente accessi-bile, la presenza di Faggio implica necessariamente un trasporto da zone lontane, col supera-mento di un dislivello di almeno un migliaio di metri, cosa che rende evidentemente assurda
22 M. ROSSI, A. GATTIGLIA, 2013, p. 24, 26.
70 Renato Nisbet
Fig. 5. Lucellina L1-501, riassemblaggio della tavola 100:3 in Larix decidua Mill., con segni di taglio all’estre-mità sinistra (foto Renato Nisbet 2013).
Fig. 6. Lucellina L1-501. A = Particolare della tavola 100:3. B = Possibili elementi strutturali 102:1 e 102:2 in Larix decidua Mill. (foto Rena-to Nisbet 2013).
l’ipotesi di un trasporto di questo tipo di legname per un utilizzo di tipo «dome-stico». La sua presenza nel ricovero è dunque da riferirsi a un uso occasionale dell’essenza. Un frammento di carbone presenta ampi tratti di corteccia; ciò ha permesso di determinare l’epoca del ta-glio (fine estate).
Piuttosto singolare è la conserva-zione di materiale vegetale compresso in sottili livelli (campioni 102:5 e 103:3), facilmente sfogliabili, parzialmente com-misti con sedimento sabbioso e granuli di quarzo riferibili a discarica mineraria. L’analisi microscopica a diversi ingran-
dimenti esclude la presenza di foglie, muschi, culmi di graminacee; sembra invece trattarsi per lo più delle parti interne di corteccia di Conifere (forse Larice), con elementi di parenchima e di fibre libriformi della regione sottocorticale. Si tratta di materiale solitamente distrutto nei processi di degrado, conservato qui nelle condizioni favorevoli del deposito. È poco chiara la funzione di questo tipo di reperti, di distribuzione discontinua. Potrebbe trattarsi del prodotto di scortecciamento di rami di Larice abbandonato alla superficie (lungo il lato Ovest); oppure del residuo di una qualche sorta di «pavimentazione» o «coibentazione» della copertura fatta con corteccia in guisa di isolante (il ricovero poteva essere utilizzato da una o due persone per trascorrere la notte). Questo utilizzo potrebbe spiegare da un lato il grado di compressione del legno, dall’altro la sua intima compenetrazione con il sedimento. L’ipotesi potrebbe essere
I resti vegetali delle miniere di Usseglio 71
meglio verificata se questo materiale fosse distribuito su ampie porzioni della superficie, il che, tuttavia, non sembra essere il caso.
Si menziona infine la presenza di alcuni frammenti di guscio di noce (Juglans regia L.), non carbonizzati: unica traccia di consumo alimentare per ora trovato nel sito.
Miniera del Masòc I pochi elementi di legno trovati all’interno della miniera23 presentano un certo interes-
se a titolo diverso. Il reperto 2:1 (fig. 7/B) è costituito da un ramo di Laburnum sp. (Maggio-ciondolo) di forma cilindrica, lungo 38 centimetri, largo 4.5 centimetri. Le sue estremità sono state leggermente assottigliate per una lunghezza di 2-3 centimetri; una di esse presenta una
superficie leggermente appiattita e an-nerita con tracce carboniose. La sua collocazione interna, verso il fondo della galleria, oltre al suo aspetto, fa prendere in considerazione l’ipotesi che si tratti di una torcia, benché la scelta del legno non appaia la più feli-ce: tanto a Piani Resinelli, in provincia di Lecco24, quanto nelle miniere del Fournel e di Faravel (Hautes-Alpes)25, era usato per l’illuminazione solo le-gno di Abete bianco. I reperti 2:2 e 2:4 (fig. 7/A), entrambi in legno di Faggio, hanno una funzione imprecisata. Il re-perto 2:3 è una tavoletta subrettangola-re lunga 31 centimetri, larga 12 centi-metri; è in legno di Larice. Fig. 7. Miniera del Masòc. A = Reperti 2:2 e 2:4 in Fagus sylvatica. B = Reperto 2:1 in La-burnum sp. (foto Renato Nisbet 2013).
Tab. 3. Usseglio, dati analitici degli altri siti in esame. C = Carboni. L = Legno.
23 A. GATTIGLIA, M. ROSSI, G. GENTILE, 2013, p. 182 (fig. 1). 24 L. CASTELLETTI, E. CASTIGLIONI, 1993. 25 V. PY, B. ANCEL, 2007.
72 Renato Nisbet
Conclusioni Sulla base della precedente esposizione, risulta che tre erano le fasce ecologico-altime-
triche da cui erano ricavati i vegetali impiegati nelle aree minerarie: i carboni le rappresentano tutte tre, mentre i legni «strutturali», tutti di Larice, erano tagliati e messi in opera sul posto stesso di impiego, nella fascia montana, oggi dominata dai pascoli26. L’ipotesi che almeno in buona parte il legno usato (direttamente o carbonizzato) nei siti minerari fosse prelevato al-l’interno delle foreste della valle sembra trovare conferma, oltre che dai divieti comunali im-posti all’eccessivo taglio delle piante alla metà del XIV secolo (dunque poco meno di due se-coli dopo l’inizio dello sfruttamento minerario), anche dal diagramma pollinico del lago Fa-lìn27. Benché situato, a 1691 metri, a una distanza di quasi 6 chilometri dai siti minerari, ma a poco più di 3 chilometri dal fondovalle, l’insieme pollinico riflette in sufficiente misura le va-riazioni vegetazionali su scala sovra-locale, come dimostra la presenza di pollini di latifoglie termofile. La data ottenuta per la Zona pollinica III (Rome-1034: 530±60 uncal BP = 1320-1440 cal AD a 1 = 1295-1454 cal AD a 2 ) non solo mostra buona corrispondenza con quel-la degli Statuti comunali prima menzionati, ma trova riscontro anche con l’età dell’utilizzo minerario dei legni e dei carboni nell’alto versante descritti supra. L’interpretazione climatica che gli Autori diedero al diagramma trova un buon accordo con le numerose indicazioni rac-colte all’interno del recente Progetto Archlim28, relativamente a un periodo medioevale (e, più precisamente, a quello che parte dai primi decenni del XII secolo) contraddistinto, in Piemon-te, da forti anomalie termiche e pluviometriche, cui fece seguito, a partire dalla metà del XIV secolo, la cosiddetta Piccola Età Glaciale. D’altra parte, nel settore biogeografico qui preso in esame, una accresciuta pressione antropica tra XII e XIV secolo (l’attività mineraria proba-bilmente aggiungendosi a una più antica pastorizia) sui fragili ecosistemi ai margini superiori delle foreste, oltre a quella certamente più massiccia esercitata più in basso sulle foreste a lati-foglie, può fornire una altrettanto adeguata e complementare chiave interpretativa alle peraltro non drammatiche variazioni osservabili in alcuni dei principali taxa arborei del diagramma stesso.
Lo studio qui condotto, ancora certamente a uno stadio introduttivo se rapportato all’e-stensione orizzontale e verticale dei siti, alle molteplici problematiche ancora celate o appena intraviste (di frequentazione stagionale, di specializzazione, di tecnologia) che si intrecciano con quelle più precisamente paleoecologiche, potrà contribuire a delineare meglio un episodio di archeologia alpina di grande interesse non solo locale, nella misura in cui le ricerche, ini-ziate da alcuni anni, potranno estendersi all’interno dell’avviato progetto interdisciplinare.
Ringraziamenti Maurizio Rossi e Anna Gattiglia hanno fornito tutte le indispensabili informazioni relative alle ricerche
sul terreno e in archivio e sono sempre stati disponibili alla discussione su alcuni difficili problemi interpretativi dei contesti archeologici. Tiziano Fantuzzi (Università di Venezia) ha provveduto alla calibrazione della data ra-diocarbonica e alla sua interpretazione. Luca Mercalli (Società Meteorologica Italiana) ha fornito materiali sul Progetto «Archlim».
Bibliografia CARAMIELLO R., SINISCALCO C., SAVANT ROS I., CALDERONI G. 1999. A late Holocene pollen record
from the lake Falin peat-bog (Piedmont, Western Italian Alps). Archivio Geobotanico 5 (1-2): 29-35. Pavia.
26 P. ZACCARA, G.C. PEROSINO, 2010. 27 R. CARAMIELLO et al., 1999. 28 L. MERCALLI et al., 2012.
I resti vegetali delle miniere di Usseglio 73
CASTELLETTI L., CASTIGLIONI E. 1993. Resti lignei del XII-XIII secolo dalla miniera “VIII Sfera”. Milano e la Lombardia in età comunale. Secoli XI-XIII, (a cura) E.A. Arslan, C. Bertelli, M.T. Fiorio, C. Paga-nini, G. Vismara: 239-242. Milano.
CHIARLE G. 2008. L’uso del bosco tema di confronto tra signori e comunità. Boschi e controllo del territorio nel medioevo, (a cura) G. Chiarle: 59-74. Torino - La Cassa.
FRESIA R. 1996. Gli statuti di Lanzo e di Forno di Lemie. Miscellanea di studi storici sulle valli di Lanzo in memoria di Giovanni Donna d’Oldenico, (a cura) B. Guglielmotto-Ravet: 75-108. Lanzo Torinese.
GATTIGLIA A., ROSSI M. 2013. Minatori, fonditori, cavatori: reperti di cultura materiale medioevale nelle col-lezioni del Museo Civico Alpino di Usseglio. Terre rosse, pietre verdi e blu cobalto. Miniere a Usse-glio. Seconda raccolta di studi, (a cura) M. Rossi, A. Gattiglia: 45-60. Usseglio - Torino.
GATTIGLIA A., ROSSI M., GENTILE G. 2013. La miniera del Masòc (1515-1772). Terre rosse, pietre verdi e blu cobalto. Miniere a Usseglio. Seconda raccolta di studi, (a cura) M. Rossi, A. Gattiglia: 181-214. Usseglio - Torino.
GATTIGLIA A., ROSSI M., PATRIA L. 2011. Il primo testo sulle miniere di Usseglio (1316) nel processo di messa in valore delle risorse ambientali dell’alta montagna. Terre rosse, pietre verdi e blu cobalto. Mi-niere a Usseglio. Prima raccolta di studi, (a cura) M. Rossi, A. Gattiglia: 53-78. Usseglio - Torino.
GATTIGLIA A., ROSSI M., SANNA C. 2011. Inquadramento storico e restauro conservativo di utensili manua-li in acciaio dal complesso minerario di Punta Corna (Usseglio). Terre rosse, pietre verdi e blu cobalto. Miniere a Usseglio. Prima raccolta di studi, (a cura) M. Rossi, A. Gattiglia: 203-224. Usseglio - Torino.
MERCALLI L., CAT BERRO D., SERGI G., CANCIAN P., BERTOLOTTO S., CEREIA D., LOMBARDI P., LUDOVICI A.M., ZONATO A. 2012. Progetto «Archlim»: ricostruzione del clima medievale da fonti documentarie in area alpino-padana. Nimbus 65-66 (2010): 1-64. Bussoleno.
MONDINO G.P. (a cura) 2007. Flora e vegetazione del Piemonte. Torino. MUSSET D. 1996. De mémoire de charbonniers. Mane. NISBET R. 2000. Alcuni aspetti di storia naturale del castagno. Uomini boschi castagne. Incontri nella storia
del Piemonte, (a cura) R. Comba, I. Naso: 9-19. Cuneo - Rocca de’ Baldi. PY V. 2006. Mine charcoal deposits: methods and strategies. The medieval Fournel silver mines in the Hautes-
Alpes (France). Charcoal Analysis: New Analytical Tools and Methods for Archaeology, (a cura) A. Dufraisse: 35-46.
PY V. 2010. Techniques et usages du bois des mineurs à Faravellum aux XIe-XIIIe siècles (Freissinières, Hautes-Alpes). Des hommes et des plantes. Exploitation du milieu et gestion des ressources végétales de la préhistoire à nos jours. XXXe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Juan-les-Pins 2009, (dir.) C. Delhon, I. Théry-Parisot, S. Thiébault: 293-321. Antibes.
PY V., ANCEL B. 2007. Exploitation des mines métalliques de la vallée Freissinières (Hautes-Alpes, France): contribution à l’étude de l’économie sud-alpine aux IXe-XIIIe siècles. Interpretation of sites and mater-ial culture from mid-high altitude mountain environments. Proceedings of the 10th annual meeting of the European Association of Archaeologists, 2004, (ed.) P. Della Casa, K. Walsh. Preistoria Alpina 42: 83-98. Trento.
RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G. 1993. Flore forestière française. Guide écologique illustré, 2: Mon-tagnes. Paris.
ROSSI M., GATTIGLIA A. 2011. L’inventario delle strutture minerarie arcaiche: i filoni delle Terre Rosse (Tè-ru Rousù). Terre rosse, pietre verdi e blu cobalto. Miniere a Usseglio. Prima raccolta di studi, (a cura) M. Rossi, A. Gattiglia: 161-190. Usseglio - Torino.
ROSSI M., GATTIGLIA A. 2013. L’inventario delle strutture minerarie arcaiche: il filone della Lucellina (l’Uzlin-a) nell’alto vallone di Arnàs (Usseglio). Terre rosse, pietre verdi e blu cobalto. Miniere a Us-seglio. Seconda raccolta di studi, (a cura) M. Rossi, A. Gattiglia: 11-32. Usseglio - Torino.
ROSSI M., GATTIGLIA A., BALAGNA DENA C. 2011. Le miniere polimetalliche della Corna (Usseglio) nel-le mappe della seconda metà del XVIII e dell’inizio del XIX secolo: dati topografici e tecnici. Terre rosse, pietre verdi e blu cobalto. Miniere a Usseglio. Prima raccolta di studi, (a cura) M. Rossi, A. Gat-tiglia: 129-160. Usseglio - Torino.
WALSH K., MOCCI F., PALET-MARTINEZ J. 2007. Nine thousand years of human/landscape dynamics in a high altitude zone in the southern French Alps (Parc National des Ecrins, Hautes-Alpes). Interpretation of sites and material culture from mid-high altitude mountain environments. Proceedings of the 10th annual meeting of the European Association of Archaeologists, 2004, (ed.) P. Della Casa, K. Walsh. Preistoria Alpina 42: 9-22. Trento.
ZACCARA P., PEROSINO G.C. 2010. Studio floristico della piana dell’alto Rio Gurie (valli di Lanzo). Rivista Piemontese di Storia Naturale XXXI: 3-34. Carmagnola.
LETTURE DAL MUSEO CIVICO ALPINO «ARNALDO TAZZETTI» DI USSEGLIO Collana diretta da Maurizio Rossi
1. Come parlano gli ussegliesi, di SILVIA RE FIORENTIN, 2006, 109 pagine.
2. Storie di pietra, terra e acqua, Documenti dell’Archivio Storico del Comune di Usse-glio, a cura di ANNA GATTIGLIA & SILVIA MARCHISIO, 2007, 107 pagine.
3. Al Museo oggi ricordiamo... il 25 aprile 1945, a cura di LUISA CIBRARIO, MAURIZIO ROSSI & NADIA YEDID, 2008, 27 pagine.
4. Pietra, legno e colore, Scultura e intaglio a Usseglio, a cura di MAURIZIO ROSSI, 2008, 97 pagine (di cui 16 a colori).
5. Per non dimenticare... il partigiano Fiorentino Peirolo, di SILVIA MARCHISIO, 2009, 35 pagine.
6. Giuseppe Sauli d’Igliano e Usseglio, Dipinti inediti, a cura di GIAN GIORGIO MASSARA, 2010, 59 pagine (di cui 14 a colori).
7. Terre rosse, pietre verdi e blu cobalto, Miniere a Usseglio, Prima raccolta di studi, a cura di MAURIZIO ROSSI & ANNA GATTIGLIA, 2011, 236 pagine (di cui 18 a colori).
8. L’anello forte di Usseglio, Forum storico sul ruolo delle donne nella coesione sociale e famigliare di un villaggio alpino, a cura di ANNA GATTIGLIA & SILVIA MARCHISIO, 2012, 89 pagine (di cui 6 a colori).
9. Cesare Ferro pittore. Dai monti di Usseglio ai templi del Siam, a cura di GIAN GIORGIO MASSARA & MARIA LUISA MONCASSOLI TIBONE, 2013, 79 pagine (di cui 9 a colori).
10. Terre rosse, pietre verdi e blu cobalto, Miniere a Usseglio, Seconda raccolta di studi, a cura di MAURIZIO ROSSI & ANNA GATTIGLIA, 2013, 291 pagine (di cui 26 a colori).
IL TERRITORIO È IL MIO LABORATORIO PASSAPORTO PER LE ANTICHE STRUTTURE PRODUTTIVE ALPINE
Collana diretta da Maurizio Rossi 1. Fila la lana, a cura di NADIA YEDID, ANNA GATTIGLIA & MAURIZIO ROSSI, 2011, 23
pagine.
2. Farina del mio sacco, a cura di ANNA GATTIGLIA, MAURIZIO ROSSI & ANNAMARIA CA-STRALE, 2011, 27 pagine.
3. Una memoria di ferro, a cura di ANNA GATTIGLIA & MAURIZIO ROSSI, 2011, 27 pagine. Finito di stampare il 4 settembre 2013, presso Globalprint s.r.l., Via degli Abeti 17/1, I-20064 Gorgonzola.





























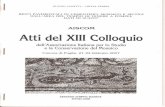











![I resti faunistici [Il villaggio medievale di Geridu (Sorso, SS)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321608b0c12e1161503c46b/i-resti-faunistici-il-villaggio-medievale-di-geridu-sorso-ss.jpg)



