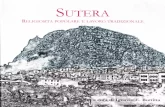Da Cipro alla Spagna, dall’arabo al latino: la Tentatio sancti Antonii di Alfonso Buenhombre
A CIPRO, L'ISOLA NATALE DELLA DEA, STUDIOSI ITALIANI PORTANO
Transcript of A CIPRO, L'ISOLA NATALE DELLA DEA, STUDIOSI ITALIANI PORTANO
A CIPRO, L'ISOLA NATALE DELLA DEA, STUDIOSI ITALIANI PORTANO ALLA LUCE UN VERO E PROPRIO CENTRO INDUSTRIALE DELL'ETÀ DEL BRONZO PER LA PRODUZIONE DI COSMETICI: BALSAMI ED ESSENZE A BASE DI INGREDIENTI MEDITERRANEI, TRA CUI... L'OLIO D'OLIVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nel 2003 la missione arche
ologica italiana del C N R
a Cipro mise in luce una
fabbrica di profumi nell'area indu
striale di un villaggio dell'età del
Bronzo Antico e Medio situato a
est del porto antico di Amathunte,
nel distretto di Limassol, Pyrgos. E
la ricerca archeometrica organizza
ta nei laboratori dell'Istituto per le
Tecnologie Applicate ai Beni Cul
turali del C N R (già famosi per aver
studiato, sotto la guida di Giuseppe
Donato, la fabbrica dei profumi di
Cleopatra di E n Boqeq sul Mar
Morto) riusci a trarre dati sulla
composizione delle fragranze che vi
si producevano.
Seguirono prove di archeologia
sperimentale per verificare l'eff i
cienza delle tecnologie estrattive
rinvenute sullo scavo, nonché vari
tentativi per ricostruire i possibili
profumi in uso all'epoca, ben con
sapevoli del fatto che, non cono
scendo le quantità utilizzate di ogni
ingrediente, era praticamente im
possibile risalire alla ricetta origina
ria. Su questa scoperta furono orga
nizzate mostre a Cipro, in Italia e in zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nella pagina
accanto:
Nascita
di Venere, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAolio su tela
di William
Adolphe
Bouguereau.
1879. Parigi,
Musée d'Orsay
E uropa, che, oltre a riportare in
auge l'importanza sociale e com
merciale dei profumi nelle antiche
civiltà Mediterranee, riaccesero la
discussione sull'origine cipriota del
mito di Afrodite, dea della bellezza.
LA PRIMA DISTILLAZIONE I n quell'occasione si rinvenne un
corredo di utensili di pietra, macine,
mortai e pestelli, insieme a decine
di vasi di eccellente qualità tra cui
spiccavano due completi apparati
per distillare, che predatano la co
noscenza della distillazione di 2600
anni. Grazie a loro, si ebbe la con
ferma che tale pratica era già nota
nell'età del Bronzo, confermando
l'identificazione di altri apparati
frammentari, trovati in Mesopota-
mia, in Sardegna e a Creta.
Tra gli utensili si rinvennero anche
tavolette di scisto quarzifero e un
raro mortaio multiplo per cosme
tici, unico anche per le 14 coppel
le di cui era composto, che indica
va una possibile produzione di
prodotti cosmetici e farmaceutici,
SCOPERTE •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PYRGOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A destra: l'isola di Cipro, con,
in evidenza, il sito di Pyrgos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Qui sotto: planimetria del laboratorio
per la produzione di cosmetici
scoperto nel 2012.
In basso: area di lavorazione con
accumulo di pendagli di conchiglia
e picrolite verde grezzi, semilavorati
e finiti, utensili e selci per la
lavorazione, a testimonianza della
polifunzionalità del laboratorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dipkarpaz
Keryneia
Guzelyurt
Nicosia Fam agosta
Pano Panayià
Pàphos
C I P R O
°0t'Troodos
Pyrgos
Larnaca
Episkopi
Lim asse-^ . A m a t h o u s
Kourion Baia di Akrotiri Penisola
dì Akrotiri zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mar Mediterraneo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
connessa all'estrazione delle fra
granze profumate.
Negli anni successivi la prosecuzio
ne degli scavi delineò il ca
rattere industriale del com
plesso architettonico, che si
trovava originariamente in
posizione centralizzata r i
spetto all'abitato circostante.
Le strutture emerse appar
tengono, infatti, a laboratori e
botteghe artigiane che produ-
"cevano mercanzia pregiata come
profumi, farmaci, bronzi, tessuti e
28 ARCHE O
A destra:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lo scavo di una grande giara,
trovata accanto alla banchina centrale
della corte interna all'ambiente Sud.
In basso: una veduta d'insieme del
laboratorio dei cosmetici. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vino. Considerando che il villaggio
preistorico si trova a soli 4 km dalla
costa, dove ancora sono attivi due
piccoli ancoraggi, e che l'area indu
striale si trovava al centro dell'inse
diamento lungo il principale asse
viario che collegava i villaggi dislo
cati a corona del golfo di Limassol,
si è ipotizzato che gli abitanti com
merciassero attivamente e che il
luogo fosse rinomato per le immen
se risorse minerarie e la produzione
di beni «di lusso», quali, appunto, i
tessuti, i profumi e le spezie.
INGREDIENTI AUTOCTONI L'indagine archeometrica rivelò
che tutte le sostanze utilizzate pro
venivano dalla flora dell'isola e che
(nei limiti delle campionature esa
minate) non c'erano ingredienti
provenienti dal mercato estero co
me l'incenso e la mirra largamente
utilizzati in E gitto fin dal I V mil
lennio a.C. Sono le stesse piante
utilizzate per produrre l'antico pro
fumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Kypros, il Myrtinum e YAmari-
k inon di cui Plinio ilVecchio e D io -
scuride riportano la ricetta del pe
riodo romano. B enché la fabbrica
dei profumi fosse situata in un vasto
ambiente che ospitava anche la
pressa per l'olio d'oliva e un magaz
zino per le giare, strumenti e mate
riali simili a quelli della profumeria,
come imbuti, mortai e portaprofu-
mi furono trovati anche in ambien
ti limitrofi, cosa che fece ipotizzare
che questa attività si svolgesse anche
in altre botteghe più piccole (vedi
«Archeo» n. 278, aprile 2008).
La scoperta della profumeria di
Pyrgos ci ha costretto e a riesami
nare la storia dei profumi di Cipro
ed è stato possibile accertare che
l'isola, nonostante le dominazioni, i
conflitti e i disastri naturali non ha
mai cessato di produrre sostanze
aromatiche, profumi e cosmetici.
Tanto che l'unica base olfattiva che
porta il nome di un luogo geogra
fico, Chypre, è stata recentemente
riconfermata da Fragonard tra le
sette famiglie olfattive del mondo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RICERCA E TRADIZIONE L'approccio multidisc iplinare
dell'indagine testimonia lo spirito
di cooperazione che ha alimentato
la ricerca stessa, al fine di ricostruire
gli elementi della più antica civiltà
cipriota, facendo emergere, raffor
zando e consolidando la continuità
di una delle tradizioni più antiche.
I l tutto, senza tradire le sue origini
fondamentali, per creare sinergie tra
la ricerca scientifica e l'eredità uma
nistica, unitamente all'intento di
conservare e trasmettere parte di
un'identità culturale che possiamo
considerare mediterranea.
Alla fabbrica dei profumi si aggiun
ge oggi una seconda scoperta che
SCOPERTE • PYRGOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
accompagna la prima, quella di un
laboratorio di cosmetici e monili, e
a quella si affianca nel fornire altri
elementi che confermano come il
mito di Afrodite dovesse gioco forza
nascere a Cipro. Le motivazioni che
hanno portato all'allestimento di un
centro commerciale come quello di
Pyrgos alla fine del I I I millennio
a.C possono essere diverse, ma si
basano principalmente sulla realiz
zazione di economie differite, con zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(segue a p. 36) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Le pa le tte cosme tiche :
t ipo log ie a confronto CIPRO PYRGOS EGITTO
PETRIE MUSEUM
occhio
disco
trapezio
losanga
rettangolo
rettangolo allungato
I COLORI DELLA VANITA L'oggetto denominato «paletta cosmetica» è una lastra sagomata di
pietra, quarzite o scisto basaltico, di spessore variabile da 1 a 3 cm sulla
cui superficie erano mescolati colori ottenuti dallo sfarinamento di ocre o di minerali compositi tipo malachite e turchese. Sporadici esempi di palette, generalmente frammentarie, provengono da diversi contesti neolitici mediterranei, ma è l'Egitto predinastico che ha restituito il numero più rilevante e le realizzazioni più elaborate di questi oggetti, dedicati alla cura del proprio aspetto. Oltre a costituire una caratteristica culturale del periodo a cavallo tra il IV e il III millennio a.C, le palette Egiziane assunsero valori di prestigio personale fino ad assumere valenze politiche e di potere in ambiente faraonico. La loro collocazione nei corredi funebri (dal Fayyum alla Nubia e dalla Libia al Sudan) ha permesso anche di valutare lo stato sociale del defunto a seconda della presenza o assenza della tavoletta cosmetica nel corredo, nonché della raffinatezza o se mplic ità dell'oggetto stesso.
IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus tipologico di queste palette, comprendente anche le più
semplici e frammentarie, conservate in massima parte nel Petrie
Museum of Egyptian Archaeology di Londra, fu stilato da Sir William Matthew Flinders Petrie nel 1910 e costituisce ancora oggi un valido strumento di confronto anche per Cipro. Occorre, tuttavia considerare che, a differenza dell'Egitto, le palette cipriote non sono state ritrovate nei corredi funebri, ma nei contesti insediamentali, generalmente in associazione all'utilizzo dell'ocra come pigmento, in siti neolitici e calcolitici, mentre sporadici esemplari provengono da abitati de ll'e tà del Bronzo Antico e Medio. La considerevole quantità di palette rinvenute a Pyrgos (ben oltre un
centinaio, calcolando le 70 dal laboratorio dei cosmetici del 2012 e le
oltre 40 trovate negli altri ambienti), be nché giustificabile dalla presenza . di un contesto industriale, costituisce un caso unico e un raro
esempio di utilizzo strumentale di tavolette di pietra per la produzione, presumibilmente a scopo commerciale, di cosmetici e belletti. La presenza di questi oggetti, accompagnati dai relativi pestelli in altri ambienti collaterali al laboratorio indagato nel 2012, fa supporre che più di una bottega di produzione si sia avvicendata nell'area industriale nel corso de ll'e tà del Bronzo Antico e Medio. Il confronto delle palette di Pyrgos con quelle «non
configurate» egiziane ha permesso di isolarne alcuni elementi
identificativi, che le rendono uno strumento maneggevole:
• lo spessore è tra 1 e 3 cm, generalmente intorno al,5 cm; • la forma è arrotondata (per quelle di basalto) o rettangolare (per quelle di quarzite), con i bordi accuratamente tagliati e smussati, spesso con una sorta di invito o taglio trasverso a un'e stre mità , in modo da poter essere impugnate con una mano, mentre l'altra mescola o impasta il colore sopra la superficie con una spatola di legno o un pestello di pietra. • la superficie destinata all'uso si differenzia da quella non adoperata poiché risulta liscia e levigata. • una concavità rotondeggiante più o meno pronunciata formatasi dall'uso e dallo sfregamento delle spatole si nota al centro del lato utilizzato. Seguendo ilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus del Petrie sono state definite 6 tipologie distinte: a occhio, a disco (rotondo e ovale), a trapezio, a losanga, a rettangolo squadrato e a rettangolo allungato.
30 ARCHE O
SCOPERTE • PYRGOS
CIPRO, AFRODITE E LA COSMESI: UNA QUESTIONE DIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MARKETING...
di Alessandro Lentini
Le ricerche archeometriche sono state attivate sui
residui di impasto prelevati sulla superficie delle
palette, identificati cromaticamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e suddivisi in quattro gruppi: bianchi, grigio chiaro, bruno terra di Siena, giallo e rosso. Le analisi hanno rivelato un quantitativo di Piombo, con valori compresi tra il 35 e il 52%, corrispondente a una percentuale che suggerisce la preparazione di un composto simile alla biacca (PbC03)2. Pb (01-1)2), un pigmento bianco, inorganico, tossico, a base di piombo. La biacca, oltre a essere tra i colori più conosciuti e usati nella pittura su tavola e nelle miniature, fu largamente utilizzata, nonostante la sua nociv ità , come cosmetico per le sue qua lità coprenti. In alcune palette sono state identificate due tipologie
diverse di ocra, relative ai colori giallo e rosso,
prevalentemente costituite da ossido idrato di ferro
(FeO (OH) nH20), che si trovano normalmente vicino alle miniere di rame (famose a Cipro quelle di Ambelikou, Apliki, Skouriotissa e Mathiati). Della stessa origine sono le terre rosse e brune, caratteristiche dei sub areali Mediterranei, composte in prevalenza da ematite (Fe203 • nH20). I caratteristici suoli rossi di Cipro indicano la presenza di molte va rie tà di ossidi di ferro, con diverse proprie tà cromatiche relative alla presenza o assenza d'acqua. Depositi di ocra rossa e terra d'ombra (la ben nota «umbra ») sono noti in tutta l'isola e furono ampiamente utilizzati come scorificanti nell'estrazione del rame, come dimostra la composizione dei milioni di tonnellate di scorie che caratterizzano il paesaggio circostante le storiche miniere di rame dell'isola. Inoltre, durante la prima fase analitica, relativa
all'essiccamento in muffola dell'acqua igroscopica
presente nei sedimenti selezionati, sono stati osservati alcuni viraggi di colore verde, rosso, blu e bianco. Le prime osservazioni allo stereomicroscopio hanno evidenziato per alcuni di questi sedimenti una serie di aggregati con abiti pseudocristallini, tridimensionali, dalla morfologia cubica o romboidale. I sedimenti presentano vari gradi di soprasaturazione di elementi che hanno nuovamente cristallizzato dei centri (germi) già esistenti, secondo un processo già noto nelle descrizioni di Aristotele relative al cloruro di sodio e in quelle di Plinio il Vecchio relative al solfato di rame. Nell'identificazione del pigmento verdastro, i sedimenti flocculati in pseudoreticoli cristallini sono stati portati in
soluzione con diversi metodi (acqua deionizzata acidificata, acidi e basi forti a caldo). Nei cristalli di colore bianco si sono notate composizioni diverse: in una è presente il magnesio (MgCI2), nella seconda il sodio (NaCI). I cristalli di colore blu sono caratterizzati dalla presenza di rame (CuS04), il verde e il rosso da una argilla dalla composizione particolare, ricca di silicati, alluminio, ferro e magnesio (Mg2+ Fe2+ Fe3+ AI3). Tra le sostanze identificate ci sono due tipi diversi di
composizioni saline: il cloruro di sodio normalmente
disciolto in acqua di mare, che a Cipro si trova anche sotto forma di salgemma minerale, e il cloruro di magnesio, presente in natura nelle marcite e nei laghi salati, caratteristici del paesaggio costiero cipriota, nella penisola di Akrotiri, nel golfo di Larnaca e in quello di Famagosta, dove i fiumi stagionali, prima della costruzione delle dighe per le riserve d'acqua, creavano lagune e paludi, ricche dei sali minerali, trascinati dal dilavamento delle acque dai giacimenti ofiolitici del massiccio della Troodos di Cipro. Di particolare interesse è l'uso dei sali di rame (CuS04. 5H20), esistenti in diverse concentrazioni, ampiamente utilizzati e commerciati per scopi farmaceutici anche nella tarda e tà imperiale (come testimoniano gli scritti di Zosimo di Panopoli e Galeno) e nel Medioevo, come riporta Francesco Balducci Pegolotti, gonfaloniere della compagnia dei Bardi a Firenze nel 1300 nel suo trattatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La Pratica della
mercatura, dal quale provengono preziose informazioni anche sulla continuità del commercio delle spezie e delle fragranze cipriote, inclusa la resina del Laudano (Cistus
Laudaniferous) simile alla mirra. In parallelo con le metodologie tossicologiche, le
soluzioni estratte da questi sedimenti, trattate con la
reazione di Bellier, si sono colorate di rosso, per la presenza di alcuni acidi grassi caratteristici dell'olio d'oliva. La presenza di olio di oliva e sali di sodio e magnesio rimandano a un qualcosa di simile alla nota composizione dermatologica «scruò» o «gommage»,
adoperata per rimuovere i depositi organici e le cellule morte dell'epidermide, in cui si ha l'associazione nutriente, antinfiammatoria e rigenerante dell'olio di oliva con il magnesio, dalle molteplici proprie tà fisiologiche che ostacolano la penetrazione delle sostanze tossiche nelle cellule epiteliali. L'uso del sale marino nei diversi
32 ARCHEO
A destra:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA una tavoletta sottoposta alle
analisi di laboratorio. Trattato con una
soluzione che innesca la reazione di
Bellier, il reperto si colora di rosso,
prova della presenza di acidi grassi
tipici dell'olio d'oliva.
Nella pagina accanto: un ramo d'olivo
con i suoi frutti. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
preparati farmaceutici è attestato a Cipro già nel periodo romano ed è ancora oggi commercializzato (per esempio il sale nero di Cipro) per i preparati galenici contro disturbi intestinali e intossicazioni. Anche i sali di solfato di rame, ampiamente utilizzati e
commerciati per le proprietà disinfettanti e astringenti
(Plinio) sono ancora oggi considerati un importante ingrediente farmaceutico nel Sistema di Classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico dell'Organizzazione Mondiale della Sa nità . Infine i test eseguiti con il reattivo dì Lugol hanno dato un riscontro positivo per la presenza di amido di frumento, ingrediente che si rigonfia in acqua calda e può essere usato come addensante o adesivo. La soluzione acquosa colloidale a temperatura ambiente forma la salda d'amido per una parziale condensazione dell'amido, che acquista anche una certa insolubilità in acqua, associata alla sua igroscopic i tà . Questa soluzione è stata utilizzata fino a un passato recente, come emolliente per la pelle e come protettivo per le infiammazioni, incluse quelle dello stomaco. L'amido è presente nelle composizioni di polveri cosmetiche pediatriche e nel «ta lco» cosmetico, ma è sempre stato impiegato come sostanza inerte per dare consistenza e forma a molti prodotti cosmetici e coloranti di diversa natura.
I risultati delle indagini preliminari condotte sui
sedimenti selezionati su alcune tavolette cosmetiche,
consentono di svolgere alcune brevi considerazioni
sulla provenienza delle sostanze evidenziate e sul paesaggio naturale antico. La presenza di piombo potrebbe essere un elemento indicativo sulle conoscenze relative alle ofioliti dei Monti Troodos e alle miniere di rame dell'isola, mentre i sali riscontrati in molti dei sedimenti analizzati rimandano a ingredienti specifici per composizioni cosmetiche o farmaceutiche. Le argille minerali, caratteristiche dell'isola, mostrano un'attenta conoscenza delle loro proprie tà e pote nz ia lità cosmetiche e curative, nonché del sistema di approvvigionamento e sfruttamento dei giacimenti. Questi elementi uniti alla presenza di olio di oliva (peraltro riscontrati nei diversi ambienti del contesto industriale di Pyrgos) possono confermare l'ipotesi già avanzata dai risultati delle analisi effettuate nella fabbrica dei profumi, circa l'impiego dell'olio di oliva come matrice di base per preparati officinali.
Gli amidi di frumento rilevati per la prima volta a Pyrgos
sembrano integrare le testimonianze archeologiche e
archeobotaniche per le numerose mole di pietra
scoperte e per i microresti vegetali di varie specie di granozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Triticum dicoccum, Triticum monococcum,
Triticum durum e Triticum sp.) recuperati durante le campagne di scavo 2004-2008. Pertanto, l'indagine archeometrica, be nché condotta su un esiguo numero di tavolette, rappresenta un primo interessante approccio nell'identificare l'utilizzo e la provenienza delle materie prime impiegate nella produzione dei preparati officinali e per la manifattura di composti che preludono a forme di cosmesi verosimilmente già note in questo periodo. Se è vero che la continuità sulla produzione dei profumi ciprioti è attestata nei secoli dalla documentazione storico-letteraria e dai profumi diffusi in tutta la «Ve cchia E uropa », è a ltre sì innegabile e a tutti noto che il cosmetico più diffuso e rinomato al mondo è stato ed è la cipria, i cui contenitori hanno fornito occasione di altissime espressioni d'arte e artigianato, dai metalli preziosi, alla tartaruga, dal vetro alla porcellana. Non meno noti e usati fin dal periodo predinastico
egizio, sono il trucco per gli occhi, il fard per le guance
e il rossetto per le labbra. Prodotti che si avvalgono delle ocre naturali di Cipro, materiale primario rinvenuto nel laboratorio di Pyrgos, ancora oggi preferito dall'industria cosmetica poiché ritenuto tra i migliori del mondo. La scoperta del laboratorio dei cosmetici si affianca quindi a quelle l'hanno preceduta (www.pyrgosmavroraki.eu; www.pyrgos-archea.it), completando e avvalorando il carattere industriale, commerciale e sociale del sito. Infatti, l'insieme dei prodotti che sono identificabili nel materiale rinvenuto nel complesso industriale e commerciale di Pyrgos/ Mavroraki può essere considerato il pacchetto de ll'e tà del Bronzo che ha trasformato Cipro in un Paese commerciale competitivo durante il II millennio a.C. come ben dimostrano le mercanzie rinvenute nei vascelli naufragati, come quello di Uluburun, e le citazioni nelle tavolette commerciali micenee ed egiziane. In questo «pacchetto» è inclusa la cultura materiale
legata alla posizione geomorfologica di Pyrgos, in cui
era possibile trovare tutte le risorse per produrre manufatti e beni effimeri per uso privato e per il mercato d'elite. Come ha dimostrato l'indagine archeometrica, la
34 ARCHEO
produzione di beni accessori a Pyrgos ne ll'e tà del Bronzo Antico e Medio si è basata non solo su unazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jf
elevata conoscenza tecnologica, ma anche su un contesto agricolo fortemente diversificato per la presenza di tutti gli elementi che costituivano fin dal Neolitico i cosiddetto «pa cche tto agricolo «de l Mediterraneo orientale. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Attraverso i dati raccolti in dieci anni di ricerche,
possiamo dividere il pacchetto in 7 categorie funzionali:
• Olio e vino (utilizzati anche come ingredienti industriali) • Metalli (soprattutto rame e sue leghe) • Fibre tessili, vegetali e animali (inclusa la seta
selvatica) • Cura del corpo (profumi, cosmetici e rimedi
farmacologici) • Stato sociale (gioielli, ciondoli, collane, ferma-trecce,
tessuti preziosi) • Strumentalità in pietra (intesa come risorsa
tecnologica diversificata, a basso costo).
Questo pacchetto conteneva tutte le variabili che non possono mancare in un sistema produttivo evoluto, caratterizzato da alternanza stagionale e organizzazione altamente strutturata del lavoro, affiancato alla straordinaria ricchezza mineraria dell'isola che supportava la qua lità dei prodotti di Cipro, rinomati già dalla me tà del II millennio a.C (come testimoniano le tavolette micenee in Lineare B, le lettere di Teli el Amarna o i poemi biblici e omerici). Fu l'inizio voluto o casuale di una fama che portò l'isola
a essere identificata con una div inità, poiché il
commercio dei prodotti di Cipro non si basava certo sulla qua ntità , dato il numero esiguo degli abitanti e degli artigiani, ma sulla qua lità . Una dote per eccellenza, che ne ll'a ntichità era considerata un'arte divina, cosi come ogni espressione tecnologica troppo «a rdita e a va nz a ta » per essere considerata frutto della mente umana. In proposito, è curioso notare che, tranne il vino, riferito al toro e a Dioniso, l'intera alta tecnologia
«me dite rra ne a » fu in seguito considerata
frutto di due divinità femminili: Atena per la tessitura, la
metallurgia, l'ulivo e l'olio, e Afrodite per i profumi, i cosmetici e il rame.
Dopo la metà del II millennio a.C, la maggior parte di
queste categorie di prodotti non hanno sostenuto il
confronto con la produzione dei Paesi d'oltremare, fatta eccezione per il settore dei profumi e dei cosmetici legati al mito di Afrodite che, lungi dallo scemare, invase i campi della bellezza e della religione. A questo proposito, si può ragionevolmente ipotizzare una mirata propaganda cipriota nel collegare i prodotti dell'isola al mito della bellezza per eccellenza. Sta di fatto che la fama di Cipro e Afrodite è ancora presente nel mercato mondiale, basti pensare alla «cipria », azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chypre, una delle sette famiglie olfattive di profumi, al verbo «ve ne ra re », da Venere, nome latino di Afrodite, sinonimo di rispetto e preghiera verso la div inità , nel senso più pieno del termine (vedi
anche, in questo numero alle pp. 110-111).
Considerando questi dati, sembra proprio che la Cipro
del II millennio a.C. sia riuscita nel primo tentativo della
storia di pubblicizzare i propri prodotti, creando intorno a loro un mito. Lo stesso tipo di informazione mediatica che è ancora oggi usato per pubblicizzare le nuove nuance di profumo e i prodotti di bellezza che vengono di solito presentati da indiscutibili icone femminili dello spettacolo. Tutte le antiche divinità mediterranee sono connesse in qualche modo con la storia del profumo, e tutte le religioni antiche hanno usato aromi e tinture particolari nei loro rituali. Ma la più famosa di queste divinità è certamente Afrodite, la dea per antonomasia della bellezza, che non poteva che nascere in un'isola dove, molti secoli prima che lei si affacciasse al mondo (considerando Esiodo il padre del suo mito), già si producevano prodotti destinati ad accrescere e favorire il fascino della donna e forse non solo il suo.
ARCHE O 35
SCOPERTE •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PYRGOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l'intento di diversificare la produ
zione per ridurre i rischi di perdite
e di accumulo dei prodotti. La posi
zione dell'impianto a ridosso di due
ancoraggi in un'area ricca di mine
rali e di piante aromatiche, gioca un
ruolo di primaria importanza sia per
l'approvvigionamento delle materie
prime che per la mobilità dei pro
dotti e fu probabilmente la base
della spinta commerciale. La studio
del modello di insediamento e della
localizzazione dell'impianto può fa
vorire la creazione di ipotesi funzio
nali circa un'economia commercia
le volta al mercato interno e d'oltre
mare, che era riuscita a organizzare
una catena produttiva e distributiva
pienamente efficiente.
INDAGINE PARZIALE Scoperto nel 2012, il nuovo edifìcio
è adiacente l'area di culto dall'ori
ginale pianta triangolare, separato
dal resto dell'area industriale da una
larga strada che attraversa diagonal
mente l'insediamento, da est a ovest.
A causa delle forti piogge che han
no caratterizzato l'autunno cipriota
del 2012, delle due stanze di cui si
compone è stata investigata solo
quella Sud. L'ambiente è rettango
lare e presenta due ingressi distinti:
uno al centro, a sud, e uno sul lato
opposto nell'angolo di nord-ovest.
U n terzo passaggio, ancora da defi
nire, aperto nel muro Nord, verso
l'estremità Est, collegava probabil
mente la stanza al secondo ambien
te, di cui solo una parte del muro
Est, in linea con quello della stanza
precedente, è stata portato alla luce.
La tecnica costruttiva dell'edificio è
quella caratteristica del Bronzo An
tico e Medio, con muri di mattoni
crudi, poggianti su fondazioni in
pietrame dello spessore variabile dai
40 a agli 80 cm.
36 ARCHE O
La stanza ha una pianta diversa da
quella degli altri ambienti messi in
luce: è formata da due perimetri
pseudorettangolari, uno all'interno
dell'altro, con ingressi in asse. I con
fronti disponibili suggeriscono che
si tratti di un vano a cortile interno,
con tettoia su tre lati che protegge
va l'ambiente di lavoro, illuminato
dalla grande apertura centrale.
Esempi di costruzioni strutturate in
questo modo si hanno nelle case
sumeriche, spesso distribuite su due
livelli abitativi, collegati da una sca
la interna. I l ritrovamento dei buchi
per i pali di sostegno della tettoia
punto di vista lavorativo, ma di dif
ficile confronto con architetture
cipriote dell'età del Bronzo.
Soluzioni simili sono infatti comu
ni nelle case tradizionali del Maroc
co e del Vicino Oriente dei secoli
più recenti, anche se l'apertura sul
soffitto, giustificabile per gli usi più
diversi (tra cui l'accesso alla super
ficie del tetto per la lavorazione e
l'essiccazione dei prodotti agricoli)
è nota in Anatolia fin dall'VI I I mil
lennio a.C. (Catal Hòyùk). Si tratta
va, comunque, di aperture molto
più piccole, mentre quella della
stanza-laboratorio di Pyrgos crea zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L'architettura d i alcuni ambienti ha caratteristiche che li avvicinano a modelii attestati nei Vicino Oriente
conferma che il perimetro interno
era aperto e le strutture che lo de
limitavano erano utilizzate come
banchine d'appoggio e divisori del
le attività che vi si svolgevano. I l
lato Ovest interno ha un andamen
to irregolare, in parte curvilineo,
che sembra riutilizzare un tracciato
più antico, inglobato dopo diversi
episodi di ristrutturazione, mentre il
lato Est della stanza è caratterizzato
da una banchina a semicerchio vi
cino all'ingresso. Abbiamo quindi
una sorta di corte squadrata su tre
lati, all'interno di una stanza rettan
golare, estremamente funzionale dal
proprio una piccola corte interna.
La pianta sembra studiata non solo
per dare piena luce allo spazio lavo
rativo, ma anche per garantire una
certa riservatezza al luogo.Al centro
di questa piccola corte c'era una
grande giara, sistemata accanto alla
banchina centrale, costruita con
pietrisco e calcina utilizzando il
dislivello del terreno.
L'alloggiamento di due pali, posi
zionati davanti all'ingresso e al cen
tro della banchina a semicerchio,
indica la posizione della trabeazione
che sosteneva la tettoia su tutti e
quattro i lati interni della stanza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nella pagina
accanto: un
momento dello
scavo, con la griglia
per consentire
il posizionamento
in pianta dei reperti.
A sinistra: oggetti
finiti in picrolite,
rinvenuti durante
lo scavo.
Si riconoscono
pendagli, «perle»
e palette
cosmetiche.
ARCHEO 37
SCOPERTE •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PYRGOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nell'area coperta dalla tettoia lo
spazio lavorativo, scandito dai pali
che sostenevano la tettoia, era orga
nizzato in modo diverso nel lato Est
e in quello Ovest.
Subito accanto alla porta, a ridosso
della banchina semicircolare, c'è
inoltre un angolo attrezzato con
una robusta lastra di basalto, perfet
tamente piatta e liscia, fissata al suo
lo con numerosi ciottoli di andesite
e quarzite legati da malta calcarea.
Accanto, una profonda fossa scavata
nella roccia, serviva da ripostiglio
per utensili e oggetti in lavorazione.
Nell'angolo di nord-est il crollo di
una struttura aggiuntiva suggerisce
la posizione di una scala di legno a
pioli e l'esistenza di un soppalco
interno, elemento spesso presente
nelle case cipriote fin dal periodo
neolitico. Proseguendo, nel settore
Est si notano sul pavimento altre
fosse: alcune intonacate, altre rif ini
te con frammenti di bacili riutiliz
zati, altre con piccole macine inca
strate nel fondo.
VERSO L'ABBANDONO Sparso all'intorno, il ricco reperto
rio di mortai, macine e centinaia di
utensili litici in pietra levigata e da
taglio, testimonia che il laboratorio
era in piena attività quando fu ab
bandonato. D i notevo
le interesse sono le cir
ca 70 palette cosmeti
che in quarzite e basalto
che, insieme ai numerosi
grumi di ocra di diverso
colore, costituiscono una
documentazione rarissima
sul sistema di produzione 1 dei cosmetici all'inizio del I I
millennio a.C. Nello stesso
ambiente decine di conchiglie e
27 oggetti di picrolite verde, rife
ribili a tutti i diversi stadi di lavora
zione dal materiale grezzo al moni
le finito, testimoniano la plurifun-
zionalità del laboratorio interamen
te dedicato alla bellezza.
I l repertorio ceramico indica una
continuità abitativa dalla fine del I I I
millennio a.C. all'inizio dell'età del
Bronzo Medio, un periodo che do
vrebbe coincidere con l'abbandono
del laboratorio, poiché non sono
stati trovati frammenti ceramici del
la cosiddettazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «metallìc ware», cioè
della Red Polished I V — classe dia
gnostica del Bronzo Medio I I —, di
cui esiste un vasto repertorio prove
niente dall'adiacente fabbrica dei
profumi, allestita probabilmente in
quel periodo.
Considerando il fatto che alcuni
elementi strumentali caratteristici
del laboratorio dei cosmetici sono
presenti anche nel repertorio rinve
nuto nella fabbrica dei profumi, è
possibile che questo laboratorio
fosse adibito anche alla lavorazione
delle essenze e che sia stato abban
donato per trasferire l'attività nella
stanza più grande, nell'età del B ron
zo Medio I . Un'ipotesi che giustifi
cherebbe la presenza di alcune pa
lette nel laboratorio dei profumi
identificato nel 2003.
G li elementi datanti di cui si è te
nuto conto sono quindi, oltre ai
frammenti ceramici: i pendagli e gli
oggetti in picrolite, gli utensili in
pietra levigata, scheggiata e osso, le
fusaiole, le scorie di rame e i fram
menti di crogioli, di metallo e di
vetro. A questi si aggiungono i mi
nerali e i materiali paleo-organici,
quali le ossa, i semi, i pollini, le con
chiglie e le fibre tessili. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
In alto: vasetti dell'età del Bronzo Antico III,
dalla fabbrica dei cosmetici.
In basso: una pisside della classe White Painted
IV, la cui presenza a Pyrgos prova l'esistenza
di scambi commerciali ad alto livello.
1
38 ARCHE O