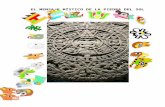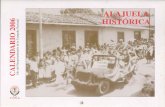Da Sant'Antonio a Natale. Il calendario cerimoniale a Sutera - Commemorazione dei defunti
Transcript of Da Sant'Antonio a Natale. Il calendario cerimoniale a Sutera - Commemorazione dei defunti
I{t I t( ,l( )\l'l \ l)( )l)( )l \}ll I t. \\ ( )lt( ) ilì \t)tll( )\ \t.t
ijl
SuuiRA
<,
wJ/1):r1,*"ti.:'
rlil &&{B rr f,4l 88§ El
'à ctrra di Ignazio E. Buttitta'tfiflfff^',
Regione SicilianaAssessorato dei Beni Culturali,Ambientali e della Pubblica Istruzione
g:-d,y,,,*ifg"@,n1tu,
CITTÀ. DI SUTERA
@ 2006 Associazione Folkstudio di PalermoVia A. Pasculli 12 - 90138 Palermo
Progetto grafico di Antonio Saporito
Sutera : religiosità popolare e lavoro tradiziotale / a cura dt Ignazio E. Buttitta. -Palermo : Folkstudio, 20061. Sutera, I. Buttitta, Ignazio Emanuele <1965->945.8212 CCD-2L SBN PaI0206471
CIP - Biblioteca centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace'
Questo volume è stato stampato con il contributo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali,Ambientali e della Pubblica Istruzione
INorcr
On. Nicola Leanza,Assessore Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione
Prof.ssa Rosalba Panvini.Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta
Sig. Gero Difrancesco,Sindaco di Sutera
Prof. Ignazio E. Buttitta,Presidente del Folkstudio di Palermo
P,rnrn I. Sronra socruE E pATRrMoMo CULTURALE
1. BENI CULTURALI E IDENTITA LOCALI. LA DIFFICILE VIAALLO SVLUPPO SOSTENIBILE
di Alessandro Pagano
2. UNA sroRrA EsEl,rplane. SocrprÀ E ECoNoMTA A SUTERA DAL '900 AI GIORNI NosrRIdi Gero Difrancesco
3. FESTA E LAVoRo Nsrr,q. Srcrlr,q. oeL cntNodi Ignazio E. Buttitta
PARTE II. Clr-nNoamo CERTMoNIALE E LAvoRo TRADIZT0NALE
I. DA SANT,ANToNIO A NATALE. IL CAIENDARIo CERIMoNIALE A SUTERAdi Emanuela Caravello e Alessandro Romano
2. DAL GRANo AL GEsso. FoRME DEL LAvoRo rRADIZIoN,c.Ls e SursRAdi Manuela Greco, Silvia Vizzini e Emanuela Caravello
3. SureRA. UN PAESE ANTrco E MoDERNodi Ignazio E. Buttitta
IMMdctNt Dt FESTA
di Giacomo Bordonaro
No'rr
BtBt,t(x;RAI,t^
lì.r,:r,r,;nr,:t,tzt,: l'o't o( ; R^tf t( t I r,l
33
11
t5
t9
73
146
185
189
204
207
223
annunciando cosi, ai fedeli rimasti a casa, il passaggio della Madre (cfr. Buttitta I. E. 1999b; Bonanzinga 2002).
Questi ultimi, se impossibilitati a partecipare alla processione e nel caso di particolare devozione, sono soliti sten-
dere ai balconi o alle finestre tovaglie e coperte bianche in onore della Vergine. Non di rado accade che taluni appun-
tino immagini della Madonna al centro dei preziosi teli o che espongano scritte in suo onore come 'EvvtvA Mar:a'.
A tal proposito una donna ricorda che appendere le tovaglie o le coperte migliori, quelle ricamate, aveva un duplice
carattere dichiarativo: da un lato indicava grande devozione per la Madonna e dall'altro intendeva comunicare alla
gente che in quella casa dimoravano pie donne dedite al cucito. Questo ultimo aspetto, certamente apprezzato in
quanto indicativo di una buona gestione della res privata fungeva da garanzia per tutte quelle ragazze che erano in
età da marito.
Giunti alla contrada sotto Sant'Agata e in particolare alle Cqsette il corleo sosta e i portatori del fercolo depon-
gono il simulacro sull'altare mentre i fedeli si raccolgono attorno ad esso. Il sacerdote procede alla consumazione
del rito secondo liturgia: hanno lluogo la Supplica alla Vergine e I'Atto di consncrazione al Cuore Immacolato di
Maria. Conlemporaneamente, alcuni fedeli distribuiscono ai partecipanti le candele da accendere durante la benedi-
zione chiesta alla Madre per intercessione della Sacra Famiglia. Il rito si conclude con il Sc/ve Regina altorr.o alle
18.30. I pofiatori prelevano il fercolo dall'altare e il corteo si appresta a rientrare presso la chiesa di Sant'Agata per-
correndo via Orti, piazza Carntba, via Mormino, via Municipio, piazza Sant'Agata. Alìe ore 19.00 il simulacro della
Madonna del Rosario è accolto in chiesa con il suono delle campane. Qui, per I'ultima volta in questo giomo di festa,
è invocata la benedizione del Signore al cui termine i fedeli salutano [a Regina del Rosario sventolando fazzoletti
bianchi al suono del Magnifcat.
1.13 CoMMEMoMZToNE DEI DEFLINTI
I1 2 novembre è il giomo tradizionalmente consacrato alla commemorazione dei defunti. Questa si esprime in
molteplici forme a seconda dei luoghi e delle tradizioni (cfr. Pitrè l88l: 393-408; Buttitta 1962 e 1996:245-255;
Giallombardo 1990b: 31-32; Buttitta I. E.2006a: 47 -152).
A Sutera tratti essenziali della commemorazione sono la visita alle tombe e i doni ai bambini e alle fidanzate
che si dichiarano elargiti dai morti stessi. L'omaggio al cimitero viene effettuato anzitutto in forma privata: singo-
lamente o in nuclei familiari i fedeli si recano alle tombe per rinsaldare i legami con i defunti. Nel ricordo di Paolina
Schifano (1923): "A lu cimiteru ci andàvamu sempri, ci ivamu afari visita e giràvamu tutti li tombi". Dal 1996 la
visita è compiuta anche dalla comunità riunita. Dalla chiesa di Sant'Agata la mattina del 2 novembre si diparte un
corteo processionale che, condotto dal sacerdote, si compone di due file di oranti, quasi esclusivamente donne, pre-
cedute da un fedele che reca tra le mani una croce lignea. Durante il percorso si recita il Rosario in suffragio dei
129
defunti e si intonano canti sacri. Il corteo si scioglie dinanzi la chiesa di San Francesco. Alcuni fedeli si recano sin-
golarmente al cimitero attiguo alla chiesa, mentre altri partecipano alla celebrazione della Santa messa. Al termine
della funzione i sacerdoti, seguiti da un congruo numero di fedeli, si dirigono in prossimitàL delle tombe per la bene-
dizione. Attraversando il cimitero il corteo sosta in prossimità di alcuni tumuli per la formulazione della preghiera e
l'aspersione dell'Acqua santa. Spiega un'anziana donna: "dal Giardinello partono cosi tutti in processione, dal
Rabato noi ci andiamo soli. Poi c'è la messa Ià alle undici e ce ne andiamo. Appenafinisce la messa escinu i preti,
giramu tutte le tombe, no tulte perché ora sono assai, mentre si canta durante la processione, poi ogni lanto siferma
e benedice le tombe". Si conchtdono così le manifestazioni che hanno luogo nella dimensione pubblica.
Nello spazio domestico, di contro, la commemorazione dei defunti si carattet'.zza anzitutto per l'uso di stren-
nare i bambini, oggi con dolci e giocattoli, sino a pochi decenni fa con pupi di zucchero e frutta secca come nella
memoria di Paolina Schifano (1923): "Andavamo a scuola magari a quarta, così, e poi c'erdno li nostri parenti,
qualche amica ci Jàceva trovare qualche cosa, ma a quei tempi niente c'era. Mi ricordo mia nonna che ci Jaceva
trovare questi pupi di zucchero ma piccolini perché eravamo assai i nipoti e ci dava questa. N'atri eravamu cunten-
ti. O delle volte ci davano ifichi secchi, mandorle, questi noi I'avevamu magari. Qualcuno ci metteva qualche soldo,
a secondo quello che disponeva. A quei tempi i mia fatta secca, dolci un ci n'eranu: qualche volta questi pupi di
zuccaru e basta".
Fautori del dono sono, secondo quanto viene fatto credere ai bambini, i murticeddi,le anime dei congiunti
scomparsi, che la notte del 2 novembre ritornano ogni anno a far visita ai propri cari. Ricorda un romo: "ai bimbi ci
davanu i morti, ci davano i morticeddi, la n'adizione antica, iu vidè i miei nonni dicianu mittiti li scarpi fora, dici,
ca i morti vi porteranno i morti, dici un dono 1...); e ni facevamo truvari carcagneddi, sono un dolce così, a pasta
di Napoli 1...), quella che la vendono i fornai, chisti biscotti con la marmurata bianca ora ci mettono la cioccola-
ta, è diverso, poi ci mettevano qualche cinque mila liri a seconda. Poi c'erano quelli ricchi 1...f ci facivanu a bam-
bola e passava I'entusiasmo pi cuntintari chisti carusi" (Francesco Maniscalco - 1954). Genitori, parenti o amici,
esercitando le veci dei morti, usavano riporre i doni all'intemo delle scarpe che i bambini, fiduciosi, disponevaro in
prossimità di porte o finestre la sera della vigilia."Ai bambini si cifa qualche cose per i morti: regali che prima ci
dicevano che li portavano i morti di notte mentre dormivano. Noi ci mettevamo li scarpi vicino al balcone che ce limettono dentro li scarpi. Io ci credevol" (Paolina Schifano - 1923).
Altra destinazione aveva il pupo di zucchero che per la forma era denominato u bersaglieri o lu cavalieri.
Questo era il dono che ciascun ragazzo recava alla propria fidanzata, in visita con la famiglia a casa di lei- "Prima
c'era u bersaglieri, bellu ranni chistu u pultavanu i fidanzati. L'usanza fera) chi ci purtavanu chistu: lu fidanzan u
purtava a fidanzata. Bellu bersaglieri, bellu ranni acatssL fattu di zuccaru [...). Usava ca ci purtava u cavalieri"
t)o
(Paolina Schifano - 1923). Tale uso pare oggi poco frequente. Ancora diffi.rsamente esteso è invece l'uso di strenna-
re i bambini, oggi con giocattoli, soldi, dolci ma anche immancabilmente con i dolci antropomorfi o teriomorfi:
'fannu li pupi ri zuccaru ma però fanno cavalli di zucchero, fanno li pupi belli ranni. Ora fanno tante cose chist'an-
nu, iu nun li vitti, ca dici ca Caltanissetta era le più belle cose che facevano di zucchero, che le fanno loro. C'erano
perfino li cartoni animati- Thnte cose fatte di zucchero ca dice che i migliori erano questi di Caltanissetta" (Paolina
Schifano - 1923).
La tradizione si adegua ai tempi, si rievoca come passato e si rinnova in quanto presente. "Per i morti a quei
tempi c'erano i pupi di zucchero e si regalavano, anche ora ci sono i pupi di zucchero, che mio nipote voleva lu pupo
di zucchero comprato l--.). C'era un bel cavallo così, grande, giusto la forma di cavallo, tuxo fotto di zucchero,
colorato poi, bello faxo; lu fidanzatu lu purtava alla fidanzata, ci ìvanu i genitori tutti e ci purtavamu sta cosa"
(Carmela Mattina - 1928; cfr. Buttitta, Cusumano 1991; Uccello 1916: 51-63).
l. 14 TMMACoLATA CoNcEzroNE
Il culto dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria è largamente difrrso in tutta I'Isola e più in
generale in tutto il mondo cristiano (cft. Pitè. 1881: 419-423).In Sicilia congregazioni mariane e fiancescane favo-
rirono, già a partire dal XV secolo, azioni di sostegno e diffrrsione di tale culto. Solo nel 1476 la festa,
dell'Immacolata Concezione entrò a far parte del calendario romano. 'Nel 1642 Filippo IV di Spagna ordinava che
nei territori del Regno, a partire da quel momento, la festa dell'Immacolata venisse festeggiata l'8 dicembre. Di lì a
poco, nel 1643 il vicerè Caprera scriveva a tutti i comuni proclamando l'Immacolata patrona di tutta l'Isola e
ordinandone la celebrazione l'8 dicembre" (cit. in Buttitta I.E. 1999a:99). In seguito, nel 1708 papa Clemente XIpromulgò un'ordinanza con cui la festa dell'S dicembre fu riconosciuta ufficialmente da tutta la cristianità come
festivita in onore dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Infine, Pio IX conlabolla Ineffabilis Deus
del 1854 definì soleruremente il dogma della Immacolata Concezione: "dichiariamo, pronunciamo e definiamo che
la dottrina, la quale ritiene che la Beatissima Vergine Maria [.. .] sia stata preservata immune da ogni macchia della
colpa originale, è dottrina rivelata da Dio e perciò da credersi fermamente e costantemente da tutti i fedeli" ( cit. in
Sgarbossa 1998: 692).
Il tempo d'Awento, segnalato al popolo dal colore viola delle vesti de1 sacerdote, si caralleizza anche per la
presenza della festività in onore dell'Immacolata Concezione. "La solennità dell'Immacolata (8 dicembre), profon-
damente sentita dai fedeli, dà luogo a molte manifestazioni di pietà popolare, la cui precipua espressione è la nove-
na dell'Immacolata" (Aa. Vv 2002: 95).
A Sutera, a partire dal primo giomo di dicembre, prendono awio le liturgie in onore della Vergine lmmacolata.
t3t