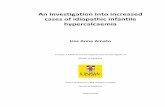2004. "Donne italiane e abbandono infantile nell'Archivio de los Senales (Rosario, Argentina, nel...
Transcript of 2004. "Donne italiane e abbandono infantile nell'Archivio de los Senales (Rosario, Argentina, nel...
Elemento unificante dell'opera, all'interno delle differen-ze tematiche e cronologiche é la figura femminile prota-gonista, dai tempi della schiavitü e dei processi di eman-
cipazione, fino alla condizione femminile contemporaneadelle donne Cree del Québec. Le analisi presentano casi distudio che danno voce e spessore storico a donne biancheanglosassoni pioniere nelle praterie canadesi, a donne ita-liane emigrate in vari paesi dell'America Latina, a donneafricane americane negli Stati Uniti. Sono figure che, purcostrette nei legami del gender seppero utilizzare, supe-rando barriere etniche e culturali, strategie di sopravvi-venza e di successo in ambito sociale, economico e pro-fessionale ed in settori quali l'antropologia o l'inchiestafotografica, tradizionalmente considerate maschili.
Gli autori/autrici, canadesi, europei e statunitensi, hannocontribuito offrendo sintesi delle loro piü recenti ricerche,
o anticipazioni sui loro studi in corso, conferendo al volu-me il carattere dell'attualitá storiografica e dell'originali-tá interpretativa.L'opera costituisce il quinto volume pubblicato dalCentroStudi EurolAtlanticí- Center for Eurt¡-Atlttntic Sttñíes- Centre
des Etudes Euro-Atlantiques dell'Universitá di Genova e,
nella serie, il secondo dedicato alla storia delle donne.
tsBN B8-86267,97-5
ililtruilililffiüililt1 euro 13,00
Fztrl4úFc/)
Oltre I'Atlantico.Ruoli di donne nelle societidel Canada e delle Americhe
Beyond the Atlantic.Women's Roles in Canadian and
American Societies
a cura diValeria Gennaro Lerda
e
Roberto Maccarini
SELTNE EDIZIONI
Questo volume é stato pubblicato con un contributo finanziario del GovernoCanadese al Centro Studi Euro-Atlantici, tramite l'Ambasciata del Canada inItalia
O Yoni, 2004
viaBazzinl2420131Milano
tel.02.26.68.17.38
fax 02.59.6L.71.'12
e mail: [email protected]
ln copertina: fotografia di valeria Gennaro Lerda (2002); statua raffigurante la
riformatrice Nellie McClung (Calgary, Olympic Square), parte del monumen-to alle "Famous Five". L-iscrizione The Women Are Persons I Les femmes sont des
personnes allude alla vittoria legale (1929) per ottenere il diritto a ricoprire lacarica di senatrici nel Parlamento del Canada.
Oltre l'Atlantico.Ruoli di donne nelle societádel Canada e delle Americhe
Beyond the Atlantic.Women's Roles in Canadian and
American Societies
a cura di
Valeria Gennaro Lerda
Roberto Maccarini
Selene Edizioni
Ai nostri nipoti
I Curatori
Inilice lTable of C ontents
lntro duzio ne f Intr o d u ctionValeria Gennaro Lerda-Roberto Maccarini
Rin gr aziamenti I Ackowl e d gme nt sValeria Gennaro Lerda-Roberto Maccarini
Parte primaEsperienze canadesil Canadian Experiences
Henrietta Muir Edwards and Aboriginal people:
Conflict and Compassion in First Waae Canadian FeminismPat Roome(Mount Royal College, Calgary)
The Quebec Cree Women. Her Enduring Statusas a Prominent Role ModelNadia Ferrara(McGill University, Montreal)
"I loae the Great Prairie":iI ruolo sociale delle donne nel Nord-Oaest canadeseValeria Gennaro Lerda(Universitá di Genova)
Parte secondaEsperienze nell' America Latinal Latin America Experiences
Donne e relazioni di genere nell'immigrazione italiana in Brasile(secoli XlXo e XX")Chiara Vangelista(Universitá di Torino e Universitá di Genova)
1,7
19
43
61
177
Donne italiane e sbbandono infantile nell'Archivio de losSenales (Rosario, Argentina, nel secolo XIX)Gabriela Dalla-Corte Caballero(Universitá d i Barcellona)
Parte terzaEsperienze statunitensif United States Experiences
Slaue-Ozoning Women, Manumission,and Free People of Color in MarylandStephen T. Whitman(Mount St. Mary College)
After the War:Women, Gender, and the New Social Orderin Southern HouseholdsElizabeth Tumer(University of North Texas)
Alice Fletcher ed il ruolo pubblico delle donne antropologhe
negli Stati Uniti tra Ottocento e NoaecentoAlessandra Lorini(Universitá di Firenze)
Documentary Photography as a Resource
for the Study of American Women?:The Farm Security Administration Photographs as a Case StudyConstance Schulz(University of South Carolina)
Note sugli autoril Notes on Contributors
143
779
197
223
253
277
Valeria Gennaro Lerda-Roberto Maccarini
Introduzione
IlCentro Studi Euro-Atlantici I Center for Euro-Atlantic Studies I Centre des
Etudes Euro-Atlantiques dell'Universitá di Genova (fondato nel 1997),ha organizzato nel corso degli anni importanti Convegni internazio-nali ed interdisciplinari per rispondere agli obiettivi ed ai progetti deifondatori e dei suoi cinquanta membri.l Tra gli scopi del Centro rive-ste un ruolo prioritario la creazione di reti di ricerca internazionali siaall'interno dell'Europa, sia tra l'Italia e le Americhe, in un ideale per-corso di collaborazione scientifica che valica l'Atlantico ed intensifical'arricchimento culturale tra studiosi delle problematiche storiche,politiche e sociali del mondo contemporaneo. I volumi finora pubbli-cati dai componenti del Centro in collaborazione con studiosi europei,canadesi ed americani testimoniano della vitalitá e della attualitá deiprogetti, che riguardano i temi cruciali del dibattito culturale interna-zionale, quali le rivisitazioni dei valori fondamentali della democrazia,le analisi del vasto e dibattuto universo economico e sociale della glo-balizzazione, I' internazionalismo americano nella sua evoluzione daWodroow Wilson ai giorni nostri, le tematiche legate alla salvaguardiadell'ambiente. La storia delle donne ed il ruolo delle donne nellesocietá contemporanee sono al centro degli interessi e dei programmidel Centro, che a partire dal 2000 ha organizzato seminari semestralisu problemi relativi alla presenza delle donne nello sviluppo sociale edeconomico del Canada, degli Stati Uniti e dell'America Latina.2
Il seminario svoltosi nella primavera dell'anno 2003, in collabora-
I Federalismi e Demouazia (1997); "IMich Global VíIlage"? Societies, Cultures and PolitícalEconomic Systems in a Euro-Atlantic Perpsectioes (1998); Canadían and American Women'sExperiences from Priztate to Public Spheres in the Atlantic World (7999).
" I volumi pubblicati dal Cent¡o Studi Euro-Atlantici, cui hanno contribuito molti stu-diosi afferenti al Centro sono: Susanna Delfino, a cura di, Federalismi e Demouazia (1999);Roberto Maccarini, a cura di, L'uomo ed il presidente. Studi su Woodrow Wilson (2007);Valeria Gennaro Lerda, a cura di, "lMich Global Village"? Societies, Cultures and politicalEconomic Systems in a Euro-Atlantic Perspectiae (2002), Valeria Gennaro Lerda e RobertoMaccarini, a cura di, Canadian and American Women. Moaing from Priaate to publicExperiences in the Atlantic World (2002).
Gabriela Dalla-Corte Caballero
Donne italiane e abbandono infantilenell'Archivo de los Señales (Rosario, Argentina, sec. XIX)*
L lntroduzione
Durante gli ultimi decenni del diciannovesimo secolo e i primi del ven-tesimo, le cittá portuali del Cono Sud dell'America Latina si trasforma-rono in spazi nei quali si sperimentarono le diverse forme di crescitacapitalistica partendo dall'immigrazione straniera che, nel casodell'Argentina, significb, tra il 1851 e il 1930I'entrata di quasi sei milio-ni di persone.' Nella lunga costruzione dell'identitá sociale e politica inArgentina, le praüche culturali attivate dagli immigrati costituisconoun problema di grande importanza nel contesto dell'organizzazionedello Stato oligarchico, fondato sul principio del "governare é popola-re". In virtu di questo precetto, l'éIiteliberale sostenne iniziative in favo-re dell'immigrazione, inserite nel quadro di costruzione del mercatonazionale della manodopera e della definizione di politiche pubbliche,fatto che mise a confronto uno Stato "moderno" e gli immigranti, i qualimettevano in pratica le loro strategie micro-sociali.'
* Ringrazio Valeria Gennaro Lerda per l'invito a partecipare al seminario intemazionaleorganizzato dal Centro Studi Euroatlantici (CSEA), Dipartimento di Storia Modema e
Contemporanea dell'Universitá degli Studi di Genova, e Chiara Vangelista per la tradu-zione del testo.1 Chiara Vangelist4 DaI uecchio al nuooo Continente, L'immigrazione in Ameríca Latina,Torino, Paravia Scriptorium, 7997, L63; cfr. anche Alejandro Andreassi, "¿Esperando a
Godot?: Estado e inmigración en Brasil y Argentina (1880-1914) perspectivas para unestudio comparativo," in Gabriela Dalla-Corte, Pilar García Jordán, y otros, comps.,Conflicto y aiolencia en América, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2002, 317-331.
= Fernando Devoto, Historia de la inmigración en la Argentina, con un'appendice sull'im-migrazione confinante di Roberto Benencia, Buenos Aires, Editorial Sudamericana,2003;ld., "81 revés de la trama: políticas migratorias y prácticas administrativas en laArgenüna (1919*1949),' in Desarrollo Económico, Retista de Ciencias Sociales, Instituto deDesarrollo Económico y Social [DES), N" '1.62, vol.41, julio-setiembre de 2001, BuenosAires,281-304;ld., "Para una historia de las migraciones españolas e italianas a lasregiones americanas sudatlánticas," in Marcello Carmagnani, Alicia Hernández Chávez
t43
-
A partire dalla specifica dimensione dell'immigrazione, lo Stato,
seguendo soltanto la seconda parte del principio "governare é popola-re" - vale a dire, l'idea legata piü al popolamento che al Soverno -lasció in larga misura in mano a corporazioni private l'esecuzione
della prima parte di questo principio, che ha a che vedere con i conflittiche gli immigrati dovevano affrontare da quando arrivavano al portodi sbarco. Uno di questi conflitti fu l'abbandono di neonati da parte didonne che mancavano di una rete sociale che, in caso di necessititpotesse farsi carico di loro e della loro prole. Mi propongo di discute-re in questa sede sul modo in cui le donne appena arrivate nel paese
hanno risolto temporaneamente il problema della cura e dell'educa-zione dei loro bimbi, al fine di potersi inserire senza impaccio nel mer-cato del lavoro, e di valutare nello stesso tempo gli effetti della povertáe della mancanza di protezione nella decisione delle donne di abban-donare definitivamente i bimbi e le bimbe in una istituzione di asilo.I- obbiettivo dell'articolo é di analizzare le condizioni nelle quali si ésviluppato il processo immigratorio di giovani donne italiane, stabi-
lendo nel contempo comparazioni con la situazione della popolazionelocale o di altri gruppi immigratori.
I- Argentina del secolo diciannovesimo consente di studiare inprofonditá sia le strategie degli immigranti, sia il ruolo dello Stato e diquelle associazi-oni private che si adoperarono per dare risposte al
fenomeno dell'immigrazione di massa e, in Particolare, a quello dell'e-mergenza rappresentata dai bambini abbandonati; un aspetto che per-mette lo studio della famiglia come parte dello spazio pubblico e nonsoltanto del privato o degli affetti.3
y Ruggiero Romano, comps., Para una historia de América lll, Los Nudos (2), México,México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, 1999,190120.
' r-abbandono di bambini e bambine da parte delle loro madri si é denomináto "espo-
sizione" , termine che fa riferimento alla dimensione pubblica ed alla perdita dello spa-
zio privato familiare e materno. Nancy Frase¡, "¿Qué tiene de crítica la teoría crítica?
Habermas y la cuestión del génerq" in Drucilla Cornella y Seyla Benhabib, Teoría femi'nista y teoría crítíca. Ensayos sobre la política de género en las sociedades de capitalismo tardio,
Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, Generalitat Valencian4 1990; cfr- anche Gabriela
Dalla-Corte, "Infancia y Género en contextos asistenciales. Las Damas de Caridad el
abandono de niños y las familias populares en Rosario, 1870-1900," Tesis de Maestría,"Poder y Sociedad desde el enfoque de Género," Facultad de Humanidades y ArtegUNR, Argentina,1995.
Studierb questi problemi a partire dalle attivitá dell'Hospicio de
Huérfanos y Expósitos di Rosario, una delle cittá portuali piü importan-ti dell'Argentina, durante il periodo che va dalla fine dell'Ottocento e
l'inizio del Novecento, analizzando l'articolazione tra le pratiche digenere e la costruzione dello Stato, cosi come il dialogo che si stabili-sce tra gli immigranti e la societá di accoglienza.o
A Rosario, gli italiani erano la comunitá piü numerosa di stranieristabiliti in cittá e in alcuni periodi arrivarono a superare la metá dellapopolazione totale. Questo fatto, sommato alla crescita massiccia delnumero degli abitanti, ha inciso profondamente sulle pratiche sociali e
culturali poste in gioco nella riproduzione familiare; infatti, i registridell'Ospizio ci mostrano che i bambini e le bambine abbandonati dallemadri italiane hanno costituito talvolta sino al 75'/o del totale. Comevedremo, la regolamentazione interna ha permesso che l'esposizioneinfantile fosse di carattere temporaneo, nei casi in cui le madri sivedessero costrette a lavorare, o di carattere definitivo, nell'ipotesi incui le madri volessero liberarsi della loro prole.
Ljassociazione incaricata di gestire l'Ospizio fu la societá "Dame diCaritá", che fu affiancata da diverse religiose della Congregazionedell'Orto, anche loro emigrate a Rosario alla fine dell'Ottocento.s
a Le fonti consultate si trovano nell'Archivo del Hospicio de Huérfanos y Expósitos deRosario (AHH) Argentina: Copiadores de Cartas de la Sociedad Damas de Caridad,I872-L907; Libros de Actas de la Comisión Directiva de la Sociedad Damas de Caridad,1869-1900; Libro de Actas de la Sociedad Protectora de los Huérfanos, 1899-1900; Librosde Asambleas de la Sociedad Damas de Caridad; Memorias de la Sociedad Damas deCaridad, 1898-1900; 1900-1901; Registro de Huérfanos y Expósitos del Hospicio deHuérfanos, 1879-1907; Archivo de Señales para el reconocimiento de niños, Cajas1890-191.3. Bisogna aggiungere che il numero dei contrassegni si riferisce al numero delneonato e non alla quantitá di contrassegni conservati; Libros de contratos y conveniosde adopciór¡ de setiembre de 1898 a enero de 1918; Libro de pagos de las amas,1881-1887; Libro de nodrizas, 1893-1896; Libro de nombres y sueldos de nodrizas oamas de leche, 1897-1900; Libro de Mensualidades de las amas de leche 1899-1901. Sultipo di fonti in una prospettiva storiografica vedi Gabriela Dalla-Corte y Dario Barriera,"Fuentes para los estudios de la familia: pinceladas y consideraciones transatlánticasdesde la historia social," in D. Barriera, y G. Dalla-Corte, comps., Espacios de Familia
¿Tejidos de lealtades o campos de confrontación? España y América, siglos XVI-XX, México,
f itanjáfora, Morelia, 2003.5 L"immagine delle Dame di Caritá di Buenos Aires che gestiscono il loro apparato cari-tatevole e di controllo dei settori popolari ci viene offerta da Eduardo Ciafardo, "Lapráctica benéfica y el control de los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires,
144
Lluniverso femminile coinvolto nell'istituzione si rende visibile nel-l'archivio che le suore e le Dame conservano ancor oggi e che hannodenominato Archiao de Señales.
La peculiaritá di questo corpus consiste nel fatto che é composto dafonti primarie provenienti dalla cultura materiale e da fonti primariemanoscritte. Nel primo caso, si tratta di "biglietti"(cédulas) o "contras-segni"(señales) vale a dire, di oggetti personali che le donne lasciava-no insieme ai loro figli abbandonati, o esposti nella ruota dell'Ospizio,contrassegni che dovevano servire a stabilire la vera identitá dei bam-bini nell'eventuahtA che potessero essere recuperati dai loro familiari.Nel secondo caso, si trattava di lettere o di frammenti di lettere, anche
questi scritti dalle madri e lasciati addosso ai neonati nella ruota o
sulla porta dell'Ospizio.
2. L'abbandono infantile, tra pubblico e priaato
Un avvenimento particolare ci permette di segnalare il percorso di pra-tiche consuetudinarie del passato formalizzate sul piano istituzionalee pubblico. La Societá Dame di Caritá fu creata nel 1869 da donne del-l'élite di Rosario, con il compito di fondare e amministrare un Ospizioper orfani ed esposti, i quali, sino ad allora, erano abbandonati ai por-toni delle case private. Le Dame di Caritá, nonostante non disponesse-ro ancora di un edificio adatto agli scopi che si prefiggevano, iniziaro-no a farsi carico dei piccoli abbandonati, contando sulla collaborazio-ne di famiglie e di balie, che accoglievano i bimbi nelle loro case.6
7890-1910," in Reaista de lndias, Madrid, Departamento de Historia de AméricaFernández de Oviedo, CSIC, N" 20L, vol. LIV Madrid, 1994,383-408..
José Luis Moreno, nel suo studio sulle Dame della Sociedad de Beneficencia e sulla lorogestione della Casa de Niños Expósitos de Buenos Ai¡es alla fine del secolo XVIII e all'i-nizio del XIX nota anche la distinzione che si faceva tra esposti e orfani. Lautore mostrache la Casa servi a concentrare neonati che sino ad allora erano abbandonati in strada e
che generalmente morivano nelle peggiori maniere (divorati da animali o investiti dallecarrozze). É interessante segnalare, come fa l'autore, che la Casa fu chiusa da JuanManuel de ltosas nel 1838 per ragioni squisitamente economicJre, e fu di nuovo aperta
nel 1852 dopo la caduta del governo di Rosas, nel contesto del consolidamento dellostato nazionale argentino, quando gli interessi dell'oligarchia locale miravano all'inte-grazione nell'economia mondiale. José Luis Moreno, "El delgado hilo de la vida. Losniños expósitos de Buenos Aires,1779-1823," inReaista de lndias,Madtid, Departamento
Nel 1872 la Societá consegnb a famiglie borghesi della cittá trebimbi orfani di madre. Com'era consuetudine sino a quel periodo,questa consegna non fu notificata alla Defensoría de Menores, in quelmomento a carico di Desiderio Rozas. Con un nuovo atteggiamento,tipico di uno Stato nazionale in formazione, il Defensor decise di recu-perare questi bambini, iniziando uno scambio epistolare che permettedi analizzare i conflitti tra le associazioni benefiche e l'apparato istitu-zionale. IlDefensor comunicb alle Dame che esse dovevano cominciaread adeguarsi alle nuove regole, rispettando la gerarchia e le prerogati-ve del Ministero; "in relazione alla sistemazione di orfani o abbando-nati, essendo la Defensoría I'snica incaricata per legge ad occuparsidella destinazione di questi, essa avrebbe chiesto alla Societá, ognivolta che si verificassero casi uguali al presente, di premurarsi di tra-smetterlo a questa ripartizione, affinché essa provveda [sic] alle misu-re necessarie".T
liOspizio degli Orfani apri le sue porte nel'1.879, facendosi carico,a partire da quel momento/ dei bambini orfani e abbandonati.L"istifuzione centralizzó una gestione che sino ad allora era rimastanelle mani dei borghesi della cittá, o della Chiesa come istituzione, e
allo stesso tempo diventb il mezzo legale per ottenere adozioni percontratto. La dipendenza dall'apparato statale é messa in luce dallaquestione dell'identitá dei bimbi: durante il periodo nel quale i bam-bini vivevano nell'Ospizio, essi dovevano avere un nome. Nel febbraiodel'l.,879, in un'assemblea ordinaria delle Dame di Caritá, si decise chei minori portassero il cognome del governatore di turno della provin-cia.a
Tra il 1879 e il 1900, l'Ospizio ricevette 1.130 bambini orfani, oabbandonati dalle loro famiglie. Furono ospitati dall'istituzione anche
de Historia de América Femández de Oviedo, CSIC, N" 220, vol. LX, Madrid, 2000,663-685.? AHH, Caja N" 1, carta del Defensor General de Rosario, Desiderio Rozas, a laPresidenta de la Sociedad Damas de Caridad, 04.08.L972. Ho analizzato questo casoanche in Gabriela Dalla-Corte, "Participación de las Mujeres de élite en el espacio públi-co," in Héctor Bonaparte y Gabriela Dalla-Corte, comps., Espacios de Género, vol '1.,
Rosario, Centro de Estudios Históricos sobre las Mujeres, UNR, 1991 139-153.a [Jn mese dopo, perb, considerando le complicazioni legali che potevano derivare datale decisione, le Dame decisero per il cognome De Paul, dal patrono dell'Ospizio, SanVincenzo de' Paoli fatto che non comportb la rottura con le autoritá locali.
746 t47
bambini le cui madri avevano bisogno di essere temporaneamentericoverate e non potevano contare su familiari o su di un marito che sifacessero carico del piccolo. Forse perb l'aspetto meno conosciuto del-l'istituzione é stata la sua affermazione come spazio di accoglienza odi collocazione di bambini i cui genitori si vedevano obbligati a inse-rirsi nel mercato del lavoro. La consistenza numerica delle entrateappare evidente nel grafico 1, mentre la tabella L mostra che piü dellametá dei bambini entrati mori nelle mura dell'istituzione.e
rllrGrafico 1. Entrate nell'Ospizio degli Orfani e degli Esposti di Rosario, Argentina, 1879-
1900.
Fonte: Archivo del Hospicio de Huérfanos y Expósitos de Rosario (AHH) Registro de
entradas de huérfanos y expósitos.
" Tre le malattie piü comuni compaiono meningite, consunzione, vaiolo, tubercolosi,"attacco", febbre, itterizia, infiammazione, mancanza di sviluppo, paralisi infantile,"difetti fisici", tosse convulsa, difterite, colera, morte improvvisa, bronchite, gastrite,
anemia, encefalite. Vedi AHH, Registro de entradas de huérfanos y expósitos.
oÉ
ul
lll
Tab. 1. Entrate e decessi dei bambini ospitati dall'Ospizio degli Orfani e degli Esposti diRosario, Argentina, 1,879 -1900.
Arm fotale Totale deceduti/e Z¿ deceduti sul tota¡€ entrate Sesso dei decedutiMaschi Femm, .l
t879 t7 8 47"1, 4 3
r880 22 l3 59% 8 5
1881 26 15 58% 6 91882 t7 t4 88% 8 61883 24 19 79E, ¡t ll1884 l8 16 89%' 7 91885 30 24 80,/,, l3 Il1886 1ó 70,j1, 7 91887 t2 54.50q" 7 51888 35 26 74r/. 9 L7
1889 50 34 6Uq, l6 l81890 52 61,50% t6 l61891 70 39 56% 27 l8la92 65 40 61,507,, l9 2'l
4l 65',la 20 21
1894 58 39 67q,, t4 25
I ¡{95 71 34 48',lo 20 t41896 88 59 67% 28 31
ilt97 46 8t,5O7a 19 271898 92 46 50% 241899 92 46 50,'r, 24 221900 tt4 56 49'lo 25 31
Totali 1130 675 59.79% 323 l4$Yol | (52'/o 1 (oYa)
Fonte: Archivo del Hospicio de Huérfanos y Expósitos de Rosario (AHH), Registro deentradas de huérfanos y expósitos.
li analisi comparativa tra i neonati e bambini depositatinell'Ospizio evidenzia tre fasi, nel periodo compreso tra il 1879 e il1900 (tab. 2). In una prima fase, che va dall'inaugurazione al 1886, lacurva che rappresenta i bimbi depositati coincide significativamentecon i neonati. Segue una seconda fase, che si chiude approssimativa-mente nel 1893, nella quale le curve dei depositati e dei neonati comin-ciano a biforcarsi, a causa della crescita del numero dei bambini fino aun mese di vita. Vi é infine un terzo periodo, nel quale é evidente ladiminuzione dei neonati, sostituiti dai bimbi di un'etá tra i tre e trentagiorni. In questo caso, la tabella 2 mostra che l'immigrazione massic-cia dell'ultimo decennio del secolo XIX comportb altre cause di depo-sito e di abbandono, forse piü complesse di quelle tradizionali.
r,hrlllAnni 1879-
r48
amo totale neonato sino ai 30 sino ai 60 sino ai 6 slno a un sino ai 2 Diü di 2 senza
slornl EOml mesl mno annl annl ndicazione
7879 t7 5 0 0 0 0 8
lEEU 22 12 5 0 0 0 31881 26 15 3 1 0 0 5
1882 t7 7 7 {} 2 0 0 0 I1883 24 15 2 2 2 0 0 0 3
1884 18 5 0 4 l, (, J
1tr85 3U 79 4 2 0 2
t886 23 6 13 0 0 0 0 3
1887 22 t9 2 {) 0 0 0 0
I 88¡t 35 19 6 2 4 0 0
1889 50 30 17 t) L) 0 0 I
I89t) 52 26 2t 2 2 0 0 0
1891 70 45 l8 4 2 t) 0 t
t892 65 4l 17 5 0 0 0 0 2
1893 b., Jb 18 4 0 Itag4 5lJ 4l 13 0 2 2 0 0 0
1895 71 42 25 I 0 0 I It896 6E 62 2f 3 2 0 0 0 0
1897 81 51 20 7 z 0 0 0
1898 92 55 22 ¡i 2 4 0 0
1899 92 52 31 3 0 2 2 0
1900 tl4 4ta 51 9 2 0 2 0 2
Totali 1130 649 324 57 z8 IE tl 42
too0/,, 57.50q,, 28.70'/. 5'/,, 2.50v. 1.60'ñ, 1'n, 0% 3.70',1,
Tab. 2. Etá dei bambini e bambine al momento dell'abbandono nell'Ospizio di Orfani e
degli Esposti di Rosario, Argentina (1879-1900)
Fonte: Archivo del Hospicio de Huérfanos y Expósitos de Rosario (AHH), Registro deentradas de huérfanos y expósitos
Poco dopo aver aperto le sue porte, l'Ospizio aveva cominciato a
ricevere figli di stranieri, ma questa situazione divenne endemica a par-tire dal 1890, quando l'Ospizio dovette farsi carico non solo di piccoliprovenienti da Rosario, ma anche di un numero crescente di bambiniche nascevano sulle navi o subito dopo l'arrivo in cittá dei genitori.Molti di questi bambini furono "collocati" nell'Ospizio durante iltempo che i loro genitori impiegavano per ottenere la prima occupa-zione.
Questo fatto é visibile nel cambiamento avvenuto durante l'ultimodecennio del secolo XIX: l'allontanamento della curva dei neonati daquella dei bambini sino a un mese di vita permette diipotizzare che sitratti di bambini e di bambine figli di stranieri, nati durante il viaggio,o nel paese, perb provenienti da famiglie europee che erano arrivate inArgentina nel contesto dell'esplosione immigratoria.
150
-
3. Etnicith, identith e contributo consolare
Come si puó immaginare,l'Ospizio comincib a chiedere l'appoggioeconomico dei consolati e delle associazioni etniche stabilitisi nellacittá di Rosario, e in modo particolare delle diverse entitá italiane radi-cate nello spazio urbano locale. Le Dame di Caritá conoscevano l'ori-gine etnica dei bambini, attraverso le conversazioni avute con i fami-liari che li abbandonavano. Questa possibilitá di dialogo si ebbe acausa del cambiamento del luogo del deposito, avvenuto nel 1894.Fino a quell'anno, e come é possibile constatare dalla tabella 3, il luogo
Tabella 3. Luogo dell'abbandono dei barnbini nell'Ospizio degli Orfani ed Esposti diRosario, Argentina (187 9 -1900)
FONTE: Archivo del Hospicio de Huérfanos y Expósitos de Rosario (AHH), Registro deIngresos de huérfanos y expósitos.
Alrc Iluota Porta 50qlra A terra Stanza Portineria Chiostro I otaleta79 16 I 771880 22 221881 26 261tt82 16 2 771883 24 24
1884 18 18
1885 29 1 301886 23 23t887 22 221888 32 1 35IEE9 50 501890 51 I 521891. 69 I 701,492 65 651893 63 631894 58 581895 7"1
1896 84 1 2 1 887897 81 811898 90 2 921899 89 921900 113 1 174
Totali 584 531 4 tt 1 1130s2% 47% 0,30y,, 0,70(lo 0.00,/,, 0,00% 0,00% to07o
di esposizione scelto preferibilmente dalle persone che abbandonava-no i bambini era la ruota, dispositivo in pietra che si trovava nellaparte piü nascosta e meno frequentata dell'edificio e che girava versof interno dell'Ospizio, facendo si che le religiose ricevessero i neonatisenza che coloro che li abbandonavano fossero visti. A partire dal 1894
le Dame de Caritá chiusero la ruota, proibirono che i bambini fosserodepositati nelle ore notturne, approfittando dell'oscuritá, e imposeroI'utilizzo della porta di entrata dell'Ospizio.
I depositi iniziarono cosi ad effetfuarsi in modo personale, faccia afaccia, e le religiose furono incaricate di trattare direttamente con igenitori. Ad ogni modo, era possibile conoscere l'identitá di coloro che
abbandonavano dalla lingua uttlizzata nelle note che accompagnava-no i bambini, quando questi erano lasciati nella ruota, o dalle conver-sazioni avute sulla porta dell'Ospizio. Nel lungo periodo, la portaservi a garantire alle religiose e alle Dame di Caritá un maggior con-trollo delle informazioni fornite dai depositanti sulle cause dell'abban-dono, sul periodo in cui pensavano di lasciare i bambini, sui loro pro-positi di recuperali - o no - in un futuro.
Per mezzo della codificazione della pratica del deposito, l'Ospiziorivesti un ruolo importante di controllo e di regolamentazione all'in-terno delle famiglie e nei confronti delle donne sole dei settori popo-lari. Nella relazione delle Dame di Caritá del 1890 si osserva che l'ob-biettivo dell'intervento dell'élite era si il bimbo o la bimba, ma anchetutto il gruppo familiare che lo circondava e, in modo particolare, le"donne-madri" che, per le donne dell'élite, non erano altro che pec-catrici o donne cadute in disgrazia. L"Ospizio diventava cosi "unaistituzione popolare tanto importante per le masse di basso livellosociale, perché é solo un filo cib che separa la macchia dalla sventu-ra".ao
D'altra parte non sempre l'intenzione dei familiari era quella diabbandonare definitivamente i loro piccoli. Questo fatto provocb alcu-ni cambiamenti nel funzionamento dell'istituzione. Subito dopo il1890Ia corrispondenza delle Dame di Caritá offre un ricco campo dianalisi, che mostra le relazioni costanti con i consolati che avevanosede in cittá e l'interesse che questi avevano di assicurare la perma-nenza nell'Ospi-zio. Thle continuitá era garantita soprattutto dall'ap-
'' AHH, Memoria de Ia presidenta de la Sociedad Damas de Caridad, Rosario, 1890.
poggio economico che le diverse associazioni etniche e di mutuo soc-corso offrivano.
Nel 1884, per esempio, la colonia francese, con a capo LeónIdiartborde e victor Fessory mandb alle Dame il ricavato di una col-letta.11 I consolati e le ambasciate mantenevano relazioni permanenticon le Dame, sollecitando il deposito di bambini nell'Ospizio, oppureritirandoli, quando potevano contattare un componente della fámi-glia di origine. Nel 1895 il consolato di Francia chiese informazionisulla sorte di Francisco, un bimbo francese di cinque anni che si tro-vava nell'Ospizio: "Nel caso che fosse uscito da detto asilo - scrisse ilconsole francese alla presidentessa della societá - La ringrazierei mol-tissimo se mi facesse sapere, se Le é possibile, dove lo si possa trova-re. Il nonno di questo giovine, desideroso di tenerlo con sé, ha otte-nuto dal governo francese le spese di viaggio di suo nipote sino inFrancia".12
Indubbiamente le associazioni piü interessate erano quelle italiane,dato che la stragrande maggioranza dei bambini stranieii abbandona-ti erano figli di immigrati italiani. Nel 1888 ilComitato delle Feste ltalianeconsegnb all'Ospizio 600 pesos, come risposta e ringraziamento alfatto che in esso fossero alloggiati figli di donne italiané o di coppie diitaliani. La Dame, per poter garantire questo servizio in fufuro,-scris-sero al Comitato che "degli orfani ed esposti che si trovanonell'Ospizio , il 75% é costituito da figli di italiani,,.13
Un caso specifico ci aiuterá ad illustrare cib che abbiamo appenasostenuto. Nel 1888 la societá Italiana unione e Benevolenza tacco-mandb un italiano appena arrivato, che aveva perso la moglie.Uobbiettivo era quello di "sistemare" nell'Ospizio due dei suoi figli,appena nati. Nella lettera inviata alle Dame, il rappresentante dellasocietá italiana comunicava che l'uomo che aveva richiesto questoaiuto era "a Rosario da pochi giorni, ha perduto la moglie, morta neldare alla luce due figli gemelli. Povero, con altri quattro figli, il sig.
'r AHH, Caja N" L, lettera dei componenti della colonia francese, rappresentati da LeónIdiartborde e Víctor Fesson, alle Damas de Caridad, 22.07.1884.'2 AHH, Caja de Correspondencia, carta del Consulado de Francia a las Damas deCaridad, Rosario, 29.07.1895; v. anche carta del Canciller y del cónsul de Francia de16.10.1895 con l'ordine di recuperare il bambino per mandarlo in Francia." AHH, Caja de Correspondencia de las Damas de Caridad, Caja N,, 1, carta de lasDamas de Caridad al Comité de las Fiestas ltalianas, Rosario, 19.10.19gg.
t52 153
Pedrotti implora a V.S. un posto all'Ospizio per le sue due creaturenate da due giorni".lo
Anche i figli delle donne immigrate detenute per crimini commes-si a Rosario erano protetti dai consolati. Nel 1896, una italiana chia-mata Luisa G. de C. fu incarcerata nell'Asilo del Buon Pastore, che aRosario faceva le veci del carcere femminile. Durante il periodo delladetenzione il figlio fu separato da lei e condotto all'Ospizio a carico delconsolato d'Italia a Rosario, che rappresentava la donna. L"ente comu-nicb di
avere in suo possesso un maschietto di tre anni della cui sorte siinteressa questo consolato senza aver pofuto trovare una fami-glia che si faccia carico del medesimo. In risposta mi é gratomanifestare al Signor Console che non c'é impedimento a che laSocietá si faccia carico del bimbo, peró gli Statuti stabilisconoche in questi casi si paghi una pensione, dato che Io stesso [ospi-zio, N.d.T.l non ha risorse autonome.l5
I-íOspizio fu concepito per perseguire obbiettivi che si collegavanoessenzialmente con il controllo e l'ordine delle famiglie e delle donnenubili dei settori popolari. Nella sua relazione del 1882, la presidenzadelle Dame affermava che la motivazione della creazione dell'istitutoera l'accoglienza sistematica dei bambini, al fine di diminuire le altepercentuali di irifanticidi di cui soffriva la cittá. Si sperava che le per-sone poverc, o nell'impossibilitá di accudire un bambino, Potesserocontare su di un luogo nel quale alloggiarli, invece di vedersi obbliga-te a ucciderli, una forma di regolamentazione delle nascite indesidera-te.
La stampa dell'epoc4 cosi come gli atti giudiziari provinciali diRosario, ci informa su questa pratica, molto comune e generalizzatatragli abitanti della cittá, e che soltanto in poche occasioni conseguivagravi condanne da parte delle autoritá giudiziarie, come ha anchemostrato Kristin Ruggiero, affermando che il disamore e la vergogna
't AHF! Caja N" 1, carta de la Societá Italiana Unione e Benezolenza a las Damas deCaridad, 24.08.1888.r'5 AHH, Caja N" 1, carta del Consulado de Italia en Rosario a las Damas de Caridad,1896.16 Archivo de los Tribunales Provinciales de Rosario (ATPR), Libros de Sentencias del
t54 155
erano i termini con i quali le donne e i loro difensori dovevano descri-vere il timore sentito per una "morte civile e sociale", giacché eranoquesti i requisiti richiesti dalla giurisp¡udenza.l6
L"ideale per le Dame era ricevere bimbi appena nati o molto picco-li, e non tutti gli infanti venivano accettati. Cib si evince dal rifiuto diuna bambina giá socializzata, mandata dal Difensore dei Minori inqualitá di depositata, con Ia spiegazione che la sua ammissione sareb-be andata contro i veri obbiettivi dell'Ospizio, che doveva evitare ognicontatto con "germogli" giá cresciuti, evitando cosi di diventare unacasa correzionale.lT
r"interesse di reintegrare nella sua famiglia il bimbo abbandonatoera giustificato dal fatto che l'esposizione era accettata solamente comepalliativo dell'infanticidio, ma non significava un perdono per coloroche attuavano l'abbandono.la Nelle Merrorias di gestione delle Damesi sostenne costantemente che tra i compiti piü importanti che laSocietá si era prefissata vi era quello di cercare di restituire i bambini,reinse¡endoli nelle loro famiglie di origine, appena verificata l'identitáe la parentela. Le Dame cercavano in questi casi di chiedere alla fami-glia una somma che coprisse le spese sostenute dall'Ospizio per ilbambino, perb non sempre ci riuscivano, a causa delle misere condi-zioni economiche nelle quali generalmente si trovavano i parenti.L"applicazione dell'usanza del pagamento di una pensione da parte dicoloro che avevano lasciato il bambino costitui una delle strategie perassicurare un'ent¡ata regolare di fondi. I consolati furono obbligati apagare mensilmente le cure dedicate ai discendenti dei loro protetti.Per esempio, nel 1896 il console di Francia fu informato che le Dameaccettavano l'invio di tre bambini tra i due e i cinque anni, figli di unfrancese, a condizione che l'organismo si facesse carico del pagamen-to di sei pesos per ciascuno di loro."
Jtzgado del Crimen de los Tribunales Provinciales de Rosario, años 1890-1910. KristinRuggiero, "Honot Matemity and the Disciplining of Women: Infanticide in late ColonialNineteenth Century Buenos Ates," Hispanic American Historical Reaiew,72, N" 3, 1992,35T373. La versione in spagnolo é in Lea Fletcher, comp., Mujeres y culturn en laArgenfina del siglo XI& Buenos Airet Feminaria Editora, 194.'7 AHFJ^, Caia de Correspondencia Nota al Defensor de Menores, 1882.18 AHF Memoria de la Presidenta de la Sociedad Damas de Caridad, 1890.
'" AHH, Caja N" 1, carta de las Damas de Caridad a Enrique Franeastel Cónsul deFrancia en Rosario, 03.12.L896. La decisione di esigere questa somma fu presa nel
4. "Non tí abbandono figlio nrio. Tí cerchero... te lo prometo. Addio".L' uniaerso dei fo glietti
In questo paragrafo analizzo l'uso dei contrassegni e del loro signifi-cato. Ho scelto di iniziare con una citazione letterale della frase di unadonna italiana ("Non ti abbandono figlio mio. Ti cerchero... Te lo pro-meto. Addio"zt-') perché ritengo che si tratti del bandolo della matassaper capire l'abbandono infantile.
Lo studio dell'abbandono infantile e del funzionamento delle isti-tuzioni di asilo non é nuovo nella storia sociale degli ultimi anni.Adela Tariffa Fernández, nel suo studio sui bambini esposti durantel'Ancien Régime a Ubeda, regione della Spagna meridionale, prosegueper cosi dire l'irmovazione apportata da Philippe Ariés alla storia del-l'infanzia. Líautrice individua le cause dell'abbandono infantile nellapovertá familiare e mostra come gli anni che registrano il maggiornumero di bambini abbandonati coincidano con i cicli di crisi econo-mica o di carestia.2l Bisogna ricordare che non tutti gli autori conside-rano che l'abbandono dei bimbi e delle bimbe debba essere inteso nellaprospettiva economica, almeno nell'Europa dell'Ancien Régime.2'
Nella nostra ricerca, indagare sulle ragioni dell'abbandono attra-verso la documentazione prodotta dalle Dame di Caritá, dall'autoritápubblica o dalla Chiesa - tutti organi incaricati di imporre l'ordinesociale - presuppone rimanere con solo una parte della storia. É piut-tosto difficile capire il comportamento sociale al di fuori delle prescri-zioni e delle valutazioni morali, igieniste e politiche. D'altra parte, siapre una nuova prospettiva mediante l'accesso alle dichiarazioni deiprotagonisti. Cib che si trova scritto nelle lettere e sui contrassegnilasciati con i neonati permette di valutare quale fosse il vero ruolo
momento in cui si apri l'Ospizio. Mennria de la Presidenta María de los Angeles Rotlríguez
de Rosas, Rosario, 1882.2" AHH, Caja de Señales, Caja del año 1899, señal N' 983.
=' Adela Tarifa Fernández, Marginación, pobreza y mentalidad social en el Antiguo Régimcn:
Ios niños expósitos de Úbeda (1665-1779, Prefazione di León Carlos Alvarez Santalo,Granada, Universidad de Granada y Ayuntamiento de tfbeda, 1988.22 León Carlos Alvarez Santalo, "Anormalidad y códigos de conducta de la familia enel Antiguo Régimen: la doctrina religiosa sobre el abandono de niños," in F. Chacón,comp., FamíIia y Sociedad en el Meditertóneo Occidental, siglos XV-XIX, EditorialUniversidad de Murcia, 1987,46.
della ruota, dell'abbandono e dell'Ospizio come istituzione, e qualifossero le aspettative dei settori popolari che si trovarono nella neces-sitá di fare uso dell'ente. Troviamo questo genere di informazionenell'Archiao de Señales che si conserva nell'Ospizio.23
Il contrassegno appare come un elemento predominante nell'ab-bandono durante il periodo in cui prevale l'uso della ruota. l"esistenzadi questa aveva favorito l'usanza di lasciare sul corpo del neonato qual-che effetto personale, o una lettera, che servivano a fomire un'identitáa chi con l'esposizione perdeva forse per sempre i legami familiari.2a
I contrassegni e le note lasciati nella ruota al momento dell'abban-dono dei neonati hanno ricevuto un'attenzione parziale da parte deglistorici europei. Lola Valverde Lamsfus, in uno studio sulla storia del-l'infanzia basca tra i secoli XVIII e Xli ci induce a considerare che icontrassegni che le madri deponevano nell'Ospizio di Rosario, inArgentina, erano quasi esattamente gli stessi che le loro progenitricilasciavano nelle ruote spagnole. Come afferma Lola Valverde, l'infan-ticidio, l'aborto e l'abbandono di bambini erano meccanismi di regola-mentazione demografica in termini maltusiani e servivano nello stes-so tempo alla salvaguardia dell'onore femminile. Essi costituisconoanche elementi centrali per capire la mentalitá, il diritto, il ruolo dellareligione e la funzione che avevano Ie nutrici nella possibilitá disopravvivenza dell'infante.2s
Monserrat Carbonell, da parte sua, affronta la povertá in Catalognadurante il secolo XVIII nell'ottica delle disuguaglianze all'interno delcontadinato e della popolazione urbana in un contesto di cambiamen-to e di crescita economica. I-lopera rientra in una storiografia di tiposociale che ha rinnovato le sue ipotesi per includere temi quali lapovertá e l'emarginazione generate dalle differenze socio-economichecome un fatto centrale e non marginale della stessa storicitá, sia del-l'impoverimento degli strati dei settori popolari, sia dell'arricchimen-
23 Vedi il lavoro precedente Gabriela Dalla-Corte, "Un archivo de Señales en la exposi-ción infantil: Derecho consuetudinario e imaginario populaq," in Reaista Mora, N 4,Buenos Aires, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Filosofía yLetras, Universidad de Buenos Aires (UBA), 1998, 83-93.2a Vedi il Dossier della Rerrisfa Historia Social N" 9, Valencia.25 Lola Valverde Lamsfus, Entre el deshonor y Ia misería. lnfancia abandonada en Guipúzcoay Nntrarra siglos XVIII y XIX, Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1994.
to dei settori del potere. Uautrice si prefigge proprio di scrivere "dalbasso" su argomenti quali la dinamica del cambiamento sociale, Ie retiassistenziali della Casa di Misericordia,le femminilizzazione delle isti-tuzioni assistenziali, la p aupefizzazione nel lavoro, la condizione deglianziani.26 L-aspetto interessante di questo testo risiede nel fatto che
esso fa riferimento all'importanza delle reti familiari (l'esistenza di zii,padrini, cognati e altri parenti) nel momento di farsi carico dei proble-mi, vale a dire, fa riferimento al ruolo del sistema parentale come stra-
tegia di previsione. L-accesso a parenti, vicini, amici era un principiodella solidarietá e della reciprocitá.
Le interpretazioni dell'abbandono sono oscillate tra l'attribuirne lacausa all'insensibilitá, all'indifferenza, al rifiuto nei confronti dell'ille-gittimitá, e alla necessitá di rafforzare codici di condotta e norme socia-li. In linea generale, l'illegittimitá é stata la causa che gran parte deglistorici hanno individuato per giustificare o spiegare l'abbandono dei
bambini. Se affrontiamo questo problema a partire dalla documenta-zione istituzionale e ufficiale dell'Archivio dell'Ospizio degli Orfani e
degli Esposti di Rosario, vediamo che l'Ospizio tendeva a presentarsicome il depositario dell'illegittimitá dei figli delle madri nubili o deifigli extra-matrimoniali. Non sto negando che il peso dell'illegittimitá,del disonore e della macchia fosse troppo duro per le madri: in alcune
lettere private vediamo che si facevano differenze di status tra figlilegittimi o illegittimi, e sPesso le madri alludono a questa situazionecome unica informazione. Cib si vede nella lettera lasciata da una
madre insieme ai suoi due figli gemelli, depositati nella ruota, con unoscritto che dichiarava solamente che erano "figli illegittimi".2T
Vi sono perb altri elementi da tenere in considerazione. Nelle lette-re - cioé fonti private delle mentalitá popolari, probabilmente uniche,in questo senso - appaiono poche manifestazioni del fatto che fosse
l'onore cib che si volesse conservare con l'abbandono del bimbo.
2ó Montserrat Carbonell i Esteller, Sobreaiure a Barcelona. Dones, pobresa í assisténcia aI
segle XVlll, Premi Oms i de Prat 1993, Manresa, Fundació Caixa de Manresa, Eumo
Editorial, l997.Della stessa autrice é molto importante lo studio sul ruolo dei pegni
come garanzia del pagamento di un debito, che fungevano anche da piccoli crediti, per-
mettendo di sopravvivere ai ceti popolari in congiunture di crisi, quali l'inverno del1264. Ll autnce analizza questa strategia nel caso del Monte di Pietá di Nostra Senyora de
l'Esperanga di Barcelona, nella sua funzione di rete di credito e previdenza.2' A}{H, Caja de Señales. Caja del año 1891, señal N" 397 y señal N" 398'
i
Quando emerge l'onore, questo awiene insieme ad altri fattori condi-zionanti: che la madre fosse nubile implicava a sua volta che essa fossesola, che fosse malata, o che fosse immigrata. Queste cause avevano unpeso maggiore del fatto che il bambino fosse nato o meno in una strut-tura familiare fondata sulla legalitá religiosa o civile. Una madre, peresempio, scrisse alle Dame che doveva lasciare il suo bimbo perché era"malata, a letto e senza poter mantenere la creatura appena nata... efiglia naturale". lJna considerazione dello stesso tipo é presente inquesta lettera, scritta da una madre italiana: "questa creatura femminaé nata alle 9 della sera del giorno 6 del mese di febbraio del 1900. Dallasignorina A., di religione cristiana, nazionalitá italiana (piemontese) éillegittima, la madre povera servente". Nel 1895 un altro immigranteitaliano, questa volta di sesso maschile, espose suo figlio nell'Ospizio,alludendo al fatto che si trattava del "frutto dunna (sic) mia amante",vale a dire, di una nascita al di fuori della struttura familiare.zs
Tra le lettere conservate, ve n'é una nella quale le stigmate di esse-re madre nubile si sommano al fatto di essere figlia naturale, vale a
dire, una persona che non contava su nessun vincolo familiare cono-sciuto e che si sentiva sola di fronte alle awersitá. Uabbandono infattifu deciso da "una domestica, madre molto giovane. Non ha marito,senza padre e senza madre o, se li h4 non li conosce. Questa poverainfelice vi chiede dibattezzarla con il nome di Rondinell4 per poterlariconoscere, se Dio vuole, e poterla un giorno abbracciarla... Vi salutacon osservanza, quella senza cognome, Ramona".2e
Quando l'illegittimitá e la colpa appaiono come uniche cause, i pro-tagonisti si sentono condizionati dal rifiuto degli altri familiari e l'o-nore e l'infamia non costituiscono un problema centrale: "La madre diquesta bimba ha dovuto affidarla all'Asilo alle vostre cure perché hacommesso un peccato e per non avere problemi con la famiglia hadovuto prendere questa decisione estrema. Chiedo affettuosamentealla Reverenda Madre che ne abbia cura e non le lasci mancare niente,ché entro tre anni tornerb a prenderla e a pagare tutte le spese per labimba suddetta".3o
28 Cfr. AHH, Caja de Señales, Caja del año 1894, señal N" 563; año 190O señal N" 1"03|año 1895, señal N" 610.
=" AHH, Caja de Señales, Caja del año 1899, señal N" 992.
'o AHH, Caja de Señales, Caja del año 1894, señal N" 582.
158 159
Nel caso degli immigranti appena arrivati in Argentina, la situazio-ne é molto diversa: si tratta di un flusso di popolazione che perde ilegami familiari e che soffre della mancanzadiuna rete di relazioni perfar fronte alla sopravvivenza.3l Michel Bertrand, specialista in retisociali, ce ne mostra l'importanzanel momento in cui gli individui siinseriscono politicamente nel mondo sociale. Imizcoz Beúnza, a suavolta, cerca nelle reti sociali il contesto e il tessuto sul quale si fonda ilfunzionamento sociale.32
In questa prospettiva, che cosa ci dicono al riguardo i protagonistidell'abbandono infantile, nelle loro lettere o nei contrassegni? La pro-porzione tra le esposizioni con e senza contrassegno si mantennecostante durante tutto il periodo considerato (v. tab. 4). Per lo storico,i contrassegni costituiscono una inestimabile fonte di conoscenza dellepratiche culturali dei settori popolari, delle sue credenze e timori, delleaspettative riposte nella gestione dei componenti dell'élite. La maggiorparte di coloro che espongono i bambini sono donne, sono le madri, e
i contrassegni, scritti e no, permettono di analizzare le ragioni dell'ab-bandono, le quali si connettono piü chiaramente come una sorta dimeccanismo di adattamento familiare e individuale alle circostanzeavverse. In tal senso, l'esposizione sarebbe una specie di transizione,un meccanismo di articolazione o di riarticolazione familiare. Questaspiegazione non presuppone perb l'adesione alle interpretazioni diRicardo Cicerc\ia, il quale vede l'abbandono di bambini come un mec-canismo sociale di distribuzione della popolazione, vale a dire, unapratica di stile maltusiano.='
3f Montserrat Carbonell i Estelle¡, Sobreaiure a Barcelona, 164-165.
"= Michel Bertrand, "De la familia a la red social," Reoista Mexicana de Sociología, N' 2,
7999, 107-135; José Maria Imizcoz Beunza, Elites, Poder y Red Social, Bilbao, ServicioEditorial Universidad del País Vasco, 1996. Vedi anche Michel Bertrand y Gabriela Dalla-Corte, comps., "Parentesco, redes familiares y sociabilidad en el mundo hispanoameri-cano en los siglos XVIII y XIX," Anuario de Estudios Boliuarinnos de la Uniaersidad SimónBoliaar, Caracas, Venezuela, 1999; Gabriela Dalla-Corte, "La red social frente a la crisisdel orden colonial: compensación judicial y vínculos de parentesco entre Buenos Aires yCataluña," in Coloníal Latin American Hístorical Rniezo (CLAHR), Spanish ColonialResearch Centet Zimmerman Library, University of New Mexico, vol. 9, summe{, N" 3,
2000,347-377.33 Ricardo Cicerchia, "Las vueltas del torno; claves de un malthusianismo popula¡," inLea Fletcher, comp., Mujeres y cultura en la Argentina del síglo XIX, Buenos Aires,Feminaria Editor a,'1.99 4.
anno mn contr. snza contr. senza indicazione totale879 5 7 5 17
1880 15 6 22
t88l zt) 4 1, 26
t882 9 8 t71883 l4 9 1 24
1 884 7 10 1 18
t885 79 t 30
1886 15 It887 16 6 22
1888 l5 20 35
1889 29 27 50
1890 29 52
891 48 22 70
t892 45 2u 65
1893 38 25 63
894 31 27 58
895 42 29 71
896 55 33 88
897 4t3 38 81
1898 53 37 9Z
1899 45 49 92
1900 56 56 114
Totali 651 469 10 1130
% 57.6 l,: 0,9 100q,,
Tab. 4. Bambini e bambine depositati con contrassegni nell'Ospizio degli Orfani edEsposti di Rosario, Argentina (1879-1900).
Fonte: Archivo del Hoipicio de Huérfanos y Expósitos de Rosario (AHH)' Registro deingresos de huérfanos y expósitos-4.
L Ospizio sorse originariamente con la funzione di albergare i bam-bini senza genitori né familiari e Prese questo universo infantile perdefinire il suo stesso nome: Ospizio degli Orfani' Come abbiamo visto,questo compito fu presto integrato da altre funzioni, con le quali l'isti-tuzione si trasformd in uno spazio di collocazione definitiva, ma anche
in un asilo per la poPolazione infantile che era "esposta", non avendo
trovato un posto nella famiglia di origine per diversi motivi, la mag-gior parte dei quali legati alla destrutturazione domestica, all'abban-dono paterno, alle carenze familiari sofferte dalla donna e alla neces-
sita di occupare un Posto nel mercato del lavoro.
3a Si é calcolato il numero dei bimbi con contrassegno in base alle informazioni annota-
te dalle religiose e dalle benefattrici nell'apposito registro e non in relazione all'Archivode Señales.
160 t61
lotaleOggetticon messaggioscritto
lettera
294
lettera di autoritá 15
cartoncino 2
mezzo cartoncinocertilicato dr batteslmoTotale 315
Tab. 5. Classificazione dei contrassegni dell'Archivio dell'Ospizio degli Orfani e degliEsposti di Rosario, Argentina (1890-1900)
In questo senso, l'Ospizio si trasformb in rifugio temporaneo per laprole dei settori popolari, i quali istituirono la pratica del contrassegnocome forma di identificazione dei bimbi. I contrassegni erano cosi lagaranzia dell'identitá del bambino lasciato all'Ospizio e la pratica piücomune fu quella di lasciare il neonato con un qualche documentoduplicato, una lettera, o un cartoncino tagliato in modo tale che sol-tanto la persona che aveva lasciato il piccolo potesse mostrare l'altrametá e fare coincidere i bordi. La razionalitá di questa pratica é note-vole, se pensiamo che sin dal Medio Evo la validitá dei contratti si assi-curava attraverso il taglio particolare del documento, lasciando cia-scuna parte coinvolta con una porzione dello scritto, come prova delfatto che l'atto era effettivamente avvenuto: "affinché quando io possariprendere mio figlio, io sappia che quello che ritiro é il mio".35
Le caratteristiche del contrassegno registrano variazioni, in basealle tradizioni regionali, le devozioni per le diverse immagini, miraco-lose, religiose o comuni e che sono cambiate storicamente. I contrasse-gni possono essere classificati in modo diverso. Al fine dei nostriobbiettivi, la tassonomia é un criterio di scrittura che abbiamo adotta-to per dividere i contrassegni in base al messaggio scritto in esso con-tenuto. La tabella 5 mostra i diversi tipi di contrassegno".conservatinell' Ar chia o d e S e ñ aI e s dell' Ospi zi o analizz ato.
Da molto tempo le donne, europee e latino-americane, hanno impa-rato e insegnato ad altre donne a nominare immagini sacre e a ricorre-re al linguaggio del "contrassegno", dipinto, scritto o ricamato peridentificare i figli che abbandonavano. Il contrassegno era un formaper chiedere favori o ringraziare per "miracoli" che le avrebbero aiu-tate a lenire paure, angustie, superare assenze, accettare separazioni, inparticolare la separazione con il neonato. Nel contrassegno sono rima-ste molte delle preoccupazioni intime e sincere delle donne attraversola storia. Uaffetto si evidenzia nell'interesse dimostrato, da chi deposi-tava il bambino, per il battesimo o per segni rappresentativi del catto-licesimo, quali scapolari, immagini, catenelle, rosari. Gran parte dellenote e dei contrassegni informano le religiose e le Dame che i neonatisono depositati "cristianizzati" o "infedeli". Il battesimo era il segno, illimite tra il puro e l'impuro. Laaffetto appare costantemente tra coloro
3s AHH, Caja de Señales, Caja del año 1.895, contrasseSno non numerato.
Uggettr senzamessggioscritto
varl ioglio taeliato 7
¡icamato 2
:artone 10
mezzo cartone;toffa 15
f¡foolio cucito 2
loglio di c¿lendario 1,
totale parziale 38
personali qioiello 1
catena 6cintura 3E
ucchiaio tasliato1)tosrafia z
nezza fotoq¡afia 4
a endente 4azzoletto 3
osa di tessutootale parziale 60
rimboli moneta 3nezza moneta 3
bandiera tricolore¡occard¿ arqentinamezzo paqhe¡b
aarta da qioco taqliata 4
totale oarziale 13'elieiosi neclaelretta 40
ned, tasliata 3
osanoolarioaqinc d'¿
roc 10
mmaslnettanezza immaeinetta 27
:otate parzrare 60
lotal -191
Iotale contrassegni 506
Fonte:Archivo delHospicio deHuérfanos yExpósitos deRosario (AHH),Archivo deSeñales para elreconocimientode niños, Caias1890-1913.
162 163
che depositano i bambini. Un cartoncino ondulato, utilizzato comesegno, contiene uno scritto indicativo del dispiacere che provocava l'e-ventualitá della morte del bimbo prima di essere ritirato dall'Ospizio:
Io, la madre del bimbo, sono molto povera. Per questo motivomi vedo obbligata a mettere mio figlio sotto la protezione dellacaritá di Dio. Spero di lavorare finché sono in buona salute permandare qualcosa perché lo curino bene... se moririr lascerb ilcontrassegno e uno scritto perché mi facciano la caritá di ritirar-lo e spero che sará vostra bontá consegnarlo. Il mio desiderio é
che lo teniate bene, senz'altro si congeda da Voi una madredisgraziata.=6
Si potrebbe quasi affermare che il contrassegno sia stato lo spazioprivilegiato della cultura per l'espressione dei sentimenti, delle preoc-cupazioni, delle speranze femminili.
I pegni che le madri hanno lasciato sul corpo dei neonati nelmomento di decidere per la ruota dell'Ospizio permettono di osserva-re da vicino il significato di questi manufatti sociali che, in quanto pro-dotti storici, furono espressioni di esigenze sociali e di restrizioni cul-turali. Il contrassegno fu cib che emergeva di un atto fondamental-mente pubblico, che si rapportava all'ambito privato. Si tratta di unospazio in cui si esprimevano e si confrontavano interessi, principi,valori, prioritá don solo delle donne, ma anche di altre forze-chiave, inmodo particolare della famiglia, e dell'universo femminile in ciascunmomento storico. In questa prospettiva, il contrassegno appare comestoria, perb come storia codificata, vale a dire, nel quale bisogna tenerconto che vi sono argornenti dei quali le donne hanno potuto parlare,mentre per altri si é mantenuto il silenzio. In questo senso, i contrasse-gni, cosi come il recupero dei bambini, costituiscono elementi centraliper comprendere i silenzi mutevoli della cultura.
3'AHH, Caja de Señales, Caja del año 1891, señal N" 400 (N.d.T.: é stato raramente pos-sibile rendere efficacemente nella traduzione in italiano gli errori ortografici presenti neldocumento originale in spagnolo).
5.ll recupero dei bambini
Gli orfani e gli esposti, questi ultimi permanenti e temporanei, eranol'obbiettivo dell'associazione benefica e giustificavano il funziona-mento stesso dell'Ospizio. Insieme a questa istanza,l'interesse si mani-festava nella "costruziane" di famiglie mediante l'inserimento di bam-bini all'interno di coppie che non potevano assicurarsi biologicamenteuna discendenza. La possibilitá di recupero da parte della famiglianaturale era tenuta presente dalle Dame di Caritá, che sempre si preoc-cuparono di mantenere aggiornate, nel Registro preparato ad hoc, leentrate, cosi come altri dati che avrebbero potuto servire all'identifica-zione dei piccoli. La consegna di una bambina, avvenuta nel 1881,mostra la cura con la quale la societá benefica registrava i piü piccoliparticolari dei bambini depositati:
Nel pomeriggio del giorno 9 di questo mese é stata depositatanella ruota dell'Ospizio degli Orfani una bambina bianca, con iseguenti vestiti: una fascia, pannicelli, una maglia lunga, unacamicia, un vestito lungo bianco, insieme a una lettera che dicepiü o meno il seguente: 'le raccomanda molto la bambina cheviene posta in consegna delle Sorelle e la si raccomanda allabalia, non é ancora cristianizzata, le si imporrá il nome diFlorencia. Io con la presente mi dichiaro la madre di detta bam-bina e chiedo rispettosamente alla signora presidentessa che misia restituita.sT
I1 registro delle entrate dei neonati segna 58 bambini depositati conl'espressa indicazione che sarebbero stati ripresi. Questa cifra, perb,deve essere analizzata a fondo, per distinguere due periodi, trail 1.879e il 190O in base alle caratteristiche dell'esposizione, vale a dire, se sitrattava di una esposizione di carattere temporaneo o definitivo. Neiprimi dieci anni, sino al 1890, vi sono solo due casi in cui i genitoriinformarono, per mezzo dell'uso dei contrassegni, che i loro figlisarebbero stati ripresi. Nella seconda fase, iniziata a partire dal 1890, ilnumero aumenta a 56 casi, fatto che ci dice che il deposito transitoriosi era trasformato, nel momento dell'immigrazione di massa, in una
ez AHFI Caja de Correspondencia, Informe de 19.09.1881.
t64 165
strategia quotidiana. É il caso di un muratore che nel 1895 usb i favoridel padrone per sollecitare l'ammissione delle sue cinque figlie, dai treai nove arni, nell'Ospizio, accennando alla mancanza dimezzi: "Coluiche firma, operaio muratore, ha avuto la disgrazia di perdere la mogliedopo una lunga malattia, durante la quale ha consumato tutto quantopossedeva... non avendo piü risorse che il mio solo lavoro, mi é asso-lutamente impossibile badare a loro e la mia paga non basta per prov-vederle del necessario".3a lJn anno dopo, nel 1.896, le Dame di Caritáricevevano una comunicazione da parte di un uomo che, prostratodalla mancanza di lavoro, quattro anni prima aveva lasciato nell'isti-tuzione i suoi due bambini. Ora, avendo ottenuto un lavoro comepasticcere, voleva esercitare il suo diritto di recuperarli.3e
Il destino di quei 58 bambini consegnati con l'annotazione che sareb-bero stati recuperati fu diverso. Nella prima fase, dei bambini abbando-nati uno fu recuperato, l'altro mori. Dei 56 rimanenti, solo nove furonoreinseriti nella struttura familiare originaria, 31 morirono e gli altri sedi-ci furono dati in adozione. Questi dati sono significativi, perché nonsempre la concreta richiesta di recupero fu preceduta da un contrasse-gno o da uno scritto nei quali si palesasse l'intenzione di realizzare que-sto desiderio. In questi casi, il recupero si basava sulla descrizione checoloro che avevano abbandonato facevano dei vestiti che il bimbo avevaaddosso al momento di essere lasciato nella ruota o alla porta, o la men-zione del giorno e dell'ora del deposito. Nel 1891 ci fu il tentativo direcuperare una bambina abbandonata venti anni prima e nella richiestaappaiono tutti questi elementi, necessari per il recupero:
Spero che la vostra benigna bontá si degni di favorire la miaimpresa. La bambina che richiedo é nata il 23 marzo 1871. Il suonome é Victorina Teodos4 é stata consegnata lo stesso giorno incui é nata, era infedele [non battezzata N.d.T.] e portava comesegno di riconoscimento una camicia e cuffia uguale al campio-ne. In piü era awolta in una coperta di damasco di lana gialla.Un dato in piü che avevo dimenticato, la bambina fu portata via
38 AHH, Caja de Correspondencia, carta dirigida a las Damas de Caridad de Rosario,22.08.1895.
'" AHH, Caia de Correspondencia, carta dirigida a las Damas de Caridad de Rosario,18.09.1896.
di casa piü o meno alle sette di sera; capelli e occhi neri, nasoschiacciatq bocca regolare di color bianco, il giorno seguentefurono mandate due camicie, una di tela, l'altra di fustagno e inpiü una carta che non so se sia stata consegnata.ao
Una donna italiana ha scritto forse una delle lettere piü dolorose,nel descrivere le condizioni in cui si trovava nel momento di deciderel'abbandono di suo figlio Carlito, mescolando parole della sua linguanatale a quelle imparate in Argentina:
Reverenda Superiora: non mi creda madre snaturata. Non credache io non voglia la mia creatura, che amo tanto. Carlito mio,quanto soffro, tuo padre é il colpevole, che dimenticb suo figlio,io non mi meritavo questo. Per un po' di tempo non potrb,Superiora, mandarle denaro, ma per favore le chiedo, non diamio figlio a qualche ricco, io voglio che ritomi da me, é mio, solomio, e non c'é denaro del mondo che lo paghi, é il mio sangue,per lui soffro. E ho sofferto tanto. Lavorerblarb qualsiasi sa'cri-ficio per risparmiare qualcosa da mandarle il piü presto possi-bile. Mi perdoni, Superiora e dia un bacio da parte mia al mioangelo.al
Tütta questa strategia di recupero dipese, evidentemente, dallasopravvivenza deibambini; la tab. 6 permette di osservare che le mortiall'interno dell'Ospizio, che all'inizio della gestione dell'istituzionerappresentavano il 70% degli ospitati, diminuirono gradualmente nelcorso degli anni, essendo stati superati i problemi di assistenza socialeurbana ed essendo nel contempo migliorata l'assistenza medica.a2Ciononostante, e come c'é da aspettarsi, il periodo piü critico per ibambini pare sia coinciso con i primi sei mesi di vita.
La societá benefica era interessata a consolidare le famiglie permezzo della consegna di bambini in adozione, pratica che é stata atten-tamente controllata non solo dall'associazione stessa e dalle autoritá
o'AHFI Caja de Correspondenci4 carta dirigida a la Presidenta Paula F. De Gallegos,año 1891.4' AHH, Caja de Señales, Caja del año 189& señal N" 890.
"2 AI{H, Menoria y Balance de Ia Sociedad Damas de Caridad, Discorso pronunciatol'11,.12.1944.
t66 t67
anno mortosubito
tlno a 1 sino a I sino a 6 sino a 1 Piü di I senza¡ndicazione
tol aledeceduti
tota leentrat¡
1879 I 2 2 3 U l)l fla0 2 I 1 4 1i 22
IETt I I 5 2 15 26
l#2 (\ 4 I 14 17
1883 2 5 E z I lv ¿4
I ttfJ4 5 7 1 2 16 18
l6u5 1 9 3 7 24 30
1886 3 4 t6 23
1aa7 I 5 2 12 22
IEEE 4 l2 2 8 26 35
lóóv 4 4 17 4 5 50
1890 7 6 13 2 4 32 52
1891 2 4 3 5 9 l6 39 tu
1492 2 6 14 4 12 40 6\1893 2 5 c IU 4 l6 41 63
la94 z 6 5 15 r1 39 5u
t ó95 5 11 3 t2 34 71
1 896 ¡i 2 24 11 l3 59 aa
7897 5 b 14 7 10 2 46 6t1898 3 7 4 15 3 t3 46
1Í199 5 6 l3 IU ll 46 92
190U 3 3 11 20 7 t2 56 114
I otall ,1 66 86 233 87 175 675 113t)
'/o 3t 10'/, 13%, 34% 13'1" 26% r%del totale
100,/o
Tab. 6. Bambini deceduti nell'Ospizio degli Orfani e degli Esposti di Rosario, Argentinae tempo della loro permanenza (1879-1900)Fonte: Archivo del Hospicio de Huérfanos y Expósitos de Rosario (AHH), Registro deingresos de huérfanos y expósitos.
locali, ma anche dai consiglieri che collaboravano con le socie. Nellaconsegna di bambini in adozione si privilegiavano i bambini conse-gnati "senza contrassegni", vale a dire senza nessun tipo di segno chepotesse servire da identificazione. Questa condizione non era reSola-mentata per statuto, fatto che nel decennio del 1890 produsse un pro-blema difficile da risolvere per le Dame, le quali mancavano di prece-denti legali nel caso si producesse un conflitto o uno scandalo con ifamiliari che volessero recuperare i loro bambini esposti e successiva-mente dati in adozione a un'altra famiglia. Nel L896 notiamo un inte-resse particolare da parte dell'associazione per stabilire il lasso ditempo che si doveva lasciar passare per dare in adozione un bimbo chefosse stato consegnato all'Ospizio "senza contrassegni". Il consigliereDavid Peña tranquillizzó le Dame, sostenendo che si doveva conti-nuare con le pratiche consuetudinarie:
Sull'etá alla quale possono essere dati i bambini esposti nell'Asilodella societá senza nessun segno che serva a riconoscerli quando li sireclami, sostengo per Vostro mezzo che non trovo alcuna disposizioneal rispetto nel Regolamento Interno della Societá e che di conseguen-za, essa ha la piü ampia liberti a criterio del Consiglio, potendosiapplicare a ciascun caso specifico cib che meglio conviene al bambinodi cui si tratti... sarebbe al di fuori delle finalitá stesse che la ispirano,e di qualsiasi senso di economia bene intesa, resistere alla consegna dicreature senza genitori alle persone che non hanno figli e che sono ingrado di dotarli di un buon futuro, rimane al Consiglio il compito disapersi trovare nelle condizioni indicate dalla prudenza.a3
6. Adozíoni e nuoae famiglie
Uaffetto dei parenti e il desidero di reinserire i bambini nell'ambitofamiliare é evidente nei'1.42 recuperi di bambini depositati (v. tab. 7).Li Archiao de Señales, per esempio, conserva due mezzi cartoncini, fatto
)epositati Totale % sueli entratilntrati rJU ltJlJ"/o
)eceduti 675 59.70'tóq.ccorclo o contratto di 234 20.7(|q,,
balia é fussitá co¡ il ñPónáfo o,SO')t'
i uscito 6 0.50./,,
Conseenato alla balia 41 3.60q,Uonsegnato a famll¡an \42 r2.6lJ"/b l'aren fotale /¿ sul totale familiari
o)26
l33
8
3
45,80'/"18,30'/,2330%2,10%
s,60%0,70%2,t0%,2.10"1,
re
:ieni toriNonniFamilia¡i
/,iiPadrini
)nza indicazioni 27 2,4001,
Tab.7. Destinazione dei bambini e bambine depositati che sono sopravvissutinell'Ospizio degli Orfani e degli Esposti di Rosario, Argentina (1879-1900)Fonte: Archivo del Hospicio de Huérfanos y Expósitos de Rosario (AHH), Registro deingresos de huérfanos y expósitos.
o" AHF{, Caja de Correspondencia, carta del Dr. David Peña, consejero del Hospicio deRosario, 17.11,.1,896.
168 169
che ci fa supporre la richiesta da parte di chi aveva depositato il bam-bino, anche se al momento dell'abbandono non si fosse espressamen-te contemplata la possibilitá del recupero. Esaminando chi fossero ifamiliari che recuperavano il bambino, abbiamo potuto verificare l'al-ta proporzione di recuperi che avevano come protagonisti gli stessigenitori, individualmente o come coppia costituita; ciononostante, siverifica una differenza nel sesso dei postulanti, dato che il recuperorichiesto dalle madri era numericamente tre volte superiore a quellorcalizzato dai padri (v. tab. 7). Nello stesso tempo, vi furono situazioninelle quali i bambini furono recuperati e subito riportati definitiva-mente dalle madri nell'Ospizio:
29 agosto 1899. M.E. de Paul, alle due del pomeriggio fu ricevu-ta alla porta all'apparenza di alcuni giorni di vit4 non avevacontrassegno, aveva indosso un camicino, una sopraveste, duepannicelli e in piü aveva con sé alcuni indumenti nuovi e untaglio di fustagno. Fu battezzata il giorno stesso, con madrinaMagdalena V. Fu consegnata a sua madre il 16 settembre 1899 eil 23 dicembre fu di nuovo portata all'Ospizio, perché la madrel'aveva di nuovo abbandonata.a'
La tab. 7 permette anche di constatare che del totale di bambini ebambine che sopravvissero nell'Ospizio, 234 (il20,7%) furono dati inadozione, superando in gran misura il numero dei recuperi effettuatidai familiari ('1.42 casi, cioé il 12,6/o degli accolti). In base ai contrattiche si stabilivano con la famiglia adottiva, l'obbligo di quest'ultima eradi "prendersi cura, istruire, vestire, alimentare e impartire una educa-zione morale e cristiana" agli adottati. Ai dieci anni di eti i bambini ele bambine dovevano essere awiati a una professione o impiego. Sinoal 1893 coloro che adottavano erano obbligati a depositare, come dote,100 pesos nella banca locale, denaro che era consegnato al figlio adot-tivo quando raggiungeva la maggiore etá. Se egli fosse morto primadei ventun anni, la dote e gli interessi maturati rimanevano alle Damedi caritá e all'Ospizio degli Orfani e degli Esposti. A partire da|1893,
'+ AHH, Registro de Ingresos de Huérfanos y Expósitos, inscripción de un ingreso del29.08.1899.I1 nome della madrina non é segnato nell'originale, ma si tratta sempre diuna donna appartenente alla societá benefica Damas de Ca¡idad.
perb, la societá stabili che questa somma fosse consegnata direttamen-te all'Ospizio sotto forma di donazione.
I contratti di adozione assunsero forme diverse e si perfezionarononel corso del periodo studiato, soprattutto a causa della necessitá diadempiere ai requisiti formali esterni. I primi accordi che si trovano trai documenti dell'Archivio della societá benefica sono manoscritti. Eall'inizio del ventesimo secolo - cioé, in un periodo che esula dai limi-ti cronologici scelti per questo lavoro - che i contratti si fanno stampa-re, necessitá che si accompagna alla menzione sempre piü ricorrentedell'intervento del Defensor de Menores o del Giudice dei Minori dellacittá, i quali dovevano essere informati puntualmente della consegnadel bambino alla famiglia adottiva.as
Una delle pratiche religiose piü adottate dall'Ospizio fu il battesi-mo dei depositati, con la designazione come madrina di una donnaappartenente alle Dame di Caritá. Talvolta le madrine rimanevano coni neonati e li integravano nella loro famiglia.46Le adozioni rappresen-tavano la strada di ricostituzione familiare di coppie che erano priva-te biologicamente della possibilitá di assicurarsi discendenza o i cuifigli erano morti. Date le preoccupazioni inerenti alle adozioni, gli inte-ressati ad accogliere un bambino in famiglia si facevano carico, in alcu-ni casi, di assicurare la societá benefica che le loro intenzioni erano diinserire l'adottato come un componente in piü della famiglia, noncome un servitore:
Mi permetto di far presente alla Signora Presidentessa che lastessa etá della bambina fa fugare qualsiasi idea che potesse sor-gere sul fatto che la vogliamo con meschini propositi, dato chedue anni vuol dire allevarla e darle cid di cui ha bisogno senzaavere idea del beneficio che possa arrecaÍe.a7
Il controllo continuava ad essere esercitato anche dopo diversi annidall'adozione. Esso era portato avanti non solo dalle Dame, ma anchedalle autoritá giudiziarie della cittá, come accadd e nel 1907, quando la
4s AHH, Libros de Contratos y Convenios de adopción, de setiembre de 1898 a enero de191& nel quale si annotano 566 contratti." AHH, Caja de Correspondencia, carta de la madrina solicitando a la expósita Antoniaa las Damas de Caridad, Rosario, 15.06.1895.4' AHH, Caja de Correspondenci4 carta del26.12.1906.
t70 t71
societá tornb a farsi carico di una bambina che era stata data in adozio-ne sette anni prima a una famiglia che, nonostante la proibizione dilasciare la cittá, si era trasferita a Buenos Aires senza informare la so-cietá benefica.*'Le adozioni, peró, non sempre consistevano nell'incor-porare bambini e bambine come figli; alcuni di loro andarono a ingros-sare le file dei domestici, come fa supporre la richiesta di un italiano:
Avendo i genitori anziani e desiderando essi avere per compa_gnia una bambina di 10 o 11 (anni) perché si prenda cura di loro,supplico a S.S. di avere la gentilezza di concederne una di que-sta istituzione assicurando che la detta bambina sará tenuta conil maggiore riguardo e amata come una nuova figlia.o'
ueventualitá che i bambini fossero usati come manodopera si veri-fica nel caso delle richieste dei coloni, l'interesse dei quali era di adot-tare bambini di piü di cinque anni: "Cib che ci proponiamo nel pren-dere questa bambina" scrisse una coppia di italiani, stabiliti in unacolonia agricola di Yrigoyer¡ che chiese di adottare una bambinadell'Ospizio, "é di farne una persona di fiducia della famiglia e cheaiuti nei lavori domestici". I coloni si servirono dell,appoggio deldirettore della scuola italiana di Yrigoyen, che aiutb la coppia tréila srrarichiesta.5o
Ladozione coinvolgeva anche coppie nelle quali la donna avesselavorato conie nutrice o balia dei depositati; questa evenienza aumen-tava nel caso che la donna avesse perso sua figlia o suo figrio. una notainviata nel 1906 dal marito di una nutrice ci permette di ipolizzarequesta situazione:
Chiede alla Signora Presidentessa la minore di due anni che hacon sé, chiamata Carmen e in maniera definitiva. La bambina éstata data perché fosse allevata dall'ospizio degli Orfani, ed éstata allattata e curata per bene dalla mia signora ed é per questa
4'AHH, caja de Correspondencia, carta de la Presidenta de las Damas de Caridad, M.Brandt, al Juez de P¡imera Instancia de los Tribunales provinciales de Rosario, 1904.'" AHH, caja de Correspondencia" carta de Domingo de vito a las Damas de caridadde Rosario, abril de 1895.
:o AHH, Caia de Correspondencia, carta de lndamira Arricruz y Ernesto Fregugli4 dela colonia Yrigoyery a las Damas de Caridad, 28.12.1895.
cura assidua che la mia signora ed io abbiamo concepito un affet-to paterno nei confronti della menzionata creatura che posso direche perfino spezzerebbe la vita alla mia signora se bisognasserestifuirla, dato che la nostra stessa figlia che avevamo quando é
stata data questa per la sua cura e alimentazione abbiamo avutola disgrazia di perderla, perb, dato che rimaneva quesfaltra, ildolore é stato meno intenso. Siamo soli e una creatura come que-sta e con l'affetto che ha avuto fa la felicitá della casa.sl
In generale, le balie non sapevano leggere né scrivere, ma furono labase sulla quale si poggiava il funzionamento dell'Ospizio, dato chepermettevano la sopravvivenza degli esposti.s2 In cambio di un paga-mento mensile, le balie accettavano di farsi carico del bambino orfanoo abbandonato dai suoi genitori; le caratteristiche di questa cura varia-rono perb nel corso degli anni. Durante i primi dieci anni dell'attivitádell'Ospizio, le nutrici erano contrattate dalle Dame, ma allevavano ineonati a casa loro ed erano periodicamente visitate da una commis-sione di signore che controllavano lo stato fisico del bambino. Le nutri-ci dovevano anche andare da un medico, obbligo che ci mostra la dif-fusione delle idee igieniste. Intomo al 1890 si decise di contrattare nutri-ci che potessero lavorare nella sede, in qualitá di inteme o bambinaie."-
In molte occasioni le nutrici manifestarono l'interesse di tenere consé i bambini che avevano allattato durante mesi. É il caso di AnicetaSalaina, che aveva tenuto con sé durante tre anni un bimbo, poi ripre-so dalle Dame. La donna si avvalse dell'aiuto di persone che sapevanoscrivere per far sapere alle Dame che
l'essere stato il bambino con me per tutto quel tempo ed esser-mi vista obbligata a consegnarlo a questo Ospizio, solo per ese-guire gli ordini ricevuti al riguardo, non é stato soltanto perchél'ho curato nella mia qualitá di nutrice, ma anche perché gli hoprodigato tutti gli aiuti e I'assistenza che gli é stata indispensa-bile nelle varie occasioni nelle quali il suo cattivo stato di salutelo ha richiesto. Questo mio modo di operare ha provocato, perdir cosi, la formazione dei vincoli materni tra madre e figlio,
"r AHH, Caja de Correspondencia, nota de 1906.s2 AHF{, Memoria de Ia Sociedad Damas de Caridad, Rosario, 1890.53 AHFI, Caja de Correspondencia, nota de las Damas de Caridad a Miguel Grandoli yLuis Pinasco, 25.11.1893.
172 t73
sostituendo nel mio cuore l'affetto che hanno avuto per questacreatura quelli che gli hanno dato la vita, abbandonandola allaprotezione di questa pietosa Confraternita.sa
Questi sentimenti inducevano le nutrici persino a fuggire con ibambini fuori dal paese. É il caso di un giované stabilitosi in Paraguay,che nel L911 scriveva alle Dame di Caritá sostenendo di essere stato unesposto dell'Ospizio e chiedendo informazioni sulla sua identitá e ilsuo certificato di battesimo.
Ora mi é grato farvi conoscere le ragioni per farvi sapere chesono orfano e che appartenevo a questo Asilo... da quanto ebbil'uso della ragione sino all'anno 1903 abitavamo a Montevideo,Uruguay. Lá [mia madre] mi ha allevato ed educato. Non c'émai stata necessitá dei documenti di nazionalitá, perché sino adallora non si conosceva il servizio obbligatorio per la patria epertanto io non conoscevo l'importanza del certificato di batte-simo o altro documento, ero vn ragazzo, sino a quel momento.Dato che mia madre da bambina era paraguaiana, volle farmiconoscere la sua terra e la mia nonna. E di fatto ci siamo imbar-cati, arrivando in Paraguay nello stesso 1903, sino ad allora nonsapevo niente. Io pensavo che lei era la mia vera madre e che lamia bandiera era quella orientale, quando ecco che qui nel 19(Xsi dichiara la rivoluzione e mi hanno chiesto i documenti. Scrissiimmediatamente a Montevideo, richiedendo il mio certificato dibattesimo, e mi hanno risposto che questo tal attestato di nasci-ta non esisteva in nessuna parrocchia. A questo notizia ho chie-sto a mia madre come era questa cosa, che essendo io orientale[uruguaiano, N.d.T.] non esisteva il mio certificato di battesimo.Allora mi rispose.- Ahi, mio figlio, il tuo certificato di battesimo é nell'Asilo degliOrfani di Rosario, sono rimasti lá perché tu dovevi tornare láuna volta concluso il periodo di un anno, m4 dato che io ti vole-vo tanto bene, non mi é stato possibile restituirti e mi sono tra-sferita con te a Montevideo, avevi allora un anno, piü o meno.Quando mi ha detto questo, sono rimasto stupefatto perchéavevo 21 anni e pertanto non ho voluto credere, perb mentre midiceva quelle cose le cadevano le lacrime dagli occhi e ho dovu-to crederlo. Sino ad allora io firmavo semplicemente Enrique
--o AHH, Caja N" L, carta de Aniceta Salina a las Damas de Caridad.
Ferriera, perché non sapevo mai bene se era Tomás Enrique oEnrique Tomás. Perb, che fare? Tutti mi credevano orientale, e
l'etá di arruolarmi era passata... Oggi non c'é piü colei che si ésacrificata per la mia vita e la mia educazione, e pertanto sonodeciso ad affrontare qualsiasi conseguenza, contento di aver fattoil mio dovere sino all'ultimo giorno della sua vita. Siamo semprevissuti da soli, mi manteneva e mi educava a costo del sudore,lavando e stirandg era povera perb onorata e religiosa".ss
7. Come conclusione
In questo mondo femminile e infantile si sono incrociati diversi inte-ressi: delle religiose, delle donne della societá benefica, delle madri e
dei padri e della societá come un tutto. Nell'Ospizio sono confluite lefinalitá piü diverse. r-"ipotesi di questo lavoro é che, piü della vergo-gna, sia stata la povertá o la necessitá cib che ha prodotto l'aumentodei bambini esposti, realtá che appare chiaramente tra le cause addot-te dagli attori coinvolti nelle attivitá dell'Ospizio.s6
Il disamore e l'irresponsabilitá come ipotesi generalizzabile devonoessere rifiutati alla luce delle espressioni di affetto e di angustia deigenitori che abbandonavano definitivamente i loro figli, oppure che sicongedavano da loro provvisoriamente. I bambini e le bambine eranoimportanti per le loro famiglie, nonostante fossero oggetti dell'abban-dono. Tra le donne straniere questo problema era piü acuto, dato che icontrassegni pongono in luce la mancanza di protezione, soprattuttoeconomica, nella quale si trovavano alcune di loro quando, in una cittásconosciuta, erano abbandonate dai loro compagni o dai loro direttifamiliari. Questa impotenza si riferisce a condizionamenti materialipiuttosto che all'idea di un onore macchiato, che sarebbe superiore allaforza della donna di affrontare la maternitá. Per tale ragione questolavoro ha cercato di collegare l'immigrazione europea, soprattutto ita-liana, dato che gli italiani arrivarono a rappresentare sino al757o dellapopolazione infantile accolta nell'Ospizio. Abbiamo collegato questi
55 AHH, Caja de Correspondencia, carta de Enrique Tomás Ferreira, 01.10.1911.
"ó AHH, Caja de Señaleq Caja del año 1891, señal N" 387; Caja del año 1892 señal N"812; Caja del año 1899, señal N" 938.
t74 175
temi anche al controllo dell'abbandono dell'infanzia in una cittá por-tuale dell'Argentina, Rosario, durante gli ultimi decenni del secoloXIX, vale a dire, nel periodo durante il quale si verificb l'esplosionemigratoria nel paese.
In quello che definisco "il lungo cammino" della cultura e dell'i-dentitá nella costruzione dello Stato nazionale nell'Argentina ottocen-tesca, lo scopo di questo articolo é stato quello di presentare praticheche indubbiamente furono simili su entrambi i lati dell'Atlantico, in undialogo intimo, comune alla popolazione femminile. L Archiviodell'Ospizio degli Orfani e degli Esposti dá voce a soggetti che, tradi-zionalmente, non hanno voce: le madri che abbandonano i loro figli.Questa voce si fa sentire per mezzo di messaggi scritti, ma anche diimmagini, oggetti, fotografie, invitandoci a riformulare tematichequali il tipo di documentazione che siamo soliti utilizzare nelle nostreprospettive storiche. Di fronte al mondo delle prescrizioni morali e isti-tuzionali, la percezione e i sentimenti delle persone che hanno abban-donato la loro prole nell'Ospizio appaiono riflessi nelle lettere consul-tate, nel simbolismo dell'iconografia. La famiglia, l'infanzia, l'immi-grazione, la costruzione dello Stato si sono nutriti di molteplici espe-rienze, individuali, ma anche culturali. Mettere in scena un universoesclusivamente femminile che si muove dietro la facciata dell'Ospizioci permette di far giocare tra loro concetti quali il genere, la classesociale, lo spazio pubblico, la condizione femminile, le identitá etnichee le costruzioni culturali.
D'altra parte, ripensare al funzionamento di organizzazioni carita-tevoli come la Sociedad Damas de Caridad, nel caso dell'Argentin4 ciporta direttamente allo studio della costruzione dello Stato nazionale.Come ha giustamente notato Donna Guy in un recente articolo, nelquale reinterpreta i difficili rapporti che hanno legato Eva Perón allaSociedad de Beneficiencia de Buenos Aires, la formazione dello Statomoderno del benessere ha dovuto sconfiggere la potente caritá nazio-nale, mentre le donne dell'élite si opponevano al sostegno degli aiutistatali stricto sensu per donne e bambini.5'Nei decenni precedenti allachiusura della Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires e al suo assorbi-mento da parte della Dirección Nacional de Asistencia Socinl il13 ottobre
'52 Donna J. Guy, "La verdadera historia de la Sociedad de Beneficencia," in BarbaraPotthast y Eugenia Scarzanella, comps., Mujeres y nnciones en AtnéricnLatina, Problemns de
1948,|a formazione dello Stato oligarchico si servi dell'opera di donnedell'élite che, avvallate dalla struttura statale, concentrarono il control-lo degli orfani e degli esposti in diverse cittá del paese.
La prospettiva di genere, dunque, non solo non pub essere assentein un'analisi dello Stato, ma anche taglia trasversalmente la stessa for-mazione dell'organiz zazione sociale e politica. Dobbiamo rivendicareil legame della storia della famiglia, che sembrerebbe concernere lospazio privato, con altri temi di maggiore prestigio, come gli effettidell'immigrazione, nelle rappresentazioni identitarie cosi come nellacostruzione dello Stato. In questo senso, ritengo che si debba collegareil genere con la costruzione del potere burocratico, basato su di unastrutfura legale razionale, catatterizzato da norme impersonali, da unacodificazione tendenzialmente universalizzantess e dalla definizionedell'autoritá alla quale si attribuiscono funzioni di gestione.
inclusióny exclusíón,Yewueú, Madrid-Frankfurt, Bibliotheca Iberoamericana, 2001,,253-270.-* Ho analizzato questi aspetti in Gab¡iela Dalla-Corte, "La legitimación de la ley discr!minatoria: las representaciones de la familia en el derec-ho laboral argentino," in ReoistaEstudos lbero-Americanos, vol. XXIV N" 2, Pontifícia Unive¡sidade Católica do RioG¡ande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciéncias Humanas, Curso de Pós-Graduagáo emHistória, L998, 11T142. Vedi anche Gabriela Dalla-Corte, "Un espacio judicial para elDerecho Natural: Doctrinas y Sentencias en el contexto de formación del Estado," inÉlida Sonzogni y Gabriela Dalla-Corte comps., lntelectuales rosarinos entre dos siglos:Serafín, Clunente y luan Alaarez. ldentidad local y esfera públicn, Rosano, Manuel SuárezEditor, 2000.
176 177