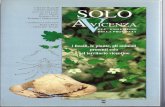(with Paola Benincà, Guglielmo Cinque, Elisabetta Fava and Paolo Piva) 101 modi per richiedere
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of (with Paola Benincà, Guglielmo Cinque, Elisabetta Fava and Paolo Piva) 101 modi per richiedere
PAOLA BENINCÀ
GUGLIELMO CINQUE
ELISABETTA FAVA
PAOLO LEONARD'
PAOLO PIVA (Padova)
101 modi per richiedere
1. ATTI LINGUISTICI INDIRETTI ( ALI )
Come possiamo distinguere che tipo di atto, oltre a quello di proferire certeparole, compie chi ci parla, nel dirci qualcosa: ci fa una richiesta, una do-manda o una proposta, oppure ci dà un consiglio, un avvertimento o unordine? Austin (1962), che chiama tutti questi atti atti illocutivi ', dedicauna cura particolare agli indicatori di forza (force-showing derices) che con-sentono di determinare che tipo di atto illocutivo compie, di volta in volta,il parlante (e). Egli ne indica diversi: modo, tono, intonazione, enfasi, avver-bi e locuzioni avverbiali, particelle connettive, gesti che accompagnano ilproferimento, circostanze del proferimento, oltre alle famose liste di verbiillocutivi che chiudono How to do things with words. Altri hanno propostonuove e più elaborate classificazioni degli indicatori di forza, ordinandolidai più ai meno significativi (Searle 1972), o hanno cercato dí superare ledifficoltà austiniane circa l'esistenza di una forma grammaticale propria del-le allocuzioni esplicite (Vendler 1972).
Ma tutti questi indicatori di forza non agiscono sempre solidalmente.Soprattutto dopo il lavoro di Grice sulla logica conversazionale (1968), s'èdimostrato molto interesse per i frequentissimi casi in cui c'è discrepanzafra gli indicatori di forza propriamente linguistici e le circostanze del pro-ferimento: un'asserzione come Non riesco a leggere che ore sono in certicasi funziona come richiesta, o una domanda come Telefoni a Giorgio?,allo stesso modo, funziona in molti casi come richiesta' (casi, evidente-
l Naturalmente questi enunciati possono, in altre circostanze essere usati per fareun'asserzione (Non riesco a leggere che ore sono, detto in risposta), o una domanda (Tele-foni a Giorgio 7 , detto a qualcuno che sia telefonando, ma non sappiamo i chi t. Questiusi, però, sono distinti da un'intonazione del tutto diversa.
/ informazione
verbale—'/ giudizio
consiglio'N. consenso
ecc.
LAVORO/(AZIONE FISICA)
NON
AZIONE
DI I DA SOLO=
DI I IN C
,ROPofferta
di P
azione (sempreverbale) peraltra azione
502 P. BENINCÀ E ALTRI
mente, diversi da quelli in cui non è chiaro, o non lo è del tutto, che tipodi atto P abbia compiuto, diversi cioè dalle illocuzioni implicite di Austin).
Perché quella che linguisticamente è un'asserzione, con -testualmente diventa una richiesta? Chi vuol sapere che ore sono,non può forse chiederlo direttamente, dicendo Dimmi che ore sono, perfavore? Può farlo, certo; ma può anche chiederlo indirettamente. Per questosiamo costretti a distinguere gli atti linguistici (AL) in atti linguistici diretti(ALD) e indiretti (ALI) 2 . Fatta questa distinzione, però, bisogna chiedersise c'è qualche relazione fra un ALI e un ALD della stessa forza. Non possia-mo, infatti, compiere un ALI usando un'espressione qualsivoglia: anche conla massima fiducia nell'acutezza dei nostri interlocutori (I), non troviamoun contesto in cui poter chiedere l'ora dicendo Ho appena visto che ore sono.
Noi intendiamo, appunto, affrontare il problema delle relazioni che in-tercorrono fra un ALT e un ALD della stessa forza.
1.1. Qui ci occuperemo, quasi esclusivamente, di ALI logicamente legatialle condizioni per compiere un ALD della stessa forza. In particolare, cioccuperemo di ALI richiestivi ', e specificamente delle richieste d'azione'.
' Austin distingue gli AL in ' locutivi illocutivi ' e ' perlocutivi'. Noi. comunque,prendiamo qui in esame propriamente solo gli illocutivi.
Proponiamo di ordinare secondo lo schema seguente tutte h: richiesti . possibili:
VERBALE
RICHIESTE DI
101 MODI PER eicinEncer. so'
Questo non è, però, certo l'unico tipo logico di ALI. Ne distinguiamo, inuna prima classificazione ancora assai rozza, almeno tre tipi:
ALI riconducibili, in qualche modo, alle condizioni di un ALI) dellastessa forza illocutiva;
ALI che consistono nella trasmissione di una delle condizioni del-l'AL. letteralmente trasmesso, o nella trasmissione di una delle presupposizioni del suo contenuto proposizionale, quando queste sono per I inatteseo dubbie;
(iii) ALT realizzati in quanto implicati dallo scopo dell'AL letteralmen-te trasmesso.
in tutti e tre i casi P compie contemporaneamente due atti: uno let-terale, la cui forza è stabilita in base agli indicatori di forza linguistici; unoindiretto, la cui forza è stabilita tenendo conto dell'AL letterale e del contestoin cui questo viene proferito'. Ma, mentre nei casi (i) p non compie propria.mente l 'AL letterale, compie cioè solo l'ALI, negli altri casi egli compie con-temporaneamente un ALI), che corrisponde all'AL letterale, e un ALI. Nondiamo subito esempi del tipo (i). perché di questo tipo ci occuperemo riòavanti.
Esempi del tipo (ii). Vieni a cena con me? detto, come invito, da unragazzo a una ragazza, per farle capire che gradisce stare con lei (condizionedell'AL letterale che può essere inattesa o dubbia). Oppure: Vai a salutarepapà! detto dalla madre casalinga al figlio, per informarlo che il padre èarrivato (presupposizione del contenuto proposizionale dell'AL letterale chepuò essere inattesa o dubbia). Analogamente, si può fare una richiesta percomunicare che non si ritiene che i la conosca; si può dare un consiglioper mostrare che si sono presi in esame i problemi di I; ci si può prendereun impegno per mostrare che si è in grado di soddisfarlo. Così, anche sequesta è evidentemente una nostra fantasia, nell'esercito, un ufficiale puòdare un ordine semplicemente per affermare, e rafforzare, la propria autorH.Anche un ministro che dice Stia tranquillo a chi gli ha appena chiesto unfinanziamento. per comunicargli che s'impegna a farglielo avere, compie nnALI di tipo (ii): egli è persona che può tranquillizzare il suo t, solo se siprende l'impegno, ma è questo ciò che il suo I non sa o di cui non è sicuro.
permesso
invito
di I impegno
Abbiamo segnato ín maiuscoletto i nodi che c'interessano e con doppia linea i legami che
li uniscono. Lo schema viene proposto solo come spunto, per distinguere ciò che c'inters,da ciò che non c'interessa: comporta però che ogni nodo e ogni percorso corrispond.m.:a delle distinzioni linguisticamente rilevabili.
All'invito ci si arriva seguendo due percorsi perché, crediamo, l'invito p/tòconsiderato un'azione coordinata di P e I.
' Si vedrà più avanti, però, che in certi ALI esistono già nell'AL letterale dell. , ro degli indicatori di forza dell'ALI.
504 P. RENINCÀ E ALTRI
Esempi del tipo (iii). Questo tipo si suddivide in due sottotipi. Il primosottotipo è quello in cui all'obiettivo standard dell'AL letterale si sostituisceuno dei suoi seguiti, e modificando così quella che è la ragione per compierel'AL (Cohen 1973) se ne modifica la forza. Cosa che accade quando si fauna richiesta per misurare la disponibilità di i nei nostri confronti, anzichéper ottenere qualcosa; o quando ci si prende un impegno per indurrei aprendersene, a sua volta, uno. Ad esempio, qualche volta, dicendo Io faccioi letti sollecitiamo I a risponderci con Io spolvero.
Il secondo sottotipo è quello in cui qualcosa è implicato dall'obiettivoperlocutivo dell'AL letterale. Così, dicendo Fuori fa un gran freddo stasera!,comunichiamo che non è consigliabile uscire stasera. Oppure, dicendo Hannorapito Sossi!, si comunica che lo Stato viene attaccato e si sollecitano i cit-tadini a difenderlo. Oppure, La Malfa, dicendo alla televisione Il paese versain gravi condizioni economiche, ci invita a produrre di più e a consumaredi meno (oltre ad allarmarci, primo sottotipo). Questo è un caso assai im-portante per la manipolazione linguistica: se è vero che gli impegni e leinformazioni sono AL, tanto più lo sono l'atto del raggiro e quello dellamanipolazione.
In generale tutte le valutazioni, in quanto sollecitano un comporta-mento sociale standard, appartengono a questo sottotipo: l'AL letteraleverdittivo ' assume così una forza esercitivo-imperativa.
1..2. Anche se esistono altri tipi di ALI, noi siamo interessati, come abbia-mo detto, quasi esclusivamente agli ALI ' richiestivi ' d'azione del tipo (i),sul quale esiste già una certa letteratura (Gordon - Lakoff 1971; I leringer1971; Green 1973; Gole 1973; Searle 1973; Sadock 1970, 1972, 1974).Dobbiamo, quindi ritornare alle condizioni di felicità di un ALI) richiestivod'azione, che riportiamo nella Tavola 1.
L'insieme di condizioni va spiegato. Innanzitutto, abbiamo usato nellacondizione (5) accetti, e non voglia, perché i può accettare di fare qual-cosa, anche controvoglia; ad esempio, può accettare di portar fuori la spaz-zatura. Nella condizione (6) e nella (7) diamo le alternative accetti onon abbia motivi per non e vuole o ha un motivo perché: si può rifiutaredi far qualcosa, e si può richiedere di farla, assumendosene tutta la respon-sabilità, senza dare motivi obiettivi per il rifiuto e per la richiesta; oppuresi possono fornire dei motivi, diminuendo la propria responsabilità nel ri-fiuto e nella richiesta. Si può chiudere una finestra dicendo Vorrei che chiu-dessi la finestra, o anche C'è corrente. Questo fatto ha una certa impor-tanza nello sviluppo del nostro discorso.
L'insieme delle condizioni è dato, inoltre, in una successione logica-
101 MODI PER RICHIEDERE
Tavola 1. Condizioni di felicità dell'atto illocutivo di richiesta d'azione
( non può (o non vuole) fare A
t fare A
i non ha già fatto e non sta facendo At possa fare A (cioè non abbia impedimenti esterni
i non abbia deciso di fare e non farà A indirei,dentemente dalla richiesta
t accetti e non abbia motivi per non fare Amotivo perché : faccia A
= parlante; = interlocutore; A = un contenuto proposizionale qualsiasi
a = condizioni basate su P; b = condizioni basate su t
mente ordinata. In Searle (1969) e in altri 1e condizioni per l'atto del ri•chiedere sono date in forma di lista: non è messa in evidenza alcuna in-terconnessione tra la condizione del contenuto proposizionale e, diciamo,quelle preparatorie o quella di sincerità. Nel nostro schema, invece, le con-dizioni (che in una teoria linguistica vanno considerate come un tipo dipresupposizione: Lakoff 1970, 1971; Cinque 1974) sono ordinate gerarchi-camente. Le più basse presuppongono tutte quelle clic le precedono in alto.All'ordinamento presentato nella Tavola 1 si può arrivare per due vie: unaè quella intuitiva del buon senso: si costruisce una formula richiestivi; si
osserva se questa soddisfa una delle condizioni, diciamo, quella che i possa
fare A e si vede se per potersi porre tale domanda è necessario che qualchealtra condizione sia soddisfatta preliminarmente; ad esempio, che 1 sappia
fare A. È ovvio che i deve saper guidare prima di poterlo fare indeterminate circostanze che glielo permettono di fatto. Diciamo quindi cheche i sappia fare A è presupposto dal fatto che i possa fare A. Nel nostroschema la condizione (4) segue la (2) per rendere conto appunto di tale
relazione presuppositiva fra le due.La seconda via per arrivare a un ordinamento delle condizioni della
richiesta è data da un fenomeno puramente linguistico che qui chiamiamotest della sospensione di presupposizioni. Le due vie portano o dovrebberoportare alle stesse conclusioni.
Qualsiasi presupposizione, legata a una parola o a un costrutto gram-maticale o altro, può essere s o s p:e s a. Possiamo sempre, cioè. scrollarci
P ritiene che
P ritiene cheP ritiene cheP ritiene che
sia capace dii Isappia
P ritiene cheP vuole o ha un
50', P. BENING\ E ALTRI
di dosso un'affermazione che è presupposta da qualcos'altro che diciamo, senon siamo o non vogliamo mostrarci sicuri della sua verità.
Se dico:
Giorgio ha smesso di fumare,
mostro di credere che Giorgio prima fumasse: cioè lo p r e s u p p o n g o.Ma posso anche dire:
Giorgio ha smesso di fumare, se ha mai fumato in vita sua,
dove tale presupposizione è sospesa.Cioè facendo seguire a una proposizione R che presuppone un'altra
proposizione s il contenuto s in una frase introdotta da se, sospendiamo talepresupposizione: mostriamo di non abbracciarla più o di non sentirci puntoimpegnati a sostenerla.
Ora, • osserviamo che le formule dirette di richiesta possono essere se-guite da una di queste sospensioni, nel caso che non sia chiaro a P se unadelle condizioni .basate su i sia soddisfatta. Ad esempio:
(3) Traducimi questa lettera, se sei capacese puoise non ti dispiacese non l'hai già fatto
Ciò è possibile perché ad essere sospesa è una presupposizione generaledell'atto illocutivo della frase; cioè del verbo performativo implicito chela domina. Con ciò riconduciamo questi casi, chiamati da Heringer (1971)illocutionary-act-qualifying if-clause, alle semplici sospensioni di presupposi-zioni di parole.
Ma si osserva che tali sospensioni avvengono anche con gli ALI basatisu una qualche condizione dell'atto del richiedere. Le restrizioni di co-occor-renza tra la formula indiretta e la formula di sospensione, a sua volta basatasu qualche condizione, sono numerose. E sono proprio tali restrizioni adarci un test esplicito per capire quale condizione presupponga quale altracondizione. Si veda:
(a) Si può dire Stai facendo la brava ragazza, se lo sai fare?, ma nonSai fare la brava ragazza, se lo stai facendo? (condizioni (2) e (3));
(h) Si può dire Puoi portare fuori la spazzatura, se non l'hai già fatto?,ma non Hai già portato fuori la spazzatura, se puoi farlo? (condizioni (3)e (4));
101 reont PER RICIIIEDEPI.
Si può dire Vai in banca, se puoi?, ma non Puoi andare in banca.se ci vai? (condizioni (4) e (5));
Si può dire Vuoi uscire, se non hai già deciso di farle? ma nonNon ha,' già deciso di uscire, se vuoi? (condizioni (5) e (16));
Si può dire Sai preparare il té, se puoi? ma non Puoi fare ilse lo sai preparare?' (condizioni (2) e (4)). E così via.
C'è una limitazione alla generalità di questo test. Non tutte le combi-nazioni di condizioni sono possibili nelle formule di sospensione: ad esem-pio non quelle basate su P. Si veda:
Puoi portare fuori la spazzatura, se non posso? (condizioni (4) e (1)).La frase dell'esempio (f) può essere recuperata come vera frase ipo-
tetica, in cui la protasi e l'apodosi sono legate da una connessione causale.ma non sono possibili nell'interpretazione sospensiva ' data alla frase colse, che abbiamo visto prima. Ciò è dovuto al fatto che P non può sospen-dere una presupposizione basata su di sé; non può cioè mostrare di nonsapere se è soddisfatta o no. Per l'ordinamento di tali condizioni, basatesu P, rispetto alle altre, il test della sospensione deve quindi essere inte-grato con la via intuitiva.
A voler rovesciare il nostro modo di procedere, potremmo usare In
sola via intuitiva per determinare la gerarchia presuppositiva delle variecondizioni, e potremmo spiegare l'agrammaticalità delle frasi succitate attra-verso questo ordinamento intuitivo, correlandolo alla nozione di ' sospen-sione di presupposizioni ' richiesta indipendentemente.
Molti ALI richiestivi in effetti consistono, come deve risultare già evi-dente dagli esempi (a)-(e) che abbiamo appena proposto, nell'asserire unadelle condizioni basate su P o nell'interrogare una delle condizioni basatesu t. Possiamo, insomma, chiedere a qualcuno di venirci a prendere dicendoVorrei che mi venissi a prendere o Puoi venirmi a prendere? Nessuna diqueste è direttamente una richiesta, ma ciascuna, almeno in alcuni conte-sti, funziona come richiesta (esempi di richieste indirette legate a ciascunadelle condizioni sono riportati nella Tavola 2). In questo senso diciamo chesi tratta di ALT richiestivi del tipo (i).
1.3. Diverse di queste forme, anzi più o meno tutte quelle che abbiamoindicato (comprese le frasi accettabili de gli esempi (a)-(e) eliminando la so-spensione di condizione), sono convenzionali (c), cioè sono immediatamentericonoscibili come richieste per qualunque t in qualunque contesto, e l'osa
5 Questo enunciato può essere usato assertivamente, senza nessuna rclazion-con l'atto del richiedere. e significa qualcosa come « Ti penne t to di far.. il h: . I.,sai fare ».
508 P. BENINCA E ALTRI
Tavola 2. Esempi di richieste indirette realizzate asserendo o interrogandocondizioni dell'atto del richiedere
(1) a. Non posso andare al telefono.Non voglio andare io ad aprirgli.Non riesco a leggere che ore sono.
(2) a. Mi pare che tu sappia tradurre bene dal russo.1). Sei capace di riparare il televisore?c. Sapresti guidare questo trattore?
(3) a. Credo che tu non abbia ancora portato fuori la spazzatura.h. Non sei ancora andata a trovarla?C. Mi pare che tu non stia studiando.d. Stai facendo la brava ragazza? (una mamma al telefono)
(4) a. Mi pare che ci puoi andare tu al mio posto.b. Potresti uscire un attimo?
(5) a. Non avevi deciso di uscire?h. Credo che non mi porterai un bicchiere di vino.c. Mi passi il sale?
(6) a. Penso che non ti dispiacerebbe lasciarci soli.Vuoi portarmi un bicchiere di vino?Ti dispiace sederti più in là?Perché non porti fuori la spazzatura?Perché non vai a trovarla?
f. Non c'è nessuna ragione perché in non vada a prenderle.
(71 a. Vorrei che non ti comportassi così.h. Spero che tu lo rada a trovare presto.e. Dovresti andare a trovarlo.(I. l lo bisogno di tre viti.e. Luigi ti ha cercato per telefono,
richiestivo di tali forme può essere riconosciuto anche quando non sia datoo non sia compreso il contesto (anche perché in questi casi esistono spessodei ' relitti ' richiestivi nell'AL letterale usato per fare la richiesta indiretta.in particolare l'intonazione discendente nelle forme interrogative, la possi-bilità d'inserire per favore all'interno della frase in posizione centrale, e,in certi casi, l'uso del condizionale). Fra le più altamente c possiamo indi-care le forme con Sai ...?, Puoi ...?, Ti dispiace ...?, Vuoi ...?, Vorrei ...?,o l'uso della semplice forma interrogativa. Forme, evidentemente legate allecondizioni dell'ALT) richiestivo elencate nella Tavola 1.
Esistono, però, anche forme meno convenzionali, che chiameremo semi-convenzionali (sc), come Dov'è il sale?, Vedi il sale?, Non trovo il sale,Hai tu il sale? Queste forme, tutte legate al particolare tipo di richiesta
101 MODI PER Riem P.M.RE
che P avanza, si richiamano, in qualche misura, alle condizioni dell'ALT)richiestivo: se non sappiamo dov'è il sale, non possiamo servircene da soli(condizione (1)); se i vede il sale, sa, per così dire, passarcelo, ecc. Questeforme, dunque, sembrano essere sc, piuttosto che c, in quanto, a differenzadelle C, esigono che T sappia quale A P richiede, ed inoltre necessitano dialmeno un passaggio in più per essere collegate alle condizioni dell'ALnrichiestivo. Anche la forma C'è bisogno ... ci sembra sc, perché pur nonesigendo che T sappia quale A P richiede, esigono che t capisca che il biso-gno è fatto presente proprio a lui, anche se attraverso una formula allocu-tivamente impersonale. (Negli sc, come nei c, si trovano a volteletterale dei relitti indicatori di forza richiestiva.)
Esistono, infine, anche forme che chiameremo non convenzionali (Nc).In particolari contesti si può sollecitare l'apertura di una finestra dicendoChe caldo!; oppure possiamo chiedere a qualcuno un prestito dicendo Domani devo pagare la rata della macchina. La necessità di conoscere il con-testo rende queste forme NC. Nel secondo esempio, infatti, i, deve sapereche noi non abbiamo i quattrini per pagare la rata della macchina, o devepoterlo supporre; inoltre deve considerarsi, sfortunatamente, persona allaquale noi possiamo chiedere un prestito. Ma queste forme sono NC ancheperché, essendo legate alla seconda alternativa della condizione (7) (P haun motivo perché ...), è necessario che il motivo che P presenta come obiet-tivo perché i faccia una certa cosa, t lo riconosca come tale, cioè che loconsideri lui stesso un motivo per fare una certa cosa. Questo può anchenon succedere: nel caso di Che caldo! T, se teme soprattutto le correntid'aria, può non ritenere che il caldo sia un buon motivo per aprire unafinestra. (Nelle richieste indirette NC non si danno nell'AL letterale usatoper realizzarle relitti indicatori di forza richiestiva.)
Naturalmente si tratta sempre di maggiore o minore convenzionalità.Le forme c possono, talvolta, risultare equivoche, possono, per esempio.essere comprese come vere domande, mentre 1e forme NC devono, almenoin contesti molto specifici o per un piccolo numero di persone, funzionare,in quei contesti e per quelle persone, come richieste. Un minimo di con-venzionalità è necessario per consentire a t di riconoscere che si tratta diuna richiesta, o perché ci sia almeno qualche possibilità che lui la ricono-sca. Diciamo che un'espressione linguistica è convenzionale quando è mutuaconoscenza fra P e i che se uno dice x allora quanto dice è da intendersiY (Schiffer 1972). Per quanto riguarda la nostra distinzione in forme richie-stive indirette c, SC e NC, tutte in qualche misura convenzionali, diremoche le forme c sono quelle che per qualsiasi r o per qualsiasi t, sulla solabase di alcuni elementi di x (relitti o indicatori di forza richiestivi presenti
nell'AL letterale), essi intendono x come richiesta. Le forme sc sono quelleper cui per qualsiasi P e per qualsiasi i, l'intero x può venir inteso incerti contesti come un Y, che essi intendono come una richiesta. Leforme NC sono quelle in cui da alcuni P e da alcuni i (il motivo per farequalcosa può non essere condiviso o non essere conosciuto da tutti), l'in-tero x può venir inteso in certi contesti come una richiesta.
2. INTEGRAZIONE DEGLI ALI NELLA TEORIA SEMANTICA GENERATELA
A questo punto è lecito domandarsi se e come è possibile integrare i fattisopra citati in una teoria esplicita del linguaggio. Preliminarmente esamine-remo le soluzioni proposte a questo riguardo nella cosiddetta semanticagenerativa '6 per vedere in che modo esse rendono conto di tali fatti e dialtri che emergeranno nel corso di questo lavoro. Gordon e Lakoff (1971),ad esempio, propongono di render conto della forza di richiesta, in certicontesti, di
Puoi passarmi il sale? (= passami il sale)Qua dentro c'è freddo (= chiudi la finestra)
per mezzo di un numero di postulati conversazionali ' che entrano in giocoa correlare una certa forma logica (quella dichiarativa di (5), ad esempio)con un'altra (quella richiestivi, sempre di (5)), se in un certo contesto laforma logica letterale ', tipica di quella frase superficiale, è ritenuta implau-sibile dall'interlocutore come significato ultimo. E analogamente se l'inter-locutore ritiene che in (4) il parlante non lo stia semplicemente interrogandosulle sue capacità motorie, allora, per dare un senso alla frase si rifarà adun postulato conversazionale del tipo:
° Col nome alquanto spurio eli 'semantica generativa ' dal 1967 in poi (una ecce-zione è un articolo del 1963 di G. LakofT, in critica alle proposte di Katz e Tkx1or, in-titolato appunto Toward generative semantics) ci si riferisce a uno sviluppo della teoriagenerativo-trasformazionale che ha abbandonato quasi tutti i postulati specifici dellateoria classica, come la si ritrova in Chomsky (1965), pur collocandosi negli stessi presup-posti epistemologici e argomentativi. Per una esposizione delle sue linee portanti, siveda Postai (1970) e Lakoff (1971). Nell'altra linea di sviluppo del modello degli Aspects,quello che va sotto il nome di teoria standard estesa ', o teoria lessicalista, il problemadi come integrare i dati sugli atti linguistici indiretti, nemmeno si pone. Questi nonvengono considerati fatti pertinenti alla 'competenza', ma dominio dell" esecuzione' equindi relegati fuori della ricerca, per ora. Questo, come altri punti di disaccordo nel-l'attribuzione di un fatto alla competenza o all'esecuzione, nelle due teorie — i perfor-mativí, la deissi, le presupposizioni, le inferenze, ecc. — fa vedere chiaramente che lasemantica generativa e la ' teoria standard estesa', più che distinguersi per il tipo <li solu-zioni clic offrono ai fatti linguistici, si distinguono per un diverso concetto di ciò che èun ' fatto linguistico ' che fa parte legittima della competenza linguistica.
(CHIEDE (a, h, PUÒ (b, o))) ---> ( RICHIEDE (a, FACCIA (ly, Q)0
basato, come s'è visto prima, su delle regolarità semantiche: la possibilitdi richiedere se sussiste una delle precondizioni per l'atto del richiedere onel dare una delle ragioni perché I faccia qualcosa. Una soluzione comequesta presuppone che tutte le formule indirette per richiedere qualcosasiano effettivamente ambigue in isolamento, e che solo il contesto possachiarire se ci troviamo di fronte a una vera domanda o asserzione oppor,a una richiesta. Ma ciò non è vero, come la Green (1973) e altri :uscortno notato. Alcune forme, come
Potresti uscire un minuto solo?Vuole per favore riscrivere il Suo nome?
sono disambiguate anche in isolamento, per ragioni intonative o sintattici,,o lessicali (presenza di per favore, del condizionale in assenza di una prop,sizione veramente ipotetica, ecc., ciò che prima abbiamo chiamato indicatoridi forza di un atto illocutivo richiestivo). Secondariamente, quello di Gordone Lakoff è un modello basato sull'interlocutore. La formulazione stessa deipostulati conversazionali contiene un trucco (indicato da un asterisco): essipossono entrare in gioco solo se l'interlocutore ha scartato, in base allaconoscenza del contesto, il significato letterale della frase. Questa direzion:rlità è altrettanto arbitraria di quella contraria, basata sul parlante. Tuttavia.ciò che disturba maggiormente (nell'un caso come nell'altro) è che si debbapassare sempre attraverso due forme logiche, quella letterale e mediatamente, quella trasmessa di richiesta, quando invece alcune formule indi-rette non hanno che l'interpretazione richiestiva 7 . Questa soluzione, cioè.non rende conto (a) del diverso grado di ' indirettezza ' di (4) rispetto a(5) e (h) del fatto che alcune formule indirette, ma non altre, hanno com-portamenti intonativi e sintattici del tutto individuali. Si osservino i se-guenti fatti:
(i) Solo alcune formule indirette di richiesta ammettono, internamen-te, prima del verbo, avverbi come per favore, per piacere, tirsilirichieste.
a. Puoi (per favore) uscire un attimo?b. Potresti (per favore) uscire un attimo?
' Questa stessa conseguenza è presente anche in Searle (1973), che tuttavia nonaccetta la necessità di ipotizzare postulati conversazionali, ma vorrebbe spiegare la presenza di una forza illocutiva indiretta solo attraverso (1) la teoria degli atti lingui<ri( ∎diretti, (2) principi conversazionali e (3) conoscenza del contesto e conoscenze del mol•(1•
condivise dal parlante e dall'interlocutore. Torneremo più avanti su questa soluzion”accettiamo solo per quegli atti illacutivi indiretti elle chiamiamo Ne. •' •
510 P. RENINCX E ALTRI101 MORI PER RIMI,
512 P. BENINCX E ALTRI
Vuoi (per favore) uscire un attimo?Vorresti (per favore) uscire un attimo?Ti dispiace (per favore) uscire un attimo?Ti dispiacerebbe (per favore) uscire un attimo?
Qua dentro c'è (*per favore) caldo.Non ha (*per favore) già portato fuori la spazzatura?
Che ne dici (*per favore) di telefonare a Marta?Non credi (*per favore) di aver parlato troppo?
(ii) Solo alcune formule indirette in forma interrogativa (tra cui tuttequelle in (9), ma non quelle in (10)) possono perdere l'intonazione interro-gativa s . Esempi:
Mi dai il sale?Hai una sigaretta?
Altre non lo ammettono:
"Sei capace di guidare?*Non è ora di andare?
(iii) Solo nel caso delle formule del tipo ricorrente in (9), si può rispon-dere non alla domanda letterale, ma alla richiesta con il sì secco proprio dellerisposte a richieste che precedono l'azione. Ciò è particolarmente evidentecon (15), dove il sì, se preso come risposta alla domanda letterale è scherzosoo dà adito a una contraddizione con la successiva azione:
f dispiace(15) Ti i
dispiacerebbe uscire? — Sì (ed esce)
Questi fatti sintattici e intonativi sembrano isolare, per l'italiano, un certonumero di formule indirette per richiedere (grosso modo quelle introdotte daPuoi, Può, Vuoi, Vorresti, Potresti, Ti dispiace, ecc.) da tutte le altre che,pure, in contesti appropriati, veicolano una richiesta. Esse infatti tolleranola presenza di certi indicatori di forza richiestivi non tollerati dalle altre.Quando, poi, sono accompagnate in superficie da tali indicatori, esse tra-smettono delle richieste e nient'altro. Noi le abbiamo chiamate formule c(convenzionali).
Sembra, perciò, controintuitivo accettare per questi casi la soluzione di
8 Si rimanda all'Appendice l per una discussione più dettagliata a riguardo e la pre-sentazione di dati sperimentali spettrografici a conferma delle affermazioni qui fatte.
101 MODI PER RICIDEDERE
513
Gordon e LakofT, che le vuole domande letterali e solo derivatamente ri
chieste °.Sadock (1972, 1974) e Cole (1973) propongono invece di derivare una
frase superficiale r, che veicola una forma logica LI, diversa da quella suatipica L2, da Li direttamente, se in superficie esistono relitti sintattici o dialtro genere di Li. Relitti di questo genere sarebbero per frasi interrogativesuperficiali il per favore richiestivo o l'intonazione richiestiva e non interro-gativa; per le interrogative retoriche del tipo chi vuoi che abbia TI. BECCO PI
UN QUATTRINO da queste parti?, la presenza di sintagmi a polarità negativ:icome quello sottolineato, che può occorrere solo in contesti negati ' -i. Vedi•
( 16) a. Non ho il becco di un quattrinoh. *110 il becco di un quattrino.
Il fatto che questo elemento a polarità negativa possa comparire anche inun contesto superficialmente positivo, è spiegabile appunto col fatto che ilsignificato ultimo trasmesso è in questi casi semanticamente negativo, comein dubito che abbia il becco di un quattrino che pure superficialmente noncontiene alcun morfema della negazione. La forma logica di chi vuoi ...infatti l'asserzione negativa Nessuno ha il becco di un quattrino (la queste
Cole cita un caso analogo per espressioni inglesi contenenti let's (cheintroduce proposte o richiestei. Casi come questi vengono avvicinati a vere eproprie forme idiomatiche o alle metafore già lessicalizzate. La propostadunque di trattare anche certe formule indirette di richiesta allo stesso modo:come formule ormai lessicalizzate o sintattizzate della lingua. Ciò non esclu-de naturalmente che anche esse abbiano avuto diacronicamente la medesimiorigine e comportamento delle formule indirette ancora non convenzionali/zatc. cioè quelle che hanno bisogno di passaggi di tipo inferenziale n.
° C'è da ricordare che Gordon e Lakolt riconoscono che l'inserzione di elementicome per favore, o altri fatti sintattici, disambiguano le formule rendendole solo dellerichieste. La soluzione che loro propongono per evitare che ciò costituisca un contro-esempio alla loro tesi è questa: l'introduzione di per favore nella derivazione di una fraseinterrogativa è possibile solo se la forma logica della frase interrogativa è collegata (attra-verso i postulati conversazionali della teoria) a un'altra forma logica di richiesta che èil signirxato ultimo trasmesso dalla frase. La forma di questa restrizione è • trasderiva-zion gle ', dato che coinvolge contemporaneamente due derivazioni (quella della fraseinterrogativa e quella che discenderebbe dalla forma logica richiestiva se questa fosseverbalizzata direttamente. Per una discussione di questo tipo di regole si veda Lakoff(1973 a). Per una critica a questa soluzione trasderivazionale si veda Sadock (1974, cap. IV).
1‘ ,-gomentazioni dello stesso tipo sono quelle che arrivano a postulare iperformativi impliciti al di sotto di frasi che non !i contengono in superficie.
Heringer (19711 — in modo diametralmente opposto a Gordon e LaUff -propone di derivare tutte le formule indirette di richiesta (siano esse asserzion!mando. ecc. n da una forma logica richiesti•a, poi trasformata attraver‹,,
35
514 P. BENINCÀ E ALTRI
Che la distinzione tra atti linguistici indiretti C e quelli NC (rispecchia-ta nella teoria dalla loro diversa derivazione sintattica) non è spuria, è te-stimoniato anche da un'osservazione della Green e di Sadock. Mentre leformule indirette di richiesta NC (quelle che rappresentano dei puri cennio allusioni) mantengono la loro forza indiretta nelle traduzioni in altrelingue, a parità di contesto, quelle altamente convenzionalizzate possono, setradotte letteralmente, anche non avere più la loro forza immediata di ri-chiesta. Ad esempio Sadock (1974, cap. 'v) riporta che in ebraico modernouna forma convenzionale di richiesta è Sei pronto a fare Q?. La sua con-venzionalità sta nel fatto che in qualunque contesto essa sia usata, vieneimmancabilmente sentita come richiesta e non come domanda letterale.È facile accorgersi che tale formula è ben lontana in italiano dal costituireuna richiesta esplicita, solo formalmente indiretta, come lo sono i variMi fai Q?, o potresti fare Q? Sei pronto a portar fuori la spazzatura?, exabrupto, non è una richiesta a i di portarla fuori: nemmeno una richiestascherzosa. Anche se gli creiamo un contesto (ad esempio: c'è un accordoche quando i porterà fuori la spazzatura è segno che in casa non ci sonoi padroni e che quindi la banda del buco, nascosta fuori, può entrare inazione), tale frase non sarà mai una richiesta tont court, ma sempre unadomanda letterale, che esige tra l'altro una risposta verbale. Ciò vuol direche mentre in ebraico la formula è convenzionalizzata, in italiano essa nonlo è. Accenni molto indiretti, invece, (C'è freddino, qui dentro — chiudila finestra, o È arrivata la posta — Vai a prenderla) in un contesto appro-priato sono traducibili e mantengono la loro forza indiretta, in ogni lingua.
Diamo ora un breve schema che riassuma le varie proposte teoricheavanzate dagli autori sopra citati:
GORDON E LAKOFF/SEARLE
L, (ti domando se
Postulati conversazione- — L2 (ti richiede dipuoi uscire)
li (Gordon-Lakoff) o in- uscireiferenze logiche basate suvari fattori tra cui quelliconversazionali (Scade)
r, Puoi uscire? F2
meno sintattiche, corrispondenti ai postulati conversazionali di Gordon e Lakoff, nelle frasisuperficiali indirette. Lo stesso tipo di critica mosso a Gordon e Lakoff si applica anchea Heringer. Per altre critiche si veda Sadock (1974, cap. m).
101 mont PER RICHIEDERE
HERINGER
L2 (Ti richiedo di uscire)•
F 1 (puoi uscire?)
SADOCK - GREEN - COLE
Alcune formule (quelle c) come T-Teringer: le altre come GordonoLakoff.
La nostra posizione a riguardo è assai vicina a quella di Sadock, dellaGreen e di Cole. In particolare abbiamo individuato le formule presentatesotto (9) e altre come Hai un x?, ecc., come quelle c in italiano, se corre-date da un indicatore di forza richiestivo. Ciò, tuttavia, non esclude che peresempio Puoi fare Q? o Hai un x? (es.: Puoi prestarmi questo libro finoa domani? e Hai un orologio?) possano essere usate come domande letteralio funzionino come richieste solo mediatamente, in quei casi dove è possi•bile perché il contenuto proposizionale o le nostre conoscenze del mondo.su ciò che si può domandare ad una persona, ad esempio, lo ammettono.Per l'incidenza del contenuto proposizionale sulla interpretabilità di una formula come un atto diretto o indiretto di richiesta, si veda 5 3.
Non è chiaro se Sadock, la Green o Cole decidano di trattare una formula, una volta stabilita come lessicalizzata, sempre come tale, op pure :unmettano la duplice possibilità, come noi.
Per le altre formule che possono trasmettere indirettamente richieste.non esistono prove grammaticali per derivarle da una forma logica di richie-sta. Ciò sembra indicare che nelle formule indirette NC, non è veicolata unaforma logica sola (quella della richiesta). ma due: quella letterale (vuoiassertiva. vuoi interrogativa, o altro) e, solo derivatamente, quella richie-stiva. Quanto al modo di ricavare quest'ultima dalla forma logica let-terale ', rigettiamo la postulazione di Gordon e Lakoff di particolari postu-lati conversazionali. Uno dei punti intuitivamente meno soddisfacenti di que-sto approccio sta nel numero teoricamente infinito di tali postulati. Gordone Lakoff, ad esempio, ne danno uno informale per t: freddo qua devtro, ch-in certi contesti. dove t capisce che non si . tratta di una semp l ice (""
516 P. BENINCÀ E ALTRI 101 mont PER RI CHIEDERE 51
zione climatica, implica Chiudi la finestra; ma è facilmente intuibile chebisognerebbe darne un numero indefinito per render conto del fatto chetale frase in contesti leggermente diversi può valere: usciamo, o apri il ter-mosifone, o passami la giacca, o ridammi la coperta, ecc.
Accettiamo piuttosto la proposta fatta da Searle (limitandola natural-mente alle sole formule indirette che non presentano traccia di indicatori diforza richiestivi), che ricava l'atto indiretto dalle condizioni generali degliatti linguistici diretti, insieme a principi conversazionali come quelli indicatida Grice, o alla conoscenza che il parlante e l'interlocutore hanno del conte-sto e del mondo. Facciamo un esempio di inferenza o deduzione tra atti lin-guistici, ricavata da Searle (1973). Una frase come Riesci a raggiungere il sale?è esemplificativa del tipo che abbiamo chiamato NC: è in base al contesto chequesta può essere o meno interpretata come richiesta di passare il sale. For-malmente non contiene alcun indicatore di forza richiestivo. Nel caso chepossa essere interpretata come richiesta, il processo di comprensione è un ri-sultato di vari fattori. In primo luogo l'interpretazione letterale della frase,come domanda di informazione; e secondariamente varie conoscenze, delcontesto e del mondo, condivise dal parlante e dall'interlocutore. Parafra-sando Searle (1973) daremo un'idea dei passaggi inferenziali che, per il no-stro esempio, possono portare dall'interpretazione letterale di richiesta diinformazione a quella derivata di richiesta d'azione:
Passaggio n. I : P mi ha fatto una domanda sulla riuscita di una mia azione futura(fatto riguardante la conversazione).
Passaggio n. 2 : Il contesto non mostra in che modo la domanda letterale possa essererilevante ai fini della comunicazione (fatto riguardante la conversazione +principio di rilevanza griceano della conversazione).
Passaggio n. 3 Se voglio continuare a ritenere il mio interlocutore sano mentalmente,devo concludere che il suo enunciato ha un altro motivo, diverso daquello di domanda letterale. (Conclusione dai passaggi I e 2.1
Passaggio n. -1 : L'informazione richiesta coincide con una delle condizioni per la buonariuscita di una richiesta di azione (quella di passargli il sale). In oltreso che la gente in un contesto come quello della tavola, in cui mi trovo,usa il sale. (Conoscenza delle regole soggiacenti agli atti linguistici +conoscenza del mondo.)
Passaggio n. 5 : Pertanto sta forse tentando di fare in modo che io gli passi il sale.(Conclusione da 3 e 4.)
Passaggio n. 6: Che un parlarne, parlando, cerchi di fare in modo che il suo interlocu-tore faccia qualcosa, costituisce la condizione essenziale per l'atto delrichiedere (Scade 1969). (Conoscenza delle regole degli atti linguistici.)
Passaggio n. 7 Pertanto P mi sta chiedendo che gli passi il sale. (Conclusione da 6 +il principio di rilevanza griceano.)
Il precedente è solo uno schema approssimativo, non formalizzato, di infe-renze necessarie per arrivare, dalla forma superficiale apparentemente veico-lante un certo atto illocutivo, all'atto illocutivo veramente trasmesso in uncerto contesto. È uno schema orientato dal punto di vista dell'interlocutore.Cioè, implicitamente, sul piano dell'esecuzione. Tuttavia, si può argomentar('che a livello di competenza un parlante-ascoltatore sa che in un certo conte-sto fare una domanda del genere conduce alla trasmissione di un diversoatto illocutivo, in base proprio alle regole della teoria degli atti linguistici,condivise da lui e l'interlocutore, ai principi condivisi della conversazione ealla conoscenza condivisa del contesto. Una volta che si giunga a formularein modo del tutto generale e automatico un calcolo di tali inferenze a partiredai principi generali cui s'è accennato sopra, potremo dire di avere a livellodi competenza quelle regole, nella nostra teoria, che governano la trasmis-sione di atti linguistici.
La nostra decisione di derivare certe formule indirette di richiesta diret-tamente da una forma logica richiestiva e di ricavare le altre dalla forma lo-gica letterale ', messa poi a rapporto con una forma logica di richiesta, cipermette di formulare una certa ipotesi sul processo di comprensione daparte di T del significato ultimo (di richiesta) trasmesso da tali formule, tantoconvenzionali che non. l,a nostra ipotesi, infatti, predice che t arrivi a com-prendere il significato richiestivo trasmesso, p r i in a nelle formule c (conrelitti indicatori della forza richiestiva o senza tali relitti), dove deve risalir('direttamente all'unica forma logica presente, quella richiestiva, che nonnelle altre, quelle NC, dove deve risalire prima al significato letterale dellafrase e solo in un secondo tempo, attraverso un certo numero di inferenze,a quello ultimo di richiesta. L'Appendice 2 darà qualche cenno a un lavorosperimentale che abbiamo condotto per controllare tale ipotesi, anche se idati che verranno offerti qui riguardano solo la memorizzazione delle for-mule ALT.
3. SELEZIONE CONTESTUALE DELLE FORMULE RICIIIESTIVE
Abbiamo detto che qualunque richiesta potrebbe venire, teoricamente, tra-smessa con un ALD, ma nella maggior parte dei casi usiamo un ALI. Perché?Una delle condizioni di felicità di Austin (1962), la A T, dice che , le personee le circostanze nel caso specifico devono essere appropriate per richiamarsialla procedura cui ci si richiama »: quindi potrebbe venir preferito un ALT
a un ALD nei casi in cui P non è, o non vuol mostrarsi, sicuro che le circo-stanze, compreso il particolare T che ha di fronte, siano quelle adatte perfare la richiesta. Questo risulta soprattutto chiaro per gli ALI Ne, (fa ea!d,,qui = aprile la finestra), che dovrebbero venire usati specialmente
518 P. RENINCÀ E ALTRT 101 MODI PPR rtcturnErtr. crì
P è imbarazzato nel fare la richiesta, e vuole quindi lasciare a t, oltre al com-pito di riconoscere l'AIA come richiesta, di esplicitare questo fatto e di sod-disfare la richiesta stessa con la massima libertà possibile, quasi spontanea-mente. Una richiesta indiretta NC lascia quindi di fatto aperta l'alternativa aP di fingere di non aver avuto l'intenzione di fare una richiesta, e a i di noncomprenderla effettivamente come tale.
Se tutto questo è abbastanza ovvio per un ALT NC, è anche vero che perfare una qualunque richiesta preferiamo normalmente usare un ALI (sia essoc o NC) anche quando l'incertezza di noi in quanto P, sul nostro t e sull'op-portunità della nostra richiesta è praticamente inesistente. Inoltre nelle richie-ste di quelli che Goffman chiama free goods", la via d'uscita di cui dice-vamo sopra è, sia per p che per l, puramente teorica: a Ti dispiace pas-sarmi il sale non c'è modo di rispondere Beh, preferirei di no, veramente.Con la stessa forma sintattica superficiale e la stessa intonazione, ma cam-biando l'oggetto della richiesta, la risposta diventa invece possibile: Tidispiace fare il turno in biblioteca mercoledì? - Beh, preferirei di no,veramente. La richiesta indiretta di un free good ha, rispetto alla richiestadiretta, un ' di più ' linguistico, che non riflette, per esempio, quella cheRobin Lakoff chiamava la regola del doni impose: la richiesta di un freegood (Sai l'ora?, Mi potresti passare quel libro?, L lì il sale?) è in praticauna imposizione, in quanto non ci si può rifiutare di soddisfare la richiestadi un free good senza violare gravemente le regole dell'interazione ' facciaa faccia ' (Goffman 1967). Nella richiesta indiretta di un free gond abbiamoquindi una sovrappiù linguistico che potremmo chiamare ` cortesia rituale ':questo tipo di cortesia non può essere riferita all'azione richiesta, che vienein realtà imposta, ma serve solo, come vedremo, a disambiguare il compor-tamento di P. La richiesta indiretta di un'azione che presenti per t una certa dif-ficoltà ha invece una forma che, come dicevamo, trasmette effettivamente ache gli si riconosce il diritto, e gli si offre la possibilità, di non soddisfarela richiesta. Sembra quindi più interessante spiegare la ` cortesia rituale ', chesembra avere ragioni più oscure rispetto alla ' cortesia sostanziale '. Analiz-zeremo dunque la richiesta secondo lo schema individuato da Goffman (1972)per gli scambi riparatori (remedial interchanges) 9:
" Goffman riunisce sotto l'etichetta di Iree goods azioni come « dare un'indicazionestradale, l'ora, un fiammifero », che costano talmente poco da rendere molto difficile unrifiuto quando siano richieste. La definizione di Goffman è molto intuitiva e forse il!ree good andrebbe definito meglio, a prescindere dal suo 'costo ' obiettivo: in Inghilterrachiedere a uno sconosciuto di smettere di fumare in un ambiente chiuso è un Per gond,
in Italia no." Il modello con cui Goffman interpreta un'ampia casistica di scambi riparatori
è un modello di origine prosscmica, che si adatta molto bene a società borghesi urbane,
Riparazione A: Puoi passarmi il vocabolario?Conforto 13: (Ecco) (o azione richiesta)Apprezzamento A: GrazieMinimizzazione Niente
Di questo schema (che, come si può vedere in Goffman 1972. può averevarianti abbreviate) ci interessa intanto la prima mossa, che sí interpretacome un'offesa virtuale per il fatto di costringere qualcuno a fare qualcosaper noi, anche solo risponderci. (Si pensi che, per iniziare uno scambio pura-mente verbale, che non sia un saluto, si usa premettere Scusi...). La richiestasarebbe quindi innanzi tutto, similmente ad altri atti linguistici, una infrazio-ne virtuale, che deve venire clisambiguata (non deve sembrare un attacco) eriparata (in quanto resta in ogni caso un'invasione) con la cortesia nellostesso momento in cui vien fatta, secondo la regola che disciplina l'access,ai rispettivi ' territori personali e ne tutela l'integrità.
Ma l'atto linguistico di richiesta si rivela più complesso in quanto, setende ad imporre a t un'azione che egli non avrebbe fatto se non richiesto.rivela d'altra parte una deficienza nell'autonomia di e nella sua capacitdi essere autosufficiente. Se la cortesia è quindi un mezzo " per disambi-guare l'attacco al territorio di i e mostrare che P è persona in grado di ap-prezzare l'azione gentile che sta richiedendo, per tutelare il territorio ' di P,cioè la stia faccia ', è necessario anche che non venga data eccessiva importanzaal bisogno che P non può e non vuole soddisfare da sé. Quindi le soglie sonodue: al di sotto di una non si può andare se non in presenza di variabilicontestuali che vedremo, altrimenti la richiesta diventa un attacco a t: andareoltre l'altra soglia diventa invece pericoloso per P e provoca uno stato didisagio nell'interazione: con un eccesso di cortesia infatti viene esagerata laportata dell'azione richiesta, mettendo in inferiorità p che diventa debitoredi i, non potendo più cavarsela con un semplice Grazie; oppure risulta im-plicitamente che t, per P, non è persona tale da essere disposta a offrire unfree good con facilità, senza dispiego di cortesia da parte di P. Se la richiestaè troppo cortese l'interazione viene inoltre disturbata perché, nel caso eh,-
la cui caratteristica si potrebbe dire sia il sovraffollamento: secondo questo modello un'in-terazione faccia a faccia ' mette in pericolo i rispettivi territori e può essere interpretatacome un'aggressione. La comunicazione orale tuttavia fa parte integrante del comporta-mento umano anche in questo modello, in quanto ha la funzione di definire il proprieterritorio e segnarne i confini quando la vicinanzi' con un altro attore diventa
" Che può essere non solo linguistico, ma anche gestuale e cinesico. ma n'al ,;occuperemo di questo as petto. Vedi per esempio in Goffman (10721sulla funzione pacificatrice del sorriso.
520 P. BENINCA. E ALTRI101 MODI PER RICHIEDERE 521
t non sia in grado di soddisfare la richiesta. la mossa successiva di r (Nonha importanza) diventa molto complessa ".
Possiamo a questo punto vedere quali variabili contestuali sono respon-sabili di diversi comportamenti linguistici nell'atto di richiesta. Tenendo pre-sente che questa analisi può essere valida solo per un ambiente borgheseurbano, e riservandoci di vedere in seguito qualche spunto per un'analisidi altri ambienti sociali, partiamo dalla definizione di Goffman di situa-zione sociale, e vediamo poi le altre variabili che modificano il rap-porto tra gli attori nella situazione sociale stessa.
Definiamo, con Goffman, una situazione sociale come l'am-biente che permette ai partecipanti il controllo reciproco, per cui un soggettoresta accessibile a tutti gli altri, e questi sono a loro volta accessibili a lui.All'interno della situazione sociale il rapporto fra i partecipanti può esseresoggetto alle seguenti variabili:
raggruppamento/incontro: si può passare dal rag-gruppamento, che è la pura partecipazione degli attori alla situazione sociale,a un incontro, che si ha quando inizia una interazione faccia a faccia; sihanno restrizioni quando la richiesta non interviene all'interno di un incon-tro già costituito, ma deve essa stessa trasformare il raggruppamento inincontro.
situazione informale/formale: la situazione socia-le può essere o no formale. Il passaggio da informale a formale deve essereconsiderato discreto. La situazione formale si sovrappone con regole propriealla situazione sociale, di cui neutralizza le regole (pranzo ufficiale, udienzapapale, conferenza, anche una lezione scolastica). Nella situazione formale,se non interviene 1' urgenza, che può essere considerata la variabilepiù forte, non si può chiedere neppure un free good. Durante una lezione sco-lastica normalmente un alunno non chiede l'ora al professore, durante la con-ferenza un uditore non chiede l'ora al conferenziere. Possono forse farlo rispet-tivamente il professore e il conferenziere, ma romperanno inevitabilmente laformalità della situazione, provocando anche alcune reazioni percepibili (chiac-chierio più diffuso, rumore di sedie, ecc.).
(c) u r g e n z a: in una situazione sociale, normale o formale, può
" Che mostrare un bisogno sia pericoloso per la ' faccia ' dell'attore si vede anchedalle regole e dalle formule dell'atto linguistico di offerta: non si possono offrire achiunque diecimila lire. L'offerta in genere deve sembrare non un favore che P vuol farea t, ma un favore che farebbe i a P accettando l'offerta. Come dice Robin Lakoff, ilbravo maggiordomo non dirà Vogliono mangiare? ma 11 pranzo è servito. Si veda ancheun'osservazione apparentemente banale di Goffman (1972, p. 66): « It is intercsting thatin micldle-class Anglo-American society it is often less incursive to ask a stranger for afree good than it is to initinte the offering of one ».
intervenire la variabile ` urgenza '. Anche in questo caso, benché si possa teo-ricamente e praticamente costruire una scala graduale di maggiore o minoreurgenza, converrà considerare il passaggio da +urgenza a --urgenzapassaggio discreto. Si ha urgenza in una situazione in cui rimandare o ri-tardare di fare x comporta conseguenze più gravi del disagio provocatotendo x.
Variabili riguardanti P e t sono:conoscenza reciproca : il fatto che l'interazione avven
ga fra sconosciuti o fra persone che si conoscono già.b) intimità: presenza o assenza di intimità fra gli attori.
simmetria o asimmetria del rispetto reci-proco: il rispetto dovuto a una persona può derivare dalla sua età (vec-chio > giovane), dal suo sesso (donna > uomo, però uomo vecchio > don-na giovane) o da gravi infermità fisiche; il rispetto può derivare dal potere.che può essere legato allo status sociale, e quindi valere in genere per tutticoloro che ne sono a conoscenza, o che lo possono riconoscere da simboliesteriori, oppure legato al ruolo che una persona ha all'interno di una strut-tura, e quindi essere rilevante solo per le persone che si trovano, stabilmenteo eccezionalmente, inserite in quella struttura. Mentre il rispetto dovuto allostatus cede normalmente di fronte al rispetto dovuto alla debolezza ' social-mente riconosciuta (età, sesso, infermità) ed anche al ruolo superordinato, ilrispetto dovuto al ruolo superordinato è il più rilevante. Quando il rispettoreciproco è asimmetrico, cioè quando, riguardo a questa variabile. P < t.molte richieste vengono bloccate, in genere quelle di azioni che rich;eclo.r,uno sforzo fisico anche molto modesto.
competenza specifica: il fatto che l'interlocutore abbiao meno una competenza specifica, derivante0i dal mestiere che esercita oda una sua particolare abilità nota, che sia pertinente all'oggetto della ri-chiesta.
(e) competenza occasionale: il fatto che l'interlocutoresi trovi nella occasionale situazione di essere la persona più adatta (o che hameno difficoltà) a soddisfare la richiesta rispetto a tutti gli altri, compres,.,il parlante.
Variabili riguardanti l'oggetto della richiesta sono:importanza che ha per r il soddisfacimento della su-
richiesta.difficoltà che avrà i a soddisfare la rich i esta di P.
(c) d i f f icolt à che avrebbe P a eseguire egli stesso l'attivita che è oggetto della richiesta.
(h) e (c) sono interdipendenti e, come si può ricavare anche dalle
ton
522 P. TIENINCÀ E ALTRI
MI. MODI PER RICHIEDERE 52:/
ni di felicità dell'atto linguistico di richiesta, la condizione preliminare perchési possa avere una richiesta, è che (b) < (c), cioè che il parlante possa perlo-meno far credere a t che la difficoltà a eseguire l'attività oggetto della ri-chiesta sarebbe maggiore per sé stesso che non per t.
Alcune delle variabili che abbiamo visto intervengono a modificare lasoglia di richiedibili t à, cioè bloccano o danno via libera adeterminate richieste, ovvero restringono o ampliano l'inventario di quelloche si può richiedere in una situazione data. Dall'esistenza di una soglia dirichiedibilità in una data situazione deriva un'altra variabile connessa all'og-getto della richiesta, cioè la sua maggiore prossimità alla soglia: chiamiamoquesta variabile livello di richiedibilità: esso sarà tanto piùalto quanto più lontano dalla soglia.
Alcune delle variabili che abbiamo visto alzano la soglia di richiedibi-lità, e quindi causano un aumento di cortesia nella formula di richiesta. Lasituazione formale come l'abbiamo definita sopra blocca immancabilmente qua-lunque tipo di richiesta, se non interviene l'urgenza.
Per quanto riguarda l'asimmetria del rispetto reciproco, in cui sia P <
le sottovariabili che producono il rispetto, e la misura in cui pesa il rispettoprodotto da queste sottovariabili, variano molto da ambiente a ambiente,da cultura a cultura. Nella cultura occidentale sembra che il più forte restiil rispetto dovuto al potere, e più precisamente a chi ha qualche potere sudi noi, cioè a chi ha un ruolo superordinato. Quindi, quando non inter-vengano variabili come l'intimità o l'urgenza, il fatto che P < i, perché i haun ruolo superordinato rispetto a P, blocca gran parte delle richieste chenon concernano strettamente il rapporto ufficiale fra e I. Anche la richiestadi un free good (lo studente che chiede un fiammifero o l'ora al suo pro-fessore) viene fatta dando i motivi per cui si fa la richiesta: Avrebbe perfavore un fiammifero, professore? Sono rimasto senza; Scusi professore, sal'ora per favore? Mi si è fermato l'orologio. L'asimmetria dei rispetto puòessere però obiettivamente presente, ma non rilevante, in una situazionesociale caratterizzata da un'attività comune, che crei al suo interno nuoviruoli o precise competenze degli attori per i compiti relativi all'attività co-mune: questo può accadere per esempio in una cordata, ma anche in unpranzo aziendale. Si potrebbe vedere in questi casi una ridistribuzionedelle competenze (vedi più avanti) degli attori: in un pranzo azien-dale il direttore diventa un commensale, con un ruolo e delle competenze re-lative al buon andamento del pranzo esattamente uguali a quelle di tutti glialtri. L'asimmetria dello status viene cancellata ancor più facilmente: il pre-sidente della repubblica è in completa balia del suo dentista che gli chiededi aprire la bocca probabilmente con la formula diretta.
Il fatto che manchi la conoscenza reciproca, cioè che il nostro t siauno sconosciuto, di cui riconosciamo eventualmente solo qualche simbolo distatus, oltre al sesso e all'età, provocherà un'ulteriore restrizione oltre a quella dovuta all'eventuale asimmetria del rispetto reciproco, permettendo s-1la richiesta di free goods, con formule puramente rituali.
Una richiesta istituisce immediatamente, all'interno di un raggruppa-mento, un incontro, o trasforma il raggruppamento in incontro. Se la situa-zione sociale come l'abbiamo definita diventa critica, e i soggetti si trovanoal limite del controllo reciproco (in un ambiente molto ampio, o con moltorumore, ecc.) ugualmente, pur alzandosi la soglia di richiedibilità, cioè 13111
restringendosi l'inventario delle cose richiedibili, la formula di richiesta èchissimo elaborata, per motivi di chiarezza e di percepibilità del tues,atio:Romeo, la porta!; Signore. la porta per fa•ore.'; Wanda, il telefono'.
Se la nostra richiesta è rivolta a un T che è impegnato in una conversa-zione, o se per farsi accendere una sigaretta P è costretto a interrompere laconversazione a cui sta partecipando, userà ugualmente formule brevissime.o soltanto gesti, per evitare che lo scambio che è intervenuto disturbi l'inte-razione precedentemente avviata. Se il parlante, per qualche motivo, nonvuole essere lui il primo a istituire l'incontro, ma vuol lasciare alla volontàdi uno degli altri partecipi del raggruppamento di diventare il suo interlocutore, preferirà una richiesta, non convenzionalizzata, di tipo impersonale:C'è qualcuno che ha l'ora esatta? (un fiammifero, una sigaretta?); C'? quel.cullo che sta dalle mie parti? (per essere accompagnato a casa • .
Fra le variabili che invece abbassano la soglia di richiedibilità la piùforte è l'urgenza, che può anche cancellare la cortesia rituale: il bisogno diP è infatti o manifesto ai partecipi della situazione sociale, e non è possibili-né utile nasconderlo con la cortesia; oppure, come si è detto, P è costrett,•a manifestare i! bisogno per evitare conseguenze peggiori, sia per sé che p-r
Se fra P e I c'è intimità, viene innanzitutto cancellata la dilli',zione fra raggruppamento e incontro, e la soglia di richiedibilità diventa 1-•,ssissima (anche se ovviamente non arriva mai a zero). Essendo mutate lecondizioni per la difesa dei rispettivi territori, la formula della richiesta pre.vede, nei casi in cui l'oggetto della richiesta sia importante per T'
di f f i c i l e per l, una esplicita manifestazione del bisogno, che può (t,zionare da sola come richiesta indiretta Ne.: il parlante inoltre può lasciarsicoinvolgere verbalmente nella difficoltà che t incontrerà per soddisfare larichiesta.
P. forse possibile unificare le variabili dell'intimità fra P e t. d. co,n.petenza specifica e della competenza occasionale di t, stilla base del l e asoet•tivc di P su e se si è in presenza di una oneste variabili. ‹l;
524 P. BENINCÀ E ALTRI
riguardo alle condizioni basate su t è molto poca: se i è il tabaccaio, e nonha dubbi che, se le ha, gli venderà un pacchetto di « Stop » col filtro: sesta passando vicino al telefono che squilla, P può prevedere che se dirà a I Ri-spondi tu, questi non avrà difficoltà a soddisfare la richiesta.
Nei casi che abbiamo appena visto inoltre succede che I, per la sua par-ticolare condizione di competente (stabile o occasionale), o per la suppostadisponibilità che gli deriva dall'intimità con P, avrà un grande aiuto, perquesti fatti contestuali, nell'interpretazione di formule NC basate sulla mani-festazione del bisogno. Se e dice all'amico i che la sua macchina da duegiorni non parte, I facilmente interpreterà l'ALI come l i lla richiesta di aiutoe non come il racconto di un fatto curioso. Se e dice al medico i Ho unafitta sotto la scapola sinistra, i non risponderà lo invece sto bene. ho soloun po' di raffreddore. ma ci visiterà, e/o ci farà una ricetta, ecc.
In presenza di competenza specifica o occasionale la difficoltà perpuò aumentare, cioè può essere richiesta un'azione obiettivamente gravosa,ma l'elaborazione della formula di cortesia resta piuttosto scarsa, se la dif-ficoltà dell'azione richiesta è neutralizzata dal fatto che l'azione rientra frale competenze di I: si può fare largo uso della pura manifestazione del bi-sogno, che in tutte le altre circostanze risulta scortese.
Abbiamo più volte parlato di formule richiestive più o meno cortesi:diamo a questo punto una scala indicativa di formule richiestive ordinatesecondo il grado di cortesia, sulla base di valutazioni intuitive, di cui i prin-cipi generali della teoria dovrebbero dar ragione. Abbiamo scelto come o gget-to della richiesta un'azione che comporta poca difficoltà per i, ma che nonè tuttavia un free good: una prova che le diverse formule sono selezionatedal contesto, ci è data dal fatto che la lettura della lista di richieste, chehanno identico contenuto proposizionale, ci costringe ad immaginare situa-zioni contestuali diverse'.
101 NUMI r•r rn turni-vit.
(i) Ti dispiace telefonare alla libreria?(1) Ti dispiacerebbe telefonare alla libreria?(in) Puoi telefonare alla librerie?
Potresti telefonare alla libreria?Ti sarei grato se telefonassi alle libreria.
(a) è la formula diretta. (h) in quanto presenta la volontà di v , comeragione sufficiente perché t faccia l'azione prevede più intimità fra eNel caso in cui la formula sia usata col pronome di .3' singolare di ca nresia siprevede un ruolo superordinato di P, rilevante per l'oggetto della richiesta(c), che è NC, è molto scortese se non si dà che fra e I ci sia +intimità.oppure che telefonare rientri fra le competenze concordate di I (se è vera unadi queste due condizioni la richiesta in questa forma non è scortese). (d):parità di condizioni, ciascuna delle formule, fra quelle date nello schema, ba-sate sulle condizioni dell'ALI) di richiesta, ammettono una variante col modocondizionale (cosiddetto di cortesia ') 11 e nella nostra lista sono messe a ungrado di cortesia superiore, rispetto alle formule base. La nostra ipotesisarebbe di riportare questo uso del condizionale agli altri usi del condizionalenelle frasi ipotetiche vere e proprie, come han tentato di fare la Pugliellie la Cibi-x-11i (1974). Non entriamo in discussione a proposito dell'analisi of.ferta sull'origine del condizionale dalle due autrici, ne accenneremo solo aproposito della loro proposta di ricondurre il condizionale di cortesia all'usocanonico del condizionale nelle ipotetiche. Il condizionale sarebbe la realiz-zazione superficiale soggiacente contenente una ipotetica il cui antecedente ècancellato perché in qualche modo recuperabile dal contesto, con in piùuna presupposizione riguardante tale antecedente: cioè che I non assuma cheassume che l'antecedente è vero. Ad esempio Verresti al cinema? (= 40 di n. ec.) verrebbe derivata da qualcosa come Vieni al cinema, se non c'è niente che
Telefona alla libreria (per favore).Vorrei che tu telefonassi alla libreria.C'è da telefonare alla libreria.Ci sarebbe da telefonare alla libreria.Telefoni alla libreria?Telefoneresti alla libreria?Vuoi telefonare alla libreria?Vorresti telefonare alla libreria?
16 Le formue da (e) a (o) possono essere usate anche con la 3' sing. di cortesia:non abbiamo considerato opportuno esaminare in particolare le restrizioni contestuali cheselezionano i due allocativi, in quanto sembrano non direttamente pertinenti alla cortesia.
" Non diamo più che un accenno al passato di cortesia ', del tipo Volevo sapere se sono stato ammesso o Cercavo Gigi. Che non si tratti di un tempo logicoè dimostrato dal fatto che formalmente qualche volta ci ptiù essere una contraddizione
ero Vidi° ‘IMIIMSSe,nella consecutio temporum: es. A quel tempo volevo sapere se
r•I:.,1 stato ,II1~3v.
Il presente logico soggiacente si sposta automaticamente all'imperfetto per ragioni pratinatiche, come è nel caso del condizionale, quando non vogliamo mostrare di imporr.direttamente la nostra volontà o il nostro bisogno come richiesta.
Si noti che questo passaggio automatico dal presente logico all'imperfetto di cortesi:,è fortemente limitato alle condizioni basate sul pensiero e sulla volontà del parlante-infatti Non potevo tradurre questa lettera non funziona come richiestiva alla pari conNon posso tradurre questa lettera. Ad esempio si veda: (i) Pensavo che :II potresti o-dare a trovarlo. (ii) Pensavo che in fondo non ti dispiacerebbe(iii) Adesso. volevo tre chili di zucchero. Ma non I iv) Mrs,,' . poh.r•• •• •
derlo (che non pur essere = a Vai a prenderlo fui.
526 P. BENINCÀ E ALTRI 101 MODI PER RICHIEDERE 52-
te lo impedisce? (= 42 di P. e c.) quando l'antecedente logico è caratterizzatodalla suddetta presupposizione. Ma restando all'interno della loro analisi delleipotetiche vere e proprie, la prima difficoltà è che l'antecedente di (42)è solo apparente, trattandosi piuttosto di una sospensione di presup-posizioni legate all'atto del richiedere. Infatti non si dà un rapporto di cau-salita tra tale pseudo antecedente e il conseguente come nelle ipotetiche veree proprie (es.: Comprerei quel libro se avessi dei soldi).
La ipoteca che secondo noi potrebbe soggiacere all'uso di cortesia delcondizionale è piuttosto Verresti al cinema se te lo chiedessi?, dove esisteun vero rapporto di causalità tra l'antecedente e il conseguente. Questa asua volta deriverebbe da qualcosa come Vieni al cinema, se te lo chiedo?, conin più la presupposizione che P non dà come vero l'antecedente. La cortesiaderiverebbe dal fatto che P dando come improbabile la sua richiesta mostradi non essere sicuro che sussistano le condizioni per poterla fare.
(e) : questa è la formula tipica della richiesta di free good col minimo dicortesia rituale che nel caso del free good non dà in effetti vie d'uscita. Ma sel'oggetto della richiesta, come nel nostro caso, non è un free gond, appare cherispetto ad (a) P comunica a t che non è sicuro che soddisferà la richiesta, e glilascia la possibilità di trovare qualche motivo per non farlo. Però (e) è menocortese delle formule successive (g), (i), (m), nelle quali è P che, informandosise sussiste una delle condizioni da cui dipende che t possa soddisfare la ri-chiesta, offre egli stesso a I una via d'uscita: I può infatti negare che sussi-sta la condizione di cui P si informa. Fra le richieste basate sulla volontà di(g: Vuoi; i: Ti dispiace) e quelle basate sulla possibilità (nr Puoi), sonopiù cortesi queste ultime, che danno a t la facoltà di portare come giustifi-cazione motivi obiettivi, mentre è più difficile giustificarsi sulla base dellapropria volontà.
(o) ha invece restrizioni opposte alle prime formule esaminate. cioè nonpuò essere troppo cortese: P presuppone che l'oggetto della richiesta nonrientra nelle competenze che t ha nei suoi confronti: non si può chiedere albarista Le sarei grato se mi facesse un caffè, ma è normale Le sarei grato sepotesse tenermi qui queste valigie fino a domani mattina.
4. DIFFERENZIAZIONI SUBCULTURALI NELL'USO DEGLI ALI
Ammesso che i nostri spunti interpretativi siano validi, risultano in ogni casobasati su un tipo di struttura sociale, quello delle culture urbane borghesi,in cui, la scarsità dello spazio ha sviluppato tecniche per la difesa del self:il largo uso del linguaggio rituale può considerarsi una risposta culturaleprecisa, sia in quanto presentazione, costruzione e difesa del territorio delsei!, sia perché la divisione del lavoro, sviluppatasi in settori tecnici di più
alta specializzazione, ha lasciato scoperti ambiti della vita quotidiana perquali non è sufficiente la socializzazione delle conoscenze (p. es. indicazionistradali) e l'automazione colletivizzata es. distributori automatici digarette).
Dove non esistono queste condizioni, nelle aree che non sono stategiunte dalla ristrutturazione (non solo fisica, ma anche dei rapp orti socialiche ha trasformato le città, i comportamenti linguistici rituali dovreb!,ereessere diversi: dovrebbe tuttavia essere possibile, sulla base delle nostre ipo.tesi sulla cortesia, fare alcune generalizzazioni che ci rendano ragio,,--questi diversi comportamenti.
Abbiamo condotto osservazioni in una zona rurale delle colline vicinea Padova, e abbiamo interrogato e osservato studenti provenienti dalle zo,lerurali delle provincie di Vicenza e di Treviso. I fatti più importanti,cui interpretazione diamo solo qualche spunto, sono questi:
si fanno pochissime richieste: con —intimità e +conoscenza (cio:.a un compaesano), non si fanno richieste se non c'è +competenza specifica(un'indicazione stradale si chiede solo a un vigile);
le richieste che si fanno hanno normalmente la forma diretta impe.rativa o dichiarativa: la cortesia (se c'è +intimità, —competenza sre.:ifi,-1o transitoria) si manifesta col tono della voce, o con qualche attenuativo d•tipo valà, eh. Le formule dell'italiano vengono eventualmente usate con—conoscenza, cioè quando P suppone che i sia estraneo al paese. oquando P è fuori dal paese;
(3) in famiglia, dove si fa il maggior numero di richieste, i usa la
formula diretta talvolta facendo seguire il motivo per cui la richiesta vienfatta a quella persona (il che è un'esplicitazione di competenza occasiona!
(4) —conoscenza abbassa la soglia di richiedibilità.Per meglio interpretare questa fenomenologia è interessante anche qui
avere un'idea di come si configura l'offerta: il principio è che le offertesi rifiutano (due volte, la terza si può accettare). espressamente perché nonsembri che si ha bisogno di qualcosa. Il contadino può regalare quAcheprodotto del suo raccolto, solo se aggiunge che altrimenti va a male: qi1::;10libera i dal ritegno ad accettare l'offerta, in quanto non lo vincola in ne.s11,modo a chi ha fatto l'offerta, e egli può accettare proprio in quanto l'offertadiventa anche un favore che t può fare a P, mantenendo inif T ri i rispeoi,:iterritori.
In una cultura dialettale che almeno storicamente si identifichi concultura della povertà, anche la mancanza di un cerino non può esser,'nernente resa nota con una richiesta, in quanto si suppone elle po,•,durre che n non ha i soldi per procurarselo.
528 P. RENINCÀ E MARI
101 MODI PER RICHIEDERE 52('
Ma si devono riconoscere anche i residui di una strutturazione socialemolto stabile, fondata sulla famiglia patriarcale. Qui la divisione del lavorofunzionava in modo minuzioso e le competenze di ognuno esaurivano lenecessità della vita quotidiana: all'interno della famiglia le richieste si fan-no in modo diretto, in quanto una richiesta si rifà a una mansione speci-fica che t ha all'interno della struttura famigliare. Però se il contadino sitrova fuori del suo paese, in un ambiente, come la città, dove non esistonopiù i presupposti strutturali per la sua autonomia, e dove inoltre sa che esi-stono regole diverse, egli è ardente che i suoi comportamenti qui sarannogiudicati diversamente che al paese, e in ogni caso che la sua faccia ' nonè in gioco perché non è conosciuto: in questo contesto la soglia di richie-dibilità si abbassa e vengono adottate formule di cortesia della cultura urbana,ma con ovvi ipercorrettismi comportamertali
APPENDICI
i. Verifica sperimentale sull'intonazione degli AI.I.
Si è analizzato l'andamento della frequenza fondamentale, il correlato elettro-acustico responsabile dei fatti intonativi, di una serie di richiestive indiretteconvenzionali del tipo (9) confrontate con un'altra serie di interrogative po-lari. (la. Mi passi il sale?; lb. Ricordi Alvise?; 2a. Mi daresti il sale?; 2h. Tiricordi il mare?; 3a. Puoi darmi una siyfiretta?; 3h. Puoi farli una motoretta?;4a. Hai una sigaretta?; 4h. Hai una motoretta?; 5a. Arresti una siga,•etta?;5b. Aspetti una motoretta?; 6a. Mi dai una sigaretta?; 6b. Ti fai una moto-retta?; 7a. Ti posso fregare una sigaretta?: 7b. Gli fai trovare una bicicletta?).
Le coppie di frasi presentano una identica struttura sillabica e accentuale(si sono considerate funzionalmente uguali consonanti geminate, lunghe inter-vocaliche, e due consonanti differenti) per evitare che nell'analisi dei datiinteragissero fattori fonetici connessi alla presenza dell'accento. Inoltre si èmantenuto il medesimo ordine delle parole (sintagma verbale e oggetto), inquanto una diversa tematizzazione avrebbe potuto dar luogo a contorniintonativi differenti.
Si sono infine esaminate le caratteristiche intonative di una serie difrasi richiestive dirette convenzionali (passami il sale. dammi una sigaretta,dammi il sale, per favore passami il sale, per favore dammi una sigaretta,per favore domini il sale).
Una verifica sperimentale spettrografica ha permesso di riscontrare nellerichiestive di tipo (9) una linea intonativa propria, diversa sia da quelladelle interrogative polari, sia da quella delle richiestive dirette convenzionali.Infatti mentre le interrogative polari presentano un andamento della melodia
nettamente ascendente sul sintagma finale e quelle richiestive dirette un ar)damento discendente, le richiestive indirette del tipo (9) sono caratterizza.te da un andamento della curva intonativa variabile e intermedio tra le du•opposte linee intonative: a volte leggermente discendente analogamente A -richiestive dirette, a volte leggermente ascendente, analogamente alle interrogative polari.
La modifica dei contorni intonativi appare essere una variabile in fumi.zione della cortesia: quanto più il parlante vuole sembrare cortese, tantopiù gioca con l'intonazione interrogativa, senza tuttavia farla mai coinciderecon essa. L'ambiguità fra un possibile significato richiestivo o interrogativnnon giunge infatti al punto di lasciare dubbi a I sul reale significato d,,11tfrase.
Carlo ARSLAN, Ricerca sperimentale stilla riconoscibilità delle ricbiev,,'indirette c, sc, e NC.
Abbiamo condotto una prova sperimentale per verificare la teoria appen,esposta, impostandola nel modo seguente.
I. Previsioni. Se la teoria è valida, abbiamo supposto che, presentando adun soggetto un certo numero di formule richiestive indirette c, se. e Nc,facendo in modo che non si abbia una memorizzazione puntuale delle frasi.il soggetto, in una successiva prova di riconoscimento delle frasi stesse, dehha mostrare uno slittamento nel ricordo dalle formule Sc e NC Verso quel-le c'. Infatti, se alle richieste indirette sc e NC sono associate due formelogiche, quelle dell'AL letterale e quella della richiesta, una volta che i abbiacompreso il messaggio come richiesta, la sola forma logica richiestivi' è quellache conta, cioè l'unica forma logica associata alle richieste indirette c.. Laforma logica dell'Al. letterale, invece, deve perdere tutta la sua importanza.soprattutto nel caso in cui il soggetto non abbia la possibilità di effettuareuna memorizzazione precisa e puntuale delle frasi che gli sono state presentate.
2. Metodo e procedura sperimentale. La nostra prova si basa essenzialmen-te sul riconoscimento di una lista di frasi precedentemente lette dallo speri-mentatore. Inizialmente sono state costruite 14 frasi, 3 C, 3 sc, 3 Nr., e
' Come è detto più avanti, per il riconoscimento di una frase, veniva proposta alsoggetto un'alternativa di tre frasi richiestive indirette, una C, una se e una NC. cotlstesso contenuto proposizienale. Il sog getto era, quindi, costretto a riconoscere seg.ur,•una richiesta indiretta. così (11 evitare interferenze fra richieste dire,re ;•,dirette e.
36
530 P. BENINCA E ALTRI 101 MODI PER RICIIIFDFRP 531
di riempimento (a), tutte inerenti allo stesso contesto. Le frasi sono stateordinate in una successione plausibile, inframmezzando le frasi R (vedi Ta-vola 3). Ne è risultata la lista finale che lo sperimentatore ha poi presentatoai soggetti come brani di una normale conversazione. Si è poi scelto di ese-guire delle prove collettive, per ovviare al problema della standardizzazionedella presentazione delle frasi. In un seconda prova, inoltre, per ovviare allamancante randomizzazione dell'ordine di presentazione delle frasi, si è ante-posto e posposto alla lista un congruo numero dí frasi R che dovevano con-temporaneamente soddisfare all'esigenza (li saturare la memoria a breve ter-mine e di aumentare il numero totale delle frasi della lista, così da far sen-tire meno l'influenza dell'ordine di presentazione delle frasi.
Inizialmente lo sperimentatore, dopo aver disposto i soggetti in modoconveniente, spiegava ai soggetti stessi il contesto cui vogliono riferirsi lefrasi della lista. Nel nostro caso si trattava di una cena che da un lato avesseun certo carattere formale, dall'altro non fosse una vera e propria cena uffi-ciale. Il nostro scopo era, in sostanza, quello di escludere sia un caratteretroppo familiare e di amicizia, in quanto in tale contesto non valgono piùesattamente le stesse distinzioni indicate prima, sia un carattere troppo for-male, in cui una frase del tipo Puoi darmi il sale? risulterebbe inaccettabile.Per ottenere ciò, ai soggetti veniva detto che dovevano immaginare le frasicome pronunciate dai diversi commensali di una cena natalizia con i parenti,quindi in una situazione in cui c'è di base un minimo di familiarità contutti per via del legame di parentela, ma c'è anche una certa dose di for-malità per via delle eventuali differenze di età, per la possibilità che alcunidei parenti non siano che dei parenti alla lontana o comunque siano personeche più o meno si vedono solo a Natale.
Spiegato questo, lo sperimentatore leggeva la lista di frasi, con into-nazione il più possibile naturale e con una pausa di circa 3 secondi fra unafrase e l'altra. La durata della pausa era stata giudicata sufficiente per permet-tere una comprensione esatta della frase senza d'altronde dare il tempo al sog-getto di codificare nella memoria a lungo termine la frase stessa in manierapuntuale. Appena terminata la lettura i soggetti eseguivano la prova di ri-conoscimento. Questa veniva compiuta su una lista di frasi scritte fra cuiil soggetto doveva scegliere quello che gli sembrava di aver udito. La listascritta era organizzata in maniera da presentare ognuna delle frasi in prova,cioè le frasi c, sc, NC, accoppiata alle altre due formulazioni della stessafrase. Per fare un esempio, se nella lista letta dallo sperimentatore vi erala frase Ti dispiace passarmi l'olio? (c), nella lista scritta vi erano le frasiTi dispiace passarmi l'olio? (c), C'è dell'olio? (sc) e L'olio è vicino a te?(Nc). Pertanto ogni frase, a parte quella a, veniva riportata nella lista scritta
in tutte e tre le formulazioni. Le frasi R, invece, non venivano riportatenella lista scritta.
Soggetti. I soggetti sono stati 27 studenti di Psicologia dell'Universi0di Padova. Nessun soggetto aveva precedenti esperienze in esperimenti no:,
loghi.
Tavola 3 a. Lista delle frasi lette dallo sperimentatore nella seconda prova di ricono-scimento (R = frase di riempimentó; RI = richiestiva usata come zeppa; c = richiestivaconvenzionaleo sc = richiestiva semiconvenzionale; NC = richiestiva nonconvenzionale1. R. Non ti pare invecchiata la zia? // 2. RT. Puoi telefonare tu a Mario? /1 3. R. Si è
laureato tuo figlio? // 4. RT. Non riesco ad aprire la bottiglia. 11 5. c. Puoi passarmi
un portacenere? /I 6. R. Sono buoni questi gnocchi, vero? H 7. c. Potresti versarmi del-
l'acqua? // 8. se. Vedi del pane? H 9. R. t tanto che non ci vedevamo, eh? // 10. R. La
carne manca di sale. II 11. se. Dove sono i grissini? 12. R. Sabato vengo a trovarti. /i
13. se. C'è del vino? // 14. NC. C'è una finestra aperta vicino a te? II 15. R. Domani
parto per le vacanze. // 16. e. Vorresti passarmi l'olio? 11 17. NC. Fumi delle Barlboro' //
18. R. Andiamo al cinema dopo? // 19. RI. Avresti un'aspirina? 11 20. n. Hai visto le
nuova automobile di Giorgio? 11 21. P!. Cè una penna da qualche parte?
Tavola 3 b. Lista delle frasi presentata al soggetto nella seconda prova di riconosci-mento, perché riconoscesse, all'interno di ogni gruppo di tre, quale frase gli aveva lelte
precedentemente lo sperimentatore
(sc) Dov'è il portacenere? - (C) Puoi passarmi un portacenere? - (Ne) In tavola non ci
sono portaceneri. /1/ (Ne) Si sono dimenticati l'acqua. - (se) Vedi dell'acqua? - (e) Potresti
versarmi dell'acqua? /// (Ne) Chissà dove hanno messo il pane. - (e) Potresti passarmi
del pane? - (se) Vedi del pane? /// (e) Vorrei del sale per la carne. - (Ne.) La carne manco
di sale. - (se) C'è del sale per la carne? II/ (c) Puoi passarmi i grissini? - (se) Dove sono
i grissini? - (Ne) Non ci sono i grissini in tavola. /// (Ne) P buono quel vino? - (c) Mi
passi il vino? - (se.) C'è del vino? I/I (se) Bisognerebbe chiudere la finestra. - (NC,) C.;
una finestra aperta vicino a le? - (e) Ti dispiace chiudere la finestra? I/I (se) C'è del.
l'olio? - (C) Vorresti passarmi l'olio? - (Ne) P olio quello? /// (se) Ci soro MarIl•,
ro? - (Ne) Fumi delle Marlboro! - (c) Ti dispiace darmi una Marlboro?
Risultati. Nonostante questa voglia essere solo una relazione prelimina•esi può affermare che i risultati principali tendono a confermare l'ipotesi i•,;.zialc. Infatti abbiamo in complesso i seguenti dati:
RICONOSCIMENTO
e Se NC
63 = 77,8 %
14 = 17,3 97(5
4 = 4,9 g
C
FRASI LETTE 37 = 45,796
30 = 37,0
14 = 17,3%
se.
11 = 13,6 %
2 = 2,596
68 = 83,9 %
Ne
Un più ampio lavoro. che tra: spunto dalli presente ricerca, 1.,„1•1.1;
successivamente.
101 MODI PFR R ICT TIFITERF 537532 P• RENINCX P. A T.TR T
I dati sono molto chiari per le frasi sc che quasi il 46% dei soggettiriconosce come c e solo il 17% circa come Ne. Anche tenendo conto di uncerto numero di scelte casuali, che nel nostro caso potrebbero forse essererappresentate dai dati delle frasi c, abbiamo una indicazione in favore del-l'ipotesi sperimentale. Analogamente si può dire, anche se con più cautela, perle frasi NC. In questo caso infatti le frasi vengono riconosciute come NC dallaassoluta maggioranza dei soggetti, complice a nostro avviso la particolare for-ma delle frasi stesse, che le rendeva molto caratteristiche e quindi moltopiù facilmente memorizzabili; ciononostante un certo numero di soggetti loriconosce addirittura come c.
In conclusione, anche se indubbiamente è necessaria una maggior preci-sione tecnica nell'esecuzione dell'esperimento, riteniamo che in complesso laipotesi sperimentale venga confermata, come anche risulta dai primi dati diuna successiva versione di questo esperimento ancora in corso di esecuzione.
RIMANDI BITILTOGRAFICI
Austin 1962 = J. L. Austin, How to do things with words, Oxford 1962.Chottisky 1965 = N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, Cambridge
(Mass.) 1965; trad. it. Aspetti delle Teorie della sintassi inN. Chomsky, La grammatica generativa trasformazionale, To-rnio 1970, pp. 41-102.
Cinque 1974 = G. Cinque, ' Presupposizioni' di voci lessicali e di costruttie loro rilevanza sintattica, in M. Medici e A. Sangregorio (ac. di), Fenomeni morfologici e sintattici nell'italiano contem-poraneo, Atti del VI Congresso internazionale di Studi dellaSLI - Società di Linguistica Italiana (Roma, 4-6 settembre1972), Roma 1974, pp. 47-69.
Cohen 1973 = T. Cohen, Illocution and perlocution, « Foundations of lan-guage », 9 (1973), pp. 492-503.
Cole 1973 = P. Cote, Conversational implicature and syntactic rules, Urba-na (III.) 1973.
Goffman 1967 = E. Goffman, Interaction ritnel: Essays on the face-to-/ace he-havior, New York 1967 (trad. it.: E. Goffman, Modelli diinterazione, Bologna 1971, pp. 3-307).
Goffman 1969 = E. Goffman, Strategie interaction, Filadelfia 1969 (trad. it.:E. Goffman, Modelli di interazione, cit., pp. 311-480).
Goffman 1972 = E. Goffman, Relations in public, New York 1972 (il cap. IV èparzialmente tradotto in P. P. Giglioli (a c. di), Linguaggio esocietà, Bologna 1973, pp. 169-194).
Gordon-Lakoff 1971 = D. Gordon e G. Lakoff, Conversational postulates, in Papersfrom the VII Regional Meeting of the Chicago LinguisticSociety, Chicago 1971, pp. 63-84.
Green 1973 = G. Green, How lo get people io do things with words f ora inP. Gole e J. Morgan (a c. di), Syntax and semantics: spercra-arts, New York 1974, pp. 107-141).
Grice 1968 = P. Grice, Logic and conversation, Berkeley 1968 (ciclostilato.inedito).
Heringer 1971 J. I leringer, Some grammaiiral correlates of conditionsand presuppositions. tesi inedita. Ohio State University 1971
Lakoff 1970 = G. Lakoff, Linguistic and nettirel logie. « Synthèse », 22 (1970 n .pp. 151-271.
Lakoff 1971 = G. Lakoff. On generative semantics, in D. Steinberg e L.Jakobovits (a e. dil, Semanties, Cambridge 1971, pp. 232-29(,.
Lakoff 1973 a G. Lakoff, Sante thoughts on transderivational constraints, inB. Kachru et al. (a e. di), Issues in linguistics, Urbana (111.,1973, pp. 442-452.
Lakoff 1973 b = G. Lakoff, The logic politeness: or rninding yours P's ani!q's, in Papers from the IX Regional Meeting of the Chirac,Linguisti(' Society, Chicago 1973. pp. 292-305.
Postai 1970 = P. Postai, On the surface verti ' remind « LinguiRtic ingoiry », 1 (1970), pp. 37-120 .
PugliellIaliberti 1974 = A. Ptiglielli e A. Ciliberti, Il condizionale, in M. Medici (-A. Sangregorio (a c. di), Fenomeni morfologici e sintattici 7,,•?l'italiano contemporaneo, cit., pp. 261-274.
Sadock 1970 J. Sadock, Whimperatives, in I. Sadock e Vanek ta c. dil.Studies presented io R. B. Lres hy his students. Edmonr•:1970, pp. 223-238.
Sadock 1972 i. Sadock, Speech acts idionts, in Papers from the Il R,•giori' Meeting of the Chicago Lingniriie Societ,,1972. pp. 329-339.
Sadock 1974 = J. Sadock, Toteards a linguistic theory of speechYork 1974.
Scarle 1969 J. Searle, Spcech acts, Cambridge 1969.Scarle 1972 — 1. Searle, A taxonomy o/ illoeuraionary nets, in corso di oolisli
cazionc in K. Gunderson (a c. di). Ali•n•r,,la ,.ri,j;,,philosophy of language.
Schilfer 1973 S. R. Schiffer, Oxford 1962.Vendler 1972 Z. Ri r cogitens, Ithacp (N. Y.i 1072.