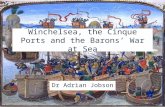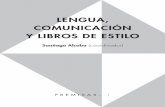La biblioteca disciplinata. Una “libraria” cinque-seicentesca tra censura e dissimulazione
Transcript of La biblioteca disciplinata. Una “libraria” cinque-seicentesca tra censura e dissimulazione
�������������������
�� � ��������� ��� � ����� ������������ ��������� ���� ��� � ������� ������
�������
���� ��������� ����������
����
865
1. circa cinquant’anni or sono Eugenio Garin poteva legittimamen-te osservare che “la storia segreta della grande battaglia intesa a sequestrare ilmondo cattolico dal progresso del sapere europeo è ancora da scrivere, seb-bene per tanta parte interessi proprio l’Italia”, mettendo in evidenza come “inudi elenchi degli Indici [dei libri proibiti] danno solo una pallida idea diquella che fu la lotta reale, con le sue insidie e le sue miserie”. Da allora glistudi sul fenomeno censorio hanno fatto progressi senza pari, non ultimomotivo la tanto attesa apertura degli archivi del Sant’Ufficio e dell’Indice cheha consentito un accesso alle fonti interne delle due Congregazioni1.
* Una differente (e più breve) stesura di questo saggio è stata pubblicata con il titolo La criticaroditrice dei censori in Saperi e meraviglie. Tradizione e nuove scienze nella libraria del medico genoveseDemetrio Canevari, L. Malfatto-E. Ferro (a cura di), Sagep, Genova 2004, pp. 41-76, ed era statascritta prima che fosse disponibile la riproduzione digitale restaurata del catalogo di cui alla nota 8.Abbreviazioni: ACDF = Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del Vati-cano; ADC = Archivio dell’Opera Pia Sussidio Demetrio Canevari, Genova; AGOP = Archi-vum Generale Ordinis Fratrum Praedicatorum, Roma; ASG = Archivio di Stato, Genova; BACR= Biblioteca dell’Accademia dei Lincei e Corsiniana, Roma; BAM = Biblioteca Ambrosiana, Mi-lano; BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana; BCB = Biblioteca Civica Berio, Genova; BUG =Biblioteca Universitaria, Genova; CFC = Catalogo del fondo Demetrio Canevari della Bibliotecacivica Berio di Genova, R. Savelli (a cura di), La Nuova Italia, Firenze 1974; ILI = J.M. De Bu-janda, Index des livres interdits, Sherbrooke, Droz, 1985-2002, 11 voll.; ILO = Index librorumomnium qui in nostra Bibliotheca… (cfr. nota 8). Le indicazioni bibliografiche sintetiche delleopere qui citate con il solo rinvio al numero di CFC sono riportate in Appendice.
1. E. Garin, Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano, Laterza, Bari 1965, p. 116. La biblio-grafia in tema di censura si è notevolmente ampliata negli ultimi decenni: per un quadro d’assie-me ricordo solo A. Rotondò, La censura ecclesiastica e la cultura, in Storia d’Italia. 5. I documenti,Einaudi, Torino 1973, II, pp. 1397-1492; G. Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica ei volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), il Mulino, Bologna 1997; Ead., Proibito capire. La
La biblioteca disciplinata.Una “libraria” cinque-seicentesca
tra censura e dissimulazione*di rodolfo savelli
rodolfo savelli
866
Chiesa e il volgare nella prima età moderna, il Mulino, Bologna 2005; La censura libraria nell’Eu-ropa del secolo XVI, U. Rozzo (a cura di), Forum, Udine 1997; M. Infelise, I libri proibiti da Gu-tenberg all’Encyclopédie, Laterza, Roma-Bari 1999; V. Frajese, Nascita dell’Indice. La censura eccle-siastica dal Rinascimento alla Controriforma, Morcelliana, Brescia 2006. Sugli archivi cfr. L’aper-tura degli archivi del Sant’Uffizio romano, Atti dei convegni Lincei 142, Roma 1998.
2. È ovvio che le considerazioni che si possono fare per questo periodo (e per l’asse Roma-Ge-nova) non sono altrettanto valide un secolo dopo: cfr. ad esempio gli studi di F. Barbierato, Nel-la stanza dei circoli: Clavicula Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli XVII e XVIII, S. Bon-nard, Milano 2002; Id., Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento,Unicopli, Milano 2006.
3. P.F. Grendler, The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605, Princeton UP, Prin-ceton 1977, p. 288 (a proposito del quale risultano sempre valide le riserve espresse da G. Coz-zi, “Books and Society”, in «The Journal of Modern History», 51, 1979, pp. 90-97).
4. Per la biblioteca di Pinelli, tra i contributi più recenti, cfr. M. Grendler, “Book Collecting inCounter-Reformation Italy: the library of Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601)”, in «Journal of Li-brary History», 16 (1981), pp. 143-151; M. Rodella, “Fortuna e sfortuna della biblioteca di Gian
Resta, per altro, abbastanza diffusa l’opinione di chi tende a sottostima-re l’estensione e la profondità del fenomeno censorio tra Cinque e Seicen-to, nella prospettiva sia della applicazione sia della progettazione2.
Prendendo il via da una situazione in parte “eccentrica”, quale quella vene-ziana, e dall’inventario di una straordinaria biblioteca (quella di Giovanni Vin-cenzo Pinelli) Paul F. Grendler era giunto a conclusioni abbastanza nette, ma amio avviso non così facilmente generalizzabili: “with a few exceptions, the cen-sors found nothing objectionable in works of classical scholarship, history, law, lite-rary criticism, mathematics, medicine, philology […] Scholars carried on theirstudy of these disciplines with little interference”3. Non basta, però, un solo cata-logo a dirci quanto ampia fosse la libertà di un intellettuale quale Pinelli (ched’altronde, come si avrà modo di vedere, non fu “immune” da inframmetten-ze censorie), né si possono equiparare le condizioni di un osservatorio relativa-mente privilegiato (Padova e Venezia) con il resto d’Italia, né quelle di un per-sonaggio dalle straordinarie relazioni (anche familiari) con quelle dei “comuni”utilizzatori professionali di libri (medici, avvocati, etc.). Né, infine, le occasio-ni offerte dal commercio clandestino possono essere parificate con la libertà dilettura o di ricerca. Nella stessa Venezia, d’altra parte, vi sono testimonianzeche si muovono in tutt’altra direzione: Leonardo Donà (e non era l’ultimo ar-rivato) sottopose la sua biblioteca a più di una ripulitura4.
Peter Godman, invece, è partito dai “vertici”: utilizzando la documen-tazione delle Congregazioni romane in modo mirato (e qualche volta opi-nabile) ha recentemente offerto un quadro della censura decisamente di ma-niera: “the image is not the traditional one of authoritarianism, planned andeffective, but of improvisation – random, slapdash, and (judged in terms of itsown objectives) counterproductive”5.
Ciò nondimeno, si considerino le politiche del “centro” o le applicazionida parte delle strutture periferiche (inquisitoriali e/o diocesane), non si puònon constatare che nella maggior parte dell’Italia (e in altre zone d’Europa) lacircolazione del libro è stata in vari modi regolamentata, limitata, talvolta dra-sticamente impedita. Potrebbe, perciò, essere interessante scegliere un ulterio-re punto di osservazione, dal “basso” se così si può definirlo, vale a dire le bi-blioteche private, uno dei diversi luoghi dove (per usare le parole di Garin) siconcretizzavano “insidie e miserie”, dove, in modo molto materiale e concre-to, si facevano sentire gli effetti “capillari” dei divieti ecclesiastici6. Se sono statiindividuati “sette modi di censurare Erasmo”, quanti erano quelli in uso per lelibrarie dove Erasmo poteva essere in compagnia di infiniti altri autori, moltomeno “pericolosi”, ma altrettanto soggetti ad analoghe attenzioni7?
la biblioteca disciplinata
867
Vincenzo Pinelli. La vendita a Federico Borromeo”, in «Bibliotheca» 2003, 2, pp. 87-125; A. Nuo-vo, Testimoni postumi: la biblioteca di Gian Vincenzo Pinelli tra le carte di Nicolas-Claude Fabri dePeiresc, in L’organizzazione del sapere. Studi in onore di Alfredo Serrai, M.T. Biagetti, S. Bonnard (acura di), Milano 2004, pp. 317-334; Ead., Dispersione di una biblioteca privata: la biblioteca di GianVincenzo Pinelli dall’agosto 1601 all’ottobre 1604, in Biblioteche private in età moderna e contempora-nea, A. Nuovo, S. Bonnard (a cura di), Milano 2005, pp. 43-54; Ead., «Et amicorum»: costruzionee circolazione del sapere nelle biblioteche private del Cinquecento, in Libri, biblioteche e cultura degliOrdini Regolari nell’Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell’Indice, R.M.Borraccini e R. Rusconi (a cura di), BAV, Città del Vaticano 2006, pp. 105-127; resta sempre digrandissimo interesse la descrizione fornita da P. Gualdo, Vita Ioannis Vincentii Pinelli, AugustaeVindelicorum, ad insigne pinus, 1607. Per Donà cfr. M. Zorzi, La circolazione del libro a Venezianel Cinquecento: biblioteche private e pubbliche, in “Ateneo Veneto”, CLXXVII (1990), pp. 132-133.
5. P. Godman, The Saint as Censor. Robert Bellarmin between Inquisition and Index, Brill, Lei-den 2000, p. 228 (su cui cfr. le osservazioni di G. Fragnito, “Gli affanni della censura ecclesia-stica”, in «Rivista Storica Italiana», CXIV, 2002, pp. 584-600).
6. Cfr. Fragnito, Proibito capire, cit., p. 17.
7. S. Seidel Menchi, Sette modi di censurare Erasmo, in La censura libraria nell’Europa del secoloXVI, cit., pp. 177-206.
rodolfo savelli
868
2. Uno stimolo insperato a mettere in cantiere la presente ricerca è ve-nuto dalla realizzazione del “restauro virtuale” del catalogo autografo dellaricca collezione di un medico genovese, Demetrio Canevari (1559-1625).Tale restauro costituisce un momento di svolta nella conoscenza di questasignificativa libraria: il pessimo stato di conservazione del manoscritto, conestese bruniture e perforazioni della carta dovute all’inchiostro, ne ha sem-pre sconsigliato (e di fatto impedito) una consultazione e uno studio siste-matici. Aver potuto fruire di una riproduzione digitale “risanata” ha con-sentito una prima serie di sondaggi che confermano l’importanza della rac-colta e delle sue vicende [figg. 1-2]8.
Allo stato attuale degli studi ancora nulla si sa della formazione della col-lezione, né dei rapporti di Canevari con il mercato librario o con gli ambien-ti culturali di Roma (dove visse dal 1584 alla morte): era troppo giovane, ap-pena arrivato nella città capitolina, perché la sua biblioteca (allora in forma-zione) potesse essere ricordata da Muzio Pansa; Gian Vittorio Rossi ne ha la-sciato un ritratto postumo, molto di colore (e probabilmente veritiero), po-vero, tuttavia, delle informazioni che vorremmo avere in proposito9.
La libraria “sommamente amata et tenuta cara” è giunta in gran parte fi-no a oggi, grazie al fatto di essere stata inserita nel fedecommesso istituitoda Demetrio e grazie alle previdenti disposizioni testamentarie, e permette
8. L’Index librorum omnium qui in nostra Bibliotheca certis pluteis continentur era stato dato perscomparso dagli inizi del secolo scorso e fu da me ritrovato presso l’ADC; è stato compilato ver-so la fine della vita di Canevari e probabilmente non completato, come si evince dal fatto chenelle pagine finali la descrizione dei volumi appare lacunosa e molti non riportano il numero di“pluteus” in cui erano collocati (cfr. infra testo corrispondente nota 16). Per le informazioni bio-grafiche, la storia della biblioteca e la bibliografia precedente cfr. R. Savelli, Demetrio Canevari ela sua biblioteca, in CFC pp. xi-l; qualche dato aggiuntivo in Id., La “libraria” di Demetrio Ca-nevari, in Da tesori privati a bene pubblico. Le collezioni antiche della Biblioteca Berio di Genova,L. Malfatto (a cura di), Pacini, Pisa 1998, pp. 91-96; e cfr. L. Malfatto, “Index librorum om-nium qui in nostra bibliotheca certis pluteis continentur”. Il catalogo autografo di Demetrio Caneva-ri, in Saperi e meraviglie, cit., pp. 11-22; G. Antonioli, F. Fermi, C. Oleari, R. Reverberi, Il re-stauro virtuale del catalogo di Demetrio Canevari. Dalla macchina fotografica allo scanner otticospettrofotometrico per la spettroscopia d’immagine nel campo dei beni artistici e culturali, in Saperi emeraviglie, cit., pp. 23-25.
9. M. Pansa, Della libraria vaticana, Appresso Giovanni Martinelli, Roma 1590; Iani NiciiErithraei [= G.V. Rossi], Pinacotheca tertia imaginum virorum [...] illustrium, Coloniae Ubio-rum, apud J. Kalcovium, 1648, p. 210.
quindi uno studio basato non esclusivamente su di un catalogo. Si conser-vano, in questo caso, le testimonianze fisiche dei volumi, con tutte le di-sparate annotazioni che portano con sé e che offrono frammentarie ma mol-teplici notizie sulla formazione, sull’uso e gli “abusi” subiti da questa colle-zione scientifica (medica, innanzi tutto, ma ricca anche di opere matemati-che, astronomiche, filosofiche – come viene enunciato nell’illuminante pre-messa al catalogo stesso che è suddiviso in quattro sezioni: “disciplinae ma-thematicae”, “philosophia”, “ars medica”, “philologia”).
Tra i tanti, diversi, segni rimasti si possono citare alcuni degli ex-librisdei precedenti possessori, che richiamano alla mente dispersioni, vendite,scambi (se non, forse, qualche piccola “depredazione”): Benedetto Varchi eil segretario apostolico Antonio Boccapaduli10; il collega Cinzio Clementi eProspero Podiani11; la Compagnia di Gesù (dalla Casa Professa ottiene unClavio e dal Collegio Romano il trattato di Galilei Intorno alle cose che stan-no in su l’acqua)12; e non bisogna dimenticare un dono con dedica di Ge-rardus Vossius13.
la biblioteca disciplinata
869
10. CFC 315 (sui libri del Varchi cfr. B. Varchi, L’Hercolano, A. Sorella (a cura di), Libreria del-l’Università Editrice, Pescara 1995, pp. 155-166; M. Firpo, Gli affreschi di Pontormo a San Lo-renzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I, Einaudi, Torino 1997, pp. 254 e ss.).Per Boccapaduli: CFC 38, 1425, 1756 (cfr. G.M. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, II, III, Giam-battista Bossini, Brescia 1762, pp. 1384-1385).
11. Per Clementi: CFC 112, 561, 924, 1063, 1547, 2351. Per Podiani: CFC 1629; la bibliotecaè ricordata tra le più ricche del tempo da Pansa, Della libraria vaticana, cit., pp. 328-329; suidepauperamenti, i prestiti e i “movimenti” dei libri cfr. J. Bignami Odier, Des manuscrits de Pro-spero Podiani à la bibliothèque Vaticane, in Studi di bibliografia e storia in onore di Tammaro deMarinis, I, s.l. [Verona] 1964, pp. 91-134; G. Cecchini, La Biblioteca Augusta del Comune diPerugia, Storia e Letteratura, Roma 1978, pp. 35 e ss.; A. Panzanelli Fratoni, Tracce di circola-zione del libro a Perugia tra Cinquecento e Seicento, in Biblioteche nobiliari e circolazione del librotra Settecento e Ottocento, G. Tortorelli (a cura di), Pendragon, Bologna 2002, pp. 263-325.
12. CFC 663 (in questo volume l’ex-libris è cancellato) e 2200. Sul ruolo della Compagnia diGesù nel dibattito scientifico cfr. U. Baldini, Legem impone subactis. Studi su filosofia e scienzadei gesuiti in Italia 1540-1632, Bulzoni, Roma 1992; Id., Saggi sulla cultura della Compagnia diGesù (secoli XVI-XVIII), CLEUP, Padova 2000.
13. “Doct. Demetrio Canevario Physico, in syncerae benevolentiae symbolum Doct. GerardusVossius pro memoria Romae dono dabat. 1599”: si tratta della Chronographia di Schultz (CFC1730).
rodolfo savelli
870
Nella biblioteca confluirono successivamente, e in modo casuale, nonmolti volumi provenienti dall’eredità del fratello Ottaviano (morto nel 1639)– “filosofo” e giurista. Se sono qui ricordati è perché taluni si caratterizzanoper quello stesso tipo di segni su cui si vuole richiamare l’attenzione14.
Prima di queste fortuite aggiunte, gli eredi prepararono due indispensa-bili strumenti per la consultazione della libraria ormai trasferita a Genova:un inventario topografico di straordinaria utilità (i libri sono descritti inmodo ancora più analitico rispetto al catalogo di Demetrio, con l’indica-zione del luogo e della data di stampa) e un indice degli autori15.
Tale lavoro fu concluso attorno al 1630. In quell’anno, infatti, “attentoquod capsiae seu plutei in quibus ab urbe Roma asportati fuere Genuam dictilibri et hactenus in eis asservati fuere constant ex lignis seu tabulis antiquis etmale compactis, imo fere inutilibus ad fidam custodiam dictorum librorum” fudeciso di costruire dodici nuovi “plutei seu armaria, vulgo scantiae”. È senzadubbio interessante il fatto che fosse mantenuta la precedente ripartizioneper “plutei seu capsiae”, visto che costituiva anche una suddivisione temati-ca. Il passaggio da Roma a Genova non comportò, in questa vicenda, si-gnificative modifiche, tranne forse il numero d’ordine all’interno di ciascun“pluteus”, i quali quarantotto erano, e altrettanti rimasero16.
14. In ASG, Notai antichi 6012 è conservato un insieme di inventari dei libri (chiaramente fruttodi un lavoro fatto in tempi e da persone diverse, in parte ripetitivo e abbastanza sommario); vi sitrovano echi dei suoi studi al collegio dei gesuiti a Milano: cfr. ad esempio l’annotazione relativaagli “scripta mea totius cursus philosophiae”. Questo apporto contribuisce forse a spiegare in partela ridondanza di così tante edizioni aristoteliche nell’attuale fondo della Biblioteca Berio.
15. Plutei et index librorum in eis repositorum respective e Secundus Index alphabeticus in confusoconservati in ADC; è allegato uno schema di distribuzione dei “plutei” nelle diverse stanze: la li-braria, collocata al momento del trasloco a Genova in casa del fratello Ottaviano, era posta “incamera”, “in salotto al muro” e “in salotto alla sbarra”. La scrittura sembra attribuibile allo stessoOttaviano (cfr. numerosi appunti in BCB, mr. III.4.13-14) ma presenta somiglianze anche conquella del nipote Gio. Luigi.
16. ASG, Notai antichi 6060. Nell’inventario dei beni redatto a Roma subito dopo la morte diDemetrio si fa riferimento a “casse quaranta otto di libri di medicina come per l’indice di manodi detto [Demetrio]” (Ibidem). Sull’uso dei termini “capsiae” e “plutei” cfr. ad esempio P. Petit-mengin, Recherches sur l’organisation de la bibliothèque Vaticane à l’époque des Ranaldi (1547-1645), in “Mélanges d’archéologie et d’histoire”, LXXV (1963), pp. 561-628. Nei rendiconticontabili del 1631 risultano acquistate 111 tavole per la nuova sistemazione.
L’esistenza di due cataloghi/inventari redatti a distanza talmente ravvici-nata di tempo potrebbe sembrare ridondante; ma così non è. Solo un lorostudio comparato e analitico (riga per riga) potrà in futuro dirci quanto siastato esaustivo il lavoro compiuto da Demetrio sul finire della sua vita, quan-to fu “perduto” in occasione del trasloco nella città natale e, infine, quantovi fu successivamente aggiunto, in primo luogo dalla dispersa collezione delfratello Ottaviano17. In confronto ad altre biblioteche di cui sono rimastisoltanto elenchi più o meno precisi, la fortunata e non consueta circostanzadella attuale presenza di un significativo numero di titoli (circa 2.400 ri-spetto ai più di 3.000 censiti nel 1630) permetterà un’adeguata valutazionedei diversi tipi di problematiche connesse al collezionismo librario tra Cin-que e Seicento18. Le diverse fonti si integrano a vicenda e aprono possibilitàdi ricerche ulteriori; in questa sede è stata affrontata quella relativa alla cen-sura e alle sue modalità di intervento (lasciando sullo sfondo il resto dellabiblioteca stessa).
3. Da un primo e sommario confronto del catalogo autografo con l’in-ventario “genovese” emerge qualche discrepanza: nel passaggio da Roma aGenova, infatti, un certo numero di titoli scomparve. Scorrendo l’index,pagina dopo pagina, risulta infatti che Demetrio aveva “schedato” anche iseguenti volumi, ad alcuni dei quali aveva parimenti aggiunto una brevissi-ma annotazione:
Hieronymi Cardani arithmetica et geometria practica.
la biblioteca disciplinata
871
17. Identificabile sia grazie agli inventari segnalati a nota 14 sia attraverso l’ex-libris, normal-mente un semplice monogramma impresso sul frontespizio, “OTC”. Nei diversi passaggi da unasede all’altra si inserì qualche altro volume: si considerino non solo quelli stampati dopo la mor-te di Demetrio (CFC 2434-2447), ma ad esempio la presenza di annotazioni di proprietà po-steriori: La geografia di Tolomeo (Venetia 1574, CFC 1633) non compare negli inventari e ripor-ta una nota di acquisto da parte di terzi, datata 1695.
18. Per una rassegna di studi in tema cfr. L. Ceriotti, Scheletri di biblioteche, fisionomie di lettori.Gli ‘inventari di biblioteca’ come materiali per una anatomia ricostruttiva della cultura libraria diantico regime, in Libri, biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, E. Barbieri e D. Zar-din (a cura di), Vita e Pensiero, Milano 2002, pp. 373-432; A. Nuovo, Le biblioteche private(sec. XVI-XVII): storia e teoria, in La storia delle biblioteche: temi, esperienze di ricerca, problemistoriografici, A. Petrucciani e P. Traniello (a cura di), A.I.B., Roma 2003, pp. 27-46.
rodolfo savelli
872
Hieronymi Cardani opus proportionum et de algebra.Nicolaus Copernicus de revolutionibus, correctus.Conradus Gesnerus de animalibus correctus et ex superiorum consensu permissus.Francisci Valessii sacra philosophia correctus.Hieronymus Cardanus de subtilitate, correctus.Hieronymus Cardanus de varietate, correctus.Io. Ludovicus Vives in lib. D. Augustini de civitate Dei, correctus.Iulius Caesar Scaliger in Theophrastum de plantis cum Arist. de plantis, correctus.Amati Lusitani centuriae medicinales.Andreas Libavius, contra unguentum armarium etc. correctus.Arnaldi de Villanova opera medica, correcta.Hieronimi Cardani de erroribus medicorum.Franciscus Hottomannus de verbis iuris, correctus19.
Ciò che accomuna questi testi e autori tra loro così eterogenei è il fattoche tutti (chi prima, chi dopo) erano stati messi all’indice – per diversi mo-tivi e in modi differenti. La condanna senz’altro più famosa (e una delle piùrecenti: 1616) era quella relativa al De revolutionibus di Copernico, benchéfosse uno dei testi più antichi (e al divieto era seguita, nel 1620, l’indica-zione dei passi da eliminare)20. Anche il De sacra philosophia del medico spa-gnolo Francisco Vallés era stato proibito nel 1603 con la clausola “donec
19. ILO, cc. 8v, 9r, 13r, 28r, 31v, 38v, 43v, 46v, 68v-69r, 81v, 111v. L’apparente mancanza diordine deriva dal fatto che i volumi erano collocati in diverse partizioni tematiche (cfr. supra).Non essendo presenti nell’inventario successivo è impossibile dire quali fossero le edizioni posse-dute. Come ho enunciato nel testo queste riflessioni sono il frutto di un primo sondaggio sul ca-talogo autografo; risultati quantitativamente e qualitativamente più significativi potranno veniresolo da un’analitica ricostruzione e comparazione dei due documenti.
20. Nel 1620 fu divulgato il Monitum ad Nicolai Copernici lectorem eiusque emendatio; sul temacfr. M.-P. Lerner, “Copernic suspendu et corrigé: sur deux décrets de la Congrégation romainede l’Index (1616-1620)”, in «Galilaeana», I (2004), pp. 21-89; F. Beretta - M.-P. Lerner, “Unédit inédit. Autour du placard de mise à l’Index de Copernic par le Maître du Sacre Palais Gia-cinto Petroni”, in «Galilaeana», III (2006), pp. 199-216. Le modalità con cui erano corrette leedizioni di Copernico sono analiticamente descritte da O. Gingerich, An Annotated Census ofCopernicus’ De Revolutionibus (Nuremberg, 1543 and Basel, 1566), Brill, Leiden 2002 (si veda-no in specie gli esemplari posseduti e/o provenienti da collezioni italiane, ma anche, ad esem-pio, quello appartenuto al collegio gesuitico di Vienna).
emendetur”, e già nel 1607 era stata pubblicata un’espurgazione (ma la proi-bizione sembra essere stata iterata nel 1618)21.
Una vecchia conoscenza degli ambienti inquisitoriali e della Congrega-zione dell’indice era invece Cardano. In Italia il primo divieto delle sue ope-re “quae de medicina non tractant” risaliva all’ottobre del 1572, in ritardo ri-spetto ad altri indici europei, ma ribadito poi, in modo non sempre univo-co, fino a quello romano del 1596; in quest’ultimo sono elencati singolar-mente alcuni titoli (come il De varietate e il De subtilitate) e poi, con la so-lita formula, “reliqua omnia, quae de medicina non tractant, nisi corrigan-tur”. La locuzione utilizzata comportava che, con un’interpretazione rigori-sta e forse un po’ lontana dalle intenzioni, anche i testi di matematica po-tessero essere esclusi da un eventuale permesso di lettura (soprattutto se con-tenevano “sconfinamenti” nell’astrologia)22.
Per quasi tutti gli altri titoli che hanno l’annotazione di “correctus” o “pur-gatus” risulta essere stata edita un’espurgazione nell’indice curato dal Maestrodel sacro palazzo nel 1607 e/o nello specifico opuscolo destinato ai libri di “me-dicina” del 1610 (Guanzelli aveva pubblicato una breve correzione anche al Deverbis iuris di Hotman, giurista che pure era stato collocato tra gli autori pri-
la biblioteca disciplinata
873
21. L’espurgazione fu edita nel volume curato da Giovanni Maria Guanzelli (Maestro del SacroPalazzo): Indicis librorum expurgandorum in studiosorum gratiam confecti tomus primus […] perFr. Io. Maria Brasichellen. Sacri Palatii Apost. Magistrum, Romae, Ex Typographia R. Cam.Apost., 1607, pp. 727-729 (e ivi anche il divieto del 1603), e fu ripubblicata in Expurgatio quo-rundam librorum medicorum prohibitorum, Taurini, Apud Io. Antonium Seghinum, 1610, c.[E4] nn. (sul frontespizio dell’opuscolo è specificato “iussu Santictiss. Inquisitionis divulgata”;cfr. G. Ottino - G. Fumagalli, Bibliotheca bibliographica italica, Roma 1889, n. 2118; su questivolumi vedi anche nota 154); per il 1618 cfr. ILI XI, p. 904. Sono ancora da valutare i motivisia dell’iterazione del divieto sia delle differenti censure che all’opera di Vallés furono pubblicatenel successivo indice spagnolo (Index librorum prohibitorum et expurgatorum Ill.mi ac R.mi D.Bernardi de Sandoval et Roxas, Madriti, apud Ludovicum Sanchez, 1612, p. 342; un cenno in J.Pardo Tomás, Ciencia y censura. La Inquisición Española y los libros científicos en los siglos XVI yXVII, CSIC, Madrid 1991, pp. 251-252).
22. U. Baldini, L’edizione dei documenti relativi a Cardano negli archivi del Sant’Ufficio e dell’in-dice: risultati e problemi, in Cardano e la tradizione dei saperi, M. Baldi e G. Canziani (a cura di),Angeli, Milano 2003, pp. 461 e ss; ILI IX, p. 937. Espurgazioni al De varietate e al De subtili-tate erano state pubblicate nell’indice espurgatorio del 1607 e nell’opuscolo del 1610 (cfr. notaprecedente), riprendendole da un precedente volume (a stampa?) non ancora identificato. PerCardano cfr. anche infra §§ 9-10.
rodolfo savelli
874
mae classis nel 1596)23. Una prima “eccezione”, se così può essere definita, èrappresentata dall’Historia animalium di Gesner (assente nelle opere espurga-torie) per la quale infatti Canevari aveva ottenuto una licentia specifica e, forsenon casualmente, aveva aggiunto quell’ulteriore nota (“ex superiorum consensupermissus”). Lo scienziato e bibliografo svizzero era inserito da tempo tra gliautori primae classis; il più duttile indice di Anversa del 1571, tuttavia, e pari-menti quello spagnolo del 1584 avevano collocato quest’opera tra quelle chepotevano essere concesse24. Una seconda eccezione è l’opera di Libavius: diquesto alchimista erano stati vietati altri testi, ma non questo (per il quale, co-me adesso si vedrà, aveva tuttavia chiesto egualmente il permesso)25.
Non è quindi da imputare a casualità il fatto che Canevari avesse regi-strato con precisione che Copernico o Vallés (così come i menzionati volu-mi e altri ancora di cui si discuterà) erano correcti. Per possedere legittima-mente libri proibiti era allora necessario un permesso di lettura (il consensus
23. ILI IX, p. 945; sull’accidentato percorso che portò all’inclusione di Hotman tra gli autoriprimae classis cfr. R. Savelli, The censoring of law books, in G. Fragnito (ed.), Church, censorshipand culture in early modern Italy, Cambridge UP, Cambridge 2001, pp. 228 e ss. Per un altrolessico giuridico umanistico posseduto da Canevari cfr. nota 118.
24. Per la licenza cfr. ACDF, SO, St. st. Q1b, c. 89r (7 giugno 1617). Per gli altri indici: ILI VII,p. 772 (“admissus […] nihil habet quod offendat”); VI, p. 993 (“permittitur”); l’elenco delle operedi Gesner permesse dall’indice spagnolo si trova anche tra i documenti ripubblicati nello Scrinio-lum Sanctae Inquisitionis Astensis, Astae, Apud Virgilium de Zangrandis, 1610 [1612?], p. 104 (sul-la circolazione di questo tipo di informazioni si veda anche infra nota 166); e cfr. A. Moreni, LaBibliotheca Universalis di Konrad Gesner e gli indici dei libri proibiti, in “La bibliofilia”, LXXXVIII(1986), pp. 143-144. Il De animalibus di Gesner risulta tra i volumi per i quali vi erano più richie-ste di autorizzazione: U. Baldini, Il pubblico della scienza nei permessi di lettura di libri proibiti delleCongregazioni del Sant’Ufficio e dell’Indice (secolo XVI): verso una tipologia professionale e disciplinare,in Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento, C. Stango (a cura di),Olschki, Firenze 2001, pp. 188, 194. E in effetti l’atteggiamento censorio tese successivamente, indeterminati contesti, a farsi meno oppressivo: l’esemplare appartenuto alla Casa professa della Com-pagnia di Gesù di Genova (apud Christoph. Froschoverum, Tiguri 1551-1554, ora BUG 3.L.IX.39-40) riporta la seguente annotazione: “In hoc libro nihil est contra fidem aut bonos mores; et rev.mus P.Inquisitor, a P. Aurelio a Calice consultus, censuit hunc et alios huiusmodi publice in bibliotheca haberiposse et ut haberentur facultatem dedit 6 maii 1636”.
25. Tractatus duo physici; prior de impostoria vulnerum per unguentum armarium sanatione Para-celsicis usitata commendataque, Francofurti, Excudebat Joannes Saur, impensis Petri Kopffii, 1594(e cfr. ILI XI, p. 548).
superiorum esplicitamente menzionato per Gesner) e, inoltre, che fossero“espurgati” secondo le disposizioni dei censori, o impegnarsi a farlo quandoqueste fossero state rese note.
Ciò risulta evidente confrontando le licenze degli anni Sessanta-Ottantacon quelle successive: nelle prime è esplicitamente previsto che colui cheavesse ottenuto tale autorizzazione (si veda, ad esempio, quella concessa aFrancesco Maria della Rovere nel 1577) “si contingerit aliquam censuram seucorrectionem dictorum librorum [...] in lucem prodire, debeat [...] iuxta dic-tam correctionem et censuram libros praedictos corrigere”; mentre in seguito sifa spesso menzione a “censure” che accompagnavano il permesso; in diversicasi si delega la ripulitura dei testi a chi ha ricevuto l’autorizzazione26. Laprassi sembra stabilizzarsi negli anni Venti del Seicento, quando diventanon inusuale trovare tra le carte inquisitoriali la seguente formula che ac-compagna spesso le licentiae legendi: “ea conditione ut corrigat eos quorumextat correctio in Indice expurgatorio edito Romae anno 1607 et nomina haere-ticorum deleat”27.
A disposizioni di questo tipo facevano riferimento due permessi del S.Ufficio indirizzati a Canevari quasi al tramonto della sua vita: uno nel 1620e un altro più corposo nel febbraio del 1623 (dopo che era stata stabilita unarevoca generale delle licenze). Gli era concessa un’autorizzazione per diversilibri proibiti alle condizioni sopra ricordate, per un triennio – “quo elapsolibros consignet S. Officio”28. Tre titoli corrispondono a quelli sopra menzio-
la biblioteca disciplinata
875
26. Una copia della licenza al della Rovere è conservata in Biblioteca Alessandrina Roma, Ms.269 (in appendice a una edizione dell’indice del 1596), e risulta aderente al formulario in uso inquei decenni (ringrazio gli amici Ugo Baldini e Leen Spruit di avermi fatto leggere una parte deidocumenti destinati all’opera da loro curata, Catholic Church and Modern Science. Documents fromthe Roman Archives of the Holy Office and the Index, in corso di pubblicazione). Sul problema sivedano anche le testimonianze ricordate successivamente (testo corrispondente a note 60 e 96).
27. ACDF, SO, St. st. Q1c, c. 79r. Il fatto che il S. Ufficio facesse riferimento all’indice espur-gatorio di Guanzelli (cit. a nota 21) è segno evidente della difficoltà in cui si muoveva la Con-gregazione, visto che sembra che quell’indice sia stato affossato anche su suo autorevole impul-so: in un documento che analizza i problemi della censura dopo l’indice clementino, in rappor-to alle diverse vie percorse dall’inquisizione spagnola, si annotava che quello di Guanzelli “man-dato romanae inquisitionis […] suspensus fuit” (ACDF, Index II/17, c. 6 e ss.).
28. ACDF, SO, St. st. Q1c, cc. 58v, 152v-153r. Per la revoca del 1622-1623 cfr. infra nota 184.
rodolfo savelli
876
nati come mancanti all’appello (Cardano Artihmetica, Libavius e Coperni-co)29; alcuni sono censiti nel suo catalogo e sono giunti fino a noi (Erastus,un Aristotele con il commento di Zwinger, Brunfels)30, diversi non risulta-no neppure nel catalogo autografo e si “persero per strada”31. Si autorizzavainoltre un’opera che (come quella di Libavius) sembra non essere stata vie-tata: il de magnete di William Gilbert32. Evidentemente era stata presentatala richiesta anche per queste; mentre, curiosamente, nel permesso non si facenno ai numerosi testi allora proibiti (e che pure Canevari possedeva) cherisultano oggi correcti: si sentiva protetto da altri precedenti permessi (seb-bene allora revocati)? Dissimulazione?
A questo punto diventa necessario cercare di spiegare perché i volumisopra elencati (e forse altri) non arrivarono mai a destinazione, o, in subor-dine, non furono inventariati dagli eredi. Questa seconda ipotesi sembrapoco verosimile. Da un lato, le opere vietate (ma permesse a Demetrio) era-no note agli organi censori romani grazie, anche, al catalogo stesso (comeora si vedrà); dall’altro, la biblioteca, una volta pervenuta a Genova, dove-va assumere un carattere “istituzionale” per i discendenti, e quindi non ave-va molto senso creare un tesoretto nascosto di libri proibiti (a differenza diquanto aveva fatto, ad esempio, Balthasar Moretus a metà Seicento)33. Almomento è impossibile offrire una soluzione unica. Si possono formulare,però, congetture tra loro non contraddittorie.
Partiamo innanzi tutto da una constatazione: nell’ultima pagina dell’au-tografo di Canevari è annotato il nulla osta a trasferire la biblioteca, con-cesso dal socio del Maestro del sacro palazzo (l’autorità competente in ma-
29. Per Copernico era specificato: “sublatis capitibus in quibus terra moveri secundum antiquosdocet”!! (corsivo mio).
30. CFC 238, 521 bis, 837.
31. Un erbario di Fuchs, il de offciis di Cicerone con note di Erasmo e Melantone, il Theatrumvitae humanae di Zwinger e Lycosthenes, M. Weinrich, De ortu monstrorum, 1595 (proibito conla clausola donec corrigatur il 12 marzo 1621), e poco altro.
32. Sulla pratica di chiedere permessi anche per opere non proibite o che potevano creare so-spetti cfr. infra.
33. L. Voet, The Golden Compasses. A History and Evaluation of the Printing and Publishing Acti-vities of the Officina Plantiniana at Antwerp, Vangendt, Amsterdam 1969, I, pp. 345-346.
teria a Roma): “extrahatur ab urbe fr. Andreas Biscionus praedicator generaliset socius R.mi patris Magistri Sacri Palatii Apostolici”34. Che il catalogo siapassato sotto gli occhi più o meno attenti dell’autorevole domenicano si puòdedurre altresì dal fatto che i margini e le pagine bianche dello stesso sonostate biffate da tratti di penna trasversali, in modo da impedire di aggiun-gere alcunché.
La sorveglianza sulle esportazioni da Roma doveva essere abbastanza ef-ficace. Nel 1619-1620, ad esempio, Girolamo Aleandro (segretario del car-dinal Bandini e in stretti rapporti con il cardinale Cobelluzzi) intendeva fargiungere a Peiresc la copia manoscritta di un commento di Valentin Naibo-da a Tolomeo (già appartenuto al Magini e allora nella biblioteca di Agesi-lao Marescotti); per evitare controlli progettava di affidarla a quella che og-gi potremmo definire la “valigia diplomatica” del chargé d’affaires francese(ed autorevole ecclesiastico) Denis Simon de Marquemont, in quanto era“necessario di dare in nota a censori del Santo Officio tutti i libri che si ca-vano di quà”; Aleandro aggiungeva: “io non ho dubbio alcuno, che questosarebbe trattenuto sotto pretesto che tratti d’astrologia giudiciaria, né co’frati ci valerebbe molto il dire che la fatica è sopra un autore antico”35.
la biblioteca disciplinata
877
34. Il permesso si trova ripetuto in un foglio sciolto allegato al volume. Andrea Biscioni non èricordato tra i “soci” di Nicolò Ridolfi da D.A. Mortier, Histoire des maîtres généraux de l’ordredes frères prêcheurs, A. Picard, Paris 1913, VI, p. 293, mentre è menzionato come “socio del se-gretario della congregazione dell’Indice” da I. Taurisano, Hierarchia Ordinis Praedicatorum, UnioTyp. Manuzio, Roma 1916, p. 115 nota. Sulle competenze specifiche del Maestro del sacro pa-lazzo in materia di libri a Roma e distretto cfr. G.B. De Luca, Relatio romanae curiae forensis, inTheatrum veritatis et iustitiae, XV, ex typographia Balleoniana, Venetiis 1759, pp. 245-246;S. Brevaglieri, Editoria e cultura a Roma nei primi tre decenni del Seicento: lo spazio della scienza,in corso di stampa in “Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Mediterranée” (ringraziol’autrice per avermene permesso la lettura in anteprima); più in generale cfr. G. Fragnito, Lacensura libraria tra Congregazione dell’Indice, Congregazione dell’inquisizione e Maestro del SacroPalazzo (1571-1596), in La censura libraria nell’Europa del secolo XVI, cit., pp. 163-177. Sulleconnessioni, non sempre limpide, che potevano venire a crearsi con il Maestro del sacro palazzorelativamente alla circolazione libraria, si veda il significativo documento pubblicato da M. Buc-ciantini, Contro Galileo. Alle origini dell’affaire, Olschki, Firenze 1995, pp. 72-73.
35. Correspondance de Peiresc & Aleandro, J.-F. Lhote e D. Joyal (a cura di), Clermont Ferrand,Adosa, 1995, II, p. 32 (e passim per il manoscritto in questione; gli interessi astrologici del Ma-rescotti emergono bene dalla licenza di lettura di libri proibiti in ACDF, SO, St. st. Q1b, cc. 15-17). Su Marquemont (già uditore di rota e allora arcivescovo di Lione) cfr. E. Cerchiari, Capel-
rodolfo savelli
878
D’altra parte le licenze di lettura di libri proibiti erano strettamente per-sonali, spesso avevano una validità limitata nel tempo (l’ultima sopra men-zionata rilasciata al medico genovese era triennale) e non potevano certopassare “automaticamente” agli eredi.
Già nella decima regola dell’indice tridentino (1564) era stato codificatoun controllo esplicito sulle successioni (poi costantemente ripetuto): come ilibrai dovevano sottoporre a controllo tutte le loro merci (e avere un indicedelle stesse)
idem quoque servetur ab heredibus et executoribus ultimarum voluntatum, ut libros adefunctis relictos sive eorum indicem illis personis deputandis afferant et ab eis licen-tiam obtineant, priusquam eis utantur aut in alias personas quacumque ratione eostransferant36.
La prescrizione fu da allora costantemente ripetuta in istruzioni, tratta-ti, costituzioni sinodali, in cui spiccano per il dettaglio e la cura quelle mi-lanesi di età borromaica37.
lani Papae et Apostolicae Sedis auditores causarum sacri palatii seu sacra rota romana [...] relatio hi-storica-iuridica, II, Roma 1920, p. 131; C. Pozzo di Borgo-Mouton-Brady, “Denis Simon deMarquemont archevêque de Lyon et cardinal (1572-1626). La carrière d’un prélat diplomate auSaint-Siège au début du XVIIe siècle”, in «Archivum Historiae Pontificiae», 15 (1977), pp. 265-294. La pratica non era certo nuova: cfr., ad esempio, P. de Nolhac, La bibliothèque de FulvioOrsini, Bouillon & Vieweg, Paris 1887, p. 77. Sul problema dell’astrologia cfr. infra § 9 e persegnalazioni di Naiboda cfr. nota 152.
36. ILI VIII, pp. 820-821.
37. Acta ecclesiae mediolanensis a B. Carolo Borromaeo […] condita, Mediolani, ex officina typo-graphica quond. Pacifici Pontii, 1599, pp. 89-90, 209, 345, 431-433 (nelle tabelle finali inseritedopo p. 1273, contenenti gli schemi di organizzazione della diocesi erano previste diverse figuredi deputati al controllo del mondo del libro, tra cui anche quelli che si dovevano occupare dei “li-brorum relictorum in hereditate”; ma mancano notizie più precise sulla realizzazione). Un inquisi-tore di Pavia ritornava più volte sul problema in un bando del 1567: R. Soriga, “Un regolamentodel Santo Ufficio per i librai pavesi”, in «La Bibliofilia», XV (1913-1914), pp. 51-53; per l’applica-zione dei dettati tridentini a Milano si veda C. Di Filippo Bareggi, Libri e letture nella Milano disan Carlo Borromeo, in Stampa, libri e letture a Milano nell’età di Carlo Borromeo, N. Raponi e A.Turchini (a cura di), Vita e Pensiero, Milano 1992, pp. 39-96. Sul tema in generale cfr. A. Posse-vino, Coltura de gl’ingegni, Vicenza, appresso Giorgio Greco, 1598, pp. 99-100; ulteriori indica-zioni in U. Rozzo, “Biblioteche e censura da Conrad Gesner a Gabriel Naudé”, in «Bibliotheca»,
La sorveglianza divenne sempre più puntuale e precisa: nel 1595 gli in-quisitori di Milano e di Vercelli ricordavano tutti i possibili casi di “incon-tro” con il libro, sottolineando in particolar modo i doveri di “dottori e stu-diosi”, i compiti dei gabellieri e dei librai (anche per quanto riguardava il“comprare o rivendere librarie vecchie”)38.
Nel 1596, alla pubblicazione del nuovo indice clementino, l’inquisitoredi Asti si lamentava del fatto che negli anni precedenti
essendo passati da questa vita presente diversi Dottori & altre persone che nelle lo-ro case havevano quantità de libri, né però furono mai consignati, né notificati alSanto Officio conforme a gl’ordini contenuti nelle Regole dell’indice antico39.
Dieci anni dopo il cardinale Federico Borromeo dettava meticolose pre-scrizioni in proposito (con una spiccata “sensibilità bibliografica”):
Commandiamo e ordiniamo alli heredi e essecutori di ultime volontà che […] deb-bano in termine d’un mese dal giorno della morte haver consignato ad alcuno di det-ti nostri Deputati e al […] R.P. Inquisitore l’indice delli libri lasciati nell’heredità,con il nome dell’Autore e Commentatori, delle stampe e tempo, e sottoscritto di lor pro-pria mano, e da loro ottenere licenza di potersene valere; e intanto non ardiscano leg-gere, usare, imprestare, vendere, o disporre in qual si voglia maniera di essi libri40.
la biblioteca disciplinata
879
2 (2003), pp. 47, 56; un rapidissimo cenno a controlli inquisitoriali su donazioni e acquisti dibiblioteche agli inizi del Seicento in V. Spampanato, “Nuovi documenti intorno a negozi e pro-cessi dell’Inquisizione (1603-1624)”, in «Giornale critico della filosofia italiana», V (1924), p.101. Il sistema sarà in uso ancora nel Settecento, applicato anche da autorità laiche: cfr. N. Her-mann-Mascard, La censure des livres à Paris à la fin de l’Ancien Régime (1750-1789), PUF, Paris1968, p. 78; R. Pasta, Editoria e cultura nel Settecento, Olschki, Firenze 1997, pp. 104-105.
38. Copie degli editti in Scriniolum Sanctae Inquisitionis, cit., pp. 641-643, 655-657; promul-gati in date differenti, 23 febbraio e 12 maggio 1595, sono però identici, palesando così la lorocomune origine. Anche nell’editto di pubblicazione dell’indice clementino a Novara si fa esplici-to riferimento a teologi, giuristi, medici “et ogni altro professore di lettere et ogn’uno che ha li-breria” (C. Bascapé, Scritti publicati nel governo del suo vescovato dall’anno 1593 fino al 1609, Ap-presso Girolamo Sesallo, Novara 1609, p. 474).
39. Scriniolum Sanctae Inquisitionis, cit., p. 164.
40. Ivi, p. 661 (corsivo mio).
rodolfo savelli
880
Passa non molto tempo e proprio dalla città ambrosiana veniva lanciatoun nuovo allarme che fornì il destro per un’altra sospensione delle licenzedi lettura41.
Nel caso della libraria del medico genovese, quindi, nonostante la pri-ma autorizzazione all’esportazione, potrebbe esservi stato un successivo efinalizzato intervento, con conseguente sequestro. In effetti sono ancorascarse le conoscenze sulle procedure effettivamente in atto nelle diverse cit-tà italiane42.
Per quanto riguarda Roma vi sono testimonianze coeve significative econgruenti con quanto accaduto alla collezione di Canevari.
Nel 1624, alla morte del “linceo” Virginio Cesarini, un altro membrodell’accademia, Johann Faber, esortava il principe Federico Cesi a trovare“tutti i modi che noi ricuperiamo li libri del Sig.r Don Virginio, se vero èche l’habbia lasciato all’Accademia nostra, et bisognerà anche procurare chehabbiamo la licenza delli prohibiti, che li Frati non li castrino”43.
Di lì a poco ciò accadde proprio alla biblioteca dello stesso Faber: al mo-mento della redazione dell’inventario post-mortem dei beni fu dapprima an-notato che “tutti li libbri essistenti in detto studio sono stati dal fiscale delMonsignor Reverendissimo Maestro del Sacro Palazzo rinchiusi in un cam-merino dentro la cammera della bona memoria del signor Giovanni, ratio-ne officii”, e quindi “non si possono descrivere”; l’inventario dei libri fu fat-to solo dopo che furono identificate le opere da requisire, quelle che “la bo-
41. Nel 1630 Giovanni Michele Pio scriveva da Milano: “le licenze date ad triennium costì ditenere libri prohibiti, giornalmente sono spirate et spirano, né si vedono che li portino al tribu-nale […] et ne moiono anco di questi facilmente e restano simili libri in mano delle heredi, chenon hanno licenza né di leggerli né di tenerli” (ACDF, SO, St. st. O2c, c. 227; e cfr. Frajese,Nascita dell’Indice, cit. p. 219).
42. Nel 1611, ad esempio, fu aperto un procedimento contro librai napoletani perché avevanoacquistato la biblioteca di Nicola Antonio Gizzarelli e ne avevano venduto una parte senza averesibito l’elenco al deputato della curia arcivescovile (Biblioteca Nazionale Napoli, Ms. XI.AA.23,cc. 254 e ss).
43. G. Gabrieli, Il carteggio linceo della vecchia accademia di Federico Cesi 1603-1630), in “Me-morie della Accademia Nazionale dei Lincei. Cl. di Scienze morali, storiche e filologiche”,s. VI, vol. VII (1938-1942), p. 876. Sul testamento di Cesarini cfr. Id., Bibliografia lincea. II.Virginio Cesarini e Giovanni Ciampoli, in “Rendiconti della R. Accademia nazionale dei Lincei.Classe di Sc. Morali, storiche e filologiche” s. VI, vol. VIII (1932), p. 446.
na memoria del sig.r Giovanni poteva in vita ritenere” (non diverse, cometipologia, da quelle “scomparse” dalla libraria di Canevari sopra ricordate ealtre che menzioneremo poi: Gesner, Patrizi, Telesio, Cardano, Scaligero,Luciano di Samosata, Junius)44.
La medesima sorveglianza fu pure attivata per la collezione di Cesi: èsempre un delegato del Maestro del sacro palazzo a sottoscrivere l’inventa-rio dei libri ed è Niccolò Riccardi (il padre “mostro”) ad autorizzarne la ven-dita, dopo l’individuazione di quelli da escludere45.
Nei primi decenni del Seicento fortissima era l’attenzione verso tutto ciòche poteva essere considerato come un segno di non-allineamento rispettoall’ortodossia tridentina e “peripatetica”, e verso il copernicanesimo in par-ticolare, anche se il comportamento delle autorità censorie non era sempreimprontato a una piena uniformità46.
la biblioteca disciplinata
881
44. BACR, Archivio di S. Maria in Aquiro 412, cc. 49r, 138r (corsivo mio). L’elenco fu segnalatoda G. Gabrieli, L’archivio di S. Maria in Aquiro o «degli Orfani» e le carte di Giovanni Faber, in “Ar-chivio della Società Romana di Storia Patria”, LI (1928), pp. 61-77; cfr. S. De Renzi, La bibliotecadi Johann Faber linceo, in Bibliothecae selectae. Da Cusano e Leopardi, E. Canone (a cura di), Ol-schki, Firenze 1993, pp. 518-519; G. Miggiano, “Libri prohibiti”: qualche appunto dalle carte di Jo-hannes Faber Lynceus Bambergensis, in L’organizzazione del sapere, cit., pp. 245-273. Tra le operefermate dal socio del Maestro del sacro palazzo vi sono anche autori non all’indice, come, ad esem-pio, Sigonio, da tempo “sospetto”: cfr. in proposito le considerazioni di P. Prodi, Il cardinale Ga-briele Paleotti (1522-1597), Storia e Letteratura, Roma 1959-1967, II, pp. 257 e ss.; W. McCuaig,Carlo Sigonio. The changing world of the late Renaissance, Princeton UP, Princeton 1989.
45. BACR, Archivio linceo, mss. antichi 13, cc. 59r, 124r, 125r, 210r; a cc. 119r-120v sono indi-cati alcuni volumi trattenuti dal Maestro del sacro palazzo: in questo brevissimo elenco (che, pe-rò, non è detto comprenda tutti quelli eccettuati dall’autorizzazione) è presente l’opera botanicadi Fuchs, e poi gli Adagia di Erasmo/Manuzio, qualche trattato astrologico, e poco altro. La do-cumentazione descritta da G. Gabrieli, La prima biblioteca lincea o libreria di Federico Cesi, in“Rendiconti della R. Accademia nazionale dei Lincei. Classe di Sc. Morali, storiche e filologi-che”, s. VI, vol. XIV (1938), pp. 614-615, è stata ripresa da A.M. Capecchi, Per la ricostruzionedi una biblioteca seicentesca: i libri di storia naturale di Federico Cesi, in “Atti della Accademia Na-zionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di Sc. Morali, storiche e filologiche”, s. VIII, vol. XLI,1987, p. 151; M.T. Biagetti, La biblioteca di Federico Cesi. Un progetto di ricostruzione, in Biblio-teche private in età moderna e contemporanea, cit., pp. 95-103.
46. Su alcuni aspetti del clima culturale di quegli anni cfr. Rotondò, La censura ecclesiastica, cit.,pp. 1461 e ss; P. Redondi, Galileo eretico, Einaudi, Torino 1983, pp. 135 e ss. (e a pp. 333-336cenni alle biblioteche di Cesi e di Giovanni Ciampoli; sul saggio cfr. V. Ferrone - M. Firpo, “Ga-
rodolfo savelli
882
D’altro canto è parimenti legittimo supporre (pur in assenza di riscontridocumentali) che i libri sopra ricordati come “scomparsi” siano stati tratte-nuti dall’inquisitore locale, una volta giunti a Genova. Nel 1595, ad esem-pio, gli inquisitori di Milano e Vercelli non ammettevano per valide liste“sottoscritte da gl’inquisitori di quelle città di dove [i libri] son partiti”. Sisa tuttavia ancora troppo poco sulle pratiche di controllo periferico per az-zardare ulteriori ipotesi47.
Responsabile dell’ufficio nella città ligure era allora il ben noto EliseoMasini, che nel 1620 si era potuto vantare di aver bruciato negli anni pre-cedenti “cinque o sei mila pezzi di libri”48. Proprio in quei decenni gli ac-quisti e la biblioteca stessa di un personaggio di “qualità” (Gio. FrancescoBrignole, futuro doge della Repubblica) furono sottoposti a ispezioni e de-pauperamenti in più riprese. In occasione di cospicui arrivi di volumi pro-venienti da Parigi (1609-1611), egli annotò di aver “mandato all’inquisito-re” l’atlante del Mercatore, le Historiae di de Thou e il Theatrum di Zwin-ger; nel 1624 appuntò in un libro di contabilità quali fossero i volumi “inmano del P. Inquisitore”: alcuni risultavano nei precedenti elenchi, ma sene erano aggiunti dei nuovi, prova evidente del fatto che si era compiutoun ulteriore e più penetrante controllo49.
lileo tra inquisitori e microstorici”, in «Rivista Storica Italiana», XCVII, 1985, p. 187 e ss); M.-P. Lerner, L’«herésie» heliocentrique: du soupçon à la condamnation, in Sciences et religions de Co-pernic à Galilée (1540-1610), Actes du Colloque international, École Française de Rome, Roma1999, pp. 69-91; Id., Copernic suspendu, cit.
47. Cfr. nota 38; Gigliola Fragnito mi ha cortesemente segnalato un documento da cui, invece,risulta che il controllo avrebbe dovuto essere fatto proprio nella città di partenza (ACDF, IndexXIX/1, cc. 155r, 167v). Tale pratica doveva essere diffusa: cfr. S. Brevaglieri, Il cantiere del Teso-ro Messicano tra Roma e l’Europa, in Id. [et al.], Sul Tesoro Messicano e su alcuni disegni del Mu-seo Cartaceo di Cassiano dal Pozzo, Ed. dell’Elefante, Roma 2007, p. 13.
48. Fragnito, Proibito capire, cit., p. 225.
49. Non tutti i volumi requisiti tra il 1611 e il 1624 tornarono in possesso dei Brignole Sale (Car-dano, ad esempio, sparì completamente) nonostante fosse poi riuscito a ottenere un permessotriennale dal S. Ufficio (ACDF, SO, St. st. Q1d, c. 5r). Col Settecento la biblioteca si aprì allacultura illuministica, ma in occasione del passaggio al municipio di Genova, nel 1875, fu prepa-rato un catalogo separato dei “libri proibiti” allora presenti, demandando alle autorità ecclesia-stiche l’ultima parola in proposito: le fonti sono indicate in L. Malfatto, La Biblioteca BrignoleSale-De Ferrari: note per una storia, in I duchi di Galliera: alta finanza, arte e filantropia tra Ge-
Dalla lettura dell’Index librorum omnium di Canevari (e dal confrontocon esperienze coeve) si può, quindi, trarre una prima, significativa, infor-mazione: il controllo sulle biblioteche private non era meramente enuncia-to in prescrizioni poco o punto rispettate, ma, almeno in questo periodo,era operante in modo tangibile, puntuale e tempestivo.
Il medesimo documento aggiunge, poi, un piccolo (ma nuovo) tassello,utile sia alla valutazione della contrastata circolazione di Copernico nell’Ita-lia cinque-seicentesca, sia all’apprezzamento degli interessi diffusi nei con-fronti della letteratura astronomica da parte del medico genovese (già am-piamente individuabili in base ai libri rimasti). Se si considera che nella bi-blioteca sono a tutt’oggi conservati altri testi di Keplero e di Galilei (ma nonpiù Il saggiatore ancora presente nel 1630), così come molte opere dei criti-ci, meglio si apprezza il valore dell’ultima fatica di Canevari.
4. Lo stesso Index permette, inoltre, di affrontare un altro genere di pro-blemi. Vi sono elencati due (apparenti) “misteri” bibliografici; ma il mistero èfacilmente risolvibile. Demetrio riportò infatti tra i libri da lui posseduti:
Ioachimi Schilerii, HerbariumDonatus Lucidus, De occultis medicamentorum proprietatibus50.
Le informazioni presenti nel successivo inventario (vale a dire che l’uno erastampato a Strasburgo nel 1539 e l’altro a Basilea nel 1574) hanno permesso disciogliere facilmente l’enigma. Il primo autore è Otto Brunfels e il secondo Tho-mas Erastus, ben noti medici e naturalisti appartenenti al mondo riformato.
Se dai cataloghi si passa ai volumi ancor oggi conservati risulta evidenteche si è di fronte a una “correzione” finalizzata all’occultamento dei nomi;in questa circostanza non si è in presenza di una mera cancellazione (cosìstabilivano regole e consuetudini censorie). Il caso più interessante e curio-so è senz’altro quello dell’erbario di Brunfels, in cui spicca un frontespiziovariamente manomesso: un lembo contenente il nome dell’autore è stato
la biblioteca disciplinata
883
nova e l’Europa nell’Ottocento, G. Assereto et al. (a cura di), Marietti, Genova 1991, II, pp. 935-989; Ead., Alcuni acquisti di libri effettuati da Gio. Francesco Brignole tra il 1609 e il 1611, in “LaBerio”, XXXIV (1994), n. 2, pp. 33-66.
50. ILO, cc. 74r, 91r.
rodolfo savelli
884
reciso e sostituito con una linea di parole a stampa, de vera herbarum cogni-tione, tratta dall’indice completamente caduto della seconda parte; primadel titolo è stato incollato un cartiglio con la scritta Ioachymus Schyllerus,ritagliato sempre dallo stesso indice, e aggiungendo la dicitura Medici Ger-mani Brandeburg. (tolta da altre pagine). Originario del Brandeburgo nonera in realtà Schiller, bensì Leonhart Fuchs – altro illustre naturalista rifor-mato, il cui nome è stato eliminato là dove compariva (così come quello diBrunfels); per Erastus le modifiche furono fatte più semplicemente a pen-na, nel frontespizio e nel testo [figg. 3-4]51.
Un trattamento analogo (sia pure in modo meno complicato) subì un’edi-zione dello stesso Fuchs, De humani corporis fabrica epitomes: per occultare ilvero autore, sul frontespizio erano state incollate singole lettere a stampa inmodo da comporre Andreae Vessalii [fig. 5], prendendo ispirazione dal fattoche Vesale aveva in effetti pubblicato un libro con identico titolo, e un’esiletraccia di questa manomissione è rimasta nel catalogo autografo, visto cheCanevari aveva così descritto il volume: “Andreae Vessalii epitomes anatomiaeper L. F.”52. Nell’esemplare è caduta inoltre la lettera dedicatoria in cui figu-rava il nome di Johann Winther von Andernach, visto che, come aveva rile-vato un censore romano, “de humani corporis fabrica epitome, Lugduni, apudAntonium Vincentium 1551: in epistola ad lectorem pag. 7 deleatur IoannesGuintherius Andornatus [!] haereticus primae classis”53.
Alla fine di entrambi i volumi (Brunfels e Fuchs) si trova la seguente an-notazione manoscritta: “die 4a iulii 1576 deletis delendis permittitur Vicarius
51. CFC 521 bis (nel volume sono state tolte anche le pagine iniziali delle singole parti, con de-diche e indici); CFC 837.
52. ILO, c. 20r (nell’inventario “genovese” è descritta sotto il nome del medico belga senza altraannotazione; anche alla pagina 14, che è stata incollata sul verso del frontespizio, ritorna questopatchwork di singole lettere componenti il nome di Vesale); CFC 939.
53. ACDF, Index II/5, c. 120v. Il censore tramandava una conoscenza non “ufficiale” (e pur verae diffusa), perché Winter von Andernach è presente negli indici solo sotto lo pseudonimo di IonasPhilologus, ragion per cui altri libri della raccolta Canevari in cui compare il nome dell’Andernacussono intatti (e ancor più numerosi erano quelli posseduti in origine e successivamente dispersi).Vi era tuttavia chi si sentiva in obbligo di chiedere l’autorizzazione per i suoi scritti: Baldini, Ilpubblico della scienza nei permessi di lettura, cit., p. 186. Ionas Philologus è ricordato da Gregorioda Napoli come editore di Galeno (cfr. testo corrispondente a nota 116), forse sulla scorta di C.Gesner, Bibliotheca universalis, apud Christophorum Froschoverum, Tiguri 1545, p. 465.
Inquisitoris Papiae” (testimonianza di un possibile passaggio di Canevaripresso lo studio pavese).
Fuchs rappresentò uno dei “casi” esemplari per la censura: nel 1558-1559era stato inserito tra gli autori di cui erano vietati gli “scripta omnia” (nel1564 era collocato nella categoria “primae classis”), ma le sue opere medichee botaniche erano molto richieste. Nel 1566 Gabriele Paleotti, appena inse-diato nella diocesi di Bologna, osservava: “essendo questa terra di studio ciserano infiniti che hanno […] il Fuchsio, et simile sorte de libri che hannoli scolari […] quali se s’haveranno da levare a tutti, non essendo ancoraespurgati, serà con confusione grandissima”54. Ancora nel 1600 (in una par-ticolare congiuntura di controllo delle biblioteche private) l’inquisitore diAsti annotava a proposito di Fuchs: “prohibito nella prima classe già anti-camente, con tutto ciò si è trovato quasi in ogni parte permesso, come mol-ti ne sono stati appresentati con sottoscritioni d’Inquisitori, […] et i medicifanno grande instantia che li siano permessi”55.
Se si considerassero censurati solo i volumi che sono descritti come talida Canevari nell’index autografo, saremmo in presenza di un numero in ve-
la biblioteca disciplinata
885
54. Prodi, Il cardinale Gabriele Paleotti, cit., II, p. 238 nota.
55. Scriniolum Sanctae Inquisitionis, cit., p. 172 (corsivo mio). Indizi del successo di Fuchs nellacultura italiana del ’500 (oltre ad alcune precoci edizioni veneziane) sono sia, ad esempio, l’ele-vata presenza di sue opere in una biblioteca come quella di Girolamo Mercuriale (cfr. infra nota180) sia il numero di espurgazioni allora circolate. Se ne ricordano manoscritte (cfr. A. Roton-dò, Nuovi documenti per la storia dell’“Indice dei libri proibiti” (1572-1638), in “Rinascimento”,s. II, 3, 1963, pp. 160, 169; Catholic Church and Modern Science, cit.) e a stampa: una pubbli-cata in due occasioni, vale a dire in appendice a un’edizione dell’indice del 1564 (Alexandriae,apud Herculem Quinctianum, 1585, c. 27) e in appendice di Annotatio librorum prohibitorum,& eorum qui suspensi fuerunt usque ad novam expurgationem Sanctiss. universalis Inquisitionis, snt.(ma probabilmente stampata sempre ad Alessandria lo stesso anno; questa Annotatio è un vero eproprio opuscolo, diverso quindi dal foglio volante del 1580, riedito in ILI IX, pp. 750-751) eripresa in Scriniolum Sanctae Inquisitionis, cit., p. 89; un’altra ripresa pari pari dall’indice espur-gatorio spagnolo del 1584 (riedita sempre in Scriniolum Sanctae Inquisitionis, cit., p. 304, doveè annotato: “R.P. Inquisitoris mandato impressa”, segno della probabile derivazione da una stam-pa autonoma); altre ancora, frutto della rielaborazione delle precedenti, videro la luce nel 1607e nel 1610 (cfr. supra nota 21). Gli stessi censori romani, inoltre, avevano stilato a metà deglianni Ottanta del Cinquecento un elenco delle opere dello stesso Fuchs “quae non egent expurga-tione et tollerari possunt” (ACDF, Index II/5, cc. 121v-122r). Su Fuchs cfr. anche testo corrispon-dente a nota 60.
rodolfo savelli
886
rità molto piccolo: oltre a quelli sopra segnalati, infatti, ben pochi altri ri-portano simili annotazioni. In realtà il fenomeno è molto più esteso, comesi avrà modo di vedere. L’indicazione di correctus o purgatus fu scritta pro-babilmente solo per gli autori presenti nell’indice del 1596, espurgati poinel 1607, o per quei titoli verso i quali l’attenzione era particolarmente vivanegli anni Venti del Seicento.
5. Le precedenti considerazioni sono servite a delineare lo sfondo entrocui va collocato il tema che s’intende esaminare, vale a dire come interagivala biblioteca di un privato – un medico dai vasti interessi culturali – con ilmondo della censura ecclesiastica (nel momento forse della sua massimaespansione), partendo proprio dalle tracce fisiche che questa ha lasciato suivolumi. Di quelli probabilmente requisiti (Copernico, Cardano, Hotmame gli altri sopra ricordati) resta il ricordo solo grazie al catalogo autografo56.
Non si pensi, per altro, che questa raccolta sia stata così “marcata” per-ché Demetrio viveva a Roma, all’ombra del cupolone, in stretti rapporticon la corte pontificia. Quella del fratello Ottaviano sembra aver subitoesattamente lo stesso trattamento (almeno per quei pochi esemplari verifi-cabili)57. Roma o Genova, Milano o Salerno, non fanno differenza in que-st’epoca, come dimostra la quantità di esemplari correcti conservati nellecollezioni italiane (e non solo italiane)58.
56. Cfr. le interessanti annotazioni di U. Rozzo, Il rogo postumo di due biblioteche cinquecentesche, inBibliologia e critica dantesca. Saggi dedicati a Enzo Esposito, Longo, Ravenna 1997, I, pp. 161-186.
57. Provengono dalla biblioteca di Ottaviano le opere di Arnaldo da Villanova (CFC 318) e ilDe curatione per sanguinis missionem di Galeno edito da Fuchs (CFC 960): il nome del medicotedesco è stato ovunque depennato, mentre al volume di Villanova sono state tagliate diverse pa-gine (e nell’indice sono stati coerentemente cancellati i titoli corrispondenti); sul frontespizio èannotata la data: “deleta fuerunt delenda 1598” (sul perché di questa data cfr. infra § 7; mentreper i criteri seguiti nell’espurgazione cfr. nota 166). Villanova entrò a far parte della collezionein seguito alla morte di Ottaviano, visto che non è presente nell’inventario fatto attorno al 1630;mentre l’opera originariamente posseduta da Demetrio è oggi da considerarsi perduta, essendoda annoverare tra quelle presuntivamente sequestrate nel 1625 (cfr. supra nota 19).
58. Si veda ad esempio il catalogo della mostra Censura e libri espurgati. Le cinquecentine dellaBiblioteca Provinciale di Salerno, in Dal Torchio alle fiamme. Inquisizione e censura: nuovi contri-buti dalla più antica Biblioteca Provinciale d’Italia, V. Bonani (a cura di), Biblioteca Provinciale,Salerno 2005 (con un ricco apparato iconografico); interessanti documenti relativi alla Bibliote-
Lo studio di una biblioteca e dei suoi libri può avvenire a livelli differen-ti: il testo, il paratesto (gioia dei bibliologi di oggi, cruccio dei censori diun tempo), le postille59. I libri espurgati, in realtà, non hanno propriamen-te delle postille (a parte l’eventuale annotazione che segnala se, e quando,sono stati corretti); sono dotati – si potrebbe dire – del loro opposto, vistoche l’intervento dei correttori si traduce di solito in un’azione demolitricee/o abrasiva: tagliano frontespizi, pagine, colonne; incollano strisce di cartabianca, cancellano righe.
Ogni singolo esemplare espurgato avrebbe dovuto riportare la sottoscri-zione di chi aveva eseguito l’intervento, come si è ricordato sopra per Brun-fels [fig. 6] e Fuchs (e come ricordava l’inquisitore di Asti). Molto spesso,però, tale indicazione è assente, per cui è ipotizzabile che nella realtà di tut-ti giorni ciò fosse effettuato, seguendo le prescrizioni censorie, da soggettidi volta in volta diversi: il singolo possessore, magari il libraio stesso, anchese tale procedura non era sempre considerata legittima. In proposito è inte-ressante la deposizione di un medico (Giuseppe Perrotta) processato a Na-poli nel 1585 per il possesso di libri proibiti:
Interrogatus an sciverit posse emendari et cassari libros absque licentia superioris et asemetipso – Respondit: che benché alcuno da se stesso cassasse il libro, nondimenoesso giudica che non sia valido perché non ci è licentia del superiore, ma si benedicendo il superiore cassa quello et cassa questo altro, credo che se possa legere cas-sato che è.
Per quanto si può dedurre dagli atti pubblicati, uno dei problemi era co-stituito proprio dal possesso di opere (proibite) “emendate et non concesse”(tra cui testi di Fuchs e di Brunfels), benché l’imputato potesse portare a
la biblioteca disciplinata
887
ca Ambrosiana di Milano sono stati pubblicati da C. Pasini, Il progetto biblioteconomico di Fede-rico, in Federico Borromeo fondatore della Biblioteca Ambrosiana, F. Buzzi e R. Ferro (a cura di),in “Studia Borromaica”, 19 (2005), pp. 259 e ss.
59. Cfr. Talking to the text: marginalia from papyri to print, ed. by V. Fera, G. Ferrau, S. Rizzo,Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2002 (in specie M. Campanelli, Scri-vere in margine, leggere il margine: frammenti di una storia controversa, II, pp. 922 e ss.) oppureLibri a stampa postillati, Atti del Colloquio internazionale, E. Barbieri e G. Frasso (a cura di),CUSL, Milano 2003.
rodolfo savelli
888
sua difesa che, per alcune, “don Francesco Lombardo cassa il nome delli au-tori de questi libri [Fuchs e Cardano] et dà licenza che si possano leggere sicome anco lui l’ha detto a me”60.
Nella catalogazione di singole collezioni, quindi, è di grande utilità ave-re a disposizione informazioni di tal genere, in quanto consentono una mi-gliore comprensione sia di percorsi censori sia di atteggiamenti culturali (deipossessori, dei lettori, dei controllori)61.
60. L. Amabile, Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli, Lapi, Città di Castello 1892, II,appendice, pp. 48-50; su Lombardo cfr. nota 116.
61. Riflettendo autocriticamente sul lavoro compiuto più di trent’anni or sono, risulta evidentecome le schede del CFC, in stringato stile short-title, non riportino informazioni che, con gliocchi di oggi, riterrei del tutto indispensabili (habent sua fata catalogi); sul problema in generalecfr. le considerazioni di E. Barbieri, Il libro nella storia. Tre percorsi, CUSL, Milano 2000,p. 225 e ss. Mi sembrano invece “peculiari” le critiche di L. Ceriotti (Scheletri di biblioteche, cit.,pp. 415-416 nota), a incominciare dal fatto che imputa al catalogo una “veste catalografica” (!?),e mi addebita il fatto di non aver tenuto conto di “esemplari canevariani in altre biblioteche del-la penisola”. Ceriotti cita in proposito uno studio di Antonio Bellucci; questo riguarda notoria-mente (e come si potrebbe evincere già dal solo titolo) le “legature erroneamente dette Caneva-ri”, non volumi appartenuti al medico genovese: Di ventisei legature adèspote ORQWS KAI MH
LOXIOS erroneamente dette Canevari dell’Oratoriana di Napoli, Napoli 1930; del Bellucci si sa-rebbe potuto ricordare anche il saggio che riassumeva allora la questione, prima degli studi diHobson (cfr. nota 119): Nuove ricerche e conclusioni sulle preziose legature cinquecentesche ORQWS
KAI MH LOXIOS, erroneamente dette Canevari, in Studi di bibliografia e storia in onore di Tam-maro de Marinis, cit., I, pp. 49-89. Il mio (dis)attento critico, poi, colloca Giuseppe Fumagalli(Firenze 1863-1939) tra gli “studiosi liguri”, trasforma Ottaviano (fratello di Demetrio) in suofiglio, attribuisce un “ricca biblioteca” al padre Teramo (di cui per il momento nulla sappiamo,in termini quantitativi e qualitativi, a parte il fatto che possedeva libri). Qualche maggiore dili-genza avrebbe probabilmente evitato così tante sviste in una sola nota; e un po’ più di “sensateesperienze” sulle fonti, e meno culto delle auctoritates, gli avrebbe inoltre permesso di non ripe-tere il consueto errore di identificare in Antonio Querenghi il proprietario della biblioteca il cuicatalogo è conservato tra le carte di Giovanni Vincenzo Pinelli (BAM S.77 sup). L’equivoco ri-sale probabilmente all’inventario Ceruti, e fu ripreso dal Catalogo dei codici pinelliani dell’Am-brosiana curato da A. Rivolta (Tip. Pontificia Arcivescovile, Milano 1933, p. 139): per una fret-tolosa lettura dell’indice iniziale del manoscritto, un “cuiusdam” è stato scambiato per un “eiu-sdem”, e così Querenghi, oltre che autore di uno scritto contenuto nella miscellanea, è diventatoanche il proprietario della biblioteca elencata alla riga successiva dell’indice; oltre a questo datodi fatto si vedano le considerazioni di Angela Nuovo, relative al contenuto dell’inventario stesso(cfr. la recensione agli studi di U. Motta in “Bibliotheca”, 2, 2003, 1, pp. 307-311; R. Savelli,Giuristi francesi, biblioteche italiane. Prime note sul problema della circolazione della letteraturagiuridica in età moderna, in Manoscritti, editoria e biblioteche dal Medio Evo all’Età contempora-
6. La vita di Demetrio Canevari e la costruzione della libraria si colloca-no sostanzialmente entro date significative della storia della censura eccle-siastica. Nell’anno in cui nacque (1559) era stato appena pubblicato l’indicedei libri proibiti curato dall’Inquisizione, cui seguì quello progettato al Con-cilio di Trento, edito a Roma nel 1564; nel 1590 e nel 1593 ne furono stam-pate due nuove redazioni, che però non furono promulgate; nel 1596 – do-po un lungo e tormentato iter – vide la luce il nuovo indice romano, volutoda Clemente VIII. Nel frattempo (tra 1574 e il 1589) erano state diffuse di-verse liste di aggiornamento; non meno importanti, per le influenze che eb-bero anche in Italia, furono gli indici varati nei domini iberici (sia in Spa-gna sia nei Paesi Bassi)62.
Per cogliere l’estensione del fenomeno censorio, inoltre, non basta limi-tarsi ai soli autori e titoli individualmente menzionati negli elenchi ufficia-li; bisogna tenere presenti i divieti contenuti in altre fonti: ad esempio bollepontificie (si veda in particolare quella di Sisto V contro l’astrologia del1586), deliberati conciliari, le regole generali premesse a ciascun indice63.
Dopo il 1596, vivente Canevari, furono pubblicate solo singole liste conaggiunte più o meno lunghe: continuavano, infatti, ad uscire libri nuovi eal contempo se ne ripescavano di “vecchi”, reputati ora degni di interdizio-ne totale o parziale (“donec corrigatur”). Nel 1616, poi, vi fu la già menzio-nata condanna delle teorie che negavano il geocentrismo.
Avendo presente questo assieparsi di norme e disposizioni (talvolta par-zialmente divergenti) si può meglio capire la molteplicità dei segni che tro-viamo sui volumi rimasti. La biblioteca si è formata tra gli anni Settanta del
la biblioteca disciplinata
889
nea, Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, M. Ascheri - G. Colli(a cura di), Roma nel Rinascimento, Roma 2006, III, p. 1245).
62. Tutti riediti in ILI. D’altronde già nel 1593 era stato pubblicato l’Index librorum expurgan-dorum ex hispano, et lovaniensi indice collectus, per uso esclusivamente interno alla Congregazio-ne dell’indice, ma che, si sa, ebbe una qualche circolazione anche fuori Roma: R. Savelli, “Alloscrittoio del censore. Fonti a stampa per la storia dell’espurgazione dei libri di diritto in Italia traCinque e Seicento”, in «Società e storia», XXVI (2003), pp. 319 e ss. Per l’utilizzo in Italia degliindici spagnoli cfr. ad esempio note 55, 131, 166.
63. Per l’acceso dibattito che accompagnò la stesura delle regole degli anni Novanta del Cinque-cento, cfr. la ricostruzione di V. Frajese, “La politica dell’Indice dal tridentino al clementino(1571-1596)”, in «Archivio italiano per la storia della pietà», 11 (1998), pp. 269-356.
rodolfo savelli
890
Cinquecento e il 1625 (il testo più recente conservato è del 1624)64. Mol-tissimi furono acquistati in quello che (più o meno propriamente) si puòdefinire il mercato dell’“usato”: sono ancora presenti un centinaio di incu-naboli, e le sole pubblicazioni edite tra il 1501 e il 1559 assommano attual-mente a più di ottocento. Questo significa che, quando Canevari compravaun libro, poteva entrare in possesso di un’opera che era stata censurata inperiodi precedenti, seguendo criteri magari non più in uso65.
Viceversa, è pensabile che lui stesso (o un imprecisato collaboratore delMaestro del sacro palazzo) intervenisse su singoli volumi anche molti annidopo che erano presuntivamente entrati a far parte della biblioteca. Oltre alcaso sopra ricordato di Copernico (la “correzione” poteva essere stata fattasolo successivamente al 1620, anno della pubblicazione della emendatio) vene è un altro non meno significativo. Nel dicembre del 1622 la Congrega-zione dell’indice proibì (sostanzialmente per un equivoco) le edizioni delleRelazioni universali di Botero, anteriori a quella del 1601, per via di un pas-so relativo alla situazione francese. Or bene, sulla copia canevariana è an-notato “corretto conforme la censura di Roma nel cap. delle forze di Fran-cia” e alle pagine 26-27 [fig. 7] sono stati accuratamente cancellati i passi“incriminati”66. Qualcosa di simile deve essere avvenuto con il volume con-tenente due opere del giurista francese P. Ayrault, Rerum iudicatarum pan-dectae [...] De patrio iure ad filium, abbinate in un’edizione milanese del1619. Sono ancora da ricostruire analiticamente i dettagli dell’episodio ab-bastanza curioso: benché il 9 luglio 1618 l’inquisitore milanese avesse dato(inavvertitamente) il permesso di stampa, il 30 luglio a Roma era proibito
64. Si tratta di G.C. Gloriosi, De cometis dissertatio astronomico-physica, ex typographia Vari-sciana, Venetiis 1624 (su Gloriosi cfr. la voce di U. Baldini in DBI 57, pp. 421-424).
65. Era possibile che l’espurgazione avvenisse, ad esempio, in occasione di un sequestro tempora-neo in bottega, come dichiarava il veneziano Girolamo Zenaro: “ho havuto speranza che me li re-stituisse depenando il nome e tagliando via l’epistola secondo che sempre m’è stato fatto” (Archi-vio di Stato di Venezia, S. Ufficio 62); sulle ispezioni cfr. Grendler, The Roman Inquisition, cit.,pp. 162 e ss. Sul problema della definizione (e della distinzione) di libri “usati” / libri “vecchi” cfr.A. Nuovo, Il commercio librario nell’Italia del Rinascimento, Angeli, Milano 20032, pp. 159-164.
66. CFC 488; sull’episodio cfr. A.E. Baldini, Le ultime ricerche di Luigi Firpo sulla messa all’In-dice delle ‘Relazioni universali’ di Botero, in Botero e la ‘Ragion di Stato’, A.E. Baldini (a cura di),Olschki, Firenze 1992, pp. 485-495.
il De patrio iure ad filium, e si attese poi l’ottobre dell’anno seguente perpubblicare il divieto; comunque sia, nell’esemplare appartenuto al medicogenovese (e in molti altri) il titolo è cancellato nel frontespizio [fig. 8] e lepagine corrispondenti risultano mancanti67. Il controllo, insomma, era ca-pillare e continuo.
Non si può escludere, inoltre, che alcune delle “correzioni” siano state fattein occasione del trasporto a Genova, da parte dell’inquisitore locale o dei con-giunti, o addirittura in anni successivi. Nell’inventario “genovese”, ad esem-pio, è descritto “Eusebius Pamphilus Caesariensis, opera omnia, Basileae 1542”;il volume è oggi privo del frontespizio e delle carte finali del quarto tomo (do-ve erano ripetute le indicazioni editoriali), e a c. 157v è stato annotato: “FI-NIS” e “ablata sunt quae prohibentur in Indice lib. prohib.”. Quindi, se già fos-se stato censurato prima del 1630, le informazioni relative al luogo e all’annodi stampa non sarebbero potute essere riportate nell’inventario68.
Altri ipotetici interventi simili a questo non cambiano il significato delleconsiderazioni che si stanno facendo: la raccolta porta con sé le testimo-nianze degli usi di un’epoca (metà Cinquecento - metà Seicento), indipen-dentemente da chi, di volta in volta, abbia materialmente operato.
I volumi oggi conservati con i segni visibili (e certi) di “intrusioni” cen-sorie sono più di un centinaio; una rivisitazione completa di tutta la colle-zione consentirà sicuramente nuove trouvailles; così come una futura analisi
la biblioteca disciplinata
891
67. CFC 2048 (nell’edizione francese del 1597 il titolo proseguiva con queste parole: ad filiumpseudoiesuitam); già il 9 maggio 1618 Bellarmino lo aveva segnalato (ACDF, Index, I/2, c. 135r;e cfr. ILI XI, p. 95; Elenchus librorum omnium [...] prohibitorum per Fr. Franciscum Magdale-num Capiferreum [...] digestus. Editio Secunda aucta, Ex Typographia Rev. Cam. Apost., Romae1640, p. 305). Il caso è ricordato da G. di Renzo Villata, “Sembra che […] in genere […] il mon-do vada migliorando”. Pietro Verri e la famiglia tra tradizione giuridica e innovazione, in PietroVerri e il suo tempo, C. Capra (a cura di), Cisalpino, Milano 1999, I, pp. 151-152.
68. CFC 846. L’espurgazione segue le prescrizioni dell’indice del 1596, che ordinava di levarespecificamente quelle pagine (le aggiunte al Chronicon successive al 1512: ILI IX, p. 492). A me-no che le informazioni bibliografiche non siano state tratte da un altro esemplare delle opere diEusebio ancora conservato: abbastanza curiosamente è rimasto un volume integro del solo Chro-nicon (CFC 847); si tratta del secondo tomo dell’edizione del 1549, in cui l’ultimo fascicolo(Ff4) è stato sostituito con l’omologo della precedente del 1542 (FFF4): cfr. H.M. Adams, Cata-logue of Books printed on the Continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge Libraries, CambridgeUP, Cambridge 1990, E 1070-1071.
rodolfo savelli
892
sistematica del catalogo e degli inventari arricchirà la nostra prospettiva, manon arriveranno sicuramente perentorie smentite. Ho scritto certi perché visono casi in cui è difficile stabilire se le mutilazioni presenti siano dovute ascelte ecclesiastiche oppure siano da imputare ai danneggiamenti subiti dal-la biblioteca tra fine Settecento e inizi Ottocento (svariate illustrazioni efrontespizi ornati risultano oggi mancanti)69.
Si apra la Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari di Galilei: al-l’esemplare mancano i fascicoli A e H-V. Furono asportati per il bel ritrattodell’autore e le figure delle macchie solari? Oppure si tratta di una tardivadamnatio memoriae, magari successiva all’abiura del 1633? All’arrivo a Ge-nova, infatti, era ancora integro, visto che fu descritto con il dettaglio dellapresenza delle “lettere al sig.r Marco Velseri delle macchie solari” e delle in-dicazioni del luogo e dell’anno di stampa (assenti, invece, quando occorre-vano mutilazioni del genere); le pagine scomparse, per altro, contengonoalcuni passaggi importanti relativi alla difesa del copernicanesimo70.
Per comprendere la pervasività del fenomeno sono necessarie a questo pun-to alcune considerazioni di carattere generale sulla vicenda degli indici e dellacensura libraria. La biblioteca di Canevari non è una “biblioteca proibita”, noncontiene cioè libri che possano essere considerati indizio di alcuna simpatiaminimamente dissidente71. Anzi, tutto fa pensare che il medico genovese ap-partenesse a una cultura contrassegnata (piuttosto) da un certo ortodosso rigo-rismo – sia per scelte personali, sia per l’ambiente familiare di formazione72.
I testi che contenevano anche scritti di famosi autori riformati (o vietatibenché non protestanti, o noti come “eterodossi” seppure non all’indice) so-
69. Per le traversie cfr. [G.B. Spotorno], “Cenni biografici su Demetrio Canevari”, in «GiornaleLigustico di scienze, lettere ed arti», I (1827), pp. 292-293.
70. CFC 2201; sulle vicende editoriali cfr. G. Stabile, “Linguaggio della natura e linguaggio del-la scrittura in Galilei. Dalla Istoria sulle macchie solari alle Lettere Copernicane”, in «Nuncius»,IX (1994), pp. 37-64.
71. Cfr. U. Rozzo, Le “biblioteche proibite” nel Friuli del Cinquecento, in Id., Biblioteche italianedel Cinquecento tra Riforma e Controriforma, Forum, Udine 1994, pp. 1-58.
72. Il nonno, il padre e il fratello Ottaviano appartenevano alla confraternita genovese del Divi-no Amore; Demetrio aveva previsto che in caso di estinzione della discendenza la biblioteca pas-sasse ai Gesuiti od ai Somaschi, i due ordini religiosi prediletti dai membri della confraternitastessa (cfr. Savelli, La “libraria” di Demetrio Canevari, cit., p. 92).
no stati radicalmente mutilati: all’edizione del trattatello pedagogico di Ba-silio di Cesarea furono tolti gli acclusi scritti di Melantone e di Erasmo, esono, parimenti, caduti quelli di Melantone che accompagnavano gli opu-scoli di Budé e Alciato (sulle misure e le monete romane) o il lavoro del ma-tematico Stifel73. Dudith, Erastus e Grynaeus sono stati rimossi da un volu-me sulle comete; stessa sorte è capitata all’Encomium medicinae di Grynaeuse al De tuenda bona valetudine di Eobanus Hessus, recisi dalle raccolte mi-scellanee in cui erano inclusi; non diversamente si è proceduto con i Moraliadel teologo gallicano Jacques Almain, privato del libellus de auctoritate eccle-siae (benché proibito nel solo indice del 1559)74.
Non sfuggì uno dei rari classici posti all’indice. Le opere di Luciano diSamosata pubblicate a Lione nel 1549 (edizione esemplata su precedenti te-desche) furono sottoposte a un doppio ordine di interventi che possono es-sere considerati emblematici di diverse tipologie censorie: furono ripulite ditutti quei nomi di traduttori, ormai intollerabili, come l’onnipresente Era-smo da Rotterdam, e poi Melantone e Mycillus (Moltzer), e altri ancora; siagì direttamente sui testi con l’asportazione di due dialoghi (di cui uno pseu-do-lucianeo) seguendo quelle che erano le disposizioni dell’indice del 1559(successivamente sempre confermate)75. Come è ormai noto da tempo sullascelta non vi era stata unità di intenti all’interno dell’Inquisizione stessa;negli indici del 1554, infatti, figurava un divieto generico per tutti i dialo-ghi (che aveva ovviamente suscitato le proteste dei librai veneziani: “Lucia-no greco et altri simili sempre sono stati stampati dapoi che la stampa èstampa […] di questi Luciani sono tutte le parti del mondo piene, dove sia-no in prezzo li studii et le buone lettere”)76. Nell’indice provvisorio del 1557,
la biblioteca disciplinata
893
73. CFC 139, 386, 1784; per la questione di Erasmo cfr. S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia1520-1580, Bollati Boringhieri, Torino 1987; Ead., Sette modi di censurare Erasmo, cit.; per unabiblioteca depauperata di tutti gli esemplari delle opere di Erasmo cfr. la lista pubblicata in G.Petrella, “Libri e cultura a Ferrara nel secondo Cinquecento: la biblioteca privata di AlessandroSardi”, in «La Bibliofilia», CVI (2004), pp. 75-80.
74. CFC 150, 161, 1067, 1775.
75. CFC 1212.
76. A. Del Col, “Il controllo della stampa a Venezia e i processi di Antonio Brucioli (1548-1559)”,in «Critica Storica», XVII (1980), p. 490. Il nome di Luciano compare negli indici stampati aMilano e Venezia nel 1554, ma non in quello edito a Firenze (ILI III, pp. 410, 433; X, p. 822).
rodolfo savelli
894
segnale forse delle possibili alternative messe in discussione, comparivanosia un’interdizione generale per l’autore sia una specifica per i due dialoghiin questione; e quest’ultima scelta fu quella che divenne operativa a partiredal 155977.
Il fatto, poi, che scienziati, medici (e qualsiasi altro scrittore) fossero an-che protestanti provocava automaticamente o un divieto o una condizionedi sospetto, una diffidenza che vi era in genere nei confronti dei libri pro-dotti in aree riformate78. Agli “eretici” andavano aggiunti tutti coloro chenon erano allineati sulle posizioni della Chiesa tridentina e post-tridentina– teologi e giuristi gallicani, astrologi e filosofi, poeti e pensatori politici,come si vedrà.
E quindi, a parte alcuni pochi casi in qualche modo prevedibili comequelli sopra ricordati, la libraria di un medico con ampie curiosità intel-lettuali (non era una mera raccolta professionale) doveva fare i conti condiverse prescrizioni censorie. Non erano propriamente le opere “scienti-fiche” a suscitare di per sé gli interessi di Inquisizione e Indice, come ri-sulta dalle numerose ricerche di Ugo Baldini79. Ma, d’altra parte, la que-
77. ILI VIII, p. 735. Mentre si stava preparando l’indice, il cardinale Ghislieri aveva infatti os-servato che “di prohibire Orlando, Orlandino, Cento novelle et simili altri libri, più presto da-ressimo da ridere ch’altrimente, perché simili libri non si leggono come cose a qual si habbi dacredere, ma come fabule et come si legono ancor molti libri de gentili, come Luciano, Lucretioet altri simili” (BUG, Ms. E.VII.15, c. 76r). Lucrezio fu messo all’indice solo nel 1718, “grazie”alla traduzione in volgare di Alessandro Marchetti. In effetti il problema della lingua sembra unadelle discriminanti: di Luciano erano uscite diverse edizioni in italiano, e di queste ci si ricordòancora nel 1590 quando si aggiunse la dizione “dialogi vernacula lingua impressi”, che in seguitofu lasciata cadere (ILI IX, p. 829). Sul problema del volgare cfr. Fragnito, Proibito capire, cit.
78. Cfr. U. Baldini, L’Inquisizione romana e le scienze: etica, ideologia, storia, in L’Inquisizione. Attidel Simposio internazionale Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, A. Borromeo (a cura di), Bibliote-ca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2003, pp. 661-707, in specie 686-687; Infelise, I libriproibiti, cit., pp. 55 e ss; per la penisola iberica cfr. Pardo Tomás, Ciencia y censura, cit., pp. 97 e ss.
79. Sul problema della letteratura scientifica si vedano le considerazioni di U. Baldini, Le con-gregazioni romane dell’Inquisizione e dell’Indice e le scienze dal 1542 al 1615, in L’inquisizione e glistorici: un cantiere aperto, Atti dei convegni Lincei 162, Acc. Nazionale dei Lincei, Roma 2000,pp. 329-364; Id., Die römischen Kongregationen der Inquisition und des Index und der naturwis-senschaftliche Fortschritt im 16. bis 18. Jahrhundert: Anmerkungen zur Chronologie und zur Logikihres Verhältnisses, in H. Wolf (Hrsg.), Inquisition, Index, Zensur. Wissenskulturen der Neuzeit imWiderstreit, Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2001, pp. 229-278.
stione dell’anti-aristotelismo di una parte della cultura tardo-cinquecen-tesca, così come la vicenda della condanna del copernicanesimo e di Ga-lilei non possono essere ridotte a sfortunato incidente, come ancora tal-volta viene fatto80.
Ben chiaro risultava ad alcuni contemporanei che a suscitare conflittoera proprio la stretta connessione tra formazione culturale tradizionale(scolastica e aristotelica) e il potere dei censori (i “frati” irrisi nei carteggilincei o in quello di Aleandro con Peiresc). Nell’informare Galilei degliimpedimenti alla pubblicazione di un’opera di Antonio Persio, Cesi os-servava: “i revisori ancor me lo trattengono, per esser grandemente con-trario ad Aristotele, che da questo pol considerarsi quanto domini hog-gidì”81.
Mantenere i rapporti con la cultura e l’editoria europea comportava im-battersi in autori o editori che potevano essere finiti sotto l’attenzione dellacensura, per motivi talvolta del tutto marginali, e implicava, quindi, di ne-cessità cercare di superare i controlli posti al commercio librario. Il che eraforse un po’ più difficile a Roma. Come aveva scritto il cardinale Bellarmi-no in una lettera ben nota “è necessario […] che ci affatichiamo di estirpar-gli almeno in quei lochi dove potiamo”82.
A Roma non era certo impossibile procurarsi volumi di autori allora a va-rio titolo vietati: la promulgazione di un indice non comportava la scom-
la biblioteca disciplinata
895
80. Si vedano in proposito le considerazioni di Rotondò, La censura ecclesiastica, cit., pp. 1461 ess. Una significativa rivisitazione della questione galileiana è in corso da parte di F. Beretta, Leprocès de Galilée et les archives du Saint-Office, in “Revue des sciences philosophiques et théologi-ques” 83 (1999), pp. 441-490; Id., Une deuxième abjuration de Galilée ou l’inaltérable hiérarchiedes disciplines, in “Bruniana & Campanelliana”, IX (2003), pp. 9-43; e cfr. M. Pesce, L’erme-neutica biblica di Galileo e le due strade della teologia cristiana, Storia e Letteratura, Roma 2005,p. 118: “quello della condanna di Galileo non è un ‘caso’, bensì una necessità”.
81. G. Galilei, Opere, Barbera, Firenze 1934, XI, p. 303; pochi anni dopo Aleandro scriveva: “ilmio commentario [...] è più d’un mese che sta in mano di questi revisori e censori de’ libri, iquali stanno su le difficoltà fratesche, essendo i loro studi di Teologia scolastica solamente” (Cor-respondance de Peiresc & Aleandro, cit., II, p. 16). Sul tema si vedano le considerazioni di F. Be-retta, “Orthodoxie philosophique et inquisition romaine au 16e-17e siècles”, in «Historia philo-sophica», 3 (2005), pp. 67-96.
82. Lettera del 1614 pubblicata in Rotondò, Nuovi documenti, cit., p. 197 (corsivo mio); e cfr.le considerazioni di D. Cantimori, Storici e storia, Einaudi, Torino 1971, p. 664.
rodolfo savelli
896
parsa automatica dal mercato di tutti i libri in questione. Nel 1598 il “libra-ro” Giovanni Tallini pubblicava un catalogo commerciale in cui (tra gli altri)comparivano Fuchs, Cardano, Erastus insieme a giuristi come Du Moulin,Hotman, Zasio (e forse non è un caso che una copia di questo catalogo siaconservata tra le carte della Congregazione dell’indice)83. Ancora nel 1602diversi librai romani dichiaravano la disponibilità di testi proibiti84. Addirit-tura otto anni dopo la pubblicazione dell’indice clementino, libri proibiti inquantità (e di qualità) sono elencati in un altro catalogo di vendita di un’im-portante bottega fiorentina, quella dei Giunta85. Relativamente note, poi,sono le molteplici vie seguite dagli intellettuali di più alto rango (chierici olaici che fossero) per cercare di procurarsi (“illegalmente”) quelle opere per lequali potevano temere di non ottenere permessi di lettura86.
Nonostante un suo illustre contemporaneo, Federico Cesi, potesse os-servare che i librai “in Roma sono scarsissimi e non hanno commercio in
83. Indice de libri forastieri del magnifico Giovanni Tallini libraro in Roma, Appresso VincentioColombara, Perugia 1598 (ACDF, Index II/14).
84. Cfr. il Registrum offitii R.mi P. Magistri Sacri Palatii in AGOP, VIII 99. E nel 1605 si proce-dette a un bel rogo di volumi sequestrati a un libraio che li aveva tenuti nascosti (ACDF, IndexI/1, c. 176r).
85. Catalogus librorum qui in Iunctarum Bibliotheca Filippi Haeredum Florentiae prostant, Flo-rentiae, [Giunta], 1604 (cfr. il carteggio con la Congregazione dell’indice: ACDF, Index II/22;e per la decisione di sequestrare le opere proibite ACDF, Index I/1, c. 186v; VI/1, c. 26r).
86. “Non so s’io potrò havere licenza di leggerlo” scriveva Aleandro, a proposito della storia delconcilio tridentino di Sarpi, appena proibito (e arrivato a Roma anche grazie allo stesso Peiresc:Correspondance de Peiresc & Aleandro, cit., II, p. 151); e cfr. infra testo relativo a nota 92. Sem-bra che proprio a Roma, a partire dalla seconda metà del Seicento, si sia sviluppato un fiorentecommercio clandestino (ma manca per il momento uno studio sistematico): cfr., ad esempio,G. Totaro, Da Antonio Magliabechi a Philip von Stosch: varia fortuna del De tribus impostoribuse de L’esprit de Spinosa a Firenze, in Bibliothecae selectae, cit., pp. 392-393; E. Di Rienzo - M.Formica, Tra Napoli e Roma: censura e commercio librario in Editoria e cultura a Napoli nel XVIIIsecolo, A.M. Rao (a cura di), Liguori, Napoli 1998, p. 228; M. Tita, “Libertà editoriale e inqui-sizione romana: Costantino Grimaldi e la difesa dei suoi libri”, in «Frontiere d’Europa», V, 1999,2, p. 165: secondo l’interessata (e un po’ tendenziosa) testimonianza di Celestino Galiani “di li-bri che sieno di eretici, che trattino di sagra scrittura o di teologia ed impugnino ex professo laReligione Cattolica [...] ne soglion capitare assai più in altre città d’Italia, e precise in Roma;donde per lo più [...] se gli soglion far venire”.
Germania”87, la biblioteca di Canevari presenta una discreta apertura al mer-cato europeo. Non vi è dubbio che sia composta in prevalenza da libri stam-pati in Italia; ma non si possono dimenticare quelli provenienti a centinaiada Lione o Parigi (dove i divieti romani erano sostanzialmente inefficaci, edove, quindi, come osservava con sconcerto il nunzio pontificio agli inizidel Seicento, “essendo qua libertà di conscienza […] non solo si leggono,ma si stampano tutto’l giorno libri pieni d’heresia”)88; alle edizioni francesivanno aggiunte quelle pubblicate a Basilea (uno dei centri della cultura uma-nistica e riformata nel Cinquecento), a Zurigo, Wittenberg, Tubinga89.
Non avendo a disposizione un carteggio quale quello di Giovanni Vincen-zo Pinelli o di Peiresc, ci sono ignoti i suoi fornitori e i canali di approvvigio-namento; è tuttavia immaginabile che seguisse le reti usuali del commerciolibrario, e forse anche quello “clandestino”, in cui più o meno frequentemen-te potevano esserci degli intoppi – come, ad esempio, quando l’inquisitore diAsti intercettò un Gesner diretto a Genova, o quando il suo collega genovesesequestrò un pacchetto ben confezionato e indirizzato a Pinelli (allora a Pa-dova)90. Non casualmente il già ricordato Cesi, tra i diversi sistemi possibili
la biblioteca disciplinata
897
87. Gabrieli, Il carteggio linceo, cit., p. 344. Sulla situazione romana del periodo cfr. la puntualemessa a punto di Brevaglieri, Editoria e cultura a Roma, cit. Non molti anni dopo, da FirenzeCarlo Dati scriveva a Holstenius: “di Alemagna non si trova la strada a far venire libri” (A. Mir-to, Lucas Holstenius e la corte medicea: carteggio (1629-1660, Olschki, Firenze 1999, p. 265).
88. G. Fragnito, “Diplomazia pontificia e censura ecclesiastica durante il regno di Enrico IV”,in «Rinascimento», ns., XLII (2002), p. 152.
89. D. Régnier-Roux, Una biblioteca in cifre. Studio quantitativo e statistico della biblioteca diDemetrio Canevari, in Saperi e meraviglie, cit., pp. 27-40. Sul ruolo di Basilea cfr., ad esempio,gli studi di P. Bietenholz, Der italienische Humanismus und die Blütezeit des Buchdrucks in Basel,Helbing & Lichtenhahn, Basel-Stuttgart 1959; Id., Basle and France in Sixteenth Century. TheBasle Humanists and Printers in their Contacts with the Francophone Culture, Droz, Genève 1971;L. Perini, La vita e i tempi di Pietro Perna, Storia e Letteratura, Roma 2002.
90. Scriniolum Sanctae Inquisitionis, cit., p. 424; W. McCuaig, On Claude Dupuy (1545-1594), in“Studies in Medieval and Renaissance History”, XII (1991), p. 74; G.V. Pinelli - C. Dupuy, Unecorrespondance entre deux humanistes, A.M. Raugei (a cura di), Olschki, Firenze 2001, I, p. 91 (ecfr. le osservazioni di A. Nuovo, “A proposito del carteggio Pinelli-Dupuy”, in «Bibliotheca», I(2002), 2, pp. 96-115). Per notizie sul contrabbando e la circolazione di libri proibiti cfr. Gren-dler, The Roman Inquisition, cit., pp. 182 e ss, 280 e ss; Id., Books for Sarpi: the smuggling of pro-hibited books into Venice during the Interdict of 1606-1607, in Essays Presented to Myron P. Gilmore,
rodolfo savelli
898
per far arrivare a destinazione le opere raccolte da Joannes van Heeck, stima-va come soluzione migliore che fosse lo stesso Heeck a trasportarle, ma evi-tando “d’entrar nelle città d’Italia, acciò non le fossero reviste” (perché i ga-bellieri dovevano controllare tutti i libri in entrata), pur, al contempo, scon-sigliandolo, perché “passarebbe troppo pericolo a portarne seco”91.
Passano alcuni decenni e un intellettuale di prestigio, ben inserito negliambienti che contavano nella Roma pontificia, quale era Lucas Holstenius,per far arrivare dall’Olanda una cassetta di libri geografici (solo geografici?)pensava che fosse più prudente ricorrere alla complicità e ad una complessatriangolazione con il principe Leopoldo de Medici, “per sfuggire l’imperti-nenza dei frati et altri ministri alli quali la materia de’ libri sta sottoposta”92.Gli esempi delle modalità di elusione dei controlli potrebbero essere molti-plicati, ma stanno a indicare anche che la funzione degli apparati di sorve-glianza continuava a sussistere e ad essere efficace93.
Quindi, se Canevari voleva vivere tranquillo, aveva senza dubbio biso-gno di licenze di lettura di libri proibiti, e queste erano (o avrebbero dovu-to essere) associate a una “espurgazione”, vale a dire l’indicazione delle parti(infinitesime o rilevanti) da cancellare nel volume oggetto del permesso. Ilmeccanismo non è stato ancora adeguatamente studiato, perché è difficile
ed. S. Bertelli - G. Ramakus, La Nuova Italia, Firenze 1978, I, pp. 105-114; Rotondò, La censuraecclesiastica, cit., p. 1414; P. Lopez, Inquisizione stampa e censura nel Regno di Napoli tra ’500 e’600, Ed. del Delfino, Napoli 1974, pp. 223 e ss; Barbierato, Nella stanza dei circoli, cit., passim.
91. Gabrieli, Il carteggio linceo, cit., p. 67; la lettera di Cesi a Stelluti (1605) diventa ancora piùsignificativa se si considera che le parole edite in corsivo da Gabrieli nell’originale erano in cifra.Un altro intellettuale residente a Roma in quel torno di anni, Antonio Querenghi, scriveva: “Nelmandar libri […] bisogna avvertir che s’accomodin come se fossero scritture o lettere, altrimentii ministri del S. Offizio voglion vederli” (L. Bolzoni, Il segretario neoplatonico, in La corte e il“Cortegiano”. II. Un modello europeo, A. Prosperi (a cura di), Bulzoni, Roma 1980, p. 152).
92. Mirto, Lucas Holstenius, cit., pp. 205-206; cfr. A. Serrai, La biblioteca di Lucas Holstenius,Forum, Udine 2000. Ancora agli inizi del Settecento Bulifon considerava che “la strada di Ro-ma è difficile per la dogana che si vuole la licenza per l’Inquisitione” (Lettere dal Regno ad Anto-nio Magliabechi, A. Quondam e M. Rak (a cura di), Guida, Napoli 1978, I, p. 210; e cfr. S.Mastellone, Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento, D’Anna,Messina-Firenze 1965, p. 103).
93. Per i corrispettivi controlli all’esportazione cfr. supra note 34 e 35.
trovare una corrispondenza biunivoca tra documentazione archivistica (do-manda e concessione di licentiae) e bibliotecaria (i libri consentiti ed espur-gati); nel caso del medico genovese, ad esempio, si sono per il momentorintracciate tre sole licentiae (e per di più tarde), mentre doveva averne sen-z’altro ricevute molte altre (confidando, magari, nell’appoggio di un auto-revole membro della Congregazione dell’indice, il cardinale Girolamo dellaRovere, di cui era medico)94. Sono rimasti in compenso i volumi; le testi-monianze coeve, d’altra parte, sembrano abbastanza concordi95.
Il già ricordato Giovanni Vincenzo Pinelli non sembra sfuggire a questaregola. Poteva certo rifornirsi a Parigi attraverso l’amico Dupuy o nei paesitedeschi ricorrendo ai servizi del “libraro” veneziano Pietro Longo (poi giu-stiziato per eterodossia), ma al contempo, per ottenere permessi di lettura,si raccomandava ai buoni uffici dell’amico Fulvio Orsini a Roma. E questicosì gli scriveva nel 1574:
Io son stato più volte col Cardinal Sirleto per la cosa sua, et fin qui non ne ho po-tuto cavare altro, che una promessa di darmi in breve la licenza di poter tenere lilibri desiderati, con la censura insieme di quello si ha da correggere in essi, che l’unacosa senza l’altra non si può dare96.
In effetti, gli atteggiamenti (e le decisioni) dei diversi organi ecclesiasticipreposti a tale attività mutavano nel tempo; la “stratificazione censoria” del-la biblioteca di Canevari li fa emergere con grande evidenza.
la biblioteca disciplinata
899
94. Cfr. supra note 24 e 28.
95. Un bell’esempio di “assillo” per ottenere i necessari permessi è stato illustrato nel saggio diA.E. Baldini, “Albergati critico di Bodin: dall’‘Antibodino’ ai ‘Discorsi politici’”, in «Il Pensieropolitico», XXX (1997), pp. 287-309, dove sono analizzate le iniziative messe in atto dopo il1596 dal duca di Urbino, Francesco Maria della Rovere (ancora più significative se si considerala figura pubblica, “sovrana”, rivestita dal duca).
96. Nuovo, A proposito del carteggio, cit., p. 106 (corsivo mio). Sulla complessa rete di relazionidi Pinelli cfr. inoltre McCuaig, On Claude Dupuy, cit.; per l’esecuzione di Longo (un personag-gio che meriterebbe uno studio analitico) cfr. Rotondò, La censura ecclesiastica, cit., p. 1410.Pure Pinelli metteva talvolta in atto tattiche di occultamento delle testimonianze più compro-mettenti: cfr. C. Maccagni - G. Derenzini, Libri Apollonii […] qui desiderantur, in Scienza e fi-losofia. Saggi in onore di Ludovico Geymonat, C. Mangione (a cura di), Feltrinelli, Milano 1985,p. 684 (omissione intenzionale del nome dell’esule András Dudith nella copia di una lettera).
rodolfo savelli
900
Il 1574 fu un anno di particolare rigore, come dimostra questa secca ri-sposta che Paolo Costabili (Maestro del sacro palazzo e collaboratore delcardinale Sirleto) indirizzò all’inquisitore bolognese:
qui [a Roma] si nega licenza di tenere e leggere libri proibiti o di autori della primaclasse, siano in qual facultà si voglia, o di grammatica o di medicina overo di legge,ne può ragionevolmente dedurre che a lei parimente convenga fare il medesimo etnon ne concedere a chi si voglia e lasciar dire a quel Dottore che vorria le Epheme-ridi del Levitio […] e se meglio vogliano chiarirsi scrivano a Roma97.
Passano pochi anni e il successore di Costabili questa volta si dimostramolto più tollerante: “il Zasio perché non tratta di religione ex professo sipuò concedere ispurgato et censurato che così anco si usa qua”98.
Agli inizi del 1600 il segretario della Congregazione dell’indice annota-va che (insieme ad altre decisioni) fu anche discusso
de archivo in Palatio Apostolico construendo de ordine S.D.N., ubi scripturaeconservari possint apud Magistrum Sacri Palatii, qui librorum censuris indiget utmultis petentibus libros censura dignos satisfacere possit.
Dalle parole del segretario si può evincere come si fosse ormai istituzio-nalizzata una procedura: a determinati soggetti (e a certe condizioni) erapossibile concedere libri vietati, che tuttavia dovevano essere “ripuliti”, eper questa attività era, appunto, necessario un deposito delle correzioni giàpronte ma non ancora pubblicate99. La pratica espurgatoria di singoli vo-
97. Rotondò, Nuovi documenti, cit., p. 154 (corsivo mio). Sul ricorrere del nome di Leowitz neipermessi di lettura cfr. Catholic Church and Modern Science, cit.
98. Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna, Ms. B 1861, lettera del 27 gennaio 1582. Sul pro-blema di Zasio (importante giurista tedesco della prima metà del Cinquecento) e delle ininter-rotte richieste di espurgazioni alla sua opera cfr. Savelli, The censoring of law books, cit.; Id., Alloscrittoio del censore, cit.; ma ancora a metà Seicento gli “opera non correcta” potevano finire alrogo: S. Cavazza, “Inquisizione e libri proibiti in Friuli e a Gorizia tra Cinquecento e Seicento”,in «Studi goriziani», XLIII (1976), p. 80.
99. ACDF, Index I/1, c. 133r (corsivo mio); cfr. V. Frajese, Le licenze di lettura tra vescovi ed in-quisitori. Aspetti della politica dell’Indice dopo il 1596, in “Società e Storia”, XXII (1999),
lumi in mano a privati pare diffusa almeno fino a metà Seicento, mentrein epoche successive l’accesso (legittimo) a libri proibiti sembra essere con-traddistinto dalla sola licenza delle autorità preposte (magari, talvolta, concuriose condizioni; ma sull’argomento mancano ancora ricerche approfon-dite)100.
7. Dopo la pubblicazione dell’indice del 1596 si produsse una vastissimacampagna di adeguamento delle biblioteche italiane ai nuovi canoni censo-ri. L’attenzione della storiografia si è rivolta per ora soprattutto a quelle diconventi e monasteri, grazie al fatto che migliaia di elenchi affluirono a Ro-ma, dove sono stati conservati fino a oggi101.
Minor interesse ha suscitato il fatto che la medesima “cura” fu riservataanche alle biblioteche private; gli esiti di una tale complessiva ripulitura so-no ancora da valutare – certo è che le forze a disposizione di inquisitori evescovi (cui a Roma si aggiungeva il Maestro del sacro palazzo) non eranotali da garantire un pieno successo: nella sola Bologna furono consegnatiall’inquisitore ben 4.000 elenchi102.
la biblioteca disciplinata
901
pp. 767-818 (che va senz’altro integrato con la ricca documentazione conservata in ACDF, SO,St. st. Q1b e ss, oltre alla serie sterminata dei Decreta); Baldini, Il pubblico della scienza, cit.,pp. 171-201; Id., The Roman Inquisition’s condemnation of astrology: antecedents, reasons and con-sequences, in Fragnito, Church, censorship and culture, cit., p. 96.
100. Si veda, ad esempio, la copia di licenza della Congregazione dell’indice con cui nel 1768 siautorizzava un certo Michele Antonio Pescetti a possedere libri proibiti di filosofia, diritto e po-litica (con la tradizionale esclusione di Machiavelli e Du Moulin) e si concedeva perfino Gian-none, ma a condizione che leggesse l’opera di G.A. Bianchi, Della potestà e della politia dellachiesa (ASG, Senato, Sala Gallo 1085).
101. Una rassegna degli studi più recenti in R. Rusconi, Le biblioteche degli ordini religiosi inItalia intorno all’anno 1600 attraverso l’inchiesta della Congregazione dell’Indice. Problemi e pro-spettive di una ricerca, in Libri, biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, cit., pp. 63-84, e Id., “Le biblioteche degli ordini religiosi in Italia alla fine del secolo XVI”, in «Rivista distoria del cristianesimo», 1 (2004), pp. 189-199; e cfr. ora Libri, biblioteche e cultura degli ordiniregolari nell’Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell’Indice, R.M.Borraccini e R. Rusconi (a cura di), BAV, Città del Vaticano 2006.
102. Per un quadro di assieme cfr. Fragnito, Proibito capire, cit., pp. 191 e ss. L’estensione e laprofondità dell’operazione emergono altresì da un’analisi di settore (i testi sul duello): C. Dona-ti, A project of ‘expurgation’ by the Congregation of the Index: treatises on duelling, in Fragnito,
rodolfo savelli
902
Il tentativo fu esteso e penetrante, compatibilmente con le risorse utiliz-zabili nelle singole località e con le reazioni suscitate: se nel 1603-1604, aPontecorvo (nella diocesi di Aquino) il vicario vescovile sottoponeva a tem-poraneo sequestro tutti i libri di un avvocato per non averne presentatol’elenco, nel 1601 l’inquisitore veneziano considerava che “molti et moltifanno instanza per il Machiavello, io le nego la licenza et perché non veggoportarmi li libbri, dubito assai quanto a questo libro et anco dell’Aretino,che molti non habbino timore”; a Napoli, una trentina di anni dopo, il car-dinale Boncompagni osservava con rammarico che era difficile un controllocapillare nelle biblioteche: “facilmente potrebbe partorire mali effetti conpericolo manifesto di disubbidienza per rispetto d’officiali regii e d’altri lai-ci potenti e poco obedienti a’ gl’ordini ecclesiastici”103.
Le frammentarie testimonianze a disposizione mostrano come, tutta-via, il tentativo fu innegabilmente posto in atto. Nel gennaio del 1600 unnobile savonese aveva risposto con queste parole in un procedimento in-quisitoriale:
io non so di haver libro alcuno proibito, anzi l’ultimo editto che fu fatto a nomedel padre inquisitore io diedi la lista de miei libri a voi P. vicario che me ne haveteritenuto alquanti quali credevo essere sospetti e delli restanti m’havete sottoscrittola lista che deve essere nelle mie scritture104.
Church, censorship and culture, cit., pp. 134-162. Tra le fonti più significative rimaste cfr. ACDF,Index XVIII/1; BAV, Vat. Lat. 11269/I e 11286.
103. Per il caso di Pontecorvo cfr. ACDF, Index III/5, VI/1; per Venezia Ibid. III/6, c. 322r (ecfr. anche note 2 e 184); per Napoli: ACDF, SO, St. St. HH1e, c. 468r; si è sopra ricordato co-me in quegli stessi anni un “potente” personaggio genovese dovesse sottostare ai controlli inqui-sitoriali: cfr. supra nota 49.
104. D. Piemontino, Il «processo dei nobili». Eresia e cultura dotta nella Savona di fine Cinque-cento, in “Annali della Fondazione Luigi Einaudi”, XXXVII (2003), p. 268. Vi sono alcuni stu-di dedicati a casi singoli o realtà locali: ad esempio C. Poma, La libreria d’un nobile biellese nel1596, in “Bollettino Storico Bibliografico Subalpino”, XXXII (1930), pp. 478-479; G. Tibalde-schi, Un inquisitore in biblioteca: Cipriano Uberti e l’inchiesta libraria del 1599-1600 a Vercelli,“Bollettino storico vercellese”, XIX (1990), 1, pp. 43-100; C. Preti, L’applicazione dell’indiceclementino a Lanciano, in “Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria”, CXI (1999,ma 2001), pp. 235-277.
Non va dimenticato, inoltre, che tali operazioni si erano periodicamenteripetute da almeno un cinquantennio: tanto è vero che nel 1597 Vincenzo Ca-stellani, giurista di Fossombrone, nel rinnovare la richiesta di permesso di varitrattati necessari all’insegnamento, ricordava che, nell’edizione delle epistolefamiliari di Cicerone, tutti i nomi di autori proibiti “già fino a l’altra volta chese rassegnarono i libri furono cancellati, insieme con tutto quello che si potevaessere di sospetto”105. Nel 1598 un medico toscano, Giovanni Battista Aggiun-ti, al momento di presentare la richiesta di autorizzazione, sottolineava che unalicenza gli era stata precedentemente accordata dall’inquisitore della sua dioce-si (Borgo S. Sepolcro) e Paolo Pico (segretario della Congregazione dell’indicee “sacri palatii promagister”) gli concedeva un relativamente lungo elenco di te-sti (di Fuchs, Gesner, Villanova, Cardano, Cornarius) con la precisazione cheerano concessi solo quelli “ad artem medicam spectantia […] nominibus hereti-corum expunctis et erroribus deletis iuxta censuram traditam”106.
A parte il problema di capire quale potesse essere l’espurgazione che (aquella data) avrebbe fatto da corredo alla licenza, il primo elemento da evi-denziare è che, innanzi tutto, si prescriveva di levare i nomi degli haeretici,condizione in qualche modo essenziale per concedere il permesso107. La que-stione era stata lungamente dibattuta nei decenni precedenti e riconducealle origini della vicenda.
L’indice del 1559 aveva proibito le opere di autori “eretici” con una for-mula latissima: “cuiuscunque argumenti sint”. L’opposizione degli ambientiprofessionali (medici e giuristi, innanzi tutto), ma anche di editori e uomini
la biblioteca disciplinata
903
105. ACDF, Index XVIII/1, cc. 184-186 (corsivo mio); non è indicato più precisamente qualeedizione fosse, potrebbe trattarsi di quella curata da Christoph Hegendorf. Per l’autorizzazioneACDF, Index I/1, c. 98v. Un altro breve elenco di opere da lui possedute in BAV, Vat. lat. 11286,c. 358.
106. ACDF, Index XVIII/1, cc. 218 e 246 (corsivo mio).
107. Non sembra esistere (o non è nota) un’espurgazione “romana” a stampa che nel 1598 co-prisse contemporaneamente tutti quegli autori; circolavano comunque manoscritte in gran quan-tità tra centro e periferia, e potrebbe essere ipotizzabile che abbiano pure attinto dagli indiciespurgatori di area spagnola; a parte quello romano del 1607 (cfr. supra nota 21), gli altri opu-scoli che furono pubblicati precedentemente, ad esempio per opere giuridiche, sono molto rari(cfr. Savelli, Allo scrittoio del censore, cit., pp. 319-321). Per un opuscolo, specificatamente indi-rizzato ai libri dei “medici”, ma successivo, cfr. supra nota 21; per Cardano cfr. nota 22.
rodolfo savelli
904
di governo aveva portato già nel febbraio del 1559 alla promulgazione di unainstructio che introduceva eccezioni a questo divieto generale: per quanto ri-guarda Fuchs, ad alcuni medici sarebbero stati concessi, per periodi limitati,i soli “libri in quibus tradit de herbarum et stirpium cognitione […] ita tamenut interim nusquam Fuchsii nomen vel memoria appareat”108. E sebbene nelsuccessivo indice tridentino del 1564 fosse previsto, invece, che le opere de-gli eretici, “qui de religione non tractant”, potessero essere lette, purché esa-minate e approvate “a theologis catholicis iussu episcoporum et inquisitorum”,aprendo così la strada a una (potenziale) circolazione dell’editoria d’oltralpe,la pratica della cancellazione dei nomi fu teorizzata e non venne mai me-no109. Come spiegò nel 1560 un difensore delle scelte pontificie “Sua Santitàhavea fatto bene a far quella prohibitione, etiandio che alcuno di quelli librinon contenesse cose di heresia, come qualche uno di quelli di Herasmo, solper levare dalla memoria delli homini il nome dell’autor cativo”110.
La più evidente e percepibile forma di censura riscontrata nella bibliotecadi Canevari è proprio quella relativa ai nomi (autori, traduttori, curatori, de-dicatari e, come si vedrà, perfino editori e tipografi) e a tutti quegli apparatiche accompagnavano le pubblicazioni dei classici (dai padri della Chiesa adAristotele, Galeno, Plinio, etc.)111. Ad attirare le attenzioni censorie, oltre ai
108. ILI VIII, pp. 100-101 (nella Instructio del 1559 vi era anche un paragrafo dedicato al The-saurus linguae latinae di Estienne, su cui cfr. infra nota 119); il concetto fu ribadito nella Mode-ratio indicis del 1561 (ibidem p. 105). Per le reazioni suscitate negli ambienti medici dalla pre-senza nell’indice di opere di carattere non religioso cfr., ad esempio, A. Panella, “L’introduzionea Firenze dell’indice di Paolo IV”, in «Rivista storica degli archivi toscani», I (1929), pp. 11-25.
109. ILI VIII, p. 813; cfr. J.B. Cardona, De expungendis haereticorum propriis nominibus etiamde libris qui de religione ex professo non tractant, Romae, Apud Iosephum de Angelis, 1576. Il du-ca d’Alba, durante la preparazione dell’indice anversano del 1571, aveva suggerito di togliere, adesempio, tutte le annotazioni di Melantone alle opere altrui, ma “annotationes quae utiles vide-buntur edi possunt sine illius nomine, modo nomen impressoris ascribatur” (J. Mendham, Supple-ment to the literary policy of the Church of Rome, Duncan, London 1836, p. 16); cfr. A. Prosperi,«Damnatio memoriae». Nomi e libri in una proposta della controriforma, in Inquisizione e percorsidi ricerca, G. Paolin (a cura di), Università, Trieste 2001, pp. 11-34.
110. Seidel Menchi, Erasmo in Italia, cit., p. 319 (corsivo mio).
111. Nella ricordata Instructio del 1559 era affrontato il problema delle edizioni di classici curateda autori proibiti e fu stabilito che non potevano essere concesse “nisi abrasis primum vel adeo
ricordati Brunfels e Fuchs, furono gli scrittori appartenenti alla galassia pro-testante, insieme ad alcuni grandi umanisti “non allineati” – primo fra tuttiErasmo. Le tecniche materiali di intervento erano le più diverse: cancellazio-ne a inchiostro, incollatura di cartigli bianchi, o di una pagina sull’altra, aspor-tazione dei fascicoli preliminari (quelli appunto contenenti le dediche)112.
A volte il volume può sembrare integro – si veda la splendida edizionegiuntina del 1553 della raccolta di trattati intitolata De balneis. Tutto sem-bra esteriormente in ordine, ma all’interno i nomi di Gesner e Fuchs sonoaccuratamente cancellati, così come quelli di altri citati da Gesner (ad esem-pio Münster e Cornarius)113.
Altre volte non ci si fermava al nome e ad elementi paratestuali: nellabella stampa parigina del De situ orbis di Pomponio Mela, sono stati recisiil frontespizio e la prima carta; il curatore, Joachim Vadianus (von Watt), èoccultato/modificato con un anodino Marlianus [fig. 9], sono state incolla-te e/o recise alcune pagine interne, là dove si esprimevano critiche alla figu-ra storica dei re magi o al digiuno114. Nella Geographia di Strabone è stata
la biblioteca disciplinata
905
obliteratis, ut legi vel percipi non possint, nominibus, cognominibus, annotationibus, scholiis, censu-ris, argumentis, summariis et quibuscunque aliis vestigiis memoriae” (ILI VIII, p. 101). E pochigiorni prima della pubblicazione il cardinale Ghislieri, allora a capo dell’Inquisizione, scrivevaall’inquisitore genovese: “li libri d’humanità de buoni autori riconosciuti, scoliati o commentatida alcuni reprobati nell’Indice, si possono concedere deletis delendis, si come anche si concedo-no i libri de Santi Dottori” (BUG, Ms. E.VII.15, c. 84r).
112. Segnalo qui alcune mutilazioni (più o meno estese) con il nome che ha attirato l’attenzio-ne censoria: CFC 197, 238, 364 (Zwinger); 948 (Erasmo e altri traduttori di Galeno); 1217(Atrocianus); 1385 (mutilo del frontespizio perché nel verso vi era una dedica di Erasmo); 205,1561 (Erasmo); 127, 1074, 1252, 1446 (Ianus Cornarius); 504, 1059 (Gesner); 769 (S. Châ-teillon e H. Estienne); 1408 (C.S. Curione); 1572 (W. Musculus); 1629 (Betuleius e Xylander);1801 (Wolff ); 1830 (Gwalther); 1197 (Beatus Rhenanus e Grynaeus); 1973 (Grynaeus); nellaMedicinae utriusque syntaxes di Wecker (CFC 1984) è stata tolta la dedica, perché come era statoscritto nelle liste del 1579-1580, “nel epistola del libro dimostra esser heretico” (ILI IX, p. 157) ealtrettanto è stato fatto nell’Antidotarium generale (CFC 1982). Altri esempi sono indicati nellepagine seguenti.
113. CFC 743. Nella Bibliotheca medica di Lecoq (CFC 1174) è stato tolto un paio di righe, al-l’interno delle voci dedicate a Erasmo e Zwinger, lasciando, per il resto, tutto integro.
114. CFC 1304; nell’indice espurgatorio di Anversa del 1571 si segnalavano correzioni sulla basedi un’altra edizione (ILI VII, p. 782); mentre questa parigina fu tenuta presente nelle espurgazioni
rodolfo savelli
906
tolta la seconda carta dopo il frontespizio e il nome del traduttore, Here-sbach, è mascherato sotto un cartiglio a stampa in cui è scritto Scholastico115.
È inutile moltiplicare gli esempi; la caccia al nome era sistematica epoteva avvalersi anche di un curioso ausilio curato da un esperto di espur-gazioni, il cappuccino Gregorio da Napoli. Questi aveva pubblicato unmanuale in cui, tra l’altro, erano elencati sia classici sia contemporaneiediti a cura e/o con note di autori proibiti; ad esempio, per Galeno se-gnalava: “In Galeno in fol. et in opuscul. scribunt Andreas Cratander, IanusCornarius, Erasmus, Conradus Gesnerus, Ioachimus Camerarius, Ionas Phi-lologus, Leonardus Fuchsius”, mettendo così sull’avviso tutti coloro cheavevano a che fare con testi “inoffensivi” come quelli di Galeno116. L’ope-ra, per altro, era stata valutata criticamente negli stessi ambienti inquisi-toriali (“tantum delet nomina haereticorum quorum errores non advertit sedpraetermittit”); serviva, nondimeno, per questi interventi superficiali (maimprescindibili)117.
Non sempre tale forma di censura era così ossessiva: la copia del Lexiconiuris civilis di Jacob Spiegel (ampiamente corretta, ma non indicata cometale nell’Index autografo) non avrebbe certo soddisfatto i canoni espurgatoridi Gregorio da Napoli: risultano, ovviamente, tagliate diverse carte conte-nenti i trattatelli di Oldendorp, Hegendorf e Melantone [fig. 11], i cui no-
curate da Gregorio da Napoli in Diligentia per servitio della Corte Romana [...] nel scoprire i partico-lari libri […] per li quali la Republica christiana resta confusa […] BAV, Vat. Lat. 12728, p. 68.
115. CFC 1795; anche l’esemplare posseduto dalla BUG è mutilo della carta a2.
116. Enchiridion ecclesiasticum, Venetiis, Hieronymo Polo, 1588, c. 153v; la lista occupa le cc.146-160, si apre con S. Agostino e si chiude con Zonara, e sarebbe stata preparata dal canonicoGiovanni Francesco Lombardo, uno degli ecclesiastici più attivi sul fronte della censura a Napoli(cfr. Lopez, Inquisizione stampa e censura, cit.; R. Savelli, Da Venezia a Napoli: diffusione e cen-sura delle opere di Du Moulin nel Cinquecento italiano, in Censura ecclesiastica e cultura politica,cit., ad indicem).
117. ACDF, Index II/21, cc. 159-160. L’attenzione di Gregorio agli “inquinamenti” ereticali loaveva portato a segnalare che nell’opera di Copernico erano presenti due autori proibiti, senzaperò valutare il libro stesso (“In Nicolao Copernico scribit Achilles Pyrminius Gassarus. Geor-gius Ioachimus Rheticus” – aveva evidentemente presente l’edizione del 1563, dove compare unalettera di Gasser, cfr. Enchiridion, cit., c. 157r). Da questa citazione dovrebbe dipendere quellasuccessiva di altri censori napoletani segnalata da Lerner, Copernic suspendu, p. 73.
mi erano depennati nell’indice (ulteriormente ricoperto da un foglio di car-ta bianca); evidenti sono le “operazioni chirurgiche”, capillari, su singolilemmi con cancellazioni e incollature, ma vi sono ancora i nomi di Erasmoe Oldendorp – depauperati degli aggettivi encomiastici [fig. 10]118.
Il problema era comunque di carattere più generale e si presentava per lamaggior parte dei lessici prodotti in paesi riformati o in Francia: molti era-no finiti all’indice proprio per la citazione di autori vietati, ma verso di essisi era manifestata una certa qual tolleranza, come in parte dimostrano le vi-cende del Thesaurus linguae latinae di Robert Estienne. Purtroppo l’esem-plare “purgatus” che aveva Canevari non è più conservato; ma potrebbe aversubito lo stesso trattamento cui fu sottoposto quello appartenuto a un suoillustre concittadino, G.B. Grimaldi119.
Benché la terza edizione del Nomenclator di A. Junius fosse stata stam-pata ad Anversa nel 1583 con il permesso del “censore regio ed ecclesiasti-co”, Iohannes Molanus, anche questo volume è ricordato nel catalogo co-me “correctus”: l’autore, infatti, era stato posto fin dai tempi dell’indice tri-dentino nella prima classis, ma dal suo interessante lessico furono tolte solo
la biblioteca disciplinata
907
118. CFC 1772; il caso di Spiegel è significativo perché, come scrisse proprio Gregorio da Na-poli, era degno di censura “non quod ipse liber sit haereticus, sed quia ibi citantur nonnulli haereti-ci cum suis sententiis” e così per più di venti pagine a stampa indicò tutte le occorrenze di Erasmoe Oldendorp (Enchiridion, cit., cc. 199-211); l’opera, benché più volte segnalata, e vietata negliindici spagnoli, non fu presa in considerazione né in quello tridentino del 1564 né in quello ro-mano del 1596 (benché ricorra negli elenchi degli anni Settanta-Ottanta): cfr. R. Savelli, Thecensoring of law books, cit., p. 241.
119. ILO, c. 121v (in base al catalogo “genovese” sappiamo che si trattava dell’edizione Venetiis1551). La copia posseduta da G.B. Grimaldi è descritta da A. Hobson, Apollo and Pegasus. Anenquiry into the formation and dispersal of a Renaissance library, Van Heusden, Amsterdam 1975,pp. 45, 149; dopo un primo permesso del 1559 (che rinviava direttamente alla ricordata Instruc-tio del cardinale Ghislieri, cfr. nota 108), ve ne è un secondo del 1594, “hac tamen lege ut nomi-na deleantur authorum qui in indice librorum prohibitorum damnati sunt [...] si tamen de religionevel moribus tractant”; e infine un terzo del 1633 che ricorda come “Robertus Stephanus Auctorhuius thesauri est auctor damnatus, opus tamen hoc est permissum”. In occasione di un sequestro aCampagna (1580) fu restituito dopo aver cancellato il nome dell’autore (J. Tedeschi, The Prose-cution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy, Binghamton, Medieval& Renaissance Texts & Studies, New York 1991, p. 326); altri casi sono ricordati da P. de Nol-hac, “La bibliothèque d’un humaniste du XVIe siècle. Les livres annotés par Muret”, in «Mélan-ges d’archéologie et d’histoire», 3 (1883), pp. 202-238.
rodolfo savelli
908
poche righe, seguendo in questo caso le segnalazioni dell’indice espurgato-rio spagnolo del 1584120.
Ovviamente, a fianco di siffatta “ossessione onomastica” stavano purela disattenzione, la trascuratezza, la dimenticanza. Vi è in effetti qualchevolume curato proprio da Brunfels o da Gesner che è rimasto integro: illoro nome magari non figurava nel frontespizio (ad esempio nell’edizionedell’Anatomia di Alessandro Benedetti)121. Oppure il censore non avevascoperto l’arcano di uno pseudonimo: il Thesaurus de remediis secretis di“Evonymus Philiater” è passato indenne benché fosse frutto della pennadi Gesner122.
Nei volumi di Canevari, inoltre, è presente il segno di un’ulteriore for-ma di controllo dei nomi: quelli dei tipografi e degli editori. Di fronte a unintervento di questo genere, un anonimo possessore (la cui mano non pareidentificabile con quella del medico genovese) annotò: “Index Romanus ar-guit libros suspectos ex impressore”123. Non sono molte le occorrenze, ancheperché la lista di questi “imprenditori proibiti” ebbe formalmente vita bre-ve: stampata in appendice all’indice del 1559, fu successivamente abbando-nata124. Pur tuttavia in qualche edizione di Johann Herwagen, Heinrich Pe-tri, Christian Hegenolph, Johann Oporinus, Andreas Cratander, Ulrich
120. ILO, c. 108r (CFC 1145); i passi cancellati sono quelli indicati in ILI VI, p. 1004. Sul ver-so del frontespizio è annotato: “Hic liber ita expurgatus permittitur. fr. Paulus de Francis magi-ster et R.mi P. Magistri sac. pal. ap.ci socius”; Paolo de Francis fu socius di Giovanni Maria Guan-zelli almeno nel periodo 1600-1605, come ricorda nella premessa al lettore delle sue Orationesselectae in sacello apostolico [...] Tomus primus. Pars prima [-tertia], Romae, apud Aloisium Zan-nettum, 1606; per altre informazioni cfr. Edizioni pavesi del Seicento: il primo trentennio, E. Gri-gnani e C. Mazzoleni (a cura di), Cisalpino, Milano 2000, pp. 66 e ss.
121. CFC 400; e CFC 284 edizione di Aristotele curata da Gesner.
122. CFC 1003. Come racconta con stupore Michel de Montaigne, a Roma gli fu confiscata latraduzione francese del De republica helvetiorum di Simler “per la sola ragione che il traduttore èeretico; e sì che non è nemmeno nominato: ma c’è da restar stupiti a vedere come conoscono gliuomini del nostro paese” (Viaggio in Italia, Laterza, Bari 1991, p. 198; sembra che il traduttorefosse Gentillet, ma in realtà tutte le opere di Simler erano all’indice dal 1559).
123. CFC 1763: si tratta del Polyhistor di Solino (Basileae per Michaelem Isingrinum et Henri-cum Petri, 1538).
124. ILI VIII, pp. 332-346.
Morhart, Robert Estienne, o in cui compariva semplicemente il loro nome,questo fu cancellato o modificato [figg. 12-13]125.
Una decisione del genere era troppo “sommaria” per avere successo (l’es-sere incluso nell’elenco avrebbe comportato un divieto per tutte le operepubblicate), ma aveva degli estimatori: vent’anni dopo, ad esempio, in unmomento di revirement rigorista, un domenicano (Paolo Artusini) compila-va a Ravenna per evidenti usi di ufficio un indice dei libri proibiti, in cuitrascriveva quello tridentino del 1564, l’aggiornamento avuto da Roma nel1579 (il cosiddetto “indice di Parma”), la lista dei tipografi del 1559 eun’espurgazione alla Cosmographia di Münster126. D’altra parte questo tipodi “rappresaglia” nei confronti di editori ritenuti pericolosi non fu del tuttodimenticato: nel 1606, in occasione del conflitto dell’Interdetto con Vene-zia, il noto Roberto Meietti fu colpito da una condanna del genere, e duesue edizioni risultano così mutilate127.
8. Quando nel 1596 si chiamarono gli inquisitori ad applicare l’indiceclementino, emersero problemi di diverso genere e numerosi furono i que-siti sottoposti alle Congregazioni romane. Uno è abbastanza ricorrente: aVercelli si osservò che “in detto Indice non sono posti tutti li libri et opereche si contengono nelle liste già più anni mandate dal Santo Offitio di Ro-ma et dal Maestro di Sacro Palazzo che sono stampate”128. Gregorio da Na-
la biblioteca disciplinata
909
125. CFC 163, 694, 886, 1200, 1555-1556, 1572, 1624, 1788, 1801, 1975.
126. Biblioteca Classense Ravenna, Ms. 512; sul cosiddetto indice di Parma (che in questo ma-noscritto è ridistribuito sotto le singole partizioni alfabetiche), cfr. U. Rozzo, Index de Parme, inILI IX, pp. 19 e ss.
127. CFC 1676, 2332. Il testo dell’editto dell’Inquisizione, particolarmente minaccioso per lesue implicazioni economiche, si trova ad esempio in Scriniolum Sanctae Inquisitionis, cit.,pp. 389-390; sequestri e perquisizioni alla ricerca di suoi libri sono segnalati da Lopez, Inquisi-zione stampa e censura, cit., pp. 207 e ss., 350 e ss.; Infelise, I libri proibiti, cit., pp. 67-68 (eancora nel 1615 si facevano sentire gli echi della scomunica: Spampanato, Nuovi documenti in-torno a negozi e processi dell’Inquisizione, cit., p. 376). Nelle istruzioni alla periferia si tolleravanole opere stampate prima del 1606: cfr. Rotondò, Nuovi documenti, cit., p. 184; sull’episodio cfr.D.E. Rhodes, “Roberto Meietti e alcuni documenti della controversia fra Papa Paolo V e Vene-zia”, in «Studi secenteschi», I (1960), pp. 165-174.
128. Tibaldeschi, Un inquisitore in biblioteca, cit., p. 48.
rodolfo savelli
910
poli suggeriva “di notare qualche regola circa li libri non notati in detto in-dice del 1596” e che pure erano stati inclusi in quelli precedenti129.
In effetti, oltre ai ricordati indici del 1590 e del 1593 (che ebbero limita-tissima circolazione, in quanto non promulgati), negli anni ’70 e ’80 delCinquecento erano stati pubblicati diversi aggiornamenti, con divieti che avolte si riallacciavano direttamente all’indice inquisitoriale del 1559, a voltepreannunciavano condanne che sarebbero venute negli anni seguenti, a vol-te introducevano titoli del tutto nuovi successivamente non accolti130.
Proprio grazie alle peculiarità di questo periodo si possono datare in mo-do più preciso determinati interventi e quindi capirne meglio il significato.Ad esempio, Canevari si era preoccupato di annotare “correctus” in corri-spondenza di “Petrus Crinitus de honesta disciplina”. Perché? La motivazio-ne va ricercata, da un lato, negli indici del 1590 e del 1593 (in questi erastato collocato tra i vietati, ma emendabili), e, dall’altro, nella raccolta diespurgazioni pubblicata dal Maestro del sacro palazzo nel 1607 dove era ri-
129. Diligentia, cit., BAV, Vat. Lat. 12728, p. 62; la vicenda da cui prese spunto il cappuccinoè abbastanza curiosa perché si tratta del giurista tedesco Matthias Coler che, a suo dire, era statoproibito nel 1593 e omesso nel 1596; in realtà non risulta nell’indice del 1593, sebbene ne fossestata proposta l’inclusione e da qualche anno avesse attirato l’attenzione dei censori romani (cfr.ACDF, Index II/2, c. 126r.; II/7, c. 256; II/9, cc. 150-160); il suo nome è presente in una listadi aggiornamento databile attorno al 1589: Annotatio librorum prohibitorum et suspensorum ultraeos qui in Indice generali Concilii Tridentini continentur, snt., su cui cfr. Savelli, Allo scrittoio delcensore, cit., p. 303. In tale prospettiva è interessante anche il caso della Paraphrasis ai Salmi diMarcantonio Flaminio: ancora nel 1605 un letterato genovese si rivolgeva al Maestro del Sacropalazzo per chiedergli una risposta “ufficiale”, in quanto in città vi era chi lo considerava del tut-to vietato, mentre altri lo leggevano liberamente; non era, infatti, presente nell’indice del 1596,mentre era più volte comparsa tra il 1559 e il 1590 (G.N. Sauli Carrega, Epistolarum libri tresposteriores, in aedibus Iosephi Pavonis, Genuae 1619, pp. 6-8; A. Pastore, Marcantonio Flami-nio. Fortune e sfortune di un chierico nell’Italia del Cinquecento, F. Angeli, Milano 1981); segnoevidente delle diffuse incertezze è il fatto che nel 1610 venisse bruciato a Napoli e riemergesse inun elenco non ufficiale di libri proibiti ancora nel 1620 (Lopez, Inquisizione stampa e censura,p. 217; Syllabus seu collectio librorum prohibitorum, & suspensorum [...] Additis etiam aliis Libris[…], Apud Marcum Naccarinum, Perusiae 1620).
130. Tutte queste liste (tranne l’Annotatio di cui alla nota precedente) sono state ripubblicate eanalizzate in ILI IX. Sulle politiche censorie del periodo cfr. Fragnito, La Bibbia al rogo, cit., pp.111-171; V. Frajese, “La revoca dell’Index sistino e la curia romana (1588-1596)”, in «Nouvellesde la République des Lettres», 1 (1986), pp. 15-49; Id., La politica dell’Indice, cit., pp. 93 e ss.
comparso (abbastanza curiosamente: la proibizione, infatti, era assente inquello del 1596)131.
Qualcosa di simile deve essere avvenuto per gli scritti del più famoso Ni-cola Cusano: l’edizione stampata a Basilea nel 1565 era stata malamente di-visa e un po’ “sconciata”132. In base agli antichi inventari risultava già collo-cata in due “plutei” distinti (contenente l’uno i volumi di filosofia, l’altroquelli di matematica); ma non è solo una questione di divisione materiale odi argomento; il fatto è che l’opera risulta priva della maggior parte dellepagine del secondo tomo, quelle che comprendevano, ad esempio, il Deconcordantia catholica. Questo trattato, che figurava già in un avviso ai li-brai del Maestro del sacro palazzo del 1574, compare negli elenchi di ag-giornamento fino all’indice del 1590. Mentre in quest’ultimo era presentecon la clausola “donec corrigatur”, nel 1579-1580 l’indicazione era ben piùradicale: “decretum est per congregationem esse comburendum librum de con-cordantia. Tenet siquidem Concilium supra Papam et multa probare nititurcontra autoritatem Papae”133.
In un caso come questo, la puntuale e zelante osservanza dei precetti cen-sori (da parte di Canevari? di precedenti possessori? dei librai?) ha portato adanni irreparabili, che già allora dovevano risultare ancora più molesti, se siconsidera che l’opera del grande intellettuale e uomo di Chiesa del XV se-colo (nonché cardinale) era stata successivamente in qualche modo accetta-ta (o meglio, non più vietata).
la biblioteca disciplinata
911
131. ILO, c. 119r (dall’inventario “genovese” risulta che si trattava dell’edizione lionese del 1561;il volume non è più conservato); Indicis librorum expurgandorum […] tomus primus, cit., pp.681-682: fu ripresa l’espurgazione a quest’opera dall’indice spagnolo del 1584. Per le discussionirelative a Crinito cfr. Frajese, La politica dell’Indice, cit., pp. 326, 336, 342.
132. CFC 737.
133. ILI IX, pp. 159, 390, 747, 749-750, 755, 757, 766, 776, 835; X 836 (cfr. Frajese, Lapolitica dell’Indice, passim). Se ne discusse ancora negli anni successivi, ma senza decisione for-mali: cfr., ad esempio, ACDF, Index I/1, c. 80v. Bellarmino sembrava attribuire le posizioni diCusano a intemperanze “giovanili”, legate ai dibattiti del concilio di Basilea (cfr. De scriptoribusecclesiasticis, Lugduni, sumptibus Horatii Cardon, 1613, p. 235). Tra le carte della Congregazio-ne dell’indice, in un appunto databile attorno al 1610 si osservava “non videtur nominatim pro-hibita, tamen multa continet in favorem conciliorum et in odium romani pontificis satis scandalosa.In Collegii Romani bibliotheca invenitur hoc opus excisum ex operibus Nicolai Cusani” (ACDF, In-dex II/21, c. 310r).
rodolfo savelli
912
Avendo presenti le proibizioni di questo periodo (1574-1593) si trovauna spiegazione delle mutilazioni che subirono altri libri, innegabilmentepiù innocui da un punto di vista teologico: ad esempio dall’edizione aldinadei Dialoghi di Sperone Speroni fu levato quello dedicato all’usura, che, co-me si registrò nei verbali della Congregazione, era “aspersus erroribus”; e Ca-nevari, diligentemente, annotava “corretto”, sebbene i Dialoghi non fosseropiù presenti nell’indice del 1596 (grazie anche al fatto che nel frattempo erastata concordata con i discendenti una versione “emendata”)134.
Qualche volta, per fortuna, questo zelo non fu così efficiente: vi sonovolumi menzionati solo negli elenchi di questo ventennio (ma non nell’in-dice del 1596) e che sono rimasti integri – ad esempio Fabio Benvoglienti oSimone Porzio135.
La libraria di Canevari offre pure una viva testimonianza delle tensioniche si manifestarono nella cultura filosofica italiana, in rapporto a quelloche, in modo convenzionale (e un po’ di maniera), si può definire l’aristo-telismo controriformista, e di come queste tensioni si traducessero poi con-cretamente nelle pratiche di circolazione e conservazione dei libri. Sono ab-bastanza note le vicende di due autori che incapparono nelle maglie semprepiù strette della censura ecclesiastica, e vi rimasero definitivamente impi-gliati: Bernardino Telesio e Francesco Patrizi136.
Or bene nell’indice del 1596 per Telesio sono ricordati con la clausola“donec expurgentur” il De rerum natura, il De somno e il Quod animal uni-versum: questi ultimi due erano stati inclusi in una raccolta di opuscoli pub-blicata nel 1590 da Antonio Persio; entrambi sono stati tolti dalla copia ca-
134. ILO c. 121r; CFC 1771 (e cfr. ACDF, Index II/1; l’edizione corretta e priva del dialogo inquestione è quella pubblicata a Venezia, appresso Roberto Meietti, 1596).
135. CFC 411, 1597.
136. L. Firpo, Filosofia italiana e controriforma, in “Rivista di filosofia”, XLI (1950), pp. 159 ess.; XLII (1951), pp. 30 e ss.; Rotondò, La censura ecclesiastica, cit., pp. 1455 e ss.; Id., Cultu-ra umanistica e difficoltà dei censori. Censura ecclesiastica e discussioni cinquecentesche sul platoni-smo, in Le pouvoir et la plume. Incitation, contrôle et répression dans l’Italie du XVIe siècle, Uni-versité de la Sorbonne nouvelle, Paris 1982, pp. 15-50; A.E. Baldini, Aristotelismo e platonismonelle dispute romane sulla ragion di Stato di fine Cinquecento, in Aristotelismo politico e ragion diStato, A.E. Baldini (a cura di), Olschki, Firenze 1995, pp. 201-226; Frajese, Nascita dell’Indi-ce, cit., pp. 161-162.
nevariana e i titoli cancellati dal frontespizio137. Nella biblioteca del medicogenovese sono rimaste solo le parti finali della rara edizione ferrarese dellaNova de universis philosophia di Patrizi, quelle contenenti i testi ermetici,ma non l’opera vera e propria138. Al filosofo, infatti, come aveva stabilito laCongregazione dell’indice, era stato ordinato
ut omnia sui operis exemplaria quam diligentissime perquireret et Congregationi tra-deret supprimenda sicuti postea per Secretarium factum est, et quae in Urbe repertasunt in unum collecta apud Magistrum Sacri Palatii servantur139.
Nell’indice del 1596 il trattato era stato vietato con una clausola espur-gatoria un po’ particolare, dettata probabilmente dal fatto che l’autore erain vita e che manteneva ampie (ma insufficienti) protezioni: “nisi fuerit abAuctore correcta, et Romae, cum approbatione R. Magistri Sacri Palatii, im-pressa”140.
Patrizi morì l’anno successivo e Telesio era già morto da otto anni. No-nostante un tentativo esperito dalla città di Cosenza e dai discendenti di farlevare il filosofo calabrese dall’indice, era ovviamente difficile procedere adun’espurgazione che la stessa Congregazione reputava “impossibilis”141. La
la biblioteca disciplinata
913
137. CFC 1822: mentre nel catalogo autografo sono elencati tutti i singoli opuscoli (omettendoquelli tagliati), nell’inventario fatto a Genova furono usate solo le parole iniziali de naturalibusrebus libelli.
138. CFC 1472; cfr. la sibillina descrizione in ILO, c. 32v: “Francisci Patritii Zoroaster et aliaeiusdem opuscula platonica ac alia”.
139. ACDF, Index I/1, c. 76r.
140. ILI IX, 945; e cfr. Frajese, La politica dell’Indice, cit., pp. 334 e ss (una delle questioni di-scusse dopo il 1593 fu appunto quella degli autori cattolici viventi).
141. ACDF, Index I/1, c. 149v; R. Bondi, “Expurgatio impossibilis”: filosofia e religione in Te-lesio, in “Rivista di storia della filosofia”, LI (1996), pp. 881-894. Che certe clausole espurga-torie equivalessero, nei fatti, a un divieto totale era palese alla stessa Congregazione dell’indi-ce: si veda il coevo caso del divieto “condizionato” della République di Bodin, per il quale siosservava che “perinde est ac si sub aliis verbis omnino prohibeatur” (sul contesto di questa com-plessa vicenda cfr. E. Baldini, Jean Bodin e l’Indice dei Libri proibiti, in Censura ecclesiastica ecultura politica, cit., pp. 79-100, e p. 97 per la citazione; e le precisazioni di Fragnito, Proi-bito capire, pp. 66 e ss.).
rodolfo savelli
914
conseguenza fu che, sebbene vietate con una clausola apparentemente piùblanda (“donec expurgentur”), nei fatti, proprio perché le espurgazioni nonarrivarono mai (o non potevano giungere), queste opere rimasero interdettenon diversamente da quelle di un Pomponazzi (De incantationibus) o di unPontano (Charon) che, messe all’indice senza alcuna clausola, erano stateparimenti asportate negli esemplari della collezione di Canevari142.
9. Durante il lungo e faticoso lavorio di scrittura dell’Amedeide, Gabriel-lo Chiabrera annotava in una lettera del 1614: “ho ricercato in lei tutto quel-lo che secondo l’uso moderno possa annoiare il P. Inquisitore e secondo menon vi ho lasciata parola che sia sbandita, dico fato, fortuna, e destini e si-migliante”143. La testimonianza è interessante perché evidenzia quello chestava diventando un diffuso fenomeno di autocensura tra i letterati: in que-sto periodo sono gradualmente eliminati “usi espressivi” che ai nostri occhipossono sembrare meramente lessicali, ma che a quelli dei censori simbo-leggiavano ben più rilevanti problematiche; tale forma di “pulizia” era mes-sa in atto dal poeta per prevenire possibili fastidi (come quelli in cui era in-corso uno stupito Montaigne, alcuni decenni prima)144.
Tali tracce letterarie sono coerenti con altre che portano direttamente alcuore di una delle ultime questioni che si vuole qui illustrare, vale a dire labattaglia antiastrologica (e in genere antimagica) condotta allora dalla Chie-sa, e di cui così tanti segni sono rimasti anche tra i libri di Canevari, a voltea livello di semplici interventi su parole ormai “vietate”. Consultando edi-
142. CFC 1574 e 1581: la prima segnalazione di Pomponazzi era del 1574 (ILI IX, p. 747), enel 1576 si era aggiunto Pontano (Scriniolum Sanctae Inquisitionis, cit., p. 89).
143. G. Chiabrera, Lettere (1585-1638), S. Morando (a cura di), Olschki, Firenze 2003, p. 205.
144. Si veda come nel resoconto del suo soggiorno romano rievochi gli incontri con il Maestrodel sacro palazzo e le censure per “aver fatto uso della parola fortuna” (Montaigne, Viaggio inItalia, cit., p. 197; sull’episodio cfr. Godman, The Saint as Censor, cit., pp. 45 e ss, 339 e ss.).Sempre attuali, in proposito, le osservazioni di Luigi Firpo (che possono essere estese alle politi-che di espurgazione): “si instaura […] fra autore e censore una schermaglia sottile: il primo si-mula con riserva mentale una docilità fittizia e mira a salvare il salvabile, il secondo misura conscrupolose seste ognuna delle parolette vecchie e delle nuove, e se in un luogo entra con la falce,altrove si contenta di piccole sforbiciature e spesso, tutto intento a cercar pagliuzze, si lascia sfug-gire la trave” (Correzioni d’autore coatte, in Studi e problemi di critica testuale, Commissione per itesti di lingua, Bologna 1961, p. 154); Fragnito, Proibito capire, pp. 166 e ss.; e cfr. nota 172.
zioni delle opere dell’astronomo tedesco del XV secolo Regiomontano (Mül-ler) si può constatare come in alcuni casi sia stata “operosa” la più volte ri-cordata censura onomastica e/o degli elementi paratestuali145; in un altro,alla rimozione di nomi (Leowitz e Melantone) si è aggiunta la modifica diun termine presente nel frontespizio: là dove si magnificava l’utilità delleTabulae directionum per l’“astrologia iudiciaria”, l’aggettivo è stato trasfor-mato nel più inoffensivo “speculativa”146.
La correzione ha motivazioni profonde, che si riannodano alle radici dellatradizione cristiana, particolarmente ravvivata nelle dispute cinquecenteschesul libero arbitrio (con possibili implicazioni del dibattito cosmologico)147. Lacondanna si era concretizzata in un divieto riassuntivo, e non nominativo, apartire dall’indice del 1559 (“Libri omnes et scripta Chiromantiae, Physiono-miae, Geomantiae […] vel Astrologiae iudiciariae divinationes circa futuros con-tingentes eventus”), ribadito e ampliato nella bolla di Sisto V Coeli et terrae del1586148. Le precisazioni contenute nella regula IX dell’indice clementino (“per-mittuntur autem iudicia et naturales observationes, quae navigationis, agricoltu-rae sive medicinae artis iuvandae gratia conscripta sunt”) avevano aperto unascappatoia per non gettare al macero tutta la letteratura astrologica e avevanofornito il destro a significative querelles interpretative149.
la biblioteca disciplinata
915
145. CFC 1143: sono cadute dediche ed è cancellato il nome di Santbech (censure del genere sitrovano in un esemplare che era appartenuto al fratello Ottaviano: CFC 1141). Interventi similiin altre opere di carattere astronomico: nelle edizioni di Reinhold (CFC 1643) e Peucer (CFC1644: depennato il nome dell’autore della dedica, K. Dasypodius; in CFC l’opera fu erronea-mente attribuita allo stesso Reinhold).
146. CFC 1140; al volume sono stati tolti anche un paio di fascicoli, oltre ai nomi “proibiti”presenti all’interno.
147. Nel lungo elenco dei libri concessi ad Antonio Roffeni per quelli astrologici era specificato“ut iis non utatur quoad iudiciariam de actibus humanis a libero arbitrio dependentibus” (ACDF,SO, St. st. Q1c, cc. 85v-86r); e cfr. infra testo corrispondente a nota 155.
148. Baldini, The Roman Inquisition’s condemnation of astrology, cit.; Id., L’Inquisizione romanae le scienze, cit., pp. 681 e ss; per un panorama non limitato agli ambienti cattolici cfr. K. Tho-mas, Religion and the Decline of Magic, Harmondsworth, Penguin, 1978, pp. 335 e ss. Sulla bol-la sistina cfr. G. Ernst, Religione, ragione e natura. Ricerche su Tommaso Campanella e il tardo Ri-nascimento, Angeli, Milano 1991, pp. 255 e ss.
149. ILI IX, p. 922; ad esempio fu messa in discussione la validità della bolla sistina anche per-ché si sapeva che non sarebbe stata inclusa nel progettato (ma non pubblicato) liber septimus de-
rodolfo savelli
916
L’aver usato in questa circostanza (come in poche altre) la locuzione li-bri omnes […] astrologiae metteva al riparo dal dover seguire una produ-zione sterminata (e di valore molto ineguale – visto che con l’astrologia siconfrontavano matematici e astronomi, medici e agronomi, ma anche sem-plici ciarlatani)150. Al contempo, forniva a censori e inquisitori uno stru-mento di potere in più, lasciando all’arbitrio individuale la decisione sucosa permettere e cosa escludere. In effetti le incertezze e la variabilità neigiudizi sono ricorrenti nella documentazione del tempo. Non è da consi-derarsi quindi casuale che, nel citato Enchiridion di Gregorio da Napoli,alla voce “astrologia” fosse inserito un lungo ed eterogeneo elenco di auto-ri, antichi e moderni, “qui non sunt notati in Indice”, i cui scritti, però,potevano avere attinenza con questo tema e verso i quali, quindi, andavaattivata la sorveglianza151.
Nel 1598 fu presentata all’Inquisizione una significativa e ricca lista dilibri vietati conservati a Pisa (Machiavelli, Bodin, Boccaccio, Aretino, e poiErasmo e i Vangeli in volgare): sono altresì elencate le “Efemeridi del Mole-to e d’altri”. Moleti e Giuntini figurano tra gli autori per cui si chiede la li-cenza di lettura a Roma; nessuno dei due era mai comparso fino ad alloranegli indici (ma erano stati segnalati nel 1588 da Gregorio da Napoli)152. Inun inventario della biblioteca medicea degli inizi del ’600 sono segnati conla “P” di proibito numerosi testi astrologici (che non erano individualmen-
cretalium (ACDF, Index, II 22, c. 150); e cfr. Baldini, The Roman Inquisition’s condemnation ofastrology, cit., pp. 95 e ss. Sulla letteratura astrologica di tipo “basso” cfr. E. Casali, Le spie delcielo. Oroscopi, lunari e almanacchi nell’Italia moderna, Einaudi, Torino 2003.
150. Come scriveva in quegli anni Agostino Bucci a Faber “Le cose d’Astrologia sono nelle re-gole generali dell’Indice però V.S. non troverà mai per tal capo nominati gli autori” (Miggiano,“Libri prohibiti”: qualche appunto dalle carte di Johannes Faber, cit., p. 254).
151. Enchiridion ecclesiasticum, cit., c. 148 (cfr. nota 116); alle cc. 160v-165v è ripubblicata labolla sistina Coeli et terrae.
152. E. Baldini, Jean Bodin e l’Indice, cit., pp. 92-93; U. Baldini, Il pubblico della scienza, cit.,pp. 188-189. Il nome di Giuntini era indicato anche in una breve lista di libri proibiti, prevalen-temente astrologici, accompagnata da un’altra di “corrigendi”, in cui è pure presente ValentinNaiboda; questi due elenchi, databili in via ipotetica agli Ottanta del Cinquecento, sono pubbli-cati in Scriniolum Sanctae Inquisitionis, cit., p. 96 (il curatore del volume aveva annotato “duaeinfrascriptae schedae [...] a quo et quando pervenerint non invenitur”). La “pericolosità” di Giuntiniè segnalata in due lettere di Bellarmino del 1596 (ACDF, Index, III/1, cc. 246-248).
te menzionati nell’indice, e la stessa “P” è annotata a fianco di trattati di ca-rattere medico-botanico, ugualmente non vietati)153.
Per capire come la censura ecclesiastica operasse in concreto, è necessa-rio non fermarsi ai soli elenchi “ufficiali” degli indici; si deve entrare in quel-la zona un po’ “grigia” rappresentata dalla comunicazione tra Roma e la “pe-riferia” (sia le istituzioni inquisitoriali locali, sia i singoli proprietari di li-bri), e cercare di comprendere come la “periferia” interpretasse i dettamidelle Congregazioni romane. La zona “grigia” diventa ancora più ampia eincerta se si tiene presente qualche documento di quel ventennio di incer-tezze sopra ricordato (1574-1593), lo stesso periodo in cui si stava forman-do la libraria di Canevari. Così facendo si capirà meglio come e perché vo-lumi della stessa siano giunti a noi mutili e incompleti.
Prendiamo l’avvio ancora una volta dagli anni a ridosso del 1596, quan-do era in atto la complessa iniziativa di ripulitura delle biblioteche italiane,ed era attesissima la pubblicazione di un indice “espurgatorio” che permet-tesse il salvataggio di una parte delle stesse154.
Tra i documenti della Congregazione dell’indice è conservata copia dellalicenza concessa dall’inquisitore di Faenza a Girolamo Casale detto il Casa-matta “professore d’astrologia”: era autorizzato a tenere testi di Cardano,Giuntini, Firmico Materno e altri, “cum hac conditione, quod dictos libros
la biblioteca disciplinata
917
153. L. Perini, Contributo alla ricostruzione della biblioteca privata dei Granduchi di Toscana nelXVI secolo, in Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan, Olschki, Firenze 1980, II,571-667. Negli anni Trenta del Seicento l’inquisitore di Aquileia e Concordia concedeva licenzedi lettura comprendenti opere non proibite: cfr. E. Kermol, La rete di Vulcano. Inquisizione libriproibiti e libertini nel Friuli del Seicento, Università, Trieste 1990, pp. 99-100.
154. Sul (parziale) fallimento di questa operazione cfr. G. Fragnito, «In questo vasto mare de li-bri proibiti et sospesi tra tanti scogli di varietà e controversie»: la censura ecclesiastica tra la fine delCinquecento e i primi del Seicento, in Censura ecclesiastica e cultura politica, cit., pp. 1-35; Ead.,Proibito capire, cit., pp. 191 e ss.; sulla pubblicazione di espurgazioni cfr. Savelli, Allo scrittoiodel censore, cit. La tarda uscita e il disconoscimento dell’indice preparato dal Maestro del sacropalazzo, Guanzelli, portò probabilmente alla pubblicazione nel 1610 di un volume analogo (madi mole incomparabilmente più ridotta) indirizzato espressamente al mondo professionale dei“medici”, la Expurgatio quorundam librorum medicorum prohibitorum (cfr. supra nota 21): nel-l’opuscolo sono edite espurgazioni a opere di Villanova, Grataroli, Cardano, Fuchs e altri; quasitutte furono tratte dall’indice di Guanzelli del 1607, che, a sua volta, aveva attinto pure in que-sta circostanza da quelli antecedenti (Anversa e Madrid).
rodolfo savelli
918
corrigat in locis suspectis ubi de futuribus contingentibus […] aut iis actionibusquae ab humana voluntate pendent certo aliquid eventum affirmare audent”.A parte Cardano (su cui si tornerà) questi autori, come si è visto, non era-no individualmente proibiti155.
Il problema doveva essere ben presente alla Congregazione visto che inun formulario di licenze di lettura ve ne è una specifica per questo tipo diopere: era precisato che si autorizzavano i libri “de astrologia […] vel ad eampertinentibus nec non res matematicas seu astrologicas continentes, modo in in-dicem romanum vel hispanum relati non sint”, che era un modo per metterealmeno qualche paletto156. Nell’indice espurgatorio allestito a Napoli nel1598 (che raccoglieva materiale redatto pure negli anni precedenti e non fumai pubblicato) si trovano correzioni a diversi testi di carattere astronomi-co-astrologico e tra questi compaiono nuovamente Moleti e Magini (e poiPitati, oltre a Leowitz, che però era all’indice dal 1559)157.
Riandando al “ventennio dell’incertezza” si incontrano molte tracce del-la presenza di questi nomi, non sempre con indicazioni univoche. In dueliste di aggiornamento dell’indice (varianti di un avviso del Maestro del sa-cro palazzo del 1574 e circolate in Piemonte), relativamente a Cardano sitrova, nell’una, “tutte l’opere stampate fuori di Roma avanti il 1574” e, nel-l’altra, “alcune opere […]”; nel 1576 ritorna nuovamente “tutte l’opere”;mentre negli elenchi del 1580 ricorrono locuzioni diverse158. In una brevis-sima nota senza data (ma che dovrebbe risalire a quest’epoca), insieme adastronomi e astrologi arabi e tedeschi, è presente (come si è sopra accenna-to) Francesco Giuntini; il quale è menzionato anche nella Annotatio del
155. ACDF, Index XVIII/1, c. 117r. Il “Casamatta” è ricordato nel volume di Casali, Le spie delcielo, cit.
156. ACDF, Index VIII/1.
157. ACDF, Index XXIII/1. Un cenno al fatto che Magini fosse stato convocato dall’Inquisizio-ne a Roma nel 1597 in M. Bucciantini, Galileo e Keplero. Filosofia, cosmologia e teologia nell’Etàdella Controriforma, Einaudi, Torino 2003, p. 70; sul sequestro dei libri e manoscritti astrologi-ci di Magini dopo la sua morte (sempre da parte dell’Inquisizione), cfr. A. Favaro, Carteggio ine-dito di Ticone Brahe, Giovanni Keplero e di altri celebri astronomi dei secoli XVI e XVII con Gio-vanni Antonio Magini, Zanichelli, Bologna 1886, pp. 60-62.
158. Scriniolum Sanctae Inquisitionis, cit., pp. 87, 89, 91-96 (ILI IX, pp. 758-769); cfr. supranota 22.
1589, ma si eclissa dagli indici romani (per sbucare, invece, in quelli spa-gnoli successivi)159.
Se da queste fonti “normative” si passa ai libri posseduti da DemetrioCanevari (e dal fratello Ottaviano) risulta che, per quanto riguarda Giunti-ni, sono rimaste soltanto le parti contenenti le tabulae e mancano quellecon le trattazioni teoriche160. Altrettanto è accaduto con le Ephemerides coe-lestium motuum del Magini; nel caso di quelle di Moleti o Stade i tagli fu-rono più mirati, cancellando singoli passi e pagine161. La tecnica è stata se-guita anche per testi di minor rilievo, come le Osservazioni de astrologia diBattista de Ruberti o l’Almanach novum di Pietro Pitati [fig. 14]162.
Spostando l’attenzione dall’astrologia a opere di carattere (che per co-modità possiamo definire) “magico”, si constata che gli effetti dell’attivitàcensoria sono sempre gli stessi: ora per levare qualche nome, ora per inter-venti su singole parti, ebbene tagli e cancellature ricorrono nei trattati diArnaldo da Villanova, Camillo Leonardi, Alessandro Achillini, Nicolò Pe-ranzone e di altri, alla ricerca di questo o quel passo, di questo o quell’opu-scolo che si era magari “intrufolato” nelle raccolte miscellanee (quelli di Lul-lo e Ruggero Bacone sono ovviamente espunti)163. Non tutti erano formal-mente e nominativamente nell’indice, se non nella misura in cui ricadeva-
la biblioteca disciplinata
919
159. Scriniolum Sanctae Inquisitionis, cit., p. 96 (e cfr. nota 152); Annotatio, cit., c.[3r] (cit. anota 129). Il fatto che autori come Giuntini, Magini e Moleti figurino nel Novus Index librorumprohibitorum et expurgatorum, Hispali, Ex typographaeo Francisci de Lyra, 1632 è il segno evi-dente di una diversa mentalità e del modo di concepire la funzione degli indici espurgatori (sugliautori citati cfr. Pardo Tomás, Ciencia y censura, cit., pp. 358-361).
160. Per lo Speculum astrologiae sia nell’edizione del 1573 (CFC 1025) sia in quella del 1581 (CFC1024: pervenuto dalla raccolta di Ottaviano) risulta assente la prima parte dell’opera, con tratta-zioni teoriche e oroscopi (non è un caso che fosse quella fortemente espurgata nell’indice spa-gnolo del 1632: Novus Index, cit., pp. 393-395); su Giuntini cfr. E. Proverbio, Francesco Giunti-ni e l’utilizzo delle tavole copernicane in Italia nel XVI secolo, in La diffusione del copernicanesimoin Italia 1543-1610, M. Bucciantini - M. Torrini (a cura di), Olschki, Firenze 1997, pp. 37-55.
161. CFC 1229, 1341, 1342, 1778; cfr. Novus Index librorum prohibitorum, cit., pp. 688, 695-698.
162. CFC 762, 1546.
163. CFC 122, 318 (dalla collezione del fratello Ottaviano: cfr. nota 57), 478, 670, 884, 1180,1494 (il raro volume di Peranzone pubblicato nel 1518 e proibito nel 1554: ILI III, p. 328), 1727.
rodolfo savelli
920
no sotto quella dizione di “libri omnes […]”; alcuni erano senza dubbio rarie/o “passati di moda”, di altri si ricordava evidentemente una condanna ri-salente a secoli addietro (il nome di Cecco d’Ascoli, ad esempio, bruciatocome eretico nel 1327, è accuratamente cancellato [fig. 15])164.
Le vicende della libraria confermano quanto ha osservato Ugo Baldinirelativamente a un “effetto d’alone” nelle pratiche censorie. Vale a dire: co-me vi erano richieste di permessi di lettura per testi non proibiti, così vi era-no espurgazioni, magari solo di tipo “onomastico”, ad autori mai stati for-malmente vietati (nella collezione di Canevari, ad esempio, si segnalanocancellature e tagli a edizioni di Symphorien Champier)165.
Al contempo risulta evidente una circolazione diffusa di informazioni tracensori e lettori riguardo a scritti che, prima o poi, sarebbero potuti cadere sot-to un’interdizione: nessuno avrebbe chiesto licenze di lettura di libri non proi-biti se fosse stato realmente sicuro della loro totale “innocenza”. I ricordati no-mi di Giuntini, Magini e Moleti, alcune opere dei quali comparvero successi-vamente nell’indice espurgatorio spagnolo del 1632, stanno a dimostrare chequando queste erano sottoposte a correzione si sapeva dove e come agire166.
Incollare strisce di carta su un capitolo dei trattati di Michele Savonaro-la (intitolato de pronosticis a verminibus sumptis) implicava un’approfonditaconoscenza della cultura dei divieti da parte di chi effettuava tale operazio-ne, una probabile partecipazione attiva da parte del possessore del libro (vi-sto che sembra poco verosimile ipotizzare che sia stato un singolo inquisi-tore ad andare a sfogliare un volume di un medico del XV secolo, stampatoagli inizi del ’500)167. Partecipazione che poteva andare oltre l’ossequio for-
164. CFC 59, 1133.
165. Baldini, Die Römischen Kongregationen der Inquisition, cit., p. 253 nota; Id., Il pubblicodella scienza, cit.; sull’influenza delle regole clementine cfr. Fragnito, La Bibbia al rogo, cit.,pp. 266 e ss.; Ead., “Girolamo Savonarola e la censura ecclesiastica”, in «Rivista di storia e let-teratura religiosa», XXXV (1999), pp. 525 e ss.; per Champier cfr. CFC 638-639.
166. Quando nel 1598 furono “emendate” le opere di Arnaldo di Villanova possedute da Otta-viano Canevari (CFC 318) non era ancora stata pubblicata in Italia un’espurgazione del volume;probabilmente fu seguito (in linea di massima) quanto previsto dall’indice spagnolo del 1584,che, non casualmente, fu poi recuperato nell’indice del 1607 e nella Expurgatio del 1610 (cfr.supra note 21 e 62).
167. CFC 1715.
male verso le disposizioni degli indici, ma presupponeva, comunque, che sifosse a conoscenza di quanto contenuto negli stessi (Demetrio aveva quellodel 1596, mentre il fratello Ottaviano possedeva quello tridentino in un’edi-zione veneziana del 1575 e l’espurgatorio di Guanzelli)168.
La biblioteca “disciplinata” può essere vista come una forma di scambiotra Chiesa e proprietario di libri: attraverso l’autodenuncia (con le richiestedi permesso), e con l’espurgazione degli stessi, si otteneva l’emersione dauna condizione di illegalità; ci si sottraeva così sia al ricatto delle spiate siaall’obbligo di dichiararli in confessione (il ricordato Enchiridion di Grego-rio da Napoli era indirizzato proprio ai confessori)169. Come ha osservatoAdriano Prosperi “la storia della lettura in Spagna e in Italia lascia le librerieper entrare in confessionale”170.
10. Se quindi per Canevari vi era una forma di adesione forte (coatta e/ospontanea) alle prescrizioni ecclesiastiche in tema di libri proibiti, non si puònon ricordare qualche caso in cui, insieme all’adesione, si manifesta (presu-mibilmente) un atteggiamento di sottile resistenza, altrettanto interessante171.
la biblioteca disciplinata
921
168. Come, ad esempio, era stato prescritto dal cardinale Borromeo nel 1579: “librorum prohi-bitorum indicem iussu Tridentini concilii confectum iam pridem promulgatum, omnes singuli apudse habere curent sive theologi sive iurisconsulti sive medici sive aliarum literarum professores discipli-narumque studiosi et alii item quicunque librorum numerosam supellectilem possident” (Acta eccle-siae mediolanensis, cit., p. 209).
169. Sui fondamenti della politica pontificia in tema a partire da metà Cinquecento cfr. E.Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo alXVI secolo, il Mulino, Bologna 2000, pp. 381 e ss., pp. 493, 569; sulla diffusione delle delazio-ni cfr., ad esempio, M.C. Capucci, Una società di delatori? Appunti da processi modenesi del San-to Uffizio (1590-1630), in Il piacere del testo. saggi e studi per Albano Biondi, A. Prosperi (a curadi), Bulzoni, Roma 2001, I, pp. 45-62; X. von Tippelskirch, “Lettrici e lettori sospetti davantial tribunale dell’Inquisizione della Venezia post-tridentina”, in «Mélanges de l’école française deRome. Italie et Méditerranée», 115 (2003), 1, pp. 326 e ss.
170. A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, Torino1996, p. 231; e cfr. Id., “Anime in trappola. Confessione e censura ecclesiastica all’università diPisa tra ’500 e ’600”, in «Belfagor», LIV (1999), pp. 257-287.
171. Nell’impossibilità di attribuire la paternità a una persona identificata in modo univoco(Canevari? i librai? i precedenti possessori? gli eredi?), queste considerazioni sono convenzional-mente attribuite a una persona ficta che rappresenta adeguatamente i costumi di una cultura.
rodolfo savelli
922
Si è sopra ricordato come nel catalogo siano presenti due pseudo-misteribibliografici (Schyller/Brunfels e Lucidus/Erastus) e come in altri volumisia stato mutato il nome di Vadianus in Marlianus e quello di Fuchs in Ve-sale. Tali “mimetizzazioni”, in effetti, sono più numerose, e non è univocala spiegazione del loro significato. Questi ritocchi possono avere diversi sco-pi: ad esempio “ingentilire” un frontespizio rovinato dall’inchiostro di unacancellatura; ma al contempo si può altrettanto legittimamente pensare aforme di dissimulazione172.
Si esamini un tipico esempio di “zelo”: nel De sanguine dialogi del medi-co francese Jean Carvin (e pastore ugonotto?), sono stati tolti il frontespi-zio, le carte iniziali con dediche e l’indice degli autori utilizzati; nel testo ilsuo nome è stato in parte cancellato e trasformato in “Io. Capuani” [fig.16]. Ho scritto zelo perché Carvin non risulta negli indici e neppure nellediverse liste di aggiornamento. La notizia della sua adesione alla fede rifor-mata doveva essere circolata e quindi Canevari pensò bene di mettersi alvento, sebbene non avesse dimenticato chi era il vero autore, perché nel ca-talogo annotò “Io. Capuani seu mavis Carvini dialogi medici”, mentre nel-l’inventario genovese si è ripetuto pedissequamente quanto figurava sullaprima pagina del libro (“Io. Capuani”)173.
Un altro a diventare “Capuanus” è il ben più celebre Girolamo Carda-no, che tanta attenzione aveva suscitato tra inquisitori e censori174. Nell’au-tografo compare sempre sotto Cardano, mentre in quello successivo un po’
172. Sul tema dell’“autocensura” e della “dissimulazione” cfr. M. Pesce, L’indisciplinabilità delmetodo e la necessità politica della simulazione e della dissimulazione in Galilei dal 1609 al 1642, inDisciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, P.Prodi (a cura di), il Mulino, Bologna 1994, pp. 161-184 (ora anche in Id., L’ermeneutica biblicadi Galileo, cit., pp. 197 e ss).
173. CFC 590; un cenno sul personaggio in E. e E. Haag, La France protestante, Cherbuliez,Paris 1846-1859, III, pp. 229-230. L’informato e consequenziale zelo censorio arrivò a togliereinoltre la dedica al lettore che Carvin aveva premesso alla Methodus dialectices di Wilhelm Vanden Steene (CFC 1916; il volume è mutilo della c. a2).
174. Cfr. da ultimo Baldini, L’edizione dei documenti relativi a Cardano, cit., e M. Valente, “Cor-rezioni d’autore” e censure dell’opera di Cardano, in Cardano e la tradizione dei saperi, cit.,pp. 437-456; L. Spruit, Giordano Bruno eretico: le imputazioni del processo nel contesto storico-dottrinale, in Cosmología, teología y religión en la obra y en el proceso de Giordano Bruno, M.A.Granada (a cura di), Universidad de Barcelona, Barcelona 2001, pp. 111-128.
è Cardano e un po’ è Capuanus. Se si consultano alcuni dei volumi rimasti(perché, come si è visto, almeno cinque svanirono tra Roma e Genova) gliinterventi su frontespizi e titoli correnti, oltre che nel testo, sono stati diuna precisione e di una maniacalità che ha dell’incredibile: nella raccolta Inseptem aphorismorum Hippocratis particulas Commentaria non solo sono sta-te tagliate e incollate diverse colonne di testo che avevano suscitato l’atten-zione degli espurgatori romani [fig. 18], ma per centinaia e centinaia di car-te la parola Cardani è stata mutata in Capiani175.
Qualcosa del genere fu effettuata anche in due altri volumi: nel primo(In Hippocratis Coi prognostica) ritorna Capuanus (ricorretto in un secondotempo, solo sul frontespizio, in Cardanus: un pentimento?), e per deviarel’attenzione di qualche occhio indiscreto era stato altresì modificato medio-lanesis in med. Canensis: il primo strato di correzioni, fatto con estrema pe-rizia calligrafica, poteva senz’altro trarre in inganno qualsiasi visitatore176. Siriscontra lo stesso modo di agire nel secondo volume qui preso in conside-razione (In Hippocratis de aere, aquis et locis): Cardano è diventato Capua-nus (nei titoli correnti qualche volta, per fare più velocemente, invece cheCapiani è scritto Cariani), ritorna il medici canensis, ma ciò che rende cautirispetto agli intendimenti del calligrafico correttore è la variazione della da-ta di stampa, che da M.D.LXX è stata trasformata in M.D.LXXV, con l’ag-giunta, apparentemente arbitraria, di una “V” [fig. 17]177.
L’aggiunta era in realtà furbescamente motivata da transeunti proibizio-ni censorie: dal 1574 al 1589, infatti, il divieto delle opere di Cardano ri-guardava tutte quelle stampate prima del 1574; dopo il 1590, come si è vi-sto, fu limitato, con la clausola “nisi corrigantur”, ad alcuni testi elencati e atutti quelli che “de medicina non tractant”178.
Con piccoli “ritocchi” a mano si cercava di salvaguardare un patrimo-nio di libri altrimenti destinati alla distruzione. Lo stesso tipo di operazio-ne, ad esempio, era stato esperito “a monte” (nella preparazione dell’edi-
la biblioteca disciplinata
923
175. CFC 579.
176. CFC 578.
177. CFC 576.
178. Per i divieti relativi al periodo 1574-1589: cfr. supra nota 158; ILI IX, pp. 749, 751; Anno-tatio cit., c. [4r]; e per 1590-1596: ILI IX, pp. 806, 868, 937.
rodolfo savelli
924
zione) con testi giuridici da cui era stato fatta scomparire la paternità delvero autore (sempre in base all’assunto che valesse la decisione tridentinarelativa agli scritti “qui de religione non tractant”); e, come è noto, era statapubblicata una raccolta degli Adagia di Erasmo sotto nome di Paolo Ma-nuzio; in fondo era un comportamento in qualche modo convergente conquello di chi sperava di “levare dalla memoria delli homini il nome del-l’autor cativo”179.
11. Dalle vicende della libraria di Demetrio Canevari e dei suoi catalo-ghi si possono trarre, pertanto, alcuni suggerimenti utili per giudicare l’ef-ficacia del fenomeno censorio e, al contempo, per consigliare atteggiamenticauti nella valutazione di documenti quali gli antichi inventari delle biblio-teche.
La presenza o, corrispettivamente, l’assenza di un titolo o di un autorepossono avere più chiavi di lettura. Si veda il significativo caso, ad esem-pio, di Copernico (o di Hotman e degli altri autori che mai giunsero a Ge-nova). Se fosse rimasto il solo index autografo, si sarebbe potuto dedurreche un medico ben inserito nella città dei papi aveva accesso, grazie alle li-cenze di lettura (e/o al mercato clandestino), ad un limitato spettro di libriproibiti, e che alcuni di questi (pochi) erano stati “correcti”. Se, al contra-rio, avessimo oggi il solo inventario fatto dagli eredi, la ricchezza e la varie-tà di tale patrimonio avrebbero continuato a suscitare l’ammirazione del ri-cercatore, senza alcun sospetto né di perdite esemplari e così significative,né, tanto meno, della capillarità delle pratiche espurgatorie.
Guardando ad altre realtà non si può non rilevare che alla fine degli anniOttanta del Cinquecento Girolamo Mercuriale trasmetteva a Pinelli un ca-talogo della propria biblioteca in cui comparivano diversi libri proibiti (eperfino il Sermo de corrigendis studiis di Melantone nell’edizione parigina del
179. Il giurista fatto “scomparire” dai frontespizi è Charles Du Moulin (Savelli, Da Venezia aNapoli, cit.); per il “nome dell’autor cativo” cfr. supra nota 110; per gli Adagia è di grande inte-resse il carteggio di Manuzio: Lettere di Paolo Manuzio copiate sugli autografi esistenti nella Biblio-teca Ambrosiana, A.-A. Renouard (a cura di), Parigi 1834, e cfr. P. F. Grendler, The Adages ofPaolo Manuzio. Erasmus and the Roman Censors, in In laudem Caroli. Renaissance and Reforma-tion Studies for Charles G. Nauert, ed. by J.V. Mehl, Thomas Jefferson University Press, Kir-ksville 1998, pp. 1-21.
1537), segno forse della patavina libertas, ma non sappiamo nulla di quantosuccesse dopo il 1596 né quale fosse lo stato di integrità dei volumi stessi180.
D’altra parte il confronto tra un catalogo più antico e quelli più recenti(inizi Seicento) della stessa collezione di Giovanni Vincenzo Pinelli ha con-sentito l’individuazione di significativi depauperamenti (Erasmo e Machia-velli, ad esempio)181.
Solo la contestuale presenza dei due elenchi e di una gran parte della col-lezione ha permesso, invece, nel caso di Canevari, di avere un quadro piùrealistico di quanto era conservato nei plutei romani e, in un secondo tem-po, in quelli genovesi: si è così potuto comprendere il ruolo giocato da in-quisitori e collaboratori del Maestro del sacro palazzo, che per più di mezzosecolo limitarono la lettura, anche di libri qui de religione non tractant, pereliminarne poi alcuni in modo definitivo. È a questo livello che si può cer-care di avere una visione dell’efficacia delle politiche censorie più articolatae aderente alla realtà; non è sufficiente la constatazione della presenza (o as-senza) di un titolo negli indici dei libri proibiti, o nell’inventario di una bi-blioteca182.
la biblioteca disciplinata
925
180. Per Mercuriale si veda il catalogo in BAM D.68 suss., edito da J.-M. Agasse, “La biblio-thèque d’un medecin humaniste: l’ index librorum de Girolamo Mercuriale”, in «Les Cahiers del’Humanisme», III-IV, 2002-2003, pp. 201-253; e cfr. le precisazioni di A. Nuovo, «Et amico-rum»: costruzione e circolazione del sapere, cit. Non si può per altro dimenticare che il sistema direlazioni di Mercuriale “se non del tutto unico [...] è certo eccezionale” (Rotondò, La censura ec-clesiastica, cit., p. 1451). Alla sua morte, visto che i libri erano stati lasciati al monastero di S.Mercuriale di Forlì (A. Mambelli, “Le librerie pubbliche conventuali in Forlì e i primordi dellacivica biblioteca”, in «Studi Romagnoli», VII, 1956, p. 147-160), intervenne la stessa Congre-gazione dell’indice che stabilì che era necessaria una cernita degli stessi, “distinguendo eosdem intres classes, quorum quidam omnino sunt prohibiti, et apud inquisitorem pisanum remanere debent,alii quia solum continent versiones haereticorum libere concedi possunt cum non sint theologici, qui-dam vero expurgari possunt ad normam expurgatorii iam promulgati, quod per inquisitorem faven-tinum fieri poterit, deletis ubique hereticorum nominibus” (ACDF, Index I/2, c. 2r; sull’indice“espurgatorio” cui si fa rinvio nel verbale della Congregazione cfr. supra nota 21).
181. M. Grendler, Book Collecting in Counter-Reformation Italy, cit., p. 150; Nuovo, Dispersio-ne di una biblioteca privata, cit., pp. 48 e ss.
182. “Per poter ricostruire un quadro a tutto tondo delle conseguenze della sorveglianza eccle-siastica sulla produzione libraria e sulla circolazione delle idee non bastano gli elenchi dei librivietati e dati alle fiamme o il meticoloso reperimento delle opere scampate” (Fragnito, Proibitocapire, cit., pp. 189-190); e come aveva già osservato Rotondò “non un muto repertorio di que-
rodolfo savelli
926
È emerso, altresì, che perfino il pio e devoto medico genovese aveva cer-cato in alcuni casi di resistere alle intrusioni dei “frati” (per usare le paroledegli intellettuali suoi contemporanei), occultando sotto nomi di fantasiaqualche libro che doveva essergli particolarmente caro.
In quegli anni poteva succedere, infatti, che le licenze di lettura fosseroimprovvisamente ritirate per ordine del Sant’Ufficio o del papa, come av-venne, ad esempio, nel 1608: promosso e rimosso Guanzelli (il Maestro delsacro palazzo curatore dell’indice espurgatorio pubblicato l’anno preceden-te, che non aveva soddisfatto le due Congregazioni romane), fu così scritto,ad esempio, al vicario arcivescovile di Napoli:
si è havuto notitia che in cotesta città et diocese molti pretendono tenere et leggerelibri prohibiti in vigore delle licenze concesse dal padre nostro Giovanni MariaGuangelli, hora vescovo di Polignano, mentre era maestro del Sacro Palazzo, diche, essendosi trattato in Congregatione del Santo Officio avanti nostro Signore,la Sua Santità mi ha ordinato che io scriva a vostra signoria che ella publichi edittorevocando tutte le licenze di tenere et leggere libri prohibiti concesse da qualsivo-glia persona di qualunque stato, grado, conditione et preminenza sia, eccettuandosolo le licenze concesse da questa Sacra Congregatione o da altri per suo ordine,comandando a tutti che debbano consignare i libri prohibiti in man sua183.
Non era un fatto straordinario ma destinato a ripetersi (ad esempio nel1623) e quindi poteva creare una situazione di incertezza anche per coloroche si erano già procurati permessi di lettura (visto che questi in passato era-no stati concessi da autorità differenti)184.
sti libri [manomessi], ma l’analisi sistematica e il confronto attento tra quel che da essi fu espun-to e sottratto e quel che in essi fu aggiunto potranno darci un’idea sempre più nitida dell’inci-denza e del peso che la censura ecclesiastica ebbe nella cultura italiana del Cinquecento e dei se-coli successivi” (La censura ecclesiastica e la cultura, cit., p. 1425).
183. Il cardinale Pompeo Arrigoni al vicario arcivescovile di Napoli (Roma, 21 giugno 1608): P.Scaramella, Le lettere della Congregazione del Sant’Ufficio ai tribunali di fede di Napoli (1563-1625), Edizioni dell’Università, Trieste 2002, p. 413; per l’indice di Guanzelli cfr. nota 21.
184. La constitutio di Gregorio XV è datata 30 dicembre 1622: un esemplare a stampa (Romae &Genuae, ex Typographia Iosephi Pavonis, 1623) è conservato tra le carte di Ottaviano Canevari(BCB, mr.III.4.14). Il 18 gennaio 1623 l’inquisitore genovese era informato del fatto che il ponte-
Inoltre la stessa pubblicazione dell’indice espurgatorio di Guanzelli, po-teva aver prodotto dubbi interpretativi nella “periferia”, perfino tra utentipiù che qualificati da un punto di vista professionale: nel 1621, di frontealla contestazione che nella Biblioteca Ambrosiana erano stati dati in lettu-ra libri proibiti, Antonio Olgiati si difendeva richiamando la regola triden-tina sulla correggibilità dei libri “qui de religione non tractant”, e si appog-giava sul fatto che anche autori “primae classis” come Fuchs, Münster, Estien-ne e altri erano stati emendati nell’indice sopra ricordato, secondo una let-tura “aperta” che ovviamente non poteva sempre incontrare il consenso del-la Congregazione del Sant’Ufficio185.
appendice
38 = Ae. Columna, Expositio in Analytica posteriora Aristotelis, B. Locatello,Venezia 1495.59 = J. de Sacro Bosco, Sphera mundi, Simone Bevilacqua, Venezia 1499.112 = Abdias, De historia certaminis Apostolici libri X, T. Belot, Parigi 1571.122 = A. Achillini, Opera omnia, G. Scoto, Venezia 1551.
la biblioteca disciplinata
927
fice aveva “rivocate tutte le licenze [...] et unitamente rivocata l’auttorità di concederle per l’avveni-re, non intendendo che si concedino se non in questa S. Congregatione del S.to Officio che suolefarsi ogni giovedì avanti Sua Santità” (ASG, Archivio segreto 1406B); e cfr. Frajese, Nascita dell’In-dice, cit., pp. 211 e ss. Anche il Maestro del sacro palazzo, ad esempio, poteva aver permesso la let-tura di libri proibiti: AGOP, VIII 99. Ma di lì a pochi anni il nuovo pontefice fu consigliato dalnunzio di Venezia di autorizzare l’inquisitore locale ad accordare licentiae, in specie ai nobili che“non habent scrupulum eos legendi” (BAV, Borg. lat. 558, c. 412v; e cfr. Barb. lat. 6334, c. 191r).
185. Così scriveva Olgiati: “le [...] regole [tridentine] sunt in viridi observantia, perché Moli-neo, Fuchsio, Mustero, Zuingero, Roberto Stefano et altri sono posti nell’indice nella primaclasse, e nondimeno sono stati emendati et le loro emendationi sono registrate nell’EspurgatorioRomano” (Pasini, Il progetto biblioteconomico di Federico, cit., pp. 269-270; sul caso si veda an-che ACDF, SO, St. st. Q1c, passim); sull’Olgiati cfr. Storia dell’Ambrosiana. Il Seicento, Cariplo,Milano 1992, passim. Almeno nel caso di Du Moulin, Olgiati si sbagliava vistosamente, datoche era stata pubblicata un’apposita bolla pontificia con il divieto totale delle opere del giuristafrancese, e ciò che vi era nell’indice espurgatorio era appunto l’indicazione di tutte le “glosse”(da espungere) presenti in opere di altri autori; per gli altri testi sembra appoggiarsi più sulla de-dica premessa da Guanzelli all’indice espurgatorio che sulla prassi censoria ormai in vigore dadecenni (cfr. Savelli, Allo scrittoio del censore, cit., p. 328).
rodolfo savelli
928
127 = Aetius Amidenus, Contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos, H.Froben e N. Episcopius, Basilea 1542.139 = A. Alciato, Libellus de ponderibus et mensuris. Budaei quaedam de ea-dem re. Philippi Melanchtonis de iisdem ad Germanorum usum sententia. Al-ciati quoque et Philippi Melanchtonis in laudem iuris civilis orationes duae, J.Secer, Hagenau 1530.150 = Alexander Aphrodisiensis, De Febrium causis et differentiis. SimonisGrynaei Medicinae commentatio sive encomium, R. Winter, Basilea 1542.161 = J. Almain, Moralia. De auctoritate Ecclesiae, C. Chevallon, Parigi1525.163 = Alphabetum hebraicum et graecum, R. Estienne, Parigi 1539.197 = S. Ardoino, Opus de venenis, H. Petri e P. Perna, Basilea 1562.205 = Aristoteles, Opera, J. Bebel, Basilea 1531.238 = Aristoteles, De moribus ad Nichomachum libri decem Tabulis perpetuisillustrati, I. Oporinus e E. Episcopius, Basilea 1566.284 = Aristoteles, De sensibus atque de his quae cadunt in sensum, G. Scoto,Venezia 1544.315 = Theologia sive mistica Phylosophia secundum Aegyptios noviter reperta,G. Mazzocchi, Roma 1519318 = Arnaldus de Villanova, Opera, F. Fradin, Lione 1509.364 = P. Bairo, De medendis humani corporis malis enchiridion, G. Rouille,Lione 1561.386 = Basilius Magnus, De instituenda studiorum ratione. Item Ioannis PiciMirandulae de homine opusculum. Rodolphus Agricola de formando studio etErasmi Roterodami ac Philippi Melanchtonis studiorum rationes, H. Petri,Basilea 1537.400 = A. Benedetti, Anatomice sive de Historia corporis humani, J. Herwa-gen, Strasburgo 1528.411 = F. Benvoglienti, Discorso per qual cagione per la religione non si sia fat-ta guerra fra Gentili et perché si faccia tra Christiani, L. Bonetti, Siena 1575.478 = P. Bonus, Introductio in divinam chemiae artem, P. Perna, Basilea1572.488 = G. Botero, Delle relationi universali, parte seconda, Popolo Romano,G. Ferrari, Roma 1592-1597.504 = A. M. Brasavola, Examen omnium catapotiorum. Conradi Gesnerienumeratio medicamentorum purgantium, J. e F. Frellon, Lione 1546.
521 bis = O. Brunfels, Herbarium, J. Schott, Strasburgo 1536-1539.561 = G. Capilupi, Fabrica et uso di alcuni stromenti horarii, eredi di G. Gi-liotti, Roma 1590.576 = G. Cardano, Commentarii in Hippocratis de aere, aquis et locis, H.Petri, Basilea 1570.578 = G. Cardano, In Hippocratis Coi prognostica, H. Petri, Basilea 1568.579 = G. Cardano, In septem aphorismorum Hippocratis particulas Commen-taria, H. Petri, Basilea 1564.590 = J. Carvin, De sanguine dialogi septem, Eredi S. Gryphius, Lione 1562.638 = S. Champier, Claudii Galeni pergameni historiales campi, A. Cratan-der e I. Bebel, Basilea 1532.639 = S. Champier, Libelli duo. Primus de medicine claris scriptoribus. Se-cundus de legum divinarum conditoribus, J. Des Champs, E. Gueynard, Lio-ne 1506.663 = C. Clavius, Astrolabium, B. Grassi, Tip. Gabiana, Roma 1593.670 = C. Rapine, De his quae mundo mirabiliter eveniunt. De mirabili po-testate artis et naturae Rogerii Baconis libellus, S. Colines, Parigi 1542.694 = Constantinus Afer, Opera, H. Petri, Basilea 1536.737 = N. Cusanus, Opera, H. Petri, Basilea 1565.743 = De balneis, Giunta, Venezia 1553.762 = B. De Ruberti, Osservazioni de astrologia, figli di L. Torrentino e C.Pettinari, Firenze 1567.769 = Diodorus Siculus, Bibliothecae historicae libri XV, H. Petri, Basilea 1559.837 = T. Erastus, De occultis pharmacorum potestatibus, P. Perna, Basilea1574.846 = Eusebius Caesariensis, Opera omnia, H. Petri, Basilea 1542.847 = Eusebius Caesariensis, Opera omnia, H. Petri, Basilea 1549 (1542).884 = G.M. Ferrari, Consiliorum repertorium, B. Garaldi, Pavia 1517.886 = J. Ferrarius, De republica bene instituenda, J. Oporinus, Basilea 1556.924 = A. Foullon, Descrittione et uso dell’Holometro, appresso G. Ziletti,Venetia 1564.939 = L. Fuchs, De humani corporis fabrica epitomes, J. Frellon, Lione 1551-1555.948 = C. Galenus, Omnia opera, eredi L.A. Giunta, Venezia 1541.960 = C. Galenus, De curatione per sanguinis missionem, J. e F. Frellon,Lione 1546.
la biblioteca disciplinata
929
rodolfo savelli
930
1003 = C. Gesner, Thesaurus Evonymi Philiatri de remediis secretis, B. Ar-noullet, Lione 1555.1024 = F. Giuntini, Speculum astrologiae, S. Beraud, Lione 1581.1025 = F. Giuntini, Speculum astrologiae, P. Roussin, Lione 1573.1059 = Gynaeciorum hoc est de mulierum morbis libri, T. Guarinus, Basilea 1566.1063 = S. Hemminga, Astrologiae, ratione et experientia refutatae liber, C.Plantin, Anversa 1583.1067 = H.E. Hessus, De tuenda bona valetudine commentariis illustratus aIoanne Placotomo. Eiusdem de natura et viribus cerevisiarum, M. le Jeune,Parigi 1555.1074 = Hippocrates, Opera, G. Griffio, Venezia 1546.1133 = J. Sacro Bosco, Sphera, eredi O. Scoto, Venezia 1518.1140 = J. Regiomontanus, Tabulae directionum et profectionum cum praefa-tione Philippi Melanthonis, Ph. Ulhard, Augsburg 1551-1552.1141 = J. Regiomontanus, De triangulis omnimodis, I. Petreius, Norimber-ga 1533.1143 = J. Regiomontanus, De triangulis planis et sphaericis, H. Petri e P. Per-na, Basilea 1561.1145 = A. Jonge, Nomenclator omium rerum, C. Plantin, Anversa 1583.1174 = P. Lecoq, Bibliotheca medica, C. Waldkirch, Basileae 1590.1180 = C. Leonardi, Speculum lapidum, G.B. Sessa, Venezia 1502.1197 = T. Livius, Decades, Prima, Tertia, Quarta et Quintae dimidium, O.Petit, Parigi 15431200 = A. Lonitzer, Naturalis historiae opus novum, C. Egenolph, Franco-forte 1551.1212 = Lucianus Samosatensis, Opera, J. Frellon, Lione 1549.1217 = F. Ae. Macer, De herbarum virtutibus, J. Faber Emmeus, Friburgo1530.1229 = G.A. Magini, Ephemerides coelestium motuum ab anno MDLXXXIusque ad annum MDCXX, Damiano Zenaro, Venezia 1582.1252 = Marcellus Empiricus, De medicamentis empiricis, physicis ac rationa-bilibus, H. Froben e N. Episcopius, Basilea 1536.1304 = P. Mela, De situ orbis, C. Wechel, Parigi 1530.1341 = G. Moleti, L’effemeridi per anni XVIII, V. Valgrisi, Venezia 1563.1342 = G. Moleti, Ephemerides annis viginti inservientes, F. de Franceschi,Venezia 1564.
1385 = J. Nauclerus, Memorabilium chronici commentarii, T. Anshelm, Tu-binga 1516.1408 = M. Nizzoli, Thesaurus ciceronianus, N. Bevilacqua, Venetiis 15661425 = A. Offredus, Expositio in primum Posteriorum Aristotelis librum, L.A.Giunta, Venezia 1520.1446 = G. Pachymeres, In universam fere Aristotelis philosophiam epitome,H. Froben e N. Episcopius, Basilea 1560.1472 = F. Patrizi, Nova de universis philosophia, B. Mammarelli, Ferrara 1591.1494 = N. Peranzone, Opusculum de memoriae naturalis reparatione, B.Guerralda, Ancona 1518.1546 = P. Pitati, Almanach novum, Giunta, Venezia 1552.1547 = P. Pitati, Supplementum ephemeridium, eredi L.A. Giunta, Venezia1542.1555 = Plato, Sebastiani Foxii Morzilli commentatio in decem Platonis librosde Republica, J. Oporinus, Basilea 1556.1556 = Plato, Sebastiani Foxii Morzilli in Timaeum commentarii, J. Opori-nus, Basilea 1554.1561 = C. Plinius Secundus, Historiae mundi, libri XXXVII, H. Froben eN. Episcopius, Basilea 1539.1572 = Polybius, Historiarum libri priores quinque, J. Herwagen, Basilea1549.1574 = P. Pomponazzi, Opera, H. Petri, Basilea 1567.1581 = G.G. Pontano, Opera, A. Manuzio e A. Torresano, Venezia 1518-1519.1597 = S. Porzio, De humana mente disputatio, L. Torrentino, Firenze 1551.1624 = Procopius Caesariensis, De rebus Gothorum, Persarum ac Vandalo-rum libri VII, J. Herwagen, Basilea 1531.1629 = M. Psellus, De quatuor Mathematicis scientiis, J. Oporinus, Basilea1556.1633 = C. Ptolemaeus, La geografia... con l’espositioni del Ruscelli, G. Zilet-ti, Venezia 1574.1643 = E. Reinhold, Prutenicae tabulae coelestium motuum, O. e G. Grup-penbach, Tubinga 1571.1644 = [K. Peucer], Absolutissimae orbium coelestium hypotyposes, P. Horst,Colonia 1573.1676 = E. Rudio, De usu totius corporis humani liber, R. Meietti, Venezia1588.
la biblioteca disciplinata
931
rodolfo savelli
932
1715 = M. Savonarola, Canonica, A. Torresano, Venezia 1503.1727 = M. Scotus, Liber Phisionomie, M. Sessa, Venezia 1508.1730 = A. Schultz, Chronographia, G. de Cartolari, Roma 1545.1756 = F. Silvestri, Annotationes in libros Posteriorum Aristotelis, O. Scoto,Venezia 1517.1763 = C.I. Solinus, Polyhistor, M. Isengrin e H. Petri, Basilea 1538.1771 = S. Speroni, I dialogi, P. Manuzio, Venezia 1542.1772 = J. Spiegel, Lexicon iuris civilis, S. Gryphius, Lione 1552.1775 = De Cometis dissertationes novae Clariss. Virorum Thom. Erasti, Andr.Dudithii, Marc. Squarcialupi, Symon Grynaei, P. Perna, L. Ostein, Basilea1580.1778 = J. Stade, Ephemerides novae, eredi di A. Birckmann, Colonia 1570.1784 = M. Stifel, Arithmetica, J. Petreius, Norimberga 1544.1788 = J. Stoeffler, In Procli Diadochi sphaeram mundi commentarius, U.Morhart, Tubinga 1534.1795 = Strabo, En tibi geographicorum commentarios a Conrado Heresbachiorecognitos, V. Curio, Basilea 1523.1801 = Suidas, Opera, J. Herwagen e J. Oporinus, Basilea 1564.1822 = B. Telesio, Varii de naturalibus rebus libelli De Cometis et Lacteo Cir-culo. De his, quae in Aere sunt. De Iride. De Mari. Quod Animal universum.De Usu Respirationis. De Somno, F. Valgrisi, Venezia 1590.1830 = Theodoretus, De providentia, C. Froschauer, Zurigo 1546.1916 = W. Van den Steene, Methodus dialectices, S. Gryphius, Lione 1542.1973 = J. L. Vives, De recta ingenuorum adolescentum ac puellarum institu-tione, R. Winter, Basilea 1539.1975 = J.L. Vives, De veritate fidei Christianae, J. Frellon, Lione 1551.1982 = J.J. Wecker, Antidotarium generale, E. e eredi di N. Episcopius, Ba-silea 1580.1984 = J.J. Wecker, Medicinae utriusque syntaxes, E. e eredi di N. Episco-pius, Basilea 1576.2048 = P. Ayrault, Rerum ab omni antiquitate iudicatarum pandectae. Hisaccessit liber De patrio iure ad filium, G.B. Bidelli, Milano 1619.2200 = G. Galilei, Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua o che inquella si muovono, C. Giunta, Firenze 1612.2201 = G. Galilei, Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, G. Ma-scardi, Roma 1613.
2332 = F. Pendasi, Physicae auditionis texturae libri octo, R. Meietti, Vene-zia 1604.2351 = W. Rechperger, Astrolabium, D. Franck, Augsburg 1611.
la biblioteca disciplinata
933
5. Fuchs trasformato in Vesalio
la biblioteca disciplinata
937
6. Sottoscrizione con il permesso dell’inquisitore
rodolfo savelli
938
7. L’espurgazione di Botero
8. Cancellazione del titolo di un’opera vietata di Ayrault
la biblioteca disciplinata
939
9. Nome di un autore vietato (Vadianus) “modificato” a penna
10. Interventi capillari sul Lexicon di Spiegel
la biblioteca disciplinata
941
12 - 13. Cancellazione e occultamento dei nomi di editori (Herwagen e Oporinus)
rodolfo savelli
942
14. Cancellazione di passi da un’opera astrologica (Pitati)
15. Anche il nome di Cecco d’Ascoli risulta “oscurato”
la biblioteca disciplinata
943
16. Carvin trasformato in Capuanus
17. Modifica della data di stampa di un’opera di Cardano