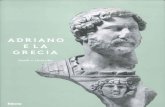«Un’immagine carica di significato»: illustrazioni novecentesche, in L’Orlando Furioso nello...
Transcript of «Un’immagine carica di significato»: illustrazioni novecentesche, in L’Orlando Furioso nello...
L’ORLANDO FURIOSONELLO
SPECCHIO DELLE IMMAGINI
ISTITUTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANAFONDATA DA GIOVANNI TRECCANI
ROMA
__00I-XIV_Presentazione_OrlandoFurioso_impaginato interno 25/06/14 14:49 Pagina V
©PROPRIETÀ ARTISTICA E LETTERARIA RISERVATA
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANAFONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.
2014ISBN 978-88-12-00517-8
© BY SIAE, 2014, PER GIORGIO DE CHIRICO, FAUSTO MELOTTI, ALBERTO SAVINIO
HA CONTRIBUITO CON UN SERVIZIO EDITORIALE: MEKKANOGRAFICI ASSOCIATIPROGETTO GRAFICO: EMANUELE RAGNISCO
FOTOLITO: VACCARI ZINCOGRAFICASTAMPA: MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI S.P.A.
LEGATORIA: L’ARTE DEL LIBROPELLE IN VACCHETTA CONCIATA IN FOSSA DELLA CONCERIA 800
Printed in Italy
__00I-XIV_Presentazione_OrlandoFurioso_impaginato interno 25/06/14 14:49 Pagina VI
ISTITUTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANAFONDATA DA GIOVANNI TRECCANI
PRESIDENTEFRANCO GALLO
VICEPRESIDENTIMARIO ROMANO NEGRI, GIOVANNI PUGLISI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONELUIGI ABETE, FRANCO ROSARIO BRESCIA, PIERLUIGI CIOCCA,
MATTEO FABIANI, LUIGI GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI, MAURIZIO PRATO,
GIANFRANCO RAGONESI, ANNA MARIA TARANTOLA, GIUSEPPE VACCA
COMITATO D’ONOREFRANCESCO PAOLO CASAVOLA, CARLO AZEGLIO CIAMPI, GIOVANNI CONSO
CONSIGLIO SCIENTIFICOENRICO ALLEVA, GIROLAMO ARNALDI, GEMMA CALAMANDREI, LUCIANO CANFORA,
MICHELE CILIBERTO, JUAN CARLOS DE MARTIN, EMMA FATTORINI, DOMENICO FISICHELLA,
EMMA GIAMMATTEI, PAOLO GUERRIERI, ELISABETH KIEVEN, ALBERTO MELLONI, CARLO MARIA OSSOLA,
GIORGIO PARISI, GIANFRANCO PASQUINO, LUCA SERIANNI,
SALVATORE SETTIS, PIERGIORGIO STRATA, GIANNI TONIOLO, GIOVANNA ZINCONE
COLLEGIO SINDACALEGIANFRANCO GRAZIADEI, Presidente; GIULIO ANDREANI,
FRANCESCO LUCIANI RANIER GAUDIOSI DI CANOSA, BRUNO PUCCI, LUIGI TONDI
FABIO GAETANO GALEFFI, Delegato della Corte dei Conti
__00I-XIV_Presentazione_OrlandoFurioso_impaginato interno 25/06/14 14:49 Pagina VII
L’ORLANDO FURIOSONELLO
SPECCHIO DELLE IMMAGINI
DIRETTORE SCIENTIFICOLINA BOLZONI
REDAZIONE
Responsabile editorialeLORETA LUCCHETTI
Cura redazionale e revisione testiPAOLA SEU; LAURA BUCCINO
SegreteriaPASQUALINA LEONE
ATTIVITÀ TECNICO-ARTISTICHE E DI PRODUZIONE
ART DIRECTORGERARDO CASALE
Produzione industrialeGERARDO CASALE; LAURA AJELLO, ANTONELLA BALDINI, GRAZIELLA CAMPUS
SegreteriaCARLA PROIETTI CHECCHI
DIREZIONE EDITORIALE
Pianificazione editoriale e budgetMARIA SANGUIGNI; MIRELLA AIELLO, ALESSIA PAGNANO, CECILIA RUCCI
SegreteriaALESSANDRA SACCHETTI; MARIA STELLA TUMIATTI
DIRETTORE EDITORIALEMASSIMO BRAY
__00I-XIV_Presentazione_OrlandoFurioso_impaginato interno 25/06/14 14:49 Pagina IX
ome vive un grande classico della letteratura attraverso i secoli? Certo mediante la lettura, ora più orameno attenta, del suo pubblico, ma anche e allo stesso tempo in mille altre forme diverse, ad esempio
mediante le immagini e le svariate espressioni artistiche che ad esso si ispirano.L’Istituto della Enciclopedia Italiana, avvalendosi della sua consolidata tradizione nelle edizioni di
testi letterari – si pensi alla Letteratura Italiana Ricciardi e alla collana dei Classici Treccani, per la quale MimmoPaladino ha realizzato nel 2011 splendidi disegni, incisioni e collages, regalandoci tra gli altri un OrlandoFurioso fatto di linee e di lettere, con il suo ippogrifo azzurro e tocchi di arancio e la sua Fata Morgana che sistempera nell’acquerello come in un sogno – e insieme dell’interesse da sempre rivolto alle immagini, ha volutodare vita a un’idea di Lina Bolzoni, realizzando questo volume con l’intento di riproporre un grande classicodella letteratura italiana e nello stesso tempo di accettare una sfida: con la certezza che anche nel mondo dioggi, dominato dalla tecnologia e dal potere delle immagini, è possibile ripensare i classici della letteratura inuna nuova luce, far sì che parole e illustrazioni interagiscano invece di combattersi a vicenda.
Questo libro, frutto della collaborazione di studiosi affermati con un gruppo di giovani ricercatoridel Centro di Elaborazione Informatica di Testi e Immagini nella Tradizione Letteraria della Scuola NormaleSuperiore di Pisa, intende ‘attraversare lo specchio’, come fa l’Alice di Lewis Carroll che incontra, grazie alsuo coraggio e alla sua curiosità, un paese sconosciuto, ricco di meraviglie.
L’Orlando Furioso è un testo che si presta in modo particolare a questa operazione. Pubblicato unaprima volta nel 1516, venne corretto, riscritto, ampliato dall’Ariosto, fino all’ultima redazione, quella del1532, divenendo da subito un best seller dell’editoria, plasmando di sé l’immaginazione, le feste, i rituali, glispettacoli, le scene d’Italia e d’Europa. E fin dalle prime edizioni cinquecentesche – come quelle venezianedello Zoppino del 1530 e del 1536, e di Giolito del 1542 – le immagini accompagnano il testo e, lungi dal-l’avere un mero effetto esornativo, contribuiscono a rendere il libro più piacevole, guidano l’occhio e la me-moria del lettore nell’intricato mondo del poema, configurandosi come una vera e propria griglia di letturaper il testo ariostesco.
Un solido e coerente sistema figurativo e culturale trovava intorno a sé l’Ariosto. Il suo sguardo,epico e cosmologico, lirico ed elegiaco, è modernissimo, cinematografico, magistralmente capace di os-servare la terra dall’alto dei cieli, come in groppa all’ippogrifo. L’occhio del poeta, ironico e curioso diesotismi e di mondi lunari, si era nutrito della pittura ferrarese e mantovana, specialmente dei paesaggi
XI
PRESENTAZIONE
C
__00I-XIV_Presentazione_OrlandoFurioso_impaginato interno 25/06/14 14:49 Pagina XI
di Mantegna: il suo nome figura infatti, nella celebre ottava del canto XXXIII, fra Leonardo e il GianBellino, accanto ai due fratelli Dossi, a Sebastiano del Piombo, Raffaello, Tiziano, a sigillare il canonedella pittura moderna.
Così il presente volume intende, a sua volta, guidare il lettore entro la selva delle immagini e analizzarecriticamente il copioso patrimonio visivo offerto dalle 516 illustrazioni che ne costituiscono l’apparato ico-nografico, nel proposito di compiere un’operazione che integri e arricchisca i tradizionali approcci critici:un’ulteriore modalità, dunque, con cui l’Orlando Furioso incontra i suoi lettori.
Vi si ripercorrono le vicende delle edizioni illustrate, dal Cinquecento al Novecento, mettendo– come scrive Lina Bolzoni nella sua Introduzione – «consapevolmente da parte la tradizione secolare chesepara la parola dall’immagine, che sancisce la superiorità della prima sulla seconda, e provando a vedere cosasuccede quando entrambe sono presenti, sotto gli occhi dei lettori, a scandire insieme un lungo percorso, asuggerire di volta in volta determinate prospettive sul testo»; ci si sofferma sul modo in cui vengono via viarappresentati i temi essenziali, come l’eros, la follia, la magia, o su come l’immagine cerca di catturare il com-plicato gioco col tempo che le mille vicende narrate nel poema intessono.
Ma quella visiva non è l’unica modalità di lettura del Furioso: esiste infatti, come spiega ancora LinaBolzoni, quella allegorica, anche se si tratta di una modalità spesso riduttiva rispetto alla dimensione pluri-prospettica del testo, che ha «a suo modo, una ‘serietà morale’, mettendo in scena anche una straordinariarappresentazione dei ‘costumi’ di uomini e donne, una specie di teatro universale delle passioni».
Ancora una volta, attraverso i saggi e i relativi percorsi iconografici, il volume mostra come eroi ederoine del poema vivano anche al di fuori del libro: nelle incisioni e nei fogli volanti, nella pittura e negli af-freschi, nelle maioliche, che portano nell’interno dello spazio domestico, sulle splendide tavole dei banchetti,gli episodi che l’Ariosto aveva cantato.
La fortuna che l’opera incontrò non è limitata soltanto al suo tempo: si vedono infatti via via riap-parire, nel corso dei secoli, l’idea e l’uso dell’Orlando Furioso come di un grande teatro della memoria, comefonte di un gioco in cui memoria e invenzione convivono, e si alimentano a vicenda. La sua vitalità si misurapoi anche nella capacità di attraversare i confini tra cultura alta e mondo popolare: alcuni saggi sono dedicatiinfatti alla fortuna del Furioso nell’editoria popolare e nei fumetti, e così anche a quella testimoniata dal teatrodei pupi. Altri saggi ripercorrono le diverse versioni teatrali del poema, fino all’innovativo spettacolo realizzato,negli anni Settanta del Novecento, da Luca Ronconi, e ancora oltre, fino alle più spregiudicate rielaborazionicontemporanee.
Il nostro auspicio è dunque che l’ampia rassegna proposta, unita alla consueta cura profusa nel rea-lizzare un prodotto editoriale di pregio, possa contribuire a confermare ancora una volta non soltanto la pre-senza vitale dell’Orlando Furioso all’interno del canone dei grandi classici della letteratura italiana, ma anchela sua inesauribile capacità di dialogare in modi sempre nuovi con il vasto pubblico dei lettori colti, degli spe-cialisti, degli appassionati così come di coloro che si avvicinano all’opera spinti da semplice curiosità intellet-tuale. E confidiamo nella benevola comprensione del lettore se ci prendiamo la libertà di immaginare checoloro che sfoglieranno queste pagine si ricorderanno dell’elogio pronunciato da Pietro Aretino, come raccontaCarlo Alberto Girotto nel suo saggio, a riguardo della copia dell’edizione del 1542 che il Giolito gli avevafatto avere e che, a suo parere, non aveva riscontri nell’editoria contemporanea, e poteva ben definirsi un«Ariosto d’oro e figurato».
XII
__00I-XIV_Presentazione_OrlandoFurioso_impaginato interno 25/06/14 14:49 Pagina XII
Il rapporto di collaborazione instaurato tra la redazione e il gruppo di lavoro sapientemente coordinatoda Lina Bolzoni è stato fondamentale nella buona riuscita del nostro progetto, così come essenziale è stataanche la collaborazione delle biblioteche che ci hanno dato la possibilità di riprodurre le numerose paginedelle più antiche e principali edizioni dell’Orlando Furioso; a loro, e a tutti coloro che a vario titolo hannopartecipato alla realizzazione del volume, va un sentito ringraziamento a nome mio personale e dell’Istitutodella Enciclopedia Italiana.
MASSIMO BRAYDirettore editoriale
dell’Istituto della Enciclopedia Italiana
XIII
__00I-XIV_Presentazione_OrlandoFurioso_impaginato interno 25/06/14 14:49 Pagina XIII
XIV
Giuseppe Cades (Roma 1750 - 1789)Allegoria dell’Italia nova, particolare
tempera su muro; 1788-1789Ariccia, Palazzo Chigi, Sala dell'Ariosto
__00I-XIV_Presentazione_OrlandoFurioso_impaginato interno 25/06/14 14:49 Pagina XIV
La benevolenza, l’amore, anzi, con cui dal pubblico furono accolte le mie edizioni illustrate del Petrarca e del
Tasso, venne a confermarmi nell’idea di pubblicare, pure illustrato, anche l’Orlando Furioso dell’Ariosto;
sicuro di rendere con ciò buon servigio ai cultori delle belle lettere e dell’arte, nonché ad ogni ceto di studiosi.
Mi posi quindi all’opera; ed ebbi cura di affidare l’illustrazione di detto poema ad uno dei più valenti nostri
pittori, quale fu appunto il Cav. N. Sanesi, celebre maestro d’arte, di fine gusto, di fama mondiale1.
Siamo esattamente nel 1900 e a parlare è l’editore Paolo Carrara, che di fronte al lettore esalta il ruolo di Nicola Sanesi,tra i più conosciuti e apprezzati illustratori del tempo, con una particolare predilezione per il romanzo storico e Guer-razzi: le sue immagini avevano attraversato in effetti tutta la penisola, passando da Paolo Carrara appunto (Milano),a Nerbini (Firenze), fino a Edoardo Perino (Roma). Non mi fermerò oltre su questa edizione, che segna l’ingresso nelNovecento del poema ariostesco, ma è interessante notare come il nuovo secolo si apra con un’edizione fondata sulprestigio e sulla riconoscibilità del suo illustratore.
Nel presente contributo sarà presa in esame una selezione necessariamente ristretta dei numerosi Orlando il-lustrati apparsi nel XX secolo (per i quali si rimanda invece a scritti e bibliografie recenti: cfr. Donne Cavalieri IncantiFollia 2012; «Arabeschi» 2013), concentrando l’attenzione su diverse tipologie editoriali-figurative e analizzando alcunicasi significativi: le pubblicazioni a dispense (il già citato Nerbini), i disegni d’artista (Fabrizio Clerici, Mimmo Pala-dino), rielaborazioni e letture di vario genere («La scala d’oro» e Calvino). Converrà allora iniziare proprio da Calvino2
prima di andare indietro nel tempo, per sottolineare da subito la centralità e l’importanza dell’immagine, in particolarmodo in un poema come l’Orlando Furioso.
Dichiara dunque lo scrittore:
Quando ho cominciato a scrivere storie fantastiche non mi ponevo ancora problemi teorici; l’unica cosa di
cui ero sicuro era che all’origine di ogni mio racconto c’era un’immagine visuale. Per esempio, una di queste
immagini è stata un uomo tagliato in due metà che continuano a vivere indipendentemente; un altro esempio
567
1 Introduzione dell’editore ad ARIOSTO 1900.2 Cfr. BELPOLITI 1996.
«Un’immagine carica di significato»:illustrazioni novecentesche
GIORGIO BACCI
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 567
poteva essere il ragazzo che s’arrampica su un albero e poi passa da un albero all’altro senza più scendere in
terra; un’altra ancora un’armatura vuota che si muove e parla come ci fosse dentro qualcuno3.
È così che nascono, tra gli altri, Il visconte dimezzato, Il barone rampante e Il cavaliere inesistente, con un’im-magine che si sviluppa e diventa un testo fantastico. Con queste parole non solo Calvino ci fornisce una chiave inter-pretativa delle sue opere, ma esorta il lettore (o sarebbe meglio dire l’ascoltatore, visto che il testo avrebbe dovuto farparte delle Lezioni americane) a riflettere sul rapporto tra testo e immagine, in un momento di profondo cambiamentodei codici visivi. Ma Calvino, come anticipato, è anche parte in causa del presente saggio, grazie alla memorabilerilettura dell’Orlando Furioso: interpretazione arricchita in anni recenti dalle illustrazioni di Grazia Nidasio.
È infatti nel 2009 che Grazia Nidasio, una delle più importanti illustratrici contemporanee, si dedica all’Or-lando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino. Siamo di fronte a un testo certamente particolare, diversoda altre riletture e riduzioni, dal momento che l’intento dello scrittore torinese era quello – attraverso una serie di tra-smissioni radiofoniche in onda in prima battuta nel 1968 – di offrire un’interpretazione filologicamente corretta e allostesso tempo accattivante, attualizzante, del poema ariostesco, spiegandone radici e derivazioni e operando scelte te-matiche. La struttura del volume rispecchia questa volontà, ed ogni capitolo è composto da un’introduzione generalecui seguono i passi scelti dei canti, tenuti insieme dalla voce narrante e critica di Calvino.
Grazia Nidasio è dunque chiamata a illustrare un libro complesso, leggendo Ariosto attraverso gli occhi diCalvino:
Calvino lo raccontava, lo spiegava, preparava il lettore facendo capire quanto ci fosse del nostro presente nello
spirito che animava ogni episodio. Infatti lui ha chiamato il poema «un grande affresco western». Geniale tra-
sposizione, perché uno dei motivi per cui non ci si accosta facilmente ai classici sta proprio nella difficoltà di
rapportarli con la vita di oggi. Convincersene è un grande grimaldello comunicativo: non sono classici per caso.
La selezione dello scrittore, soprattutto la presentazione, fa capire quanto il poema fosse stato da lui assorbito
e metabolizzato. Tanto da nutrirne la sua stessa fantasia. Calvino ha reso accessibile il lessico cinquecentesco
ed ha isolato ogni dettaglio, o fotogramma, proprio come in un grande affresco, o in un film, interpretandolo,
e invitando ciascuno a capire il lavoro del regista, dell’autore, in questo caso di Ludovico poeta.
Dunque, non era facile illustrare il testo, non potevo affrontare impunemente l’Ariosto: meglio sarebbe stato
clonare direttamente Gustave Doré. Oppure ricorrere ad altri illustratori più bravi di me a rendere cavalieri,
castelli e duelli e quant’altro. [...] O perfino a quegli specialisti di immagini fantasy in grado di restituire
cavalli, armature, tornei e castelli con una precisione filologica eccezionale. Ma non mi sembrava esser questo
l’obiettivo di Calvino. Lui voleva rendere l’Orlando confidenziale, farlo scoprire dai ragazzi4.
Identificato il sentiero interpretativo, l’artista segue un proprio percorso inventivo, amalgamando idee legatealla figura di Calvino scrittore e spunti offerti invece dalla narrazione calviniana stessa, lasciando correre la fantasia.
Nel primo caso rientra ad esempio la serie iniziale, allorché Calvino introduce il poema, contestualizzandoloe storicizzandolo: Grazia Nidasio ritrae lo scrittore immerso nella lettura, appollaiato su un albero. Il rimando, eclatante,
568
3 CALVINO 2002, p. 90.4 BACCI 2014.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 568
è al Barone rampante, ma non solo: la rete di richiami è più complessa e raffinata. Infatti, come visto poc’anzi, la Trilogiaè portata da Calvino ad esempio del processo creativo stesso, che si sviluppa a partire da un’immagine: con questo ac-cenno, l’artista vuole così ammiccare al lettore e allo stesso tempo attivare un dialogo con lo scrittore, quasi a suggerirela circolarità di un percorso che partito da una figura visiva è passato attraverso il testo per poi ‘rifarsi figura’ grazie al-l’opera dell’illustratore. Ad arricchire ulteriormente il panorama, potremmo anche ipotizzare che un ruolo non secon-dario, per un’artista conosciuta in prima istanza grazie al «Corriere dei Piccoli», sia stato svolto dal riferimento calviniano,poco più avanti nella già citata ‘lezione americana’, proprio al mitico giornalino per ragazzi, identificando anzi in quellalettura-visione il seme iniziale della sua futura ispirazione:
[...] io che non sapevo leggere potevo fare benissimo a meno delle parole, perché mi bastavano le figure. [...]
Passavo le ore percorrendo i cartoons d’ogni serie da un numero all’altro, mi raccontavo mentalmente le storie
interpretando le scene in diversi modi, producevo delle varianti, fondevo i singoli episodi in una storia più
ampia, scoprivo e isolavo e collegavo delle costanti in ogni serie, contaminavo una serie con l’altra, immaginavo
nuove serie in cui personaggi secondari diventavano protagonisti. Quando imparai a leggere, il vantaggio che
ricavai fu minimo [...]5.
Il volume si apre così con un omaggio alla fantasia e al potere creativo delle immagini, e prosegue con unarutilante serie di invenzioni e rielaborazioni di opere celebri sulle quali merita soffermarsi, a partire dal castello d’acciaiodi Atlante (fig. a p. 582), ritratto come il museo di Gehry6:
Era lì per me: il mio tempo mi ha offerto un ‘castello d’acciaio’, che poi non è di acciaio e non è un castello,
ma non importa, lo spirito è quello. Questo parallelo tra passato e presente mi sembra essere stato il tema
conduttore di Calvino quando ha fatto questa selezione. Con l’effetto di stringere un poema antico in un suo
(e nostro) abbraccio letterario7.
Dopo il museo di Gehry il lettore incontra la Maya desnuda di Goya, ovvero Doralice sorpresa nella sua tendadal truce Mandricardo, coperto di sangue (fig. a p. 583):
Che può fare una povera ragazza? Urlare di spavento! Alla fine però si lascia sedurre e se ne va con lui, rinun-
ciando a raggiungere il povero promesso sposo Rodomonte il quale si butta nella mischia e, infatti, ne morrà.
È una scena da gossip, col finale da film dei due avviati ‘sulla via di un futuro radioso’, come in Tempi moderni8.
Altro importante capolavoro citato è Forme uniche della continuità nello spazio (Umberto Boccioni, 1913), rie-laborato per raffigurare Rodomonte all’assalto di Parigi (fig. a p. 584). Un vortice di velocità e potenza che sembra unireil ricordo della scultura con le sperimentazioni fotografiche dei fratelli Bragaglia e con altre opere di ambito futurista:
569
5 CALVINO 2002, p. 95.6 Si veda anche GUZZETTI 2012.7 BACCI 2014.8 Ibid.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 569
da La città che sale (Umberto Boccioni, 1910) a Ragazza che corre sul balcone (Giacomo Balla, 1912). È curiosa anchel’operazione che Grazia Nidasio compie sull’immagine, moltiplicando la figura della scultura per accentuare la sensazionedi movimento, in un certo senso contravvenendo a quello che era l’obiettivo dichiarato di Boccioni:
Dinamismo è la concezione lirica delle forme interpretate nell’infinito manifestarsi della loro relatività tra
moto assoluto e moto relativo, tra ambiente e oggetto, fino a formare l’apparizione di un tutto: ambiente +
oggetto. È la creazione di una nuova forma che dia la relatività tra peso ed espansione. Tra moto di rotazione
e moto di rivoluzione, insomma è la vita stessa afferrata nella forma che la vita crea nel suo infinito succedersi.
Questo succedersi, mi sembra ormai chiaro, non lo afferriamo con la ripetizione di gambe, di braccia, di figure,
come molti hanno stupidamente supposto, ma vi giungiamo attraverso la ricerca intuitiva della forma unica
che dia la continuità nello spazio9.
Sempre in ambito di scultura, Orlando, pazzo, trasporta in spalla... il cavallo di Francesco Messina:
E poi, tra l’altro, c’è un omaggio al mio maestro, Francesco Messina, nel cavallo che Orlando ormai furioso
trasporta a spalle: è quello celebre della Rai, per intenderci. Proprio al tempo in cui frequentavo l’Accademia,
Messina era impegnato nei primi studi sui cavalli in vista dell’opera da eseguire10.
Contaminazione di campi diversi: pittura, cinema, scultura, ma anche la cronaca del XX secolo, con lo sbarcosulla luna di Astolfo e s. Giovanni che viene equiparato, tramite l’inserimento della famosa fotografia dell’orma diAldrin, a quello realmente avvenuto nel 1969 (fig. a p. 585); oppure i paladini che piantano una bandiera in fronte aRodomonte sconfitto e ucciso (fig. a p. 586) diventano una trasfigurazione della celebre fotografia di Joe Rosenthal,tradotta poi nel monumento di Iwo Jima, a ricordo della omonima battaglia, raffigurante i soldati americani in atto dipiantare una bandiera americana sulla vetta del monte Suribachi.
Rielaborazione ironica, umoristica, dunque, che contribuisce a velocizzare e rendere ancor più dinamica unanarrazione avvincente: Grazia Nidasio da un lato ingaggia una sfida con il lettore colto, invitandolo a rintracciare isuoi richiami, e dall’altra rende ancor più piacevole il testo per un pubblico di ragazzi, restituendo anche la sensazionedi appunti presi in margine al libro, come nel caso della ‘vestizione’ di Orlando, tradotta in scenette successive, conbrevi segni grafici a margine, sul modello dei flip books o libri animati. Da grande illustratrice, la Nidasio gioca anchecon le parole, con le potenzialità fantastiche dell’immagine, sfruttando al meglio il rapporto tra testo e immagine: adesempio il capitolo «Angelica inseguita» si apre, sulla pagina di sinistra, con la donna a cavallo che, fuggendo, escefuori dalle pagine di un libro, per finire, dopo aver messo a soqquadro le lettere, in quelle del volume accanto. Oppurematerializza il sogno di Orlando, raffigurando in basso il paladino addormentato, sovrastato da una conturbante An-gelica con una svolazzante veste rosa.
Nella ricca tradizione delle riduzioni per ragazzi si colloca anche La leggenda di Orlando (Torino 1933; fig. ap. 587), apparsa nel 1933 all’interno de «La scala d’oro», fortunata collana graduata per anni a seconda dell’età delbambino, pubblicata dalla UTET a partire dal 1932, e che basava il suo successo sulla qualità delle opere proposte e
570
9 BOCCIONI 1977, pp. 85-86.10 BACCI 2014.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 570
delle immagini. Il libro, di formato maneggevole e agile, con la consueta tavola fuori testo riprodotta e applicata inrilievo sulla copertina, si prefigge naturalmente il compito di avvicinare i ragazzi al capolavoro ariostesco, attualizzandoil volume con una narrazione scattante, affidata alla rilettura di Eugenio Treves, e con un’efficace resa figurativa grazieal segno di Gustavino, tra i maggiori illustratori del tempo, così descritto da Antonio Faeti:
Il territorio che Gustavino preferisce è quello in cui si muovono i personaggi in costume: egli cerca sempre
uno spazio alternativo, opposto al presente e lontano da esso; lo delinea come un eden remoto, dove agiscono
solo maschere che non indossano mai le nostre vesti. Questo coerente rifiuto dell’attualità, basato sull’adesione
ad un universo dove ci si può rifugiare, può essere sinteticamente raffigurato da una tavola che Gustavino di-
segnò per la «Scala d’oro» e che divenne uno dei simboli di quella collana. Nell’immagine si vede un ippogrifo
che vola accanto ad un dirigibile, componendo quasi un manifesto in cui è espressa una precisa ideologia.
L’animale alato – cioè l’elemento fantastico – domina tutto lo spazio e rende approssimativo e banale il mezzo
meccanico, ridotto alla pochezza espressiva delle sue semplici dimensioni tecnologiche11.
Questo è solo un breve estratto dell’analisi che Faeti dedica nel 1972 a Gustavo Rosso, Gustavino appunto,come amava farsi chiamare occhieggiando al ‘grande’ Gustave (Doré, naturalmente): eppure, queste parole, sono ancorautili per capire la natura dell’artista torinese, assoluto protagonista, con ben sedici volumi illustrati, de «La scala d’oro». Subito, per favorire l’immedesimazione del lettore nel protagonista, i primi capitoli sono dedicati all’infanzia di Orlando,identificato tra i «monelli di Sutri», preso a benvolere da Carlo Magno fin da bambino grazie alle sue sfrontate mani-festazioni di coraggio.
Il linguaggio, come detto, è semplice e a tratti ingenuo, sempre calibrato su un pubblico bambino di un’etàprossima agli undici anni. Significativa al riguardo l’animata discussione che si scatena tra i paladini nel tredicesimocapitolo, fino all’esplosione d’ira di Astolfo verso l’imperatore:
– Me ne vado! Me ne vado! E il malanno sia con voi e con quell’Imperatore di cartapesta. Vado dove va Or-
lando, l’unico vero eroe che sia al mondo, l’unico amico leale e sincero. E non tornerò, se non quando tornerà
lui. E voi intanto schiattate tutti quanti, voi e il vostro re dalla barba di stoppa!
Non facevano complimenti, come vedete, i Paladini, quando uscivan dai gangheri12.
In effetti, la descrizione di Treves ricorda più una ‘zuffa’ al parco, piuttosto che il momento di massima tensionenel campo cristiano.
È vero però, come notato da Catelli13, che il testo è percorso anche da riferimenti impliciti a una retorica eroicae magniloquente che rimanda al clima di quegli anni (in pieno regime fascista). È così ad esempio che il narratore esortaOrlando nel «giardino dei mostri»: «bisognava dunque vincere o morire»14. E ancora, nel diciottesimo capitolo, quelloche descrive la disperata resistenza della retroguardia dell’esercito di Carlo Magno contro i ‘pagani’, Treves indugia inun’esortazione di questo tipo:
571
11 FAETI 2011, p. 363.12 La leggenda di Orlando 1933, p. 78.13 CATELLI 2012.14 La leggenda di Orlando 1933, p. 38.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 571
– Signori, – disse – avrete una battaglia come non ve ne sono state mai. Resisterete?
– Tutti! – giurarono i ventimila cavalieri. – Tutti! Fino alla morte! Sia maledetto chi cede!15.
Da un punto di vista grafico invece non sembra trasparire un appesantimento ideologico, in linea d’altrondecon la storia personale dell’artista, alieno dalla grancassa fascista. È tuttavia pur sempre un romanzo/racconto di avventure,di scontri fieri e di inseguimenti, di amori e di inganni. È allora comprensibile che le quattro tavole fuori testo a colorisiano scelte con attenzione al riguardo: la prima, posta in antiporta, si riferisce all’ingresso di Orlando nel castello incantato,ammaliato con una bevanda magica offertagli da una fanciulla che gli si fa incontro sul ponte di accesso (fig. a p. 588); laseconda, ripresa in copertina, rappresenta il fiero scontro tra Orlando e Rinaldo, accecati dalla passione per Angelica (fig.a p. 587); la terza ritrae Rodomonte mentre sta entrando, con un balzo prodigioso, a Parigi, in procinto di compiere unastrage (fig. a p. 589); la quarta infine è dedicata al vescovo Turpino che, prima di morire, benedice gli eroi di Roncisvalle.
Su quattro immagini dunque, ben tre si riferiscono a scene di guerra, e una a un ‘incontro galante’ che si ri-solverà in un tranello. Non a caso è stato scelto, come copertina, lo spettacolare scontro tra Orlando e Rinaldo: un vi-luppo di corpi di cavalli (contrapposti anche nei colori, bianco e nero), di lance che si spezzano, di cavalieri che siinarcano, colpiti duramente dall’avversario. Subito emerge una caratteristica delle illustrazioni di Gustavino: realistae fantasioso, nutrito di suggestioni fantastiche rese credibili da una figurazione che non altera le proporzioni e la ve-rosimiglianza dei personaggi. A differenza di altri autori, l’illustratore torinese rispetta la descrizione realista, anchequando questa assume i tratti dell’impresa iperbolica: valga per tutti Orlando che infilza sei nemici sulla sua lancia(fig. a p. 590). Non c’è spazio per la metafora ariostesca, d’altronde non riportata nel testo, rimane invece Orlandoche sostiene, come un pesante spiedino, la sua lancia con le vittime infilzate, non alterate nei rapporti dimensionali.Questo procedimento, che Gustavino segue per tutto il racconto, fa sì che anche Orlando, di solito enfatizzato intutta la sua prestanza, venga tratteggiato, anche durante la pazzia, rispettando le proporzioni: semmai l’alterazioneviene restituita attraverso il volto stravolto e allucinato, acceso da una luce sinistra (come nell’illustrazione al tratto incui Orlando trascina il cavallo ormai morto).
Tuttavia Gustavino, assecondando il ritmo della narrazione, lascia trapelare un’altra sua abilità: quella del ca-ricaturista, che raggiunge il punto più alto nella restituzione della Discordia, rappresentata come una vecchia stregacon una veste a brandelli e il volto storpiato (fig. a p. 591):
E da un’ampia poltrona a capo tavola, esultante e sghignazzante, contemplava la baruffa una strana donna
dal volto puntuto e beffardo, dagli occhietti lustri e maligni, dai capelli d’oro e d’argento e neri e bigi arruf-
fatissimi, dalla veste fatta di tante listerelle, qual lunga e qual corta, e ognuna d’un colore diverso: insomma
proprio la Discordia!16.
Con La leggenda di Orlando dunque, grazie all’alternarsi di diversi registri stilistici, Gustavino riesce a saldarele tante anime della sua arte, al tempo stesso fantastica e realistica, immaginifica e beffarda, raggiungendo un equilibrioconvincente, superando le perplessità degli inizi della carriera (ormai ben avviata del resto):
572
15 Ibid, p. 174.16 Ibid, p. 82.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 572
Ma quella della caricatura non era la sua strada: mai troppo aspre, troppo deformate o troppo ‘di parte’, queste
prime prove di Gustavino denunciano, nel signorile distacco e nell’ironia mai spietata, quella che sarebbe stata
la sua cifra peculiare, mentre, sempre negli stessi anni, il paziente esercizio alla traduzione al tratto delle foto-
grafie per consentirne la riproduzione, avrebbe esaltato quella vocazione all’indagine realistica, che il continuo
studio dal vero era destinato a trasfigurare nella sempre più puntuale ricerca psicologica e di atmosfera17.
Passano dodici anni, segnati drammaticamente dalla guerra, e, nel 1945, quasi a simboleggiare una rinascitadelle arti, viene pubblicato dalle Edizioni Labor un sontuoso Orlando Furioso, adorno di 46 tavole in tricromia - 46tavole in rotocalco fuori testo e 46 disegni episodici di Giambattista Galizzi, pittore e illustratore attivissimo in ambitolombardo. Nel 1908 riceve la medaglia d’oro all’Esposizione Umoristica di Milano e partecipa alla Biennale di Venezia,nel 1913 è tra i fondatori della Società degli Acquafortisti Bergamaschi, mentre nel 1915 compie le tavole caricaturaliper il Don Chisciotte pubblicato da Sonzogno nello stesso anno. Soprattutto, nel 1916 è presente all’Esposizione dell’In-cisione Italiana a Londra, ospitata dalla Royal Society of British Artists, e nel 1923 esegue le illustrazioni per The lifeand death of John Falstaff, pubblicato da J.M. Dent & Sons di Londra. Nel 1927 illustra I Promessi Sposi per l’IstitutoItaliano d’Arti Grafiche, cui segue una serie di importanti commissioni: nel 1942 lavora a Le avventure di Pinocchio(edizioni S.E.I.), nel 1943 alla Divina Commedia (Edizioni Labor), nel 1945 appunto all’Orlando Furioso.
Come già avevano visto Vittorio Pica e Raffaele Calzini, si tratta in effetti di un artista capace di sondare adampio raggio la gamma di possibilità espressive, passando dalla vena umoristica alla grafica inglese e francese, seppurdifettando, a volte, di una propria spiccata personalità:
Le virtù peculiari del Galizzi illustratore si riassumono in una speciale deformazione degli elementi reali, con-
sistono in una curiosa e immaginosa composizione e fusione di tali elementi. [...] Nelle illustrazioni a Pinocchio
il Galizzi risente un po’ troppo, e sia pure involontariamente, il ricordo dei moderni d’oltr’alpe: il Rackham
inglese e il Dulac francese: il testo insomma, del Collodi, è più schiettamente italiano delle illustrazioni del
Galizzi. Perciò la stessa nostra ammirazione per lui ci induce a consigliargli di ricercare più a fondo la propria
personalità [...]18.
Nell’Orlando Furioso Galizzi riesce probabilmente a fondere queste diverse sfumature stilistiche. Nella tavolarelativa al canto I (fig. a p. 592), che ritrae Angelica stesa a riposare dietro un cespuglio, adotta una pennellata filamen-tosa e un colore steso ‘alla Dulac’, ricordando nell’impostazione della figura l’Ofelia di John Everett Millais. Anche losfondo e il contorno paesaggistico sono di marca inglese: dai fiori rosa analiticamente descritti ai simpatici animaletti,un coniglio e una lepre, ai bordi di uno specchio d’acqua.
Un capolavoro di arte umoristica è invece l’illustrazione del canto II, in cui Sacripante viene disarcionato daBaiardo (fig. a p. 593). Il cavallo si inarca sulle zampe anteriori, scalciando, e costringe il cavaliere a reggersi in modogoffo per non cadere, puntando i piedi sulle staffe e cercando di aggrapparsi alla schiena dell’animale. Divertente ancheil contrasto tra il volto sorridente e compiaciuto di Rinaldo e quello terrorizzato, ormai a livello di una macchietta, di
573
17 PALLOTTINO 1989, p. 6.18 CALZINI 1923, pp. 368-373.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 573
Sacripante. Ancora Sacripante è vittima della vena umoristica di Galizzi nel canto XVII: il ‘pagano’ racconta che unfurfante gli aveva sottratto il cavallo lasciandolo sospeso, tanto era immerso nelle sue riflessioni, sopra la sella in bilicosu quattro assi di legno. E Galizzi raffigura proprio Sacripante sopra la sola sella, in bilico sopra le assi, con il dito sullabocca in atto di pensare, mentre alle sue spalle si intravede il ladro che porta via il cavallo. Tocca però anche a Marfisae Bradamante essere ritratte con acume dall’artista bergamasco (fig. a p. 594): le due donne, nel canto XXXVI, lasciatele armature, travolte dalla gelosia, si tirano per i capelli e lottano come due ‘popolane’, mentre alle loro spalle Ruggiero,chiaramente ignorato, armato di tutto punto, sta finemente argomentando per cercare di farle smettere, con tanto digesto declamatorio.
Le illustrazioni hanno ovviamente un forte legame anche con le altre opere dell’artista: ad esempio la tavoladel canto VI (fig. a p. 595), con i cavalieri/animali vittime della magia di Alcina, richiama alla memoria i dipinti mo-raleggianti in chiave espressionista di Galizzi, come La baraonda, uno dei suoi lavori più importanti, del 1916, e Circe,del 194519. Nel primo dipinto (fig. a p. 596) viene infatti stigmatizzato il disordine morale della contemporaneità, conuna citazione dantesca sullo sfondo, la montagna del Purgatorio immortalata, tra gli altri, anche da Doré. Donne se-minude ammiccano allo spettatore, creature deformate dal peccato si aggirano per il paesaggio, dove compare ancheun grasso prete in atto di celebrare la messa. Gli uomini e le donne dell’alta società manifestano la loro vera natura,contorcendosi in abbracci troppo espliciti. Il secondo dipinto citato (fig. a p. 597) serve invece da deposito fantasticoper quanto riguarda gli animali antropomorfizzati: vi compaiono infatti tigri, scimmie, cicogne, leoni e perfino uncammello. Una citazione non autoreferenziale è quella del ‘capitano’ del gruppo di cavalieri trasformati in animali daAlcina, a cavallo di una testuggine come specifica Ariosto, e avvicinato da Galizzi, nelle apparenze e nell’iconografia, aSileno, trasportato a braccia dai suoi compagni.
Tra i riferimenti stilistici, merita segnalare una testata, quella del canto VIII, che riecheggia, nella visualizza-zione degli scheletri che progressivamente riprendono vita, le cartoline della Danza Macabra Europea di Alberto Mar-tini20, mentre l’Angelica legata alla roccia nel canto X può ricordare certe atmosfere di ambito simbolista.
Tre anni dopo, nel 1948, Nerbini pubblica in una versione ‘di lusso’, sempre a dispense, l’edizione uscita inprima battuta nel 1933, che a sua volta andava a sostituire l’economica del 1925, da cui dunque converrà partire.Già la copertina è indicativa (fig. a p. 598), con un paladino, quanto mai ‘alla moda’ nel taglio dei baffi, che schiacciacon il piede un nemico sconfitto e sofferente: l’inquadratura dell’immagine, con il protagonista che volge il suosguardo fuori dalla pagina all’indirizzo del lettore, accentua la volontà modernizzante e coinvolgente di presentazionedel volume. Anche la parte testuale concorre a restituire l’idea di una lettura romanzesca contemporanea. Il nomedi «Lodovico Ariosto» compare in alto a sinistra, ma l’attenzione è puntata soprattutto sul titolo Orlando furioso adestra, accompagnato da un eclatante sottotitolo: Avventure cavalleresche narrate in prosa. Illustrate da Tancredi Scar-pelli21. E ancora, l’editore promette «meravigliose imprese di Carlo Magno – Rinaldo – Malagigi – Brandimarte»,denotando un’attenzione alla dimensione epica che si riallaccia direttamente ai cantari popolari, agli stornelli e al-l’ottava: discorso tanto più valido dal momento che a pubblicare il libro è un editore popolare toscano che rinverdiva,soprattutto negli anni Trenta, una tradizione che trovava in Salani, a Firenze, e in Perino, a Roma, alcuni dei rap-presentanti più autorevoli.
574
19 Cfr. Giovan Battista Galizzi 1998.20 Cfr. MARTINI 2008.21 ARIOSTO 1925, copertina.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 574
La raccolta si compone di sedici dispense, vendute a quaranta centesimi l’una: supponendo un’uscita setti-manale, in quattro mesi il lettore avrebbe potuto completare l’Orlando Furioso, ricco di trentasette illustrazioni inbianco e nero e una a colori (la copertina). Per un’edizione popolare, un vero privilegio, ma d’altronde Nerbini era uneditore accorto, se è vero che per primo, nel 1932, pubblicherà Topolino.
Le immagini delle dispense, stranamente, non si riferiscono ad episodi successivi, come di solito avvenivaper solleticare la curiosità del pubblico, ma sono invece relative a passaggi già incontrati dal lettore, indizio che puòessere interpretato in due modi: l’ampia conoscenza del tema, soprattutto in ambito popolare toscano, e la fiduciadell’editore che la fidelizzazione avvenisse grazie alle immagini indipendentemente dal loro riferirsi ad avvenimentipassati o futuri.
Non è un caso che Tancredi Scarpelli, tra gli illustratori di riferimento di Nerbini, compaia nel volume L’il-lustrazione nel romanzo popolare (Torino 1988, libro di riferimento nel campo dell’illustrazione ‘popolare’), considerandola sua abilità nel restituire con pochi tratti efficaci un’atmosfera, e nel blandire il lettore con scene fantastiche, chevedono protagonista naturalmente l’ippogrifo, oppure duelli, oppure ancora immagini ammiccanti. A tal proposito, èsignificativa la presenza non solo delle immancabili tavole con Angelica legata nuda allo scoglio e con l’incontro diBradamante, Marfisa e Ruggiero con le tre donne nude del seguito della regina d’Islanda, ma anche di quella dedicataal racconto di Ricciardetto, che spiega a Fiordispina di aver salvato una donna, la «ninfa amata da Giove»22, ritratta inriva al lago, dalle grinfie di un fauno con le sembianze di una creatura infernale (fig. a p. 599). Tra le illustrazioni piùriuscite va segnalata invece quella che ritrae la pazzia d’Orlando, intento a devastare campi e uccidere chiunque incon-trasse per la sua strada: nell’interpretazione di Scarpelli il guerriero, seminudo, con ancora indosso i gambali dell’ar-matura, procede brandendo una testa mozzata, con i lineamenti del volto deformati dall’ira, seminando il panico tra icontadini intorno a lui.
Diverso è l’intento della seconda edizione nerbiniana, che fu pubblicata nel 1933 con le illustrazioni diFabio Fabbi (fig. a p. 600):
Dopo l’Eneide e le Bucoliche di Virgilio, l’Iliade e l’Odissea di Omero, il Decamerone del Boccaccio e la Divina
Commedia di Dante, la mia Casa Editrice, animata dal proposito di favorire lo sviluppo della cultura nazionale,
inizia la pubblicazione dell’Orlando furioso dell’Ariosto in grande e bella edizione, ricca di quadri a colori del
Fabbi. A continuare queste edizioni di classici mi ha indotto il favore sempre crescente con cui il pubblico le
accoglie e la simpatia con la quale esso segue l’attività di questa Casa che non soltanto persevera nel suo com-
pito di render popolare il libro in Italia, ma ha voluto anche da qualche tempo giovare agli studi con la pub-
blicazione di opere originali di grande pregio, che, come la Storia d’Italia di Paolo Giudici in cinque grossi
volumi, darebbero da sole lustro ad una Casa Editrice. Sono sicuro che il favore e la simpatia del pubblico mi
sorreggeranno ancora nella via che percorro e mi procureranno altre soddisfazioni. Fra queste indubbiamente
noterò quella che i lettori mi daranno accogliendo con la solita benevolenza questa edizione del Furioso che
vede la luce nel IV centenario della morte del Poeta e che è il modesto contributo della mia Casa alle onoranze
che l’Italia tributa al grande cantore delle donne, dei cavalieri, delle armi e degli amori23.
575
22 ARIOSTO 1925, p. 143.23 Nota dell’editore ad ARIOSTO 1933.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 575
Alla presentazione dell’editore rispondono anche i dati materiali del volume: un formato più grande e unaqualità maggiore della carta e delle immagini riprodotte. Il prezzo è doppio rispetto al precedente, ovvero 80 centesimia dispensa (40 uscite in tutto): il lettore avrebbe anche potuto comprare il volume intero, come si evince dalla quartadi copertina, per 35 lire complessive. Ogni dispensa è aperta da una tavola fuori testo a colori, e la maggior parte deicanti è arricchita da testatina, finalino e tavola fuori testo al tratto. Una confezione editoriale, dunque, decisamentepiù ambiziosa di quella del 1925, con sovraccoperta e copertina distinte.
Sulla sovraccoperta la scena utilizzata è quella che ritrae Orlando assalito dagli abitanti di Biserta dopo che haucciso il mostro marino salvando Olimpia (nuda sullo sfondo), mentre sulla copertina compare Bradamante che ha le-gato all’albero Brunello. Anche al livello testuale della copertina emerge il nuovo intento dell’editore, conciliare cioè ladiffusione popolare con il libro di pregio: si sottolinea infatti la compresenza di testo originale e volgarizzazione, eFabio Fabbi, a differenza di Scarpelli, è preceduto dalla qualifica di ‘professore’, evidenziando la ricercatezza delle im-magini, opera non di un semplice illustratore. Fabbi, oggi ai più sconosciuto, era infatti un artista e un personaggio diuna certa importanza, essendo stato nominato nel 1893 professore di pittura all’Accademia di Belle Arti a Firenze, nel1894 accademico a Bologna, e addirittura nel 1898 cavaliere della Corona d’Italia. Illustratore apprezzato, aveva unacaratteristica che a Nerbini probabilmente sembrò decisiva: aveva compiuto viaggi non solo in Europa ma anche inEgitto, portandone i segni in quadri come Donna Araba, Un terrazzo ad Alessandria, Il vasaio e Vecchio musulmano. In-somma, aveva la caratura giusta per far fare all’editore fiorentino un salto di qualità, e infatti per Nerbini illustrò anchel’Iliade, l’Odissea, l’Eneide, il Decameron. Per l’Orlando Furioso si attiene fedelmente al testo, alternando efficacementela finezza dell’illustrazione al tratto, scattante e veloce, con la pastosità di un acquerello corposo per le tavole a colori,dove rielabora anche la sua passata attività di caricaturista, come nella figura grottesca di Gabrina nella tavola fuoritesto dedicata al canto XXI (fig. a p. 601).
Affrontate le pubblicazioni a dispense, conviene volgersi ora, con un notevole salto temporale, verso gli ultimidecenni del Novecento e i primi anni del Duemila, con le opere di Fabrizio Clerici e Mimmo Paladino.
È il 2 giugno 1977 quando su l’Unità, nella cronaca di Firenze, possiamo leggere un breve articolo dedicatoalla «settimana fiorentina a Kiev», e tra le diverse mostre che vengono organizzate – tra cui una di fotografia, Firenzeieri e oggi, e una, itinerante, dedicata a Jacopo Della Quercia (forse una riduzione dell’importante mostra curata da Pre-vitali nel 1975) – troviamo anche «quella delle illustrazioni su Orlando Furioso e Marco Polo di Fabrizio Clerici».Segue poi la descrizione di altri eventi, dai documentari sulla Resistenza e sull’alluvione del 1966 a una «esposizione dielaborati della scuola Mazzini», fino all’organizzazione di due partite della Fiorentina, con la Dinamo Kiev e con l’Ar-mata Rossa24. Le illustrazioni di Clerici risalgono a circa dieci anni prima, almeno al 1967, data di pubblicazione del-l’Orlando Furioso da parte dell’editrice Electa, con introduzione di Riccardo Bacchelli (fig. a p. 602). Ai disegni diClerici sono state già rivolte pagine fondamentali da parte di critici e scrittori del calibro di Ragghianti, Briganti, Mo-ravia, Buzzati, che hanno di volta in volta sottolineato l’atmosfera surrealista e l’invenzione grafica, nonché la fitta teladi rimandi stilistici e culturali, «per esempio con Magnasco [...], con Arcimboldi per certi costumi e armature sofisticate,con Piranesi per alcune scenografie architettoniche [...]; con Leonardo, sulla sua scia con Michelangiolo, e infine colBrueghel [...], cioè col Brueghel osservante Leonardo»25.
576
24 Delegazione del comune... 1977, p. 10.25 RAGGHIANTI 1990, pp. 212-213.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 576
E ancora, soffermandosi sul segno grafico di Clerici, sul rapporto tra «segno» e «disegno»:
Insomma il «disegno» di Clerici si compone di «segni» che formano tra di essi una armonia del tutto analoga
a quella che le immagini letterarie conferiscono con le rime, i ritmi, le pause, l’andamento cantabile, le schegge
di parole e addirittura di sillabe, entro la cornice fissa dell’ottava ariostesca. Ma l’anima ariostesca del proce-
dimento grafico di Clerici non si riduce a un revival di tipo rinascimentale ma si manifesta alla luce di tutt’altro
clima spirituale. Un clima persino contrastante e contraddittorio a quella olimpicità, essendo la cultura di
Clerici dichiaratamente portatrice di moderno decadentismo o simbolismo di formazione dechirichiana. Ma
chissà che, alla fin fine, aver fatto intravedere nel limpido azzurro ariostesco la nube dell’uragano non sia un
modo più compiuto di leggere l’Orlando?26
È Clerici stesso poi a spiegare, in un’intervista rilasciata alla RAI nel 1967, come fosse stato attratto dalla«grandiosità, non solo poetica ma delle invenzioni del testo», incontrando «molte situazioni [che] erano [...] congenialial mio modo di vedere e di intendere la pittura e la grafica». Pur avendo fatto «un piano architettonico», l’artista spiegadi non aver seguito una successione rigida, ma di aver «aperto a caso il poema», cominciando «dall’ottava che più miera congeniale. Il segno che ho adoperato è un segno che varia anche secondo le situazioni: [...] [quelle] umane mi im-ponevano un segno più rapido e più libero, [...] [quelle] magiche mi permettevano di entrare invece con più analisinella figurazione che io intendevo comporre»27. È un’autoanalisi, quella di Clerici, che se da un lato rimanda alla suaformazione di architetto, dall’altro richiama, nella finezza del procedere grafico, attento alle variazioni e ai sussulti deltesto, un articolo, dal significativo titolo Fabrizio o della fantasia pericolosa, che Giò Ponti gli aveva dedicato nell’ormailontano 1940, presentando alcuni oggetti d’arredo progettati dall’architetto-artista:
Quale è il pregio loro? È nella fantasia, nella libertà, nel gusto elegante, nella finezza è soprattutto per noi
nella intelligente scioltezza da ogni auto-accademia, nel gusto di varcare certi limiti, di provarsi a questi
estremi, nella vivacità, nella intelligenza sveglia e non professorale, nella ricchezza di idee. [...] queste cose, ai
limiti del morboso e dell’errore, hanno la bellezza loro non nel prestigio d’un risultato sereno, sicuro e fermo,
ma in quel tanto di riuscito ardimento da giocoliere a tenersi su un filo senza cader nei precipizi dove inevi-
tabilmente cadrebbero gli incauti imitatori, o Fabrizio Clerici stesso, se un giorno si fidasse troppo e procedesse
a occhi chiusi28.
Dunque, è interessante pensare che questo artista passi dalle pagine di «Domus» a quelle de l’Unità, fino a diventareun motivo di vanto da portare in Unione Sovietica. Non è l’unica volta che Clerici compare sul quotidiano comunista, chein verità segue l’artista con una certa attenzione. Ad esempio ne parla Dario Micacchi in un articolo del 3 ottobre 1978:
[...] in questi fogli per «Orlando Furioso» Clerici tocca l’acme nell’immaginazione dell’energia e del «lonta -
no» [...]. È la storia della terra e degli uomini che cambia pelle, che si rinnova. E una sensazione vitale ac-
577
26 TROMBADORI 1981, pp. 122-123.27 Intervista disponibile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=76eksf43K8I (29/04/2013); v. anche BONDI, RIZZARELLI 2012.28 PONTI 1940, p. 39.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 577
compagna la visione surreale di tale ricambio: folle sterminate e che non hanno volto vengono a popolare e
ad agire nel piccolo spazio figurato del foglio: [...] è come lo straripare di una corrente sterminata e possente
e che trascina con sé per altro uso grandi sradicati frammenti di vita e di cultura29.
Il momento di maggior coinvolgimento dell’opera di Clerici è però da individuarsi nel lancio dell’abbona-mento del giornale per l’anno 1982, allorché ai sottoscrittori veniva offerto come strenna Il Milione illustrato proprioda Clerici, con prefazione di Giorgio Manganelli. Anche nel breve trafiletto a corredo della pubblicità, accompagnatasulla sinistra da un discorso di Berlinguer, veniva rimarcata la sensibilità per certi versi avveniristica dell’artista,capace di definire i contorni di un’umanità futura, chiudendo così un percorso di analogie che accostava MarcoPolo ai giornalisti de l’Unità:
[...] Fabrizio Clerici ha fatto il suo viaggio nel Kathai e oltre sullo stimolo di Marco Polo e nelle terre più de-
serte e desolate ha visto ciottoli misteriosi, li ha aperti e ci ha visto imprigionate dentro le figure di una grande
storia dell’uomo. Leggete il libro, guardate con calma le immagini: vi ritroverete un po’ diversi e un po’ più
avanti [...] Marco Polo, cronista del XIII secolo, ebbe un’idea modernissima: scoprire, capire, raccontare. Per
questo affrontò un viaggio di 7000 giorni al di là delle frontiere del mondo conosciuto. Noi de «l’Unità»,
cronisti di oggi, raccogliamo e applichiamo quell’idea e ti proponiamo di affrontare insieme un viaggio di
365 giorni attraverso le cose piccole o grandi, chiare o inedite ma sempre importanti del mondo contempo-
raneo: un mondo che inizia nella tua casa e si espande fino a comprendere tutti gli uomini30.
Prima di arrivare al 2011, con l’edizione illustrata da Mimmo Paladino, bisogna ricordare che risale al 2005la pubblicazione di L’Orlando Furioso. Le illustrazioni di Paul e Gaëtan Brizzi dell’opera dell’Ariosto, che vede all’operai due fratelli francesi, ma di origine italiana, legati al mondo dell’animazione. La decisione di compiere queste tavoleera nata non a caso nel 1998, quando erano impegnati in un film d’animazione per la Walt Disney tratto dal DonChisciotte. Nelle loro illustrazioni convergono suggestioni differenti, manifestando «una opulenta, libera voglia diracconto che i Brizzi sembrano condividere pienamente con alcuni loro illustri predecessori, quali il più giovane af-filiato del gruppo dei Nazareni, Julius Schnorr von Carolsfeld»31. Le immagini hanno tuttavia la fluidità dell’anima-zione, con un gioco continuo di chiaroscuri e focalizzazioni vicine e lontane che implicano la cooperazione di unlettore-spettatore abituato al ritmo visivo dei film: con grande abilità i fratelli Brizzi manovrano la matita come sefosse una telecamera, restituendo di volta in volta il momento grottesco e quello epico, il raccoglimento e la passione,il duello e il tradimento (figg. alle pp. 603-605).
Ed ecco infine i disegni di Mimmo Paladino per l’Orlando Furioso, pubblicato dall’Istituto della EnciclopediaItaliana, nella collana «Classici Treccani», nel 2011. Il libro rientra tra i volumi di grande «qualità editoriale classica»32
«stampati al torchio piano cilindrico e rilegati a mano in pelle»33, dedicati dalla Treccani ai grandi classici della lette-
578
29 MICACCHI 1978, p. 8.30 Il Milione 1981, p. s.n.31 CUNACCIA 2005, p. s.n.32 BACCI 2013.33 TEDESCO 2012.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 578
ratura (da Il Milione a Il Principe, dall’Orlando Furioso alla Gerusalemme liberata, solo per citarne alcuni). È importantesottolineare come Paladino, non sia solo pittore e scultore, ma anche un grande «artista prestato alla letteratura»(come si è autodefinito), che oltre a essersi dedicato a imprese editoriali ricercate e rare, come l’Iliade e l’Odissea, ilPhilobiblon e l’Orlando Furioso appunto, il ‘servito buono’, le ‘porcellane di Sèvres’, per citare Anatole France34, hadato la sua opera anche per libri ad ampia circolazione, come Le Metamorfosi e la Nuova Bibbia Salani, Le ceneri diPirandello, o ancora, nel 2001, realizzando una serigrafia a nove colori per l’inaugurazione della linea 1 della metro-politana di Napoli. Tirature limitate e migliaia di copie, destinazione ristretta e circolazione popolare.
Venendo nello specifico all’Orlando Furioso, si tratta di un’edizione estremamente curata, per la quale l’artista haelaborato tredici illustrazioni (compreso il ritratto di Ludovico Ariosto in antiporta), tutte a piena pagina. Tuttavia non sitratta di mere illustrazioni descrittive ma, come spiega Paladino stesso, di immagini in grado di restituire una «lettura con-temporanea», nuova, del capolavoro classico. In quanto «pittore prestato alla letteratura», l’artista non segue tanto un per-corso filologico (pur presente), quanto un atteggiamento quasi rabdomantico, «anche aprendo una pagina a caso e leggendouna frase a caso [...] rubo quello che mi può servire per ottenere un’immagine», arrivando a riconoscersi nella figura em-blematica di Don Chisciotte che «erra per questa pianura, incontra ma non sa, vede una cosa per un’altra»35.
In effetti, tanto l’atteggiamento ‘del rabdomante’, quanto il desiderio di sperimentare, vengono confermatidalle illustrazioni stesse. Per quanto riguarda il primo aspetto, emerge come non vi sia un’equa ripartizione delle im-magini tra i diversi canti: è chiaro che Paladino ha seguito la propria ispirazione, cercando, o trovando, i passi a lui piùcongeniali. Vediamo allora alcune delle immagini. Apre la serie, scelto a emblema della narrazione, un potente e insiemedelicato ippogrifo, tratteggiato graficamente su un cielo blu, percorso da segni grafici ritornanti. Unica eccezione allaleggerezza grafica: le ali definite coloristicamente in arancione (fig. a p. 606).
La prima illustrazione interna si riferisce invece ad Angelica (fig. a p. 607), descritta anch’essa graficamente,con un appena percettibile segno di matita, quasi metonimicamente schiacciata, nella sua fuga, da più corposi arbusti(verdi) e sagome di alberi (nere). Tanto è etereo il profilo di Angelica, tanto è invece sfuggente, immerso in una biancae candida nebbia, il volto della fata Morgana. A proposito del profilo di Angelica, tuttavia, pare ineludibile il riferimentoalle parole con cui Paladino descrive il proprio lavoro in ambito scultoreo, attestando un comune modo di procedere:
parto da una forma che a volte viene anche fatta direttamente, ma sempre la immagino come forma grafica,
quasi mai plastica, pur essendo plastile: sempre visioni prospettiche schiacciate, come se fossero dei segni
insomma. Un cavallo ad esempio è una forma geometrica, poi è anche volume, ma prima di tutto è forma
geometrica36.
E in effetti, definita da un disegno che sembra richiamare alla mente la sensualità e sinuosità lineare del Matissedelle Poésies di Stéphane Mallarmé (Lausanne 1932), è l’illustrazione per il canto X (fig. a p. 608), raffigurante il mo-mento in cui «Ruggier, commosso dunque al giusto grido, / slegò la donna, e la levò dal lido» (canto X, 111, vv. 7-8).Se il cavaliere appare baldanzoso, sostanziato dal colore, imperioso nella sua derivazione dalla scultura italica, con tantodi usbergo arcaico, fragile e indifeso, delicato, appare invece il profilo di donna ai suoi piedi. Riferimenti a una classicità
579
34 BENJAMIN 2012, p. 16.35 BACCI 2013.36 Ibid.
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 579
remota che contraddistinguono anche Cloridano e Medoro mentre trasportano il possente corpo di Dardinello, impa-stati letteralmente di terra e colore. Non impastato di terra, ma pur sempre paragonabile a una divinità per certi versictonia, è il mago Atlante descritto da Paladino (fig. a p. 609): una sagoma verde, con in mano una sorta di tridente, euna testa che sembra ricordare la matericità di Dubuffet (in particolare il Dubuffet illustratore di Les Murs, Paris 1950),seguito dall’artista nei suoi esordi, eppure negato come riferimento nella presente circostanza:
Non c’ho pensato in realtà. Agli esordi sì, c’era Dubuffet, ma in quegli anni avevo Persico come professore al
liceo, pittore napoletano in contatto con il gruppo dei nucleari e Baj. Quindi direi che se c’era un’influenza
era più da ricondursi a Baj, con il quale ci siamo anche conosciuti37.
Tuttavia, tra le illustrazioni più efficaci, spicca senza dubbio quella dedicata alla pazzia d’Orlando (fig. a p.610), dove la perdita di senno, la dispersione delle armi e la nudità, sono rappresentati sinesteticamente attraverso unalinea grafica semplice e scarna che tratteggia il corpo del paladino, vittima di una sorta di sparagmòs: il suo corpo èquello di un burattino, alle estremità alcuni caratteri evidenziano il lacerarsi del senno ma anche di ogni senso compiutoassociato alle lettere. I colori, i tanti colori che caratterizzano le singole linee, confermano la perdita di controllo:
È proprio l’idea del linguaggio, della parola, che può essere oggetto di pura follia. Ma in quel periodo io stavo
di nuovo lavorando al Don Chisciotte: ci sono delle affinità, la follia di Don Chisciotte è legata al linguaggio
della letteratura, una follia che porta il protagonista a mescolare tutto quello che aveva letto in un’enorme
storia dove entra ed esce qualunque cosa, una metafora della letteratura38.
È con questa immagine che si chiude il percorso nelle illustrazioni ariostesche, indagate, come dichiarato inapertura, in base a tipologie differenti: le riduzioni, le riletture, le edizioni popolari, quelle di lusso e quelle d’artista.L’obiettivo dell’intervento è stato di rendere attraverso poche edizioni significative lo spaccato delle possibilità espressiveassociate alle più varie modalità editoriali-illustrative: da quelle legate ad esigenze di restituzione e di narrazione aned-dotica (dove il testo era interpretato fedelmente dagli illustratori), a quelle invece collegate ad un proposito di arricchi-mento ulteriore di tipo interpretativo (le figure di Paladino che cercano di trovare un senso sempre nuovo all’internodi un capolavoro illustrato e commentato svariate volte).
La diversa intenzione critica si può ben riassumere proprio con le parole di Paladino, che per evidenziare l’ec-cezionalità del suo lavoro tiene a precisare che la sua capacità, come artista, è «trovare nel testo qualcosa di nuovo, qual-cosa che può sollecitare a fare un disegno che sia comunque sorprendente per chi lo guarda e soprattutto che possadare una lettura diversa dalla pagina stessa»39.
37 Ibid.38 Ibid.39 Ibid.
580
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 580
Bibliografia
L. ARIOSTO, Orlando Furioso commentato ed annotato da Giovanni Andrea Barotti. Illustrato dal celebre pittore Cav. NicolaSanesi, Milano 1900; R. CALZINI, Un illustratore: G. B. Galizzi, «Emporium», LVIII, 348, 1923, pp. 368-373; L. ARIOSTO,L’Orlando furioso. Avventure cavalleresche. Riduzione popolare di M. Guarnieri. Illustrazioni originali di T. Scarpelli, Firenze1925; ID, L’Orlando furioso. Testo integrale con l’aggiunta della volgarizzazione in prosa di M. Guarnieri. Illustrazioni di F.Fabbi, Firenze 1933; La leggenda di Orlando, narrata da Eugenio Treves, illustrata da Gustavino, collana «La scala d’oro»,s. VI/4, Torino 1933; G. PONTI, Fabrizio o della fantasia pericolosa, «Domus», 150, 1940, pp. 39-45; U. BOCCIONI, Pitturascultura futuriste (dinamismo plastico), Milano 1914, ora in ID., Pittura scultura futuriste (dinamismo plastico), a cura di L.Vinca-Masini, Firenze 1977; Delegazione del Comune in partenza per Kiev, in l’Unità, 2 giugno 1977, p. 10; D. MICACCHI,Riscoperta del mondo attraverso la furia di Orlando, in l’Unità, 3 ottobre 1978, p. 8; Il Milione. La strenna de «l’Unità» aisuoi lettori più affezionati: gli abbonati del 1982, in l’Unità, 10 dicembre 1981; A. TROMBADORI, Il segno di Orlando, «L’Eu-ropeo», XXXVII, 16, 1981, pp. 122-123; P. PALLOTTINO, A pranzo con le fate, in Gustavino, a cura di P. Pallottino, Roma1989, p. 6; C.L. RAGGHIANTI, Fabrizio Clerici. Fantasia e libertà (introduzione ai disegni di Fabrizio Clerici per l’OrlandoFurioso nel catalogo della mostra alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia nel 1968), ora in Fabrizio Clerici. I disegni perl’Orlando Furioso, presentazioni di A. Gonzalez-Palacios e A. Cipriani, e scritti di R. Bacchelli, G. Briganti, C.L. Ragghianti,C. Segre, Roma 1990, pp. 209-216; M. BELPOLITI, L’occhio di Calvino,Torino 1996; Giovan Battista Galizzi 1882-1963.Pittore simbolista, a cura di F. Rea, catalogo della mostra, Bergamo 1998; I. CALVINO, Lezioni americane. Sei proposte per ilprossimo millennio, Milano 2002 (I ed. Milano 1988), p. 90; C. CUNACCIA, introduzione a L’Orlando Furioso. Le illustrazionidi Paul e Gaëtan Brizzi dell’opera di Ariosto, a cura di E. Brizzi, Firenze 2005; A. MARTINI, Danza Macabra Europea. La tra-gedia della Grande Guerra nelle 54 cartoline litografate, saggi a cura di A. Mulas, Genova 2008; A. FAETI,Guardare le figure.Gli illustratori italiani dei libri per l’infanzia, Roma 2011 (I ed. Torino 1972); W. BENJAMIN, Aprendo le casse della mia bi-blioteca. Discorso sul collezionismo, trad. E. Dell’Anna Ciancia, Milano 2012, p. 16 [articolo apparso per la prima voltain «Die literarische Welt», 27, 1931]; F. BONDI, G. RIZZARELLI, scheda relativa a Fabrizio Clerici, in Donne CavalieriIncanti Follia. Viaggio attraverso le immagini dell’Orlando Furioso, a cura di L. Bolzoni, C.A. Girotto, catalogo dellamostra (Pisa), Lucca 2012, pp. 94-97. N. CATELLI, scheda relativa a Gustavino, ibid. pp. 82-84; F. GUZZETTI, schedarelativa a Grazia Nidasio, ibid., pp. 85-88; I. TEDESCO, I classici Treccani illustrati da Paladino, «Piazza Enciclopedia Ma-gazine», 14 giugno 2012, http://www.treccani.it/magazine/piazza_enciclopedia_magazine/cultura/Paladino_Classici.html(12 marzo 2014); G. BACCI, «Trovare un’immagine sorprendente»: a colloquio con Mimmo Paladino, «Arabeschi. Rivistadi studi su letteratura e visualità », 2, 2013, http://www.arabeschi.it/intervista-mimmo-paladino/ (12 marzo 2014); ID.,Dall’Orlando Furioso a Valentina Melaverde: un viaggio nella fantasia insieme a Grazia Nidasio, «Arabeschi», 3, 2014,http://www.arabeschi.it/tag/grazia-nidasio/ (15 aprile 2014).
581
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 581
(© 2009 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, per le illustrazioni. [Tutti i diritti riservati])
Tavola fuori testo di Grazia Nidasio con il castello di Atlantein Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino,
Milano, Mondadori, 2009
582
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 582
583
(© 2009 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, per le illustrazioni. [Tutti i diritti riservati])
Tavola fuori testo di Grazia Nidasio con Mandricardo e Doralicein Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino,
Milano, Mondadori, 2009
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 583
(© 2009 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, per le illustrazioni. [Tutti i diritti riservati])
584
Tavola fuori testo di Grazia Nidasio con Rodomonte all’assalto di Parigiin Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino,
Milano, Mondadori, 2009
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 584
(© 2009 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, per le illustrazioni. [Tutti i diritti riservati])
585
Tavola fuori testo di Grazia Nidasio con Astolfo e s. Giovanni verso la lunain Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino,
Milano, Mondadori, 2009
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 585
(© 2009 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, per le illustrazioni. [Tutti i diritti riservati])
586
Tavola fuori testo di Grazia Nidasio con l’uccisione di Rodomontein Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino,
Milano, Mondadori, 2009
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:23 Pagina 586
(“su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.”)
587
Copertina di Gustavino (Gustavo Rosso)per La leggenda di Orlando, narrata da Eugenio Treves, illustrata da Gustavino,
Torino, UTET («La scala d’oro», serie VI/4), 1933Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 587
(“su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.”)
588
Tavola fuori testo di Gustavino (Gustavo Rosso) con l’ingresso di Orlando nel castello incantato in La leggenda di Orlando, narrata da Eugenio Treves, illustrata da Gustavino,
Torino, UTET («La scala d’oro», serie VI/4), 1933Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 588
(“su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.”)
589
Tavola fuori testo di Gustavino (Gustavo Rosso) con Rodomonte all’assalto di Parigiin La leggenda di Orlando, narrata da Eugenio Treves, illustrata da Gustavino,
Torino, UTET («La scala d’oro», serie VI/4), 1933Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 589
(“su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.”)
590
Illustrazione infratesto di Gustavino (Gustavo Rosso) con Orlando che infilza sei nemici in La leggenda di Orlando, narrata da Eugenio Treves, illustrata da Gustavino,
Torino, UTET («La scala d’oro», serie VI/4), 1933, p. 93Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 590
(“su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.”)
591
Illustrazione infratesto di Gustavino (Gustavo Rosso) con la rappresentazione della Discordiain La leggenda di Orlando, narrata da Eugenio Treves, illustrata da Gustavino,
Torino, UTET («La scala d’oro», serie VI/4), 1933, p. 83 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 591
(Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara/Mirandola Grafica)
592
Tavola fuori testo di Giovanni Battista Galizzi con Angelica stesa a riposarein Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. 46 tavole in tricromia - 46 tavole in rotocalco fuori testo
e 46 disegni episodici di Giambattista Galizzi, Milano, Edizioni Labor, 1945 Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 592
(Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara/Mirandola Grafica)
593
Tavola fuori testo di Giovanni Battista Galizzi con Sacripante disarcionato da Baiardoin Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. 46 tavole in tricromia - 46 tavole in rotocalco fuori testo
e 46 disegni episodici di Giambattista Galizzi, Milano, Edizioni Labor, 1945 Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 593
(Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara/Mirandola Grafica)
594
Tavola fuori testo di Giovanni Battista Galizzi con Bradamante e Marfisa in lottain Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. 46 tavole in tricromia - 46 tavole in rotocalco fuori testo
e 46 disegni episodici di Giambattista Galizzi, Milano, Edizioni Labor, 1945 Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 594
(Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara/Mirandola Grafica)
595
Tavola fuori testo di Giovanni Battista Galizzi con i cavalieri vittime della magia di Alcinain Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. 46 tavole in tricromia - 46 tavole in rotocalco fuori testo
e 46 disegni episodici di Giambattista Galizzi, Milano, Edizioni Labor, 1945 Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 595
(© Archivio Carlo Galizzi)
596
Giovanni Battista Galizzi (Bergamo 1882 - 1963)La baraonda
olio su tela; 1916Bergamo, collezione privata
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 596
(© Archivio Carlo Galizzi)
597
Giovanni Battista Galizzi (Bergamo 1882 - 1963)Circe
olio su cartone; 1945Bergamo, collezione privata
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 597
(Biblioteca Marucelliana, Firenze/su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)
598
Copertina di Tancredi Scarpelliper Ludovico Ariosto, Orlando furioso. Avventure cavalleresche narrate in prosa.
Illustrate da Tancredi Scarpelli, Firenze, Nerbini, 1925Firenze, Biblioteca Marucelliana
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 598
(Biblioteca Marucelliana, Firenze/su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)
599
Tavola fuori testo di Tancredi Scarpelli con Ricciardetto che salva una donna dal faunoin Ludovico Ariosto, Orlando furioso. Avventure cavalleresche narrate in prosa.
Illustrate da Tancredi Scarpelli, Firenze, Nerbini, 1925.Firenze, Biblioteca Marucelliana
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 599
(Biblioteca Marucelliana, Firenze/su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)
600
Sovracoperta di Fabio Fabbi con Orlando assalito dagli abitanti di Bisertaper L’Orlando Furioso di Lodovico Ariosto. Testo integrale con volgarizzazione in prosa
di M. Guarnieri. Quadri del Prof. Fabio Fabbi, Firenze, Nerbini, 1933Firenze, Biblioteca Marucelliana
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 600
(Biblioteca Marucelliana, Firenze/su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)
601
Tavola fuori testo di Fabio Fabbi con Zerbino che uccide Ermonide alla presenza di Gabrinain L’Orlando Furioso di Lodovico Ariosto. Testo integrale con volgarizzazione in prosa
di M. Guarnieri. Quadri del Prof. Fabio Fabbi, Firenze, Nerbini, 1933Firenze, Biblioteca Marucelliana
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 601
(Archivio Fabrizio Clerici)
602
Tavola di Fabrizio Clerici con Orlando che scopre le iscrizioni di Angelica e Medoro in Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. Introduzione di Riccardo Bacchelli.
Tavole e illustrazioni di Fabrizio Clerici, Milano, Electa, 1967
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 602
(© Paul and Gaëtan Brizzi)
603
Tavola di Paul e Gaëtan Brizzi per il canto II dell’Orlando Furiosoin L’Orlando Furioso. Le illustrazioni di Paul e Gaëtan Brizzi dell’opera dell’Ariosto, a cura di E. Brizzi,
Firenze, Pagliai Polistampa, 2005
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 603
(© Paul and Gaëtan Brizzi)
604
Tavola di Paul e Gaëtan Brizzi per il canto VIII dell’Orlando Furiosoin L’Orlando Furioso. Le illustrazioni di Paul e Gaëtan Brizzi dell’opera dell’Ariosto, a cura di E. Brizzi,
Firenze, Pagliai Polistampa, 2005
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 604
(© Paul and Gaëtan Brizzi)
605
Tavola di Paul e Gaëtan Brizzi per il canto XIII dell’Orlando Furiosoin L’Orlando Furioso. Le illustrazioni di Paul e Gaëtan Brizzi dell’opera dell’Ariosto, a cura di E. Brizzi,
Firenze, Pagliai Polistampa, 2005
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 605
(Per gentile concessione dello Studio Paladino)
606
Antiporta con l’ippogrifo acquaforte realizzata da Mimmo Paladino per Ludovico Ariosto, Orlando Furioso,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 606
(Per gentile concessione dello Studio Paladino)
607
Tavola fuori testo di Mimmo Paladino con Angelica per il canto I dell’Orlando Furiosoin Ludovico Ariosto, Orlando Furioso,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 607
(Per gentile concessione dello Studio Paladino)
608
Tavola fuori testo di Mimmo Paladino con Ruggiero per il canto X dell’Orlando Furiosoin Ludovico Ariosto, Orlando Furioso,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 608
(Per gentile concessione dello Studio Paladino)
609
Tavola fuori testo di Mimmo Paladino con il mago Atlante per il canto IV dell’Orlando Furiosoin Ludovico Ariosto, Orlando Furioso,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 609
(Per gentile concessione dello Studio Paladino)
610
Tavola fuori testo di Mimmo Paladino con la pazzia di Orlando per i canti XXIII-XXIV dell’Orlando Furiosoin Ludovico Ariosto, Orlando Furioso,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011
567-610_Bacci_OrlandoFurioso_impaginato interno 09/07/14 11:24 Pagina 610
PRESENTAZIONE
di Massimo Bray XI
INTRODUZIONE
L’ORLANDO FURIOSO: GIOCHI DI PROSPETTIVA SUL TESTO E MONDI DI IMMAGINI
di Lina Bolzoni XV
«ARIOSTO D’ORO E FIGURATO»:LE PRINCIPALI EDIZIONI ILLUSTRATE DEL CINQUECENTO
di Carlo Alberto Girotto 1
«RAGIONAR DI QUELLI INCANTI STRANI». MAGHI E MAGHE NELLE ILLUSTRAZIONI DEL FURIOSO
di Martyna Urbaniak 35
«IN FURORE E MATTO». RAPPRESENTAZIONI DELLA FOLLIA NELLE IMMAGINI DEL FURIOSO
di Fabrizio Bondi 69
«L’AMOROSE RETI»: LE IMMAGINI DELL’EROS NELLE EDIZIONI CINQUECENTESCHE
di Nicola Catelli 109
VEDERE IL TEMPO: STRATEGIE NARRATIVE NELLE ILLUSTRAZIONI
di Giovanna Rizzarelli 141
MAPPE ED ECFRASI NELL’EDIZIONE VALGRISI DEL 1556di Alessandro Benassi, Serena Pezzini 183
ILLUSTRANDO I CINQUE CANTI
di Andrea Torre 227
I VOLTI DI ORLANDO. EDIZIONI ILLUSTRATE DAL SEICENTO ALL’OTTOCENTO
di Paola Pallottino 263
IL FURIOSO NELLE INCISIONI: DA TIZIANO ALLE STAMPE POPOLARI
di Chiara Callegari 303
TRA PALAZZI E VILLE, TORRI E GROTTE: CICLI PITTORICI CINQUECENTESCHI
di Federica Caneparo 345
LE «CORBELLERIE» DEL FURIOSO NELLA PITTURA DEL CINQUECENTO E DEL SEICENTO
di Massimiliano Rossi 395
MOLTO AMORE PER NULLA: IL FURIOSO IN PITTURA NEL SETTECENTO ITALIANO
di Rodolfo Maffeis 449
Sommario
763
759-768_REFERENZE def._impaginato interno 09/07/14 11:40 Pagina 763
IL FURIOSO NELLA PITTURA DAL NEOCLASSICISMO AL SIMBOLISMO
di Fernando Mazzocca 485
EPISODI DELLA FORTUNA DEL FURIOSO NELLA PITTURA DEL NOVECENTO IN ITALIA
di Flavio Fergonzi 525
L’ARIOSTO NELLE MAIOLICHE
di Monica Zampetti 545
«UN’IMMAGINE CARICA DI SIGNIFICATO»: ILLUSTRAZIONI NOVECENTESCHE
di Giorgio Bacci 567
L’ORLANDO FURIOSO NEL FUMETTO ITALIANO
di Marco Arnaudo 611
«UN ORLANDO NOVISSIMO»: RIPRESE TEATRALI, MELODRAMMI E INTERMEZZI
DAL CINQUECENTO AL SETTECENTO
di Stefano Tomassini 655
LA FORTUNA DELL’ORLANDO FURIOSO NELLE ARTI PERFORMATIVE. SCENARIO ITALIANO
di Francesca Bortoletti 689
GIUOCARE O GUARDARE? L’ORLANDO FURIOSO DI RONCONI-SANGUINETI TRA PIAZZA E TVdi Claudio Longhi 725
REFERENZE ICONOGRAFICHE 759
RINGRAZIAMENTI 762
764
759-768_REFERENZE def._impaginato interno 09/07/14 11:40 Pagina 764
QUESTO VOLUME, EDITO DALL’ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA,È STATO STAMPATO IN 1999 ESEMPLARI
SU CARTA SPECIALE SCHEUFELEN.
QUESTO ESEMPLARE È IL NUMERO ……/1999
759-768_REFERENZE def._impaginato interno 09/07/14 11:40 Pagina 766