Distillati dal Sole e dalla Luna: significati e importanza dello specchio nella cultura cinese
Transcript of Distillati dal Sole e dalla Luna: significati e importanza dello specchio nella cultura cinese
Jian e jingIn cinese sono due i caratteri più utilizzati per indicare lo spec-chio, ed entrambi sono composti fono-semantici in cui la partesinistra significa “metallo” e la parte destra dà indicazione sullapronuncia (fig. 1). Jian deriva da un antico pittogramma che raf-figura una persona china su un bacile, intenta a specchiarsi nel-l’acqua in esso contenuta, e mantiene nel cinese contemporaneoil significato di “guardare attentamente, ispezionare”. Il sensodell’ideogramma può essere reso dunque come “il metallo chepermette di ispezionare”. Le origini pittografiche dell’altro ter-mine, jing, sono meno chiare e il suo significato è più astratto:indica un limite, uno stacco, un completamento, ma anche l’in-contro con qualcosa di inaspettato. Volendo forzare un po’ lamano delle analisi etimologiche, diremmo che questo specchiorappresenta “il limite metallico” tra due mondi, quello della real-tà e quello del suo riflesso.Un excursus sul significato e sull’importanza dello specchionella cultura cinese non può prescindere dalla sua duplice faccia:una liscia, chiara e diretta (yang, direbbero i cosmologi dell’an-tichità), destinata a scopi pratici di toeletta e di palese scintillìo;l’altra complessa, nascosta, yin, ornata di simboli più o menoarcani che necessitano di uno sforzo di interpretazione ma checostituiscono parimenti la ragion d’essere dell’oggetto in que-stione. Il legame tra le due facce risulta tanto più stretto se sipensa che, a parte una fase iniziale di sperimentazione con spec-chi “a doppio corpo” e una fase finale di impoverimento dellematerie prime e delle tecniche di fusione che resero necessarioplaccare la faccia riflettente per renderla fruibile, il recto e ilverso dello specchio cinese sono costituiti da uno stesso metalloottenuto in un unico episodio di fusione.Jian e jing sono anch’essi termini intercambiabili, dalle sfuma-ture diverse ma complementari, necessarie l’una all’altra. Non èesagerato affermare che quando un cinese teneva uno specchiopoteva credere di tenere in mano un intero universo: di fronte ilriflesso di se stesso e del mondo reale, transeunte nel transeun-te; sul retro il riflesso della cultura del suo tempo e del mondoimmutabile dei simboli, fossero essi di carattere cosmologico,religioso o genericamente augurale. Le iscrizioni che talvoltaaccompagnano questi simboli ne aumentano la significatività in
un perfetto esempio di interazione tra testo e immagine. È diffi-cile pensare a un altro oggetto di uso pratico e di valore artisticotanto vicino – fisicamente e spiritualmente – al proprietarioquanto lo specchio, e tale constatazione da sola dovrebbe illumi-narci sulla sua importanza nell’ambito della cultura cinese. Invita, strumento indispensabile per controllare l’aspetto impecca-bile imposto dal ruolo sociale o autoimposto dal narcisismo, maanche oggetto di lusso da mostrare e “promemoria” visivo delleforze che controllano i ritmi del mondo; in morte, oggetto tra ipiù ambiti per accompagnare il defunto nel suo viaggio nell’al-dilà e per illuminare l’oscurità del sepolcro. Usi edonistici, idea-listici ed esoterici si mescolano a tal punto che la definizionedello specchio come “bene suntuario” o il suo incasellamento trale arti minori adottata da molti testi suonano quantomeno inade-guati. La perfetta fusione di funzione e significato in un’unicaforma ne fa piuttosto un’epitome della produzione artistica cine-se, un chiaro riflesso della “coscienza collettiva” nelle varie epo-che della storia.Sarà un caso che tra i più antichi manufatti di bronzo finora ritro-vati, prodotti con certezza nell’attuale territorio cinese e risalen-ti a circa quattromila anni fa, gli specchi occupino una posizio-ne di primo piano. Non è un caso però che, dopo essersi defini-tivamente affermato alla metà del primo millennio a.C., questooggetto abbia resistito indenne – unico tra i prodotti del bronzi-sta – ai mutamenti della cultura e del gusto, mentre le altre tipo-logie dei bronzi venivano soppiantate da altri materiali e da altrivalori. Rimase un bene elitario irrinunciabile fino al XVIII seco-lo, quando cominciò a essere sostituito dagli specchi di vetro diispirazione occidentale.È opinione consolidata che l’età di massimo splendore della pro-duzione bronzistica in Cina si sia esaurita prima dell’avventodell’era volgare. Lo specchio di bronzo è quindi un nobilesopravvissuto di quest’arte arcaica, nella quale la cultura cinese
13
Distillati dal sole e dalla luna: significati e importanzadello specchio nella cultura cinese
Marco Guglielminotti Trivel
1. I caratteri cinesi jian e jing, scritti nella variante antica del “Piccolo Sigillo”e nella forma attuale
(jian) (jing)
RIFLESSI 012-045:099��17-11-2012��11:47��Pagina�13
14
stessa affonda le sue radici. Certo, sono noti anche antichi esem-plari in giada e in pietra levigate, che probabilmente avevanodestinazioni più rituali che pratiche a causa della natura stessadei materiali1. E in alcuni periodi furono utilizzati anche altrimetalli, sebbene più per necessità che per scelta, come testimo-niano ad esempio gli specchi di ferro (cat. 52). Ma la lega terna-ria rame-stagno-piombo – tre metalli per eccellenza (sanshang)dell’alchimia daoista –, e in particolare lo speculum ad alto teno-re di stagno noto anche ai Romani per la sua parvenza argenteae riflettente2, continuò a mantenere un ruolo privilegiato per tuttala storia cinese dello specchio.
Contatti con lo sciamanesimo scito-siberianoLa più antica citazione letteraria di uno specchio metallico in Cinarisale al 673 a.C., dove viene descritto appeso alla cintura di unaregina3. Si tratta, è lecito supporre, di uno specchio rituale piutto-sto che d’uso pratico, che richiama immediatamente gli specchiappesi alle vesti degli sciamani in Asia settentrionale: amuleti eaccessori d’elezione per creare un alone di baluginìo attornoall’intermediario tra i mondi della terra, del cielo e del sottosuo-lo. Il parallelismo con gli specchi delle popolazioni scite/saka esarmate/sauromate delle steppe euroasiatiche rinforza la teoriadell’introduzione (o meglio della reintroduzione) dello specchioin Cina grazie ai contatti con queste popolazioni nel corso delprimo millennio a.C.4. Il primo specchio propriamente cinesedoveva essere di tipo sciamanico, ancora poco adatto a rifletterela realtà in modo attendibile ma ottimo per creare effetti di luce e,almeno in una fase iniziale, legato probabilmente a un culto ditipo solare. Dalla stessa fonte sembra scaturire il primato simbo-lico dello specchio in Giappone, ad esempio, dove è consideratol’attributo principale della divinità shintō da cui si fa discendere ilpopolo giapponese: Amaterasu-no-ōmikami, la dea del sole non-ché l’archetipo sciamanico per eccellenza. A proposito dello scia-manesimo mongolo, Heissig (1980, p. 19) scriveva:
Anche nei casi in cui il resto della veste cerimoniale è stato dimenti-cato, il grembiule rituale e la sospensione degli specchi giocano
ancora un ruolo prominente […]. Una volta uno sciamano mi spiegòdi persona che negli specchi vive il bianco cavallo dello sciamano.Spesso […] sono indossati sul petto e sulla schiena. Questi specchihanno una funzione multipla. In primo luogo spaventano le forze egli spiriti malefici. […] Un’altra funzione simbolica dello specchio[…] è che esso riflette tutto, all’interno come all’esterno, inclusi ipensieri più segreti. Attraverso il potere dello specchio lo sciamanoacquisisce lo status di un essere onnisciente. Infine, il terzo compitodello specchio è quello di disperdere gli ostili dardi invisibili delleforze del male e proteggere così lo sciamano dalle ferite che posso-no infliggere.
L’onnipresenza dello specchio come paramento sciamanicospiega bene in realtà anche una ragione fondamentale della for-tuna che lo specchio cinese ha sempre goduto nello spazio asia-tico. Dotato di qualità riflettenti, artistiche e tecniche superiori,veniva commercializzato e tesaurizzato per usi rituali primaancora che come oggetto da toeletta5. Non è raro trovare tuttoraantichi specchi cinesi appesi ai grembiuli sciamanici di diversepopolazioni asiatiche, dagli Evenchi in Manciuria orientale aiTuvani in Siberia meridionale e oltre: e più lo specchio è antico,più viene considerato efficace. Con sfumature diverse, anche ilmelong tibetano condivide analoghe proprietà.La pregnanza magico-rituale dello specchio cinese aiuta anche agiustificarne la forma: prevalentemente rotonda, senza manico,con una presa centrale forata sul retro dove far passare un nastroo una corda che ne permetteva la presa sicura in una mano (fig.2), oppure la possibilità di assicurarlo a sostegni verticali quan-do era troppo grande/pesante o quando si necessitava di duemani libere per la toeletta (fig. 3). Si tratta di un retaggio ditempi più antichi, quando il suo uso principale era quello dirimanere appeso allo sciamano durante la danza e la trance, eche si può riconoscere nei gancetti decentrati degli antichi spec-chi di area mancese e coreana (catt. 22-23). Un manico da presasarebbe risultato superfluo, addirittura ingombrante. Tanto radi-cata era l’abitudine a questa forma nella mente cinese che, puressendo attestati specchi con manico già in epoca Han (206 a.C.
1 Si vedano a questo proposito Hirth (1906, pp. 216-217) e il ritrovamento del periodo Han Occidentale (206 a.C. - 8 d.C.) segnalato in Hunan (1984, p. 793).2 Caius Plinius Secundus (23-79), Naturalis Historia, Liber 34, § 160.3 Zuozhuan (Commentario di Zuo), cronache dell’anno 21 del duca Zhuang di Lu. Riprodotto in Legge (1872, p. 101).4 Si rimanda ai contributi di Rubinson, Davis-Kimball, Chugunov, eccetera in Aruz et al. (2006).5 Si vedano in proposito gli studi di Maenchen-Helfen (1973) e Raschke (1978).
RIFLESSI 012-045:099��17-11-2012��11:47��Pagina�14
- 220 d.C.; Chêng 1957, tav. 62/2) e di nuovo molto più tardi inepoca Song (960-1279), essi vennero sempre trattati come curio-sità esotiche o capricci di un bronzista eccentrico, e non venne-ro mai prodotti su larga scala.La forma rotonda aveva anche una ragion d’essere tecnica fon-damentale, ovvero la possibilità di conferire alla faccia rifletten-te una superficie convessa uniforme attraverso la quale i cinesicapirono presto di poter riflettere un’immagine più grande suuna superficie specchiante di diametro ridotto, secondo il princi-pio ottico della lente convergente. Lo stesso espediente è diffi-cilmente realizzabile quando lo specchio ha i contorni sagomatied è praticamente impossibile in presenza di angoli. Per questo,a parte certi esemplari quadrati di epoca preimperiale e ripresidai Tang (618-907), oppure le forme lobate Tang e qualche spe-rimentazione successiva, la forma prediletta per lo specchio datoeletta è sempre stata rotonda. Ma la ragione profonda eraanche di tipo simbolico: rotondo è il sole, rotonda la luna piena,rotonda la volta celeste secondo le più antiche concezionicosmologiche cinesi; nella forma circolare è anche più faciledisporre in maniera armonica i vari elementi decorativi e figura-tivi del verso, talvolta ordinati in vere e proprie rappresentazio-ni dell’universo.
Lo specchio daoistaGli studiosi si sono sbizzarriti nel cercare parallelismi tra glispecchi e il Cielo, soprattutto per quanto riguarda le più impor-tanti produzioni della Cina preimperiale (per es. cat. 15) e Han.Camman (1955, pp. 43-44), per esempio, li paragona ai dischilavorati di giada con foro centrale, Bulling (1955) alla trasposi-zione bidimensionale di parasoli e baldacchini rituali di stoffa:tutti questi oggetti erano simboli di alto rango collegati tradizio-nalmente all’ambito celeste e ricoprivano un ruolo importantenei riti funebri. Il palese assorbimento dello specchio nelle spe-culazioni cosmologiche ed escatologiche cinesi giunge a com-pimento nella prima epoca Han, quando le necessità politichecomportano una rivisitazione e omologazione dei simboli edelle credenze delle diverse culture che confluivano nel nuovo
15
2. Particolare di un pannello di pietra dipinta, 120 × 71 cm,dalla tomba di Yang Hui, Jingbianxian (Shaanxi), circa 736
3. Particolare del dipinto su seta Consigli dell’istitutrice per le dame di corte,copia Tang (?) da Gu Kaizhi (circa 344-406). Londra, The British Museum
RIFLESSI 012-045:099��17-11-2012��11:47��Pagina�15
16
impero. Emblema di questa riorganizzazione sono gli specchicosiddetti “TLV” (cat. 37), ma quasi tutte le nuove tipologie delperiodo si prestano a interpretazioni di tipo “cosmico”. Le raf-figurazioni sul retro dello specchio ne fanno un simbolo spazio-temporale potente, un vero e proprio intermediario tra l’uomo eil cosmo, collegato probabilmente a pratiche divinatorie.Da questo momento in poi lo specchio diventa appannaggio pre-ferenziale del Daoismo e delle credenze – anche popolari – a essocollegate. Si può anzi affermare che la storia dello specchio siaintimamente legata all’evoluzione/involuzione di questa correntedi pensiero filosofico-religioso più di altri oggetti artistici chegodevano di una diffusione paragonabile tra le classi abbienti6.L’identificazione dello specchio con il Daoismo conosce il suoculmine nella seconda parte della dinastia Han, quando questocomincia a conformarsi come religione organizzata anche peremulazione e in concorrenza con il Buddhismo, che proprio neiprimi secoli dell’era volgare aveva iniziato ad attecchire sulsuolo cinese. Ma anche se alcune immagini di Buddha hannotrovato sporadicamente spazio sul retro degli specchi di quelperiodo, peraltro sempre in contesti figurativi daoisti, i cosmo-grammi e le divinità più rappresentati – per non parlare delleiscrizioni che li accompagnano – sono indubbiamente di stampodaoista7. Anche più tardi, quando con i Tang i riferimenti alDaoismo sembrano attenuarsi e infine (dai Song in poi) simescolano sempre più a simbologie augurali di stampo popola-re, le decorazioni dello specchio sono riconducibili in maggiormisura al Daoismo piuttosto che al Buddhismo o alConfucianesimo. Il retaggio autoctono si è tramandato sul retrodegli specchi più che in altre manifestazioni artistiche e questospiega a sua volta il perché della sopravvivenza dello specchiocome elemento di conservatorismo nella cultura cinese.D’altronde, l’alone magico dell’arte dei metalli che caratterizza-va la Cina preimperiale aveva trovato uno sbocco naturale nel-l’alchimia daoista, e i daoisti stessi si erano fatti portatori deisegreti del bronzista ammantandoli di valenze esoteriche8. Lospecchio, oggetto già culturalmente carico di forze arcane, si pre-stava perfettamente a simboleggiare il mistero dell’alchimia e a
divenire il supporto di raffigurazioni sacre. I daoisti utilizzavanoqueste raffigurazioni come sussidui rituali per pratiche di medi-tazione, visualizzazione e viaggi astrali (“percorrere il vuoto”secondo il loro lessico; cfr. Schafer 1977), in maniera paragona-bile all’utilizzo dei maṇḍala nel Buddhismo. Lo specchio rappre-senta a tutti gli effetti un microcosmo del macrocosmo, è un dia-gramma tipicamente cinese che procede parallelamente – e forseprecede – ad analoghe pratiche buddhiste come quelle evidenzia-te, per esempio, da cat. 117. Con l’aiuto dello specchio, l’adeptodaoista poteva richiamare visivamente dentro di sé le divinità ouscire di sé per incontrarle; immaginava di effettuare dei veri epropri viaggi interstellari che, come acutamente enunciato daSchafer (1976), corrispondevano a viaggi intercellulari nell’uni-verso del proprio corpo grazie a un sistema in cui macrocosmo emicrocosmo, estremamente grande ed estremamente piccolo,alchimia esterna e alchimia interna, sostanzialmente coincidono.Gli specchi, insieme alle spade, erano paramenti rituali impre-scindibili degli altari daoisti (Cahill 1986, p. 63) e adempivano afunzioni apotropaiche (Little, Eichman 2000, pp. 344, 347).
Ricettacoli di luceLe credenze cinesi sulle proprietà magiche degli specchi sonoinnumerevoli e derivano fondamentalmente dalla sua capacità didivenire ricettacolo di luce, di poter carpire l’energia yang del solee yin della luna per poi rimetterla, quando necessario, al suo pos-sessore. Lo stesso atto creativo della fusione degli specchi è spes-so ammantato di allegorie daoiste e di ritualismi tesi a garantirneil pieno successo. Molte iscrizioni sugli specchi recano ad esem-pio la datazione del giorno bingwu, che, secondo il tradizionalesistema di computo sessagesimale del tempo carico di corrispon-denze cosmologiche, rappresenta il culmine dell’elemento delfuoco nei “Cinque Agenti” (wuxing) o elementi costitutivi del-l’universo: fuoco, terra, metallo, acqua, legno. Indipendentementedal fatto che un tale mese di tale anno potesse vantare o meno ungiorno chiamato bingwu, ribadire l’azione del fuoco nel momen-to della presunta fusione dello specchio doveva essere sicuramen-te garanzia di qualità eccelsa (non solo riflettente) del manufatto9.
6 Si veda a questo proposito Cahill (1986 e 1994).7 I daoisti avevano fatto delle concezioni cosmologiche ereditate dalla Cina preimperiale e codificate nel Primo Impero uno dei fondamenti intellettuali della loro religione.8 Sotto i Song Meridionali (1127-1279), ad esempio, troviamo ancora alcuni maestri fonditori di specchi che si definiscono daoisti (cfr. Wang Shilun, Wang Mu 2006, fig. 165).9 Si veda ad esempio l’iscrizione di cat. 40: non c’era un giorno bingwu in quel mese di quell’anno.
RIFLESSI 012-045:099��17-11-2012��11:47��Pagina�16
Il giorno migliore per la fusione di uno specchio era considerato ilsolstizio d’estate, a mezzogiorno, quando il principio yang e l’ele-mento fuoco erano al culmine. Famosa in questo senso è una leg-genda relativa alla creazione di uno specchio shuixin (“cuore d’ac-qua”) per il compleanno dell’imperatore Tang Xuanzong (r. 712-756). La fusione aveva avuto luogo su una barca a Yangzhou, inmezzo al fiume, e al termine dell’operazione un drago si era innal-zato dalle acque a suggellarne la piena riuscita: lo specchio eraperciò dotato delle essenze giuste, era carico di potere magico(Sun Kerang 1998). Fu infatti grazie a questo specchio che, secon-do la stessa fonte, l’imperatore riuscì a porre fine a un periodo ditremenda siccità: il drago raffigurato sul verso (cat. 89) si materia-lizzò e, nella migliore tradizione estremo-orientale, divenne por-tatore della pioggia benefica che fa crescere le messi10.Il parallelismo specchio-sole-quintessenza di yang è ricco diesempi nella letteratura cinese, e sono peraltro attestati specchiustori concavi per accendere il fuoco, in particolare i fuochisacri per i rituali di Stato (Hirth 1906, p. 227; O’Donoghue1990, pp. 80-83)11. Ancora più ricorrente, tuttavia, è il parago-ne del disco luminescente di bronzo con la luce fredda dellaluna, e quindi con l’elemento acqua e con la massima espressio-ne del principio “femminile” yin, complementare al “maschile”yang. Si tratta per lo più della luna ispiratrice dei poeti e dun-que di un topos ricorrente per esprimere nostalgia, struggimen-to, bellezza del volto femminile imbellettato, eccetera (cfr.iscrizione cat. 60).Ma la simbologia profonda che lega lo specchio alla luna è anco-ra una volta retaggio di credenze derivate dal Daoismo, legate inparticolare alla cosiddetta “rugiada lunare” di cui si nutrono gliimmortali yuren (“uomini piuma”; Little, Eichman 2000, p. 378).Secondo le fonti, certi specchi potevano essere lasciati all’apertodurante la notte per raccogliere la preziosa “acqua di luna” dalsatellite, ovvero la rugiada notturna. Nell’era Kaiyuan (713-742),durante una ricorrenza mensile in onore delle dame di corte – evi-dente richiamo al principio femminile – si esponevano gli spec-chi alla luna e li si tamburellavano12. Come ulteriore binomioconcettuale rispetto al sole, sembra che il momento più opportu-
no per fondere questo tipo di specchi fosse la mezzanotte del sol-stizio d’inverno, quando l’essenza yin dell’acqua era al suo cul-mine. Alcuni studiosi hanno voluto distinguere specchi “solari”rotondi da specchi “lunari” quadrati (cfr. Pelliot 1920-1921, p.51), che con i loro bordi rialzati sul retro sarebbero stati eccellen-ti contenitori di liquidi (cat. 12). Punto focale di argomentazioneè una delle più diffuse concezioni cosmologiche, secondo cui ilcielo rotondo è legato al principio solare yang mentre la terraquadrata si associa al principio lunare yin, ma tale interpretazio-ne non ha trovato riscontri univoci13. Forse converrebbe conside-rare tutti gli specchi un po’ yang, perché nascono col fuoco, e unpo’ yin, perché mantengono una fredda luce nascosta come i cri-stalli che (secondo alcune credenze) illuminano la luna dall’inter-no: la doppia faccia si prestava in ogni caso egregiamente a riflet-tere la luce da un lato e a raccogliere la rugiada dall’altro.Merita ancora menzione una simbologia minore collegata allaluce emessa dallo specchio, quella del lampo. La divinità daoi-sta Dianmu (“Madre del Fulmine”) viene spesso rappresentatacon in mano degli specchi che emettono saette (Little, Eichman2000, p. 239).In virtù della loro luce intrinseca, gli specchi venivano ancheposti nelle tombe per illuminare la vita post mortem del defun-to. Una funzione precipua degli specchi decorati con disegnicosmologici doveva essere quella di costituire una mappa del-l’universo e dello scorrere del tempo per l’orientamento deldefunto (Loewe 1979, pp. 60-85). In alcuni contesti funerari,invero, la collocazione degli specchi in scatole da toletta assie-me ad altri oggetti non suggerisce un’interpretazione altra daquella della necessità del morto di portare quanto sarebbe ser-vito alla cura del proprio aspetto anche nell’aldilà. Ma più spes-so la loro posizione è ravvicinata al defunto, accanto alla testao sul petto, a indicare un rapporto intimo e privilegiato.Sicuramente, oltre a fungere da “lampada” nelle tenebre delsepolcro, lo specchio doveva possedere proprietà apotropaichee demonifughe (sulle quali torneremo) per proteggere il cada-vere da influssi nefasti. In epoca Han si sospendeva talvolta unospecchio all’interno della bara, dentro un apposito recipiente
17
10 Taiping guangji, vol. 231, pp. 1771-1172.11 Un raro specchio ustorio (yangsui) di epoca Tang è illustrato in Du Naisong (2006, tav. 169).12 Pei wen yun fu (Deposito in rima di frasi stimate), compilato da Zhang Yushu et al. nel 1711, cap. 86, p. 7. Riportato in Hirth 1906, p. 228.13 I riferimenti letterari si prestano infatti a diverse interpretazioni, e non è detto che il recipiente per la rugiada – chiamato nelle fonti fangzhu – fosse davvero uno specchio. Cfr.Wang 2005, n. 38; Schulten 2005, n. 34.
RIFLESSI 012-045:099��17-11-2012��11:47��Pagina�17
18
dotato di un’apertura verso il basso14. Talaltra le virtù protettivee illuminanti erano estese all’intera camera funeraria: un gran-de specchio veniva inglobato o appeso, recto in giù, al centrodel soffitto. Tale espediente fu largamente praticato ad esempionelle tombe di epoca Liao (907-1125), seppur arricchito di sim-bologie cosmologiche e di riferimenti al Buddhismo (cfr.Steinhardt 1997, pp. 342-350; Schulten 2005).Le fonti parlano anche di specchi appesi negli edifici dei vivi,utilizzati sia allo scopo pratico di gettare luce riflessa in ambien-ti bui, sia per scopi rituali e legati alla superstizione. Alla base diquesti ultimi c’era l’opinione radicata che lo specchio riflettessesoltanto la verità delle cose e che quindi gli spiriti malvagi, cela-ti sotto false spoglie, avrebbero mostrato il vero volto rifletten-dosi in esso: la visione del proprio orribile aspetto, reso final-mente palese ai loro stessi occhi, sarebbe bastata a farli fuggire.Nel testo Baopuzi (Il Maestro che abbraccia la Semplicità) diGe Hong (284-364) si racconta che gli adepti daoisti, quandoviaggiavano per le montagne, portavano uno specchio di bronzosospeso dietro la schiena per difendersi dagli attacchi dei demo-ni15. In buona sostanza, lo specchio era un perfetto e potente tali-smano, da portare sul proprio corpo sia in vita che in morte. Inquesta valenza magica ravvisiamo un ulteriore rimando a cre-denze di tipo sciamanico, ereditate dal Daoismo religioso e daiculti popolari, che implicavano il controllo delle forze divine esoprannaturali attraverso lo specchio. Si riteneva infatti che essopotesse proteggere il guerriero nella battaglia, e la presenza diuno specchio cucito all’altezza del petto sulle armature degliultimi sovrani mancesi non è che un residuo di tali credenze (fig.4). Esso diviene inoltre metafora di potere in molti riferimentileggendari, come ad esempio i 12 specchi – uno per ogni mesedell’anno – fusi dall’Imperatore Giallo, capostipite della civiltàcinese16. Merita menzione, a questo proposito, anche lo specchioHan, “che dissipa la guerra”, simbolo dell’età di pace inaugura-ta dall’impero centralizzato, che trova un’eco nell’iscrizionedell’esemplare cat. 59 riferita ai Sui (581-618; Chavannes 1906,p. 102; Soper 1967, pp. 56-58).Poiché lo specchio “dice sempre la verità” ed è espressione di unpotere benefico, è naturale che gli vengano attribuite proprietà
14 Brashier (1995) ha avanzato l’ipotesi che in epoca Han lo scopo di tale pratica fosse quella di augurare longevità al defunto, ma a nostro parere questo aspetto simbolico dellospecchio non esclude le funzioni vere e proprie che gli venivano attribuite.15 Si veda il brano tradotto in Ware (1966, p. 281).16 Huangdi Neizhuan (Biografia segreta dell’Imperatore Giallo), riprodotto in Takeuchi (1911, p. 311) e Weitz (2002, p. 115).
4. Divisa da parata militare, XIX secolo. Città del Vaticano, Musei Vaticani,Museo Missionario Etnologico
RIFLESSI 012-045:099��17-11-2012��11:47��Pagina�18
profetiche e mantiche. L’impossibilità di vedere il proprio rifles-so, ad esempio, è considerata presagio di morte imminente (Dien2007, p. 261). Esso serve certamente per guardare nel futuro, masoprattutto per riguardare al passato e riflettere su pregi e difettidei predecessori. Lo specchio come riflesso della storia è quindiun altro tropo importante, sfruttato a piene mani soprattutto dachi voleva mettere in guardia i sovrani del presente17. Una delleraccolte storiografiche più importanti della Cina, pubblicata nel1084 per ordine imperiale, porta il significativo titolo di ZizhiTongjian, “Specchio Generale per servire il Governo”, e il jian(lo specchio per ispezionare) finisce qui per identificarsi con uncerto tipo di cronaca storica, dagli intenti edificanti e – per unavolta almeno – imbevuta di conservatorismo confuciano inveceche di misticismo daoista. Si pensi, per analogia, ai vari speculamedievali e rinascimentali in Occidente.Se lo specchio riflette la storia, riflette prima ancora l’animoumano. Aforismi che lo adottano come metafora di purezza e diintelligenza abbondano fin dal periodo preimperiale. Al signifi-cato psicologico (lo specchio come strumento di autoanalisi) siaggiunge quello filosofico. Si ricordi ad esempio la massima delZhuangzi (cap. 13), secondo cui “La mente del saggio è perfet-tamente calma, è come uno specchio che riflette il cielo e la terrae tutti gli esseri”18.Strettamente collegata a questa metafora è un’altra virtù attribui-ta allo specchio: quella della trasparenza, sia di se stesso siadella realtà che rispecchia.
Trasparenza e purezzaIn Cina furono prodotti, almeno dall’epoca Han, degli specchichiamati oggi touming jing, “specchi trasparenti”, la cui facciariflettente esposta a una fonte di luce diretta ha la proprietà diproiettare su una superficie piana lo stesso motivo e le stesseiscrizioni che si trovano sul retro del manufatto. Si tratta per lopiù di rari specchi del tipo “a motivo raggiato” come l’esempla-re cat. 31, e la tecnica straordinaria che permetteva tale fenome-no di rifrazione non è ancora stata spiegata con chiarezza: sulrecto, infatti, non è percepibile nessun disegno, né alla vista néal tatto. Non abbiamo qui spazio a sufficienza per addentrarci
nell’argomento; basti dire che si tratta probabilmente di unfenomeno legato alle differenti velocità di raffreddamento tra leparti più spesse e quelle più sottili del rilievo sul verso dopo lafusione che provocavano impercettibili ondulazioni regolarisulla superficie opposta, ondulazioni che costituiscono diversiangoli di rifrazione della luce19. Se teniamo a mente le valenzemagiche e simboliche attribuite agli specchi, non sarà difficileimmaginarsi l’effetto che tali espedienti potevano produrrenella Cina tradizionale: veder realizzata oggettivamente lamagia inspiegabile del riflesso, le proprietà rivelatrici e traspa-renti dell’oggetto, quella “luce propria” che si mescola alla lucedel sole per produrre effetti meravigliosi. Il criptico riferimen-to poetico al “fiore di castagna d’acqua” nell’iscrizione di cat.62 è ispirato a questo tipo di specchio magico illuminato dalsole; l’accostamento al riflesso della luna dello stagno ribadisceinvece quel dualismo sole/luna di cui abbiamo già sottolineatol’importanza.Non è un caso che buona parte degli specchi ritrovati nelletombe giapponesi dei periodi tardo Yayoi/primo Kofun (III-IVsecolo) e dei primi esemplari prodotti in Giappone appartenga-no alla tipologia “a motivo raggiato” (cat. 56). Come deducia-mo dalla quantità e qualità dei ritrovamenti, lo specchio ingenerale era uno dei simboli di potere più importante per laclasse dominante del periodo, e specchi dalle proprietà prodi-giose di questo genere, provenienti dal continente, non dovette-ro passare inosservati: se si aggiunge che il motivo raggiatopoteva essere intuitivamente associato alla simbologia solare,lo specchio diventava automaticamente il segno del favore delladea Amaterasu per la sua discendenza di re-sciamani giappone-si (Edwards 1999).Vale la pena ricordare per inciso che furono proprio gli “spec-chi magici” ad attirare per la prima volta l’attenzionedell’Occidente sugli specchi di bronzo dell’Asia orientale nelXIX secolo. Sull’onda del positivismo ottocentesco, si era tut-tavia troppo interessati a spiegare scientificamente il fenomenocon l’intento di mostrare la superiorità occidentale rispetto allecredulità del resto del mondo per rendersi conto dell’alto valo-re – tecnologico, artistico, culturale – dello specchio estremo-
19
17 Si veda a questo proposito l’interessante articolo di Wang (1994).18 Riportato in Hall 1935, p. 184.19 Sicuramente interveniva a posteriori una speciale tecnica di politura della superficie riflettente che non cancellava queste tracce ma semmai le esaltava. Per alcune spiegazionipossibili del fenomeno si rimanda a Needham (1962-1971, parte I, pp. 90 sgg.) e Shanghai (2005, pp. 144-145).
RIFLESSI 012-045:099��17-11-2012��11:47��Pagina�19
orientale, il cui primo studio davvero scientifico risale a pocopiù di un secolo fa20.Per quanto riguarda le virtù di trasparenza dello specchio tra-smesse alla realtà che esso riflette, è famoso a questo propositoil leggendario specchio “che schiarisce il fiele”, posseduto dalPrimo Augusto Imperatore dei Qin (r. 247-210 a.C.) e descrittocome uno strumento radioscopico ante litteram. Si narra che nelPalazzo Afang fosse appeso un grande specchio rettangolare attoa riflettere una persona nella sua interezza e a esplorarne i“Cinque Visceri” per diagnosticare malattie e scompensi psico-fisici. Nella migliore tradizione della letteratura denigratoria suQin Shi Huangdi, dipinto immancabilmente come un sovranocrudele e spietato, l’uso principale dello specchio era quello diispezionare la bile e il cuore delle sue concubine, per scoprirequelle che covavano rancori o infedeltà e metterle a morte21.Superstizioni a parte, questo e altri riferimenti letterari suggeri-vano l’esistenza di grandi specchi rettangolari che nel 1979hanno trovato conferma dalle scoperte archeologiche (De Caro,Scarpari 2010, p. 272; fig. 5). Questo esemplare Han, insieme auno più antico dello Stato di Qi (III secolo a.C.), dotato di treanelli mobili lungo il bordo (Qi Wentao 1972; Li 1985, pp. 309-310), sono eccezioni notevoli alla forma usuale dello specchiocinese: erano in questi casi le loro stesse dimensioni a renderesuperflua la presa centrale.Le virtù “radiologiche” degli specchi sono accostabili ad altreproprietà magiche di tipo medicamentoso che sono state loroattribuite fino a tempi recenti. L’ispezione del paziente con unospecchio era una pratica adottata da molti dottori per determi-nare le cause della malattia, mentre talvolta se ne sfruttavano lepresunte proprietà tumaturgiche per contatto, passandolo sullaparte malata. Alcune ricette mediche richiedevano espressa-mente come ingrediente la polvere macinata di specchio: piùantico esso era più la medicina sarebbe stata efficace. Fino aepoche recenti, si pensava ad esempio che i preparati a base dispeculum fossero in grado di regolare il ciclo mestruale (Hirth
20
20 Della vasta letteratura sull’argomento, si ricordino per esempio David (1836) e Bertin (1881). Hirth (1906, pp. 211-212), pur accennando alla questione, concentra per primol’attenzione su altri tipi e su altri significati dello specchio cinese.21 “Xijing zaji (Miscellanea della Capitale Occidentale)”, attribuito a Liu Xin (50 a.C. - 23 d.C.), in Han Wei Liuchao biji xiaoshuo daguan (Grande compendio di annotazioni enarrazioni degli Han, dei Wei e delle Sei Dinastie), Guji chubanshe, Shanghai 1999, vol. III, p. 97.
5. Retro di uno specchio di bronzo rettangolare, 115 × 57,7 cm,dalla tomba del Re di Qi, Zibo (Shandong), dinastia Han
RIFLESSI 012-045:099��17-11-2012��11:47��Pagina�20
1906, pp. 231-232). Anche in questo caso le proprietà magichedello specchio cinese e quelle degli specchi sciamanicidell’Asia settentrionale si sovrappongono e tradiscono una radi-ce comune. La differenza sostanziale è che le speculazioni daoi-ste e le concettualizzazioni del letterato confuciano hanno nobi-litato e sistematizzato le credenze animistico-sciamaniche nelcorso della lunga storia cinese. Tali convinzioni erano peròsempre pronte a riemergere a livello popolare.La natura sacra dello specchio determina, come in Occidente,grande sfortuna per una sua eventuale rottura. In Cina la sventu-ra è limitata però all’ambito matrimoniale/sentimentale: la frat-tura dello specchio è metafora della separazione della coppia(vedovanza inclusa), mentre “ricongiungere lo specchio” èun’espressione tipica degli amanti ritrovati o convolati a nuovenozze22. Come testimoniano i numerosi specchi “nuziali” Tangpresenti in catalogo, si usava offrire uno specchio in dono allanovella sposa che la accompagnasse come talismano durante lacerimonia e per sospenderlo poi a scopi protettivi e auguralinella camera nuziale.A differenza dell’Occidente, in Cina non si sottolineano gli
aspetti narcisistici dello specchio se non per ironia o a sostegnodi ulteriori simbologie. Si dice per esempio che il fagiano,messo di fronte allo specchio, cominci a danzare inebriato dellapropria bellezza fino a stramazzare (cfr. iscrizione cat. 62).Paragoni e parallelismi potrebbero continuare ad libitum, mauscirebbero dagli scopi circoscritti di questo breve saggio.Abbiamo dovuto sorvolare ad esempio sull’importante apportodel Buddhismo alla simbologia e agli usi rituali dello specchiocinese dai tardi Tang in poi23. In tale contesto predominano sicu-ramente metafore come il vuoto, l’alone (lunare) che circondagli esseri superiori, il centro del maṇḍala, la “mente delBuddha”, eccetera (cfr. Sen 1999 e Shen 2006). Lo specchioserve anche a esprimere pensieri sottili in ambito Chan (giap.Zen): “Il corpo è l’albero della Bodhi (Illuminazione), la menteè come il supporto di uno specchio lucente. Occorre semprelustrarlo con diligenza perché la polvere non si depositi”. A que-sta quartina composta dal monaco Shenxiu (607?-706) rispon-deva il novizio Huineng (638-713): “La Bodhi in sé non è unalbero, e lo specchio lucente è senza supporto. Se fondamental-mente niente esiste, dove potrà mai depositarsi la polvere?”24.
21
22 L’archeologia riporta dei casi di deliberata rottura dello specchio in due metà, ritrovate nelle tombe separate di due coniugi (Peng Shifan, Tang Changpu 1980, pp. 28-29). Cisono anche indicazioni di tipologie distinte preferite dai due sessi almeno a partire dall’epoca Han (Chou 2000, p. 13).23 Alcune informazioni possono essere tratte dalle schede di specchi a soggetto buddhista in catalogo.24 Liuzu tanjing (Sūtra della Piattaforma del Sesto Patriarca), Taishō, vol. 48, pp. 348b, 349a. Riportato in Ch’en 1973, p. 355 e Cahill 2005, p. 32.
RIFLESSI 012-045:099��17-11-2012��11:47��Pagina�21
Bagua: “Otto Trigrammi”. Sono gli otto simbolidivinatori di base dai quali derivano i 64 esagrammidello Yijing, il Classico dei Mutamenti, erappresentano i cicli del divenire. Ogni trigramma èformato da una delle otto possibili combinazioni di trelinee, intere o spezzate, che simboleggiano idealmentele manifestazioni base della mescolanza tra i dueprincipi yang* e yin*: cielo e terra, vento e tuono,acqua e fuoco, montagna e lago. Sono raggruppativisivamente, molto spesso, attorno al simbolo cosmicodel Taiji, e rappresentano anche i quattro punticardinali e le quattro posizioni intermedie.
Baihu: “Tigre Bianca”. Nella serie dei “Quattro Spiri-ti” (sishen*), è la creatura che presiede all’Occidente eall’autunno, ed è associata al Metallo nella serie deicinque elementi (wuxing*). È considerata inoltre,assieme all’unicorno (qilin*), la più importante dellecreature pelose nella suddivisione degli esseri viventiin squamati, pelosi, piumati, corazzati e ignudi.
Bixie: “Dissipatore del Male”, è il nome attribuitodalle Cronache degli Han (Han Shu) a una creaturasimile al cervo, dotato di due corna, le statue guardianedel quale venivano poste insieme a quelle del tianlu*lungo la “Via degli Spiriti” che conduce alle sepoltureimportanti. Le sue caratteristiche iconografiche nonsono chiaramente definite e sono mutate nel corso deltempo, finendo per assumere quelle di una chimerabicorne dai tratti leonini.
Chi Songzi: “Maestro del Pino Rosso”, leggendarioeremita daoista pre Han che avrebbe ottenuto l’immor-talità attraverso pratiche di medicina esoterica; come“spirito immortale” sarebbe poi divenuto uno degli“spiriti tutori dei Sovrani umani”. Nelle agiografiedaoiste post Han è anche considerato come “Signoredella pioggia” al servizio di Shennong*.
Chokkomon: lett. “motivo retta-arco”. Motivo deco-rativo tipicamente giapponese dalle presunte proprietàmagiche: lo si ritrova dipinto o inciso su oggetti e sar-cofagi durante il periodo Kofun (III-VI secolo) nellaregione del Kansai. È composto da linee che si incro-ciano in una X, delimitando zone triangolari attraver-sate da linee arcuate. Non è noto cosa rappresentasse,ma probabilmente aveva qualche relazione con le sca-pole di cervo o i carapaci di tartaruga usati nella divi-nazione.
Dao: la “Via”, il “Sentiero”, è il concetto filosoficofondamentale e fondante del Daoismo. Rappresenta ilprincipio ineffabile preesistente all’Universo, la quieteperfetta, l’origine e l’impulso di tutti gli esseri chesfugge a ogni definizione: “la Via che come tale puòessere presa, Via eterna non è / Il nome che come talepuò essere preso, nome eterno non è” (Daodejing - IlClassico della Via e della Virtù, 1).
Dizhi: “Rami Terrestri”, una serie di 12 caratteri cheindicano le 12 divisioni dell’equatore celeste, ovvero lesezioni del cielo (stazioni) attraverso le quali passa ilpianeta Giove nella sua orbita di 12 anni attorno alsole. Questi simboli vennero utilizzati dai cinesi persegnalare non soltanto le direzioni dello spazio e il pas-sare degli anni, ma anche i mesi dell’anno, le 12 “dop-pie ore” che costituiscono una giornata. I caratteri dei“Rami”, in combinazione con quelli dei 10 TronchiCelesti (tiangan), formano il ciclo sessagesimale gan-zhi, sistema attraverso il quale tradizionalmente in Cinasi misurava lo scorrere del tempo.
Dongwanggong/Dongwangfu: “Duca/Re Padredell’Est”, divinità daoista che tiene il registro di tuttigli immortali e dimora nella mitica isola di Penglai nelMare Orientale. Controparte maschile di Xiwangmu* eappartenente probabilmente a una tradizione più tarda,divenne un motivo comune nell’immaginario religiosoe artistico della tarda epoca Han.
E-kagami: “Specchio col manico”. Gli e-kagami fan-no la loro comparsa nel periodo Muromachi (1336-1573) e raggiungono un’ampia diffusione tra la bor-ghesia del periodo Edo (1603-1868). Dapprima ilmanico è lungo e stretto, per poi divenire più largo ecorto. Con l’inserzione del manico, lo specchio nonnecessita più per essere manovrato del passafilo centra-le che così scompare, permettendo una maggiore liber-tà nella decorazione figurativa.
Fenghuang: la fenice cinese è una creatura propiziache racchiude in sé le caratteristiche di diversi animali.Nella sua forma più comune appare come un bell’uc-cello dal lungo collo e dal ricco piumaggio. Le descri-zioni testuali si sbizzarriscono nel trovare riferimenti alcollo della tartaruga, al becco della rondine, al corpodel drago, eccetera. Emblema per eccellenza di bellez-za e fortuna, la fenice è immortale, si nutre di bambù esi posa soltanto sul wutong, un albero della famigliadelle Sterculiaceae.
Hakudo: lett. “rame bianco” o cupronichel. Lega dirame e nichel con presenza di stagno; è uno deimateriali maggiormente utilizzati per gli specchigiapponesi.
Horaikyo: tipologia di specchio i cui elementi decora-tivi si rifanno all’iconografia dello Horaisan*. Essisono: una coppia di gru, la tartaruga cosmica, mino-game*, rocce (spesso i tre picchi), le tre piante pino-susino-bambù e altri fiori dal significato benaugurale.
Horaisan: la montagna mitica rappresentata con trepicchi che, secondo la tradizione cinese, si trova nellaCina orientale e costituisce la dimora delle divinità chequi portarono l’elisir dell’immortalità. Tema iconogra-fico diffuso nell’arte giapponese.
Houtian: “Cielo Posteriore” è il nome dell’arrangia-mento degli Otto Trigrammi (bagua*) nella realtàfenomenica, rappresenta il diagramma cosmico creatoin seguito al manifestarsi dei principi complementariyin* e yang* nel mondo. Partendo da nord si susseguo-no in senso orario i trigrammi kan (acqua), gen (mon-tagna), zhen (tuono), xun (vento), li (fuoco), kun (ter-ra), dui (lago), qian (cielo).
Hu: termine generico per tutti i tipi di recipienti pan-ciuti con collo alto atti a contenere liquidi; di solitoindica un vaso rituale per il vino di cereali, a voltemunito di coperchio e di una coppia di anelli mobilisulla spalla, la cui origine risale alla fase Anyang (cir-ca 1300-1046 a.C.) del periodo Shang.
Laozi: “Vecchio Maestro”, il semileggendario fonda-tore del Daoismo filosofico vissuto tra il VI e il V seco-lo a.C. e presunto autore del Daodejing, il Classico del-la Via e della Virtù, testo fondamentale della dottrinadaoista. In molte scuole del Daoismo religioso vieneassunto come massima divinità del pantheon e parago-nato al dao* stesso.
Liubo: gioco molto amato dalle classi alte del periodoHan, spesso raffigurato sulle pareti delle tombe e suglispecchi. Il set si componeva di una tavola da gioco,pedoni e sei bacchette: queste venivano gettate perdeterminare il movimento dei pedoni, ma le preciseregole del gioco non si sono tramandate. Lo scopodoveva essere l’annientamento dell’avversario e/o laconquista del centro della “scacchiera”, ed era proba-bilmente arricchito di valenze divinatorie basate sullecredenze cosmologiche in voga a quel tempo.
Luan: uccelli mitici appartenenti alla famiglia dellefenici; simboleggiano grado elevato e alto appannag-gio, ma sono soprattutto un topos poetico e iconografi-co per esprimere il legame di coppia. Vuole infatti laleggenda che il maschio e la femmina, se separati, pos-sano morire di dolore vedendo la propria immagineriflessa, che riporta loro alla mente quella dell’amato/acon cui non si possono ricongiungere.
Minogame: la tartaruga (kame) dalla folta coda è unavariante giapponese della tartaruga cinese, simbolo dilongevità. Mino, che significa letteralmente “imper-meabile di paglia”, rappresenta le alghe che cresconosul carapace delle vecchie tartarughe: sono questemorbide alghe che vengono confuse con la coda delrettile.
Qilin: l’unicorno cinese è una creatura ibrida descrittanei testi come avente il corpo del cervo, la coda delbue, gli zoccoli del cavallo e un singolo corno carnososulla fronte. Nell’iconografia assume tuttavia aspettimolto diversi a seconda dei contesti e delle epoche. Sitratta di un animale mitologico di buon auspicio, con-
232
Glossario
RIFLESSI 228-240:099��17-11-2012��11:58��Pagina�232
233
traddistinto dalla benevolenza verso ogni essere viven-te, la cui comparsa coincide di solito con la nascita diun grande saggio.
Qinglong: “Drago Verde (o Blu)”. Nella serie dei“Quattro Spiriti” (sishen*), è la creatura che presiedeall’Oriente e alla primavera, ed è associato al Legnonella serie dei cinque elementi (wuxing*). Il drago èinoltre la più importante delle creature squamate nellasuddivisione degli esseri viventi in squamati, pelosi,piumati, corazzati e ignudi.
Ruishou: “Animale di buon auspicio”, è un terminegenerico utilizzato in Cina per indicare quelle creaturefantastiche per le quali non si riesce a trovare un termi-ne specifico e che sono portatrici una generica valenzaaugurale.
Ruyi: lett. “a piacimento”. Termine che designa unsimbolo propiziatorio con l’estremità lobata e il mani-co curvo, spesso definito come “scettro che esaudiscetutti i desideri”. L’origine di questa forma è forse daricercarsi in una trasposizione stilizzata del “fungo del-l’immortalità” lingzhi; la forma della “testa” rimandaanche al generico senso benaugurale della nuvola.
Shengxiao: traducibili come “Segni Ciclici” di valen-za astrologica, legati all’anno di nascita dell’individuoe corrispondenti a 12 posizioni del compasso. Già epo-ca Han i 12 Rami Terrestri (dizhi*) potevano essererappresentati da altrettanti animali simbolici, noti erro-neamente in Occidente col nome collettivo di “zodiacocinese”: Topo (nord), Bue, Tigre, Coniglio (est), Dra-go, Serpente, Cavallo (sud), Pecora, Scimmia, Gallo(ovest), Cane, Maiale. Tale espediente fu ripreso nel VIsecolo e divenne la prassi con i Tang.
Shennong: “Contadino Divino”, l’eroe mitologicoche avrebbe introdotto in Cina le tecniche di coltiva-zione agricola nei tempi prestorici della tradizionalestoriografia cinese.
Sishen: i “Quattro Spiriti”, detti anche “Quattro Sim-boli” (sixiang), sono le creature che rappresentano iquattro quadranti del cielo, ovvero i quattro punti car-dinali, le quattro stagioni e altre serie quadripartite divalenza geomantica: qinglong*, zhuque*, baihu*,xuanwu*. Derivano da antiche costellazioni.
Suanni: nome di un animale fantastico che deriva pro-babilmente dall’iconografia iranica del leone, introdot-ta in Cina nel periodo di divisione tra gli Han e i Tang.Nelle raffigurazioni Tang e seguenti lo si identifica
solitamente come una variante meno possente del leo-ne, a metà tra un agile felino e un canide dal musoallungato.
Taotie: maschera zoomorfa rappresentata frontalmen-te e spesso altamente stilizzata, che costituisce unricorrente motivo simbolico nella decorazione vascola-re della Cina preimperiale.
Tianlu: “Cervo Celeste”, scritto anche “EmolumentoCeleste” per un gioco di parole basato sull’omofoniadella sillaba lu. È il nome attribuito dalle Cronachedegli Han (Han Shu) a una creatura simile al cervo,dotato di un singolo corno, le statue guardiane del qualevenivano poste insieme a quelle del bixie* lungo la “Viadegli Spiriti” che conduce alle sepolture importanti. Lesue caratteristiche iconografiche non sono chiaramentedefinite e sono mutate nel corso del tempo.
Wangzi Qiao: nelle agiografie daoiste post Han è rite-nuto figlio del Re Ling (circa 571-545 a.C.) dei Zhou ecapace di cavalcare un grande uccello bianco sul qua-le, una volta divenuto immortale, se ne sarebbe volatovia per non comparire mai più tra gli uomini. In altrestorie sarebbe stato ucciso per sbaglio dal suo discepo-lo (Wenzi), il quale dopo averlo composto coprendolocon una vecchia coperta, lo vide trasformarsi in ungrande uccello bianco e scomparire nel cielo.
Wudi: cinque “Imperatori” delle Cinque Direzioni,chiamati anche “I Perfetti delle Cinque Città”, riporta-ti nel Laozi Zhongjing (Scrittura Centrale di Laozi), untesto daoista composto nei primi secoli dell’era volga-re (cfr. Raz 2007, p. 106). Furono adottati nella cosmo-logia daoista per esprimere controllo dei cinque punticardinali, come variante antropomorfa dei sishen*:Gou Mang a est, Zhu Rong a sud, Ru Shou a ovest, YuQiang a nord, Huang Chang al centro. Nel testo del IIsecolo a.C. Huainanzi questi nomi corrispondono –con qualche variante – agli assistenti dei Cinque Impe-ratori leggendari: Taihao/Gou Mang, Yandi/Zhu Rong,Shaohao/Ru Shou, Zhuanxu/Xuan Ming, Huangdi/HouTu (ivi, pp. 87-88).
Wuxing: sistema dei Cinque Agenti, tradotti anchecome Elementi o Fasi, che secondo la cosmologia tra-dizionale cinese sono alla base della classificazione diogni cosa che esiste: Fuoco, Terra, Metallo, Acqua,Legno. Secondo un sistema di corrispondenze codifica-to con la dinastia Han, a ogni Agente corrisponde pre-cisamente un colore, una direzione dello spazio, unanimale simbolico e via dicendo, in modo da incasella-re in gruppi pentadici molti ambiti dell’esistente.
Xiwangmu: “Regina Madre dell’Ovest”, è una divini-tà femminile importante dell’immaginario cinese diispirazione daoista. Viene rappresentata soprattuttodurante l’epoca Han, spesso in coppia col consorteDongwanggong*, ma le sue origini sono più antiche.Secondo la leggenda, la Regina dimora sulle montagneoccidentali del Kunlun e presiede a un paradiso conmeravigliosi palazzi e giardini, dove crescono dellepesche magiche che conferiscono l’immortalità a chi lemangia.
Xuanwu: “Guerriero Oscuro (o Nero)”. Nella serie dei“Quattro Spiriti” (sishen*), è la creatura composita chepresiede al Settentrione e all’inverno, ed è associatoall’Acqua nella serie dei cinque elementi (wuxing*). Èrappresentato come un serpente avvinghiato attorno auna tartaruga, un’unione propiziatoria di due animalicarichi di implicazioni simboliche. La tartaruga è inol-tre la più importante delle creature corazzate nella sud-divisione degli esseri viventi in squamati, pelosi, piu-mati, corazzati e ignudi.
Yin: il principio “femminile” della natura secondo laconcezione filosofica e culturale cinese. Corrispondea concetti come passività, ricettività, oscurità, morbi-dezza, è correlato alla fredda luce della luna e allaTerra.
Yang: il principio “maschile” della natura secondo laconcezione filosofica e culturale cinese. Corrisponde aconcetti come attività, creatività, luminosità, durezza, ècorrelato alla calda luce del sole e al Cielo.
Yu Boya: eccellente suonatore di cetra guqin, forsevissuto nel periodo Primavere e Autunni o in quellodegli Stati Combattenti, che pur capace di sublimimelodie era largamente incompreso dai suoi contem-poranei. Solo un taglialegna di nome Zhong Ziqi, aven-dolo udito per caso, comprese l’armonia delle suemusiche divenendo suo amico per sempre. Alla mortedi Zhong Ziqi, infatti, Boya strappò le corde del suo qine fece voto di non suonare mai più.
Zhong Ziqi: si veda Yu Boya*.
Zhuque/Zhuniao: “Uccello Vermiglio (o Rosso)”.Nella serie dei “Quattro Spiriti” (sishen*), è la creaturache presiede al Meridione e all’estate, ed è associato alFuoco nella serie dei cinque elementi (wuxing*). Peranalogia con la fenice (fenghuang*) è considerata inol-tre la più importante delle creature piumate nella sud-divisione degli esseri viventi in squamati, pelosi, piu-mati, corazzati e ignudi.
RIFLESSI 228-240:099��17-11-2012��11:58��Pagina�233
234
Aikens, Higuchi 1988Aikens, Melvin C. - Higuchi, Takayasu, Prehi-story of Japan, Academic Press, New York -London 1988.Akiyama et al. 1968Akiyama, Terukazu - Matsubara, Saburo -Okano, Taeshi, Arts of China (I): NeolithicCultures to the T’ang Dynasty, KodanshaInternational Ltd., Tokyo - Palo Alto 1968.Allan 1979Allan, James W., Persian Metal Technology.700-1300 AD., Ithaca Press London, Oxford1979.Anlen, Padiou 1989Anlen, Léon - Padiou, Roger, Les miroirs debronzes anciens, symbolisme et tradition, GuyTrédaniel Editeur, Paris 1989.Aruz et al. 2006Aruz, Joan - Farkas, Ann - Fino, ElisabettaValtz (a cura di), The Golden Deer of Eurasia.Perspectives on the Steppe Nomads of theAncient World, Metropolitan Museum of Art,New York 2006.Augustin 2010Augustin, Brigitta, “Eight Daoist Immortals inthe Yuan Dynasty: Note on the Origin of theGroup and its Iconography”, Orientations, vol.41, n. 6, Hong Kong 2010, pp. 81-87.Bagley 2001Bagley, Robert, “Debris from the HoumaFoundry”, in Chinese Bronzes: Selected Arti-cles from Orientations 1983-2000, Orienta-tions Magazine Ltd., Hong Kong 2001, pp.246-254.Bai Yunxiang 1999Bai Yunxiang, “Xi Han shiqi daguang mingcaoye wen jing ji qi zhufan de kaocha (Ricer-che sugli specchi del periodo Han Occidentalecon iscrizione daguang e motivo a “erba efoglie” e sui loro stampi)”, Kaogu, n. 4, Bei-jing 1999, pp. 65-78.Bai Yunxiang 2007Bai Yunxiang, “Linzi Qiguo gucheng Handaijing fan ji xiangguan wenti yanjiu (Ricerchesugli stampi degli specchi di epoca Han delsito di Linzi, nell’antica città dello stato di Qi,e problemi correlati)”, in Bai Yunxiang, Shi-mizu 2007, pp. 95-133.Bai Yunxiang, Shimizu 2007Bai Yunxiang - Shimizu, Yasuji (a cura di),Shandong sheng Linzi Qiguo gucheng Handaijing fan de kaoguxue yanjiu (Ricerchearcheologiche sugli stampi degli specchi diepoca Han rinvenuti nel sito di Linzi, dell’an-tica città dello stato di Qi nella provincia del-lo Shandong), Kexue chubanshe, Beijing2007.Béguin et al. 2000Béguin, Gilles - Maucuer, Michel - Chollet,Hélène, Arts de l’Asie au musée Cernuschi,Paris-musées-Editions Findakly, Paris 2000.Bernardini 1992Bernardini, Michele, s.v. “Bronzo - Islam”, inEnciclopedia dell’Arte Medioevale, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana fondata da GiovanniTreccani, Roma 1992, pp. 782-790.Bertin 1881Bertin, M., “Magic Mirrors”, Science, vol. 2, n.62, Cambridge (MA) 1881.Bjaaland Welch 2008Bjaaland Welch, Patricia, Chinese Art: A Gui-de to Motifs and Visual Imagery, Tuttle Publi-shing, Hong Kong 2008.Bobot 1973Bobot, Marie-Thérèse, L’art chinois, Ecole duLouvre, Desclée de Brouwer, Paris 1973.Boisselier 1966Boisselier, Jean, La Cambodge, Éditions A. etJ. Picard, Paris 1966.Brashier 1995Brashier, Ken E., “Longevity like Metal andStone: The Role of the Mirror in Han Burials”,T’oung Pao, vol. 81, fasc. 4/5, Leiden 1995,pp. 201-229.Brown, Chou 2005Brown, Claudia - Chou, Ju-hsi (a cura di),Clarity and Luster: New Light on Bronze Mir-rors in Tang and Post-Tang Dynasty China,600-1300. Papers from a Symposium on theCarter Collection of Chinese Bronze Mirrorsat the Cleveland Museum of Art, ClevelandStudies in the History of Art, vol. 9, ClevelandMuseum of Art, Cleveland (OH) 2005.Bruxelles 1982Trésors d’art de la Chine, Palais de Beaux-Arts, Bruxelles 1982.Bulling 1955Bulling, Anneliese G., “The Decoration ofSome Mirrors of the Chou and Han Period”,Artibus Asiae, vol. 18, fasc. 1, Ascona 1955,pp. 20-45.Bulling 1960Bulling, Anneliese G., The Decoration of Mir-rors of the Han Period: A Chronology (ArtibusAsiae, Supplementum 20), Ascona 1960.Bunker 1994Bunker, Emma, “The Enigmatic Role of Silverin China”, Orientations, vol. 25, n. 11, HongKong 1994, pp. 73-78.Bunker 2002Bunker, Emma, Nomadic Art from the EasternEurasian Steppes: The Eugene V. Thaw andOther New York Collections, MetropolitanMuseum of Art Series, New York 2002.Bussagli 1970Bussagli, Mario, “Asia centrale e mondo deinomadi”, in Bussagli, Mario - Petech, Luciano- Muccioli, Marcello (a cura di), Asia Centralee Giappone, vol. XX dell’opera Nuova StoriaUniversale dei Popoli e delle Civiltà, Utet,Torino 1970, pp. 1-234.Cahill 1986Cahill, Suzanne E., “The World Made Bronze:Inscriptions on Medieval Chinese Bronze Mir-rors”, Archives of Asian Art, vol. 39, Honolulu1986, pp. 62-70.Cahill 1994Cahill, Suzanne E., “Boya Plays the Zither:
Two Types of Chinese Bronze Mirror in theDonald H. Graham Jr. Collection”, in Nakanoet al. 1994, pp. 50-59.Cahill 2005Cahill, Suzanne E., “The Moon Stopping in theVoid: Daoism and the Literati Ideal in Mirrorsof the Tang Dynasty”, in Brown, Chou 2005,pp. 24-41.Cammann 1948Cammann Schuyler, “The TLV-pattern onCosmic Mirrors of the Han Dynasty”, Journalof the American Oriental Society, n. 68, NewHaven (CT) 1948, pp. 159-167.Cammann 1953Cammann, Schuyler, “The Lion and Grape Pat-tern on Chinese Bronze Mirrors”, Artibus Asiae,vol. 16, fasc. 4, Ascona 1953, pp. 265-291.Cammann 1955Cammann, Schuyler, “Significant Patterns onChinese Bronze Mirrors”, Archives of theChinese Art Society of America, vol. 9, Uni-versity of Hawaii Press, Honolulu 1955, pp.43-62.Campanelli, Pennetta 2003Campanelli, Adele - Pennetta, Maria Paola,Attraverso lo specchio, Carsa Edizioni, Pesca-ra 2003.Castello Sforzesco 1995I bronzi estremo-orientali dalla Raccolta Etno-grafica del Castello Sforzesco, Mazzotta,Milano 1995.Caterina, Verardi 2005Caterina, Lucia - Verardi, Giovanni (a cura di),Tang - Arte e cultura in Cina prima dell’annomille, Electa, Napoli 2005.Cattani 2007Cattani, Maurizio, “Origine del nomadismopastorale nelle steppe eurasiatiche”, in Bonora,Gian Luca - Marzatico, Franco (a cura di), Oridei cavalieri delle steppe, Silvana Editoriale,Cinisello Balsamo 2007, pp. 32-39.Chang 1999Chang, Kwang-Chih, “China on the Eve of theHistorical Period”, in Loewe, Shaughnessy1999, pp. 37-65.Changde 2010Changde bowuguan, Changde chutu tongjing(Specchi rinvenuti a Changde), Yuelu shushe,Changsha 2010.Chase 1994Chase, Thomas W., “Chinese Bronzes:Casting, Finishing, Patination, and Corrosion”,in Scott, David A. - Podany, Jerry - ConsidineBrian B. (a cura di), Ancient & Historic Metals:Conservation and Scientific Research, GettyConservation Institute, Los Angeles 1994, pp.85-117.Chase, Franklin 1979Chase, Thomas W. - Franklin, Ursula M., “Ear-ly Chinese Black Mirrors and Pattern-etchedWeapons”, Ars Orientalis, n. 11, Washington1979, pp. 215-258.Chavannes 1906Chavannes, Edouard, “Le Cycle Turc des Dou-
ze Animaux”, T’oung Pao, vol. 7, fasc. 1, Lei-den 1906, pp. 51-122.Chen 1997Chen, Peifen, “Early Chinese Bronze Mirrors”,Orientations, vol. 28, n. 3, Hong Kong 1997,pp. 88-93.Chen 2001Chen, Peifen, “Early Chinese Bronze Mirrors”,in Chinese Bronzes: Selected Articles fromOrientations 1983-2000, Orientations Magazi-ne Ltd., Hong Kong 2001, pp. 260-265.Chen Baiquan 1985Chen Baiquan, “Songdai tongjing jianlun (Anno-tazioni sugli specchi di epoca Song)”, Kaogu yuwenwu, n. 4, Beijing 1985, pp. 96-103.Chen Binying 1983Chen Binying, “Gansu sheng bowuguan shou-zang de san mian Jindai tongjing (Tre specchidi epoca Jin conservati nel museo provincialedel Gansu)”, Kaogu yu wenwu, n. 2, Beijing1983, pp. 102-104.Chen Yuyun et al. 1987Chen Yuyun - Huang Yunlan - Yang Yong-ning - Chen Hao, “Moni ‘heiqigu’ tongjingshiyan yanjiu (Ricerche sui test di simulazionedel ‘nero lacca antico’ degli specchi in bron-zo)”, Kaogu, n. 2, Beijing 1987, pp. 175-178.Ch’en 19733
Ch’en, Kenneth, Buddhism in China. A Histo-rical Survey, Princeton University Press, Prin-ceton (NJ) 1973 (3ª ed.).Chêng 1957Chêng, Tê-K’un, Archaeological Studies inSzechwan, Cambridge University Press, Cam-bridge 1957.Chou 2000Chou, Ju-hsi, Circles of Reflection: the CarterCollection of Chinese Bronze Mirrors, TheCleveland Museum of Art, Cleveland (OH)2000.Chutu wenwu 1973Chutu wenwu zhanlan gongzuozu, WenhuaDageming qijian chutu wenwu (Reperti cultura-li scavati nel periodo della Grande RivoluzioneCulturale), Wenwu chubanshe, Beijing 1973.Ciarla 1985Arte cinese in collezioni italiane fine-secolo,Museo Nazionale d’Arte Orientale, Roma1985, pp. 28-29.Ciarla 1994Lucidi, Maria Teresa (a cura di), La Seta e laSua Via, De Luca Editore, Roma 1994, p. 196.Ciarla 1999Ciarla, Roberto, “Il cuore della Collezione: leceramiche invetriate vietnamite”, in Ciarla,Rispoli 1999, pp. 79-89.Ciarla 2003Ciarla, Roberto, “Specchio giapponese”, inCampanelli, Pennetta 2003, p. 122.Ciarla 2009aCiarla, Roberto, “Specchio del tipo a figure diImmortali”, in Pacini 2009, pp. 158-161.Ciarla 2009bCiarla, Roberto, “Specchio con Immortali a
Bibliografia
RIFLESSI 228-240:099��17-11-2012��11:58��Pagina�234
cavallo di animali fantastici”, in Pacini 2009,pp. 206-209.Ciarla 2010Ciarla, Roberto, Archeologia e arte della Cina,Artemide, Roma 2010.Ciarla, Giorgi 2010Ciarla, Roberto - Giorgi, Maria Luisa (a curadi), Archeologia e Arte della Corea, MuseoNazionale d’Arte Orientale, Roma 2010.Ciarla, Rispoli 1999Ciarla, Roberto - Rispoli, Fiorella (a cura di),Ceramiche e Bronzi dall’Oriente Estremo. Lacollezione Ivanoe Tullio Dinaro, MuseoNazionale d’Arte Orientale, Roma 1999.Colledge 1977Colledge, Malcom A.R., Parthian Art, CornellUniversity Press, New York 1977.Curatola 1989Curatola, Giovanni, Draghi. La tradizioneartistica orientale e i disegni del tesoro delTopkapï, Poligrafo, Venezia 1989.Davis 1836Davis, John F., The Chinese: a generaldescription of the empire of China and itsinhabitants, Volume 2, Harper & Bros., NewYork 1836.Debaine-Francfort 1995Debaine-Francfort, Corinne, Du Néolithique àl’Age du Bronze en Chine du Nord-Ouest: laculture de Qija et ses connexions, EditionsRecherche sur les Civilisations, Paris 1995.De Bisscop 2004De Bisscop, Nicole, “La metamorphose del’animal mytique”, in De Bisscop, Nicole (acura di), L’empire du Dragon: chefs-d’œuvredu Musée du Henan en Chine, Kunsthal Sint-Pietersabdij, Gent 2004.De Caro, Scarpari 2010De Caro, Stefano - Scarpari, Maurizio, I dueImperi. L’aquila e il dragone, Federico MottaEditore, Milano 2010.Delacour 2001Delacour, Catherine, De bronze, d’or et d’ar-gent. Arts somptuaires de la Chine, Réuniondes musées nationaux, Paris 2001.Di Cosmo 1999Di Cosmo, Nicola, “The Northern Frontier inPre-Imperial China”, in Loewe, Shaughnessy1999, pp. 885-966.Di Flumeri Vatielli 2005Di Flumeri Vatielli, Gabriella, “Oggetti inmetallo”, in Mazzeo, Donatella (a cura di),Splendori dall’Asia. ‘Frammenti di Diamante’ -opere esemplari da una donazione, MuseoNazionale d’Arte Orientale, Roma 2005, pp.133-145.Dien 2007Dien, Albert E., Six dynasties civilization, YaleUniversity Press, New Haven (CT) 2007.Earle 2000Earle, Joe (a cura di), Japanese Art and Design,V&A Publication, London 1986 (rist. 2000).Eberhard 1986Eberhard, Wolfram, A dictionary of Chinese
symbols, Routledge & Kegan Paul, London -New York 1986.Ecke Tseng 1994Ecke Tseng, Yuho, “Cosmic Mirrors”, inNakano et al. 1994, pp. 46-49.Edwards 1999Edwards, Walter, “Mirrors on Ancient Yama-to. The Kurokuza Kofun Discovery and theQuestion of Yamatai”, Monumenta Nipponica,vol. 54, n. 1, Sophia University, Tokyo 1999,pp. 75-110.Egami et al. 1966Egami, Namio - Fukai, Shinji - Masuda, Sei-ichi, Dailaman II: The Excavations at Noruz-mahale and Khoramrud, 1960, The TokyoUniversity Iraq-Iran Archaeological Expedi-tion Reports 7, Tokyo 1966.Eliade 1979Eliade, Mircea, Dall’età della pietra ai misterieleusini, vol. I dell’opera Storia delle credenzee delle idee religiose, Sansoni, Firenze 1979.Eskenazi 1996Eskenazi, John, Sculpture and ornament inearly Chinese art, Eskenazi, London 1996.Failla 1995Failla, Donatella, Edoardo Chiossone - un col-lezionista erudito nel Giappone Meiji, ServizioBeni Culturali Comune di Genova e IstitutoGiapponese di Cultura di Roma, Genova 1995.Fogg 1969Grenville L. Winthrop, Retrospective for a col-lector, Fogg Museum of Art, Cambridge (MA)1969.Frédéric 1992Frédéric, Louis, Les dieux du bouddhisme. Gui-de iconographique, Flammarion, Paris 1992.Frumkin 1970Frumkin, Grégoire, Archaeology in SovietCentral Asia, Handbuch der Orientalistik 3,E.J. Brill, Leiden-Köln 1970.Fu Juyou 2008Fu Juyou, “Tiejing chunqiu - Zhongguo gudaitiejing de fasheng, fazhan, fanrong he xiao-wang (Primavere e Autunni degli specchi diferro: nascita, sviluppo, apogeo e scomparsadegli antichi specchi cinesi in ferro)”, Zhong-guo wenwu bao, Beijing, 9 luglio 2008, p. 5.Fukunaga 2004Fukunaga, Shin’ya, “Der Kult der Bronzespie-gel - die Diskussion und das Rätsel der Spiegelmit dreieckiger Randleiste”, in Wieczorek etal. 2004, pp. 300-304.Gao Zhixi 1991Gao Zhixi, “Lun Chu jing (A proposito deglispecchi di Chu)”, Wenwu, n. 5, Beijing 1991,pp. 42-60.Geng Qingyan 1987Geng Qingyan, “Henan Qixian zhengji de yipi Song Yuan tongjing (Un gruppo di specchidi bronzo Song e Yuan raccolti a Qixian, nel-lo Henan)”, Kaogu, n. 3, Beijing 1987, pp.283-285.Getty 1978Getty, Alice, The Gods of Northern Buddhism,
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.,New Delhi 1978.Ghirshman 1956Ghirshman, Roman, “Un miroir T’ang deSuse”, Artibus Asiae, vol. 19, fasc. 3/4, Asco-na 1956, pp. 230-233.Gimello 2004Gimello, Robert M., “Icon and Incantation:The Goddess Zhunti and the Role of Images inthe Occult Buddhism of China”, in Granoff,Phyllis E. - Shinohara, Koichi, Images in Asianreligions: texts and contexts, UBC Press, Van-couver 2004, pp. 225-256.Giorgi 2003Giorgi, Maria Luisa, “Specchio buddhista conformule religiose”, in Campanelli – Pennetta2003, p. 153.Giteau, Guéret 1997Giteau, Madeleine - Guéret, Danielle, KhmerArt. The Civilisations of Angkor, ASA Édi-tions, Paris 1997.Goto 1964Gotō Bijutsukan, Meikyō. Tōkyō OrinpikkuKinen (“Specchi Lucenti”. In commemorazio-ne delle Olimpiadi di Tokyo), Gotō Bijutsukan,Tokyo 1964.Guangxi 1988Guangxi Zhuangzu zizhiqu bowuguan, Guang-xi Guixian Luobowan Hanmu (Le tombe Handi Luobowan nella contea di Gui, Guangxi),Wenwu chubanshe, Beijing 1988.Guangzhou 1956Guangzhou shi wenwudui, “San nian Guang-zhou shi gu muzang de qingli he faxian (Treanni di scoperte e scavi di tombe antiche nellamunicipalità di Guangzhou”, Wenwu cankaoziliao, n. 5, Beijing 1956, pp. 21-32.Guangzhou et al. 1981Guangzhou shi wenwu guanli weiyuanhui -Guangzhou shi bowuguan - Zhongguo shehuikexueyuan kaogu yanjiusuo, Guangzhou Hanmu (Tombe Han a Guangzhou), 2 voll., Wen-wu chubanshe, Beijing 1981.Guangzhou et al. 1991Guangzhou shi wenwu guanli weiyuanhui -Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo- Guangdong sheng bowuguan, Xi Han Nanyuewang mu (Tomba del re di Nanyue [del perio-do] Han Occidentale), 2 voll., Wenwu chuban-she, Beijing 1991.Gugong 1986Gugong bowuguan, Gugong tongjing tezhantulu. Catalogue of Special Exhibition of Bron-ze Mirrors in the National Palace Museum,Guoli gugong bowuyuan, Taipei 1986.Gyllensvard 1957Gyllensvard, Bo, “T’ang Gold and Silver”,Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiqui-ties, vol. 29, Stockholm 1957, pp. 1-230.Hall 1935Hall, Ardelia R., “The Early Significance ofChinese Mirrors”, Journal of the AmericanOriental Society, n. 55, New Haven (CT) 1935,pp. 182-189.
Harada et al. 2005Harada, Kazutoshi - Koyama, Mayumi S. -Peternolli, Giovanni, Kinkō: i bronzi orientalidella collezione Garda, Hever, Ivrea 2005.Hargett 1989Hargett, James M., “Playing Second Fiddle:the Luan-Bird in Early and Medieval ChineseLiterature”, T’oung Pao, vol. 75, fasc. 4/5, Lei-den 1989, pp. 235-262.Harper 1999Harper, Donald, “Warring States Natural Phi-losophy and Occult Thought”, in Loewe, Shau-ghnessy 1999, pp. 813-884.Hayashi 1975Hayashi, Ryoichi, The Silk Road and the Sho-so-in (trad. dal giapponese di Robert Ricketts),The Heibonsha Survey of Japanese Art, vol. 6,Weatherhill-Heibonsha, New York - Tokyo1975.He Lin 2007He Lin (a cura di), Tongjing (Copper Mirrors),The Forbidden City Publishing House, Beijing2007.He Lin 2008He Lin (a cura di), Gugong cang jing. ThePalace Museum’s Collections of Bronze Mir-rors, Forbidden City Publishing House, Bei-jing 2008.He Tangkun 1985He Tangkun, “Guanyu gu tongjing biaomiantouming ceng de fenxi (Analisi degli strati tra-sparenti delle superfici degli antichi specchi inbronzo)”, Ziran kexue shi yanjiu, n. 3, Beijing1985, pp. 252-257.He Tangkun 1999He Tangkun, Zhongguo gudai tongjing dejishu yanjiu (Ricerche sulle tecniche di fabbri-cazione degli specchi in bronzo nella Cinaantica), Zijincheng chubanshe, Beijing 1999.Heissig 1980Heissig, Walter, The Religions of Mongolia,University of California Press, Berkely andLos Angeles 1980.Henan 1986Henan sheng wenwu yanjiusuo, Xinyang Chumu (Le tombe di Chu a Xinyang), Wenwu chu-banshe, Beijing 1986.Higuchi 1979Higuchi Takayasu, Kokyō (Ancient mirrors),Shinchōsha, Tokyo 1979.Hirth 1906Hirth, Friedrich, “Chinese metallic mirrors,with notes on some ancient specimens of theMusee Guimet”, in Laufer, Berthold (a curadi), Boas anniversary volume; anthropologicalpapers written in honor of Franz Boas, G.E.Stechert & Co., New York 1906, pp. 208-256.Ho 1991Ho, Judy Chengwa, “The Twelve CalendricalAnimals in Tang Tombs”, in Kuwayama,George (a cura di), Ancient Mortuary Tradi-tions in China. Papers on Chinese Ceramicfunerary Sculpture, Los Angeles CountyMuseum of Art, Los Angeles 1991, pp. 60-84.
235
RIFLESSI 228-240:099��17-11-2012��11:58��Pagina�235
236
Ho 2005Ho, Chuimei, “Magic and Faith: Reflections onChinese Mirrors in the Tenth to the FourteenthCentury”, in Brown, Chou 2005, pp. 90-97.Hobson 1927Hobson, Robert L., “A series of Japanese Mir-rors”, The British Museum Quarterly, vol. 2, n.3, British Museum, London 1927, pp. 64-65.Hong Kong 2002Zhanzheng yu heping. Qin Han wenwu jinghuazhan (War and Peace. Treasures of the Qinand Han Dynasties), The Hong Kong Museumof History, Hong Kong 2002.Horlyck 2002Horlyck, Charlotte, “Korean Bronze Mirrorsand Their Chinese and Japanese Influences”,Orientations, vol. 33, n. 9, Hong Kong 2002,pp. 48-53.Hu 2008Hu, Philip K., Later Chinese Bronzes. TheSaint Louis Art Museum and Robert E. KreskoCollection, Saint Louis Art Museum, SaintLouis 2008.Hua Jueming 1999Hua Jueming, Zhongguo gudai jinshu jishu(Tecniche di lavorazione dei metalli nella Cinaantica), Daxiang chubanshe, Zhengzhou 1999.Hubei, Ezhou 1986Hubei sheng bowuguan - Ezhou shi bowuguan,Echeng Han Sanguo Liuchao tongjing (Spec-chi di bronzo [di epoca] Han, Tre Regni e SeiDinastie da Echeng), Wenwu chubanshe, Bei-jing 1986.Hunan 1983Hunan sheng bowuguan, “Hunan Zixing Jiushizhanguo mu (Tombs of the Warring States atJiushi in Zixing, Hunan Province)”, Kaoguxuebao, n. 1, 1983, pp. 93-121.Hunan 1984Hunan sheng bowuguan, “Changsha Shumu-ling Zhanguo mu Amiling Xi Han mu (Tombadegli Stati Combattenti a Shumuling e tombadegli Han Occidentali ad Amiling, Changsha)”,Kaogu, n. 9, Beijing 1984, pp. 790-797.Hunan 1989Hunan sheng bowuguan, Zeng hou Yi mu (Latomba del marchese Yi di Zeng), Wenwu chu-banshe, Beijing 1989.Hunan 1995Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo, Jiang-ling Jiudian Dongzhou mu (Le tombe [di epo-ca] Zhou Orientale di Jiudian presso Jiang-ling), vol. I, Kexue chubanshe, Beijing 1995.Iannaccone 1991Iannaccone, Isaia, Misurare il Cielo: l’anticaAstronomia cinese, Istituto UniversitarioOrientale (Serie Didattica 2), Napoli 1991.Idemitsu 1989Idemitsu bijutsukan, Chūgoku no kōgei. Ide-mitsu bijutsukan zōhin zuroku. Ancient Chine-se arts. Catalogue of the collection in the Ide-mitsu Art Gallery, Heibonsha, Tokyo 1989.Jacob 1991Jacob, Lionel, Arts de la Chine ancienne. For-mation de la culture chinoise, du néolithique àla fondation de l’Empire, vol. I, Éditions del’Albaron, Thonon-les-Bains 1991.Jacobson 1995Jacobson, Esther, The Art of the Scythians: theinterpretation of cultures at the edge of theHellenic world, Handbuch der Orientalistik 8,E.J. Brill, Leiden - New York - Köln 1995.Jia Minfeng 2004Jia Minfeng, “Dingzhou Kaiyuansi ta tasha
faxian yipi wenwu (Scoperti alcuni reperti cul-turali nella cuspide della pagoda del tempioKaiyuansi a Dingzhou)”, Wenwu, n. 10, Bei-jing 2004, pp. 55-60.Jingzhou 1982Jingzhou diqu bowuguan, “Hubei JianglingMashan zhuangong yi hao mu chu tu da piZhanguo shiqi sizhipin (Tessuti del periododegli Stati combattenti portati alla luce in grannumero nella tomba n. 1 della fabbrica di mat-toni di Mashan presso Jiangling, Hubei)”,Wenwu, n. 10, Beijing 1982, pp. 1-8.Juliano 1985Juliano, Annette L., “Possible Origins of theChinese Mirror”, Source: Notes in the Historyof Art, vol. 4, fasc. 2/3, New York 1985, pp.36-45.Kaplan 1937Kaplan, Sidney M., “The Origin of the TLVMirror”, Revue des Arts Asiatiques, n. 11, Paris1937, pp. 21-24.Karlgren 1941Karlgren, Bernhard, “Huai and Han”, Bulletinof the Museum of Far Eastern Antiquities, vol.13, Stockholm 1941, pp. 1-125.Karlgren 1968Karlgren, Bernhard, “Early Chinese Mirrors:Classification Scheme Recapitulated”, Bulletinof the Museum of Far Eastern Antiquities, vol.40, Stockholm 1968, pp. 77-98.Keightley 1994Keightley, David N., “L’antica civiltà dellaCina: riflessioni su come divenne ‘cinese’”, inRopp, Paul S. (a cura di), L’eredità della Cina,Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli,Torino 1994, pp. 33-68.Kerr 1990Kerr, Rose, Later Chinese Bronzes, Victoriaand Albert Museum-Far Eastern Series, Bam-boo Publishing Ltd., London 1990.Kim 1963Kim, Won-Yong, “Bronze Mirrors from Shih-erh T’ai Ying-tzu, Liaoning”, Artibus Asiae,vol. 26, n. 3/4, Ascona 1963, pp. 207-214.Koehn 1952Koehn, Alfred, “Chinese Flower Symbolism”,Monumenta Nipponica, vol. 8, n. 1/2, SophiaUniversity, Tokyo 1952, pp. 121-146.Kong Xiangxing, Liu Yiman 1984Kong Xiangxing - Liu Yiman, Zhongguogudai tongjing (Antichi specchi di bronzo del-la Cina), Wenwu chubanshe, Beijing 1984.Kong Xiangxing, Liu Yiman 1992Kong Xiangxing - Liu Yiman, Zhongguo tong-jing tudian (Dizionario illustrato sugli specchidi bronzo cinesi), Wenwu chubanshe, Beijing1992.Kong Xiangxing, Liu Yiman 1994Kong Xiangxing - Liu Yiman, Zhonguo gutongjing (Antichi specchi di bronzo dellaCina), Wenwu jianshang congshu n. 1 (Rac-colta di stimati reperti storici n. 1), He Gong-shang, Taipei 1994.Kossolapov, Twilley 1994Kossolapov, Alexander - Twilley, John, “Adecorated Chinese dagger: evidence for ancientamalgam tinning”, Studies in conservation, vol.39, n. 4, London 1994, pp. 257-264.Koyama, Vitali 1994Koyama, Mayumi S. - Vitali, Fabio A., Laccheorientali della collezione Garda, Olivetti,Milano 1994.Kubo 1999Kubo Tomoyasu, “Chūsei, kinsei no kagami
(Specchi medievali e moderni)”, Nihon nobijutsu, n. 394, Tokyo 1999.Kuz’mina 2007Kuz’mina, Elena E., The origin of the Indo-Iranians, a cura di J.P. Mallory, Brill, Leiden2007.Larre, Rochat de la Vallée 2004Larre, Claude - Rochat de la Vallée, Elisabeth,I simboli cinesi di vita e di morte nelle pitturedel drappo funerario di Mawangdui (II secoloa.C.), Jaca Book, Milano 2004.Lausanne 19995000 ans de sport en Chine, Musée Olympi-que, Lausanne 1999.Legge 1872Legge, James, The Chinese Classics, Vol. 5:The Ch’un Ts’ew with the Tso Chuen, Trübner& Co., London 1872.Li 1985Li, Xueqin, Eastern Zhou and Qin Civiliza-tions, Yale University, New Haven-London1985.Li Chaoyuan 2005Li Chaoyuan, “Xin huo Zhanguo toukong fuhejing yanjiu (New Acquired Double-tier Mirrorswith Openwork Design of the Warring Sta-tes)”, in Shanghai 2005, pp. 36-53.Li Chaoyuan et al. 2004Li Chaoyuan - Zhou Ya - Ma Jinhong - Wu Lai-ming - Lian Haiping, Zhongguo gudai qing-tongqi (Antichi bronzi cinesi), Wuzhou chuanbochubanshe, Beijing 2004.Li Dewen 2008Li Dewen (a cura di), Lu’an chutu tongjing(Specchi di bronzo rinvenuti a Lu’an), Wenwuchubanshe, Beijing 2008.Li Huhou 1980Li Huhou, “Qijia wenhua tongjing de feipohuai jianding (Autenticazione dei repertinon danneggiati fra gli specchi in bronzo dellacultura Qijia)”, Wenwu, n. 4, Beijing 1980, pp.365-368.Li Xueqin 1997Li Xueqin, “Tongzhai jing tashi ling (Alcunicalchi di specchi dello Studio Tong)”, Shou-cangjia - Collectors 23, Beijing 1997, pp. 28-29.Li Yinde 2005Li Yinde, Da Han Chu wang: Xuzhou Xi HanChu wang lingmu wenwu ji cui (I re di Chu [altempo] dei grandi Han: collezione dei beniculturali delle tombe dei re di Chu presso ilsito di Xuzhou [al tempo] degli Han Occiden-tali), Zhongguo shehui kexue chubanshe, Bei-jing 2005.Li Zehou 2004Li Zehou, La via della bellezza. Per una storiadella cultura estetica cinese, Einaudi, Torino2004.Ligori 1996Ligori, Massimo, “Nuove ipotesi sulla relazioneAmaterasu/Susanoo. I miti di sovranità giappo-nesi e le arti del metallo: parte prima”, Il Giap-pone, vol. 36, IsIAO, Roma 1996, pp. 5-62.Ligori 1997Ligori, Massimo, “Nuove ipotesi sulla relazio-ne Amaterasu/Susanoo. I miti di sovranitàgiapponesi e le arti del metallo: parte secon-da”, Il Giappone, vol. 37, IsIAO, Roma 1997,pp. 5-43.Lin Meicun 1997Lin Meicun, “Zhongguo jingnei chutu dai ming-wen de Bosi he Zhongya yingqi (Oggetti d’ar-gento persiani e centroasiatici con iscrizioni sca-
vati in territorio cinese)”, Wenwu, n. 9, Beijing1997, pp. 55-65.Little, Eichman 2000Little, Stephen - Eichman, Shawn, Taoism andthe arts of China, University of CaliforniaPress, Berkeley 2000.Liu 2005Liu, David T., “Painted mirror with daily lifescenes”, in Liu et al. 2005, pp. 380-383.Liu et al. 2005Liu, Cary Y. - Nylan, Michael - Barbieri-Low,Anthony (a cura di), Recarving China’s Past.Art, Archaeology and Architecture of the “WuFamily Shrine”, Yale University Press, NewHaven-London 2005.Liu Yiman 1985Liu Yiman, “Shilun Zhangguo tongjing de fen-qu (Sulla regionalizzazione degli specchi dibronzo [nel periodo] degli Stati Combattenti)”,Kaogu, n. 11, Beijing 1985, pp. 1008-1014.Loewe 1979Loewe, Michael, Ways to Paradise: the Chine-se Quest for Immortality, George Allen &Unwin, London 1979.Loewe. Shaughnessy 1999Loewe, Michael - Shaughnessy, Edward L. (acura di), The Cambridge History of AncientChina: From the Origins of Civilization to 221B.C., Cambridge University Press, Cambridge(MA) 1999.Loubo-Lesnitchenko 1973Loubo-Lesnitchenko, E., “Imported Mirrors inthe Minusinsk Basin”, Artibus Asiae, vol. 35,fasc. 1/2, Ascona 1973, pp. 25-61.Lü Jing 2011Lü Jing, “Yulin xueyuan Shaanbei lishi wenhuabowuguan cang Xi Han caihui tongjing (Spec-chio in bronzo dipinto del museo di cultura e distoria dello Shaanxi settentrionale, AccademiaYulin)”, Wenwu, n. 9, Beijing 2011, p. 79.Luoyang 1959Luoyang qu kaogu fajuedui, Luoyang ShaogouHan mu (Le tombe Han di Shaogou a Luo-yang), Kexue chubanshe, Beijing 1959.Luoyang 1988Luoyang Bowuguan, Luoyang chutu tongjing(Specchi di bronzo rinvenuti a Luoyang), Wen-wu chubanshe, Beijing 1988.Ma Jinhong 2005Ma Jinhong, “Shanghai bowuguan cang qing-tong jing zonglun (Breve dissertazione suglispecchi di bronzo conservati presso il Museodi Shanghai)”, in Shanghai 2005, pp. 10-29.Maenchen-Helfen 1973Maenchen-Helfen, Otto, The world of the Huns:studies in their history and culture, Universityof California Press, Berkeley (CA) 1973.Magotti 2009Magotti, Sergio, Nippontō. L’anima del samu-rai: evoluzione, arte, tecnica dell’arma piùefficiente della storia, Ponchiroli, Mantova2009.Marino 2003Marino, Maria A., “Su alcuni specchi in bron-zo del Museo di Arte Islamica del Cairo”, inFontana, Maria V. - Genito, Bruno (a cura di),Studi in onore di Umberto Scerrato per il suosettantacinquesimo compleanno, Napoli 2003,vol. II, pp. 547-564.Masaaki 1979Masaaki, Sawada, “Non-Destructive X-rayFluorescence Analysis of Ancient Bronze Mir-rors Excavated in Japan”, Ars Orientalis, n. 11,Washington 1979, pp. 195-213.
RIFLESSI 228-240:099��17-11-2012��11:58��Pagina�236
Matsumoto 1998Matsumoto, Nobuyuki, “Some Questions Con-cerning the Seashore Design Mirrors”,Museum, n. 554, Tokyo 1998, pp. 49-70.Maucuer 2005Maucuer, Michel, “Kofun Period Bronze Mir-rors Rediscovered in Enrico Cernuschi’s Col-lection”, Orientations, vol. 36, n. 5, HongKong 2005, pp. 35-39.McKillop 1992McKillop, Beth, Korean Art and Design, Vic-toria and Albert Museum, London 1992.Meng Qiang, Geng Jianjun 1997Meng Qiang - Geng Jianjun, “Xuzhou Xi HanWanqu hou Liu Zhi mu (La tomba di Liu Zhi,principe di Wanqu degli Han Occidentali, aXuzhou)”, Wenwu, n. 2, Beijing 1997, pp. 4-21e 22-25.Mirviss, Carpenter 1995Mirviss, Joan B. - Carpenter John, The FrankLloyd Wright Collection of surimono, Wea-therhill/Phoenix Art Museum, New York1995.Montuschi 1993Montuschi, Lucia (a cura di), Antichi BronziCinesi, Franco Cantini Editore, Firenze 1993.Nakano 1994Nakano, Toru, “Ancient Chinese Bronze Mir-rors”, in Nakano et al. 1994, pp. 9-45.Nakano et al. 1994Nakano, Toru - Ecke Tseng, Yuho - Cahill,Suzanne, Bronze Mirrors from Ancient China,Donald H. Graham Jr. Collection, Orienta-tions, Teachpearl Printing Ltd., Hong Kong1994.Needham 1962-1971Needham, Joseph (a cura di), Science and civi-lisation in China, vol. 4: Physics and PhysicalTechnology, Cambridge University Press,Cambridge (MA) 1962-1971.Needham 1984-2000Needham, Joseph (a cura di), Science and civi-lisation in China, vol. 6: Biology and Biologi-cal Technology, Cambridge University Press,Cambridge (MA) 1984-2000.Nei Menggu et al. 1994Nei Menggu wenwu kaogu yanjiusuo - Xilin-guole meng wenwu guanlizhan - Duolun xianwenwu guanlisuo, “Yuan Shangdu nan Zhen-zishan nanqu muzang fajue baogao (Rapportodi scavo della necropoli di Zhenzishan a sud diShangdu [di epoca] Yuan)”, in Li Yiyou - WeiJian (a cura di), Nei Menggu wenwu kaoguwenji - diyi ji (Antologia di reperti storici e diarcheologia della Mongolia Interna, vol. I),Zhongguo dabaike quanshu chubanshe, Bei-jing 1994, pp. 639-671.Nei Menggu, E’erduosi 1997Nei Menggu wenwu kaogu yanjiusuo - E’er-duosi bowuguan, “Wushen Qi Guoliang SuiTang muzang fajue baogao (Rapporto di scavosulle sepolture Sui e Tang a Guoliang, Bandie-ra di Wushen)”, in Wei Jian (a cura di), NeiMenggu wenwu kaogu wenji - di’er ji (Antolo-gia su reperti storici e archeologia della Mon-golia Interna, vol. II), Zhongguo dabaike quan-shu chubanshe, Beijing 1997, pp. 484-501.NMK 2005National Museum of Korea, The NationalMuseum of Korea, Seoul 2005.NPM 1986Catalogue of Special Exhibition of BronzeMirrors in the National Palace Museum,National Palace Museum, Taipei 1986.
O’Donoghue 1988O’Donoghue, Diane M., Reflection and Recep-tion: The Origins of the Mirror in Bronze AgeChina, Harvard University, Cambridge (MA)1988.O’Donoghue 1990O’Donoghue, Diane M., “Reflection andReception: the Origins of the Mirror in BronzeAge China”, Bulletin of the Museum of FarEastern Antiquities, vol. 62, Stockholm 1990,pp. 11-183.Pacini 2009Pacini, Marcello (a cura di), Il potere dell’im-magine riflessa. Specchi di bronzo dell’anticaCina dal VI secolo a.C. al X secolo d.C., Qua-derni di collezionismo di arte asiatica antica,s.l. 2009.Pelliot 1920-1921Pelliot, Paul, “Bulletin Critique”, T’oung Pao,vol. 20, fasc. 2, Leiden 1920-1921, pp. 142-156.Peng Hao 1996Peng Hao, “Churen sizhi de huihuang (Splen-dore dei tessuti serici dei Chu)”, Lanshangjia- Connoisseur, n. 3, Shanghai 1996, pp. 34-45.Peng Shifan, Tang Changpu 1980Peng Shifan - Tang Changpu, “Jiangxi faxianji zuo Bei Song jinian mu (Alcune tombe data-te dei Song Settentrionali scoperte nel Jiang-xi)”, Wenwu, n. 5, Beijing 1980, pp. 28-39.Pi Daojian 1995Pi Daojian (a cura di), Chu yishu shi (Storiadell’arte di Chu), Hubei Jiaotong chubanshe,Wuhan 1995.Pirazzoli-t’Serstevens 1996Pirazzoli-t’Serstevens, Michèle, “I Qin e gliHan”, in Pirazzoli-t’Serstevens, Michèle (acura di), La Cina, Utet, Torino 1996, vol. I, pp.167-251.Pirazzoli-t’Serstevens 2002Pirazzoli-t’Serstevens, Michèle, “Un miroirpeint du début de l’époque des Han”, ArtsAsiatiques, n. 57, Paris 2002, pp. 223-225.Portal 2000Portal, Jane, Korea: Art and Archaeology, Bri-tish Museum, London 2000.Qi Wentao 1972Qi Wentao, “Gaishu jinian lai Shandong chu-tu de Shang Zhou qingtongqi (Cenni generalisulle recenti scoperte di bronzi Shang e Zhounello Shandong)”, Wenwu, n. 5, Beijing 1972,pp. 3-18.Quan Hong 1994Quan Hong, “Shilun Dong Han Wei Jin Nan-beichao shiqi de tiejing (Saggio introduttivosugli specchi di ferro nel periodo Han Occiden-tale, Wei, Jin e Dinastie del Sud e del Nord)”,Kaogu, n. 12, Beijing 1994, pp. 1118-1126.Raschke 1978Raschke, Manfred G., “New Studies in theRoman Commerce with the East”, in Haase,Wolfgang, Aufstieg und Niedergang der römi-schen Welt: Geschichte und Kultur Roms imSpiegel der neueren Forschung, Walter deGruyter & Co., Berlin 1978, pp. 604-1378.Rastelli 2006Rastelli, Sabrina, “Specchio con decoro a “dra-ghi””, in Lanciotti, Lionello - Scarpari, Mauri-zio (a cura di), Cina Nascita di un Impero, Ski-ra, Milano 2006, p. 289.Rastelli 2008Rastelli, Sabrina (a cura di), Cina, alla cortedegli Imperatori. Capolavori mai visti dallatradizione Han all’eleganza Tang (25-907),Skira, Milano 2008.
Rastelli, Scarpari 2008Rastelli, Sabrina - Scarpari, Maurizio (a curadi), Il Celeste Impero. Dall’Esercito di Terra-cotta alla Via della Seta, Skira, Milano 2008.Rawson 1984Rawson, Jessica, Chinese Ornaments: theLotus and the Dragon, British Museum Publi-cations Ltd., London 1984.Rawson 1996Rawson, Jessica (a cura di), Mysteries ofAncient China: New Discoveries from the EarlyDynasties, British Museum Press, London1996.Rawson, Bunker 1990Rawson, Jessica - Bunker, Emma C., AncientChinese and Ordos Bronzes, The OrientalCeramic Society, Hong Kong 1990.Raz 2007Raz, Gil, “Imperial Efficacy: Debates on Impe-rial ritual in early Medieval China and theEmergence of Daoist Ritual Schemata”, inReiter, Florian C. (a cura di), Purposes, Meansand Convictions in Taoism. A Berlin Sympo-sium, Asien-und Afrika-Studien 29 der Hum-boldt-Universität zu Berlin, Harrassowitz Ver-lag, Wiesbaden 2007, pp. 83-109.Rispoli 1999Rispoli, Fiorella, “Alcuni Bronzi Khmer”, inCiarla, Rispoli 1999, pp. 49-55.Rispoli 2004Rispoli, Fiorella, “Specchio Khmer”, in Cam-panelli – Pennetta 2003, p. 127.Rispoli 2007Rispoli, Fiorella, “The Incised & Impressed Pot-tery of Mainland Southeast Asia: Following thePaths of Neolithization”, East and West, vol. 57,fasc. 1-4, 2007, pp. 235-304.Rubinson 1985Rubinson, Karen S., “Mirrors on the Fringe:Some Notes”, Source: Notes in the History ofArt, vol. 4, fasc. 2/3, New York 1985, pp. 46-50.Sabattini, Santangelo 2008Sabattini, Mario - Santangelo, Paolo, Storiadella Cina, Laterza, Roma-Bari 2008.Salmony 1998Salmony, Alfred, Sino-siberian art in the Col-lection of C.T. Loo, edizione rivista del 1933 acura di Bruce L. Miller, SDI Pubblications,Thailand 1998.Sasano 1980Sasano, Masayuki, Kagamishi tsuba (Tsuba[realizzati] dagli artisti-artigiani di specchi),Tokyo 1980.Savage 1977Savage, Elizabeth, Seleucia on the Tigris: anexhibition of the excavations at Seleucia, Iraqby the University of Michigan, 1927-32, 1936-37, Kelsey Museum of Archaeology andAnthropology, Ann Arbor 1977.Schafer 1976Schafer, Edward H., “A Trip to the Moon”,Journal of the American Oriental Society, n.96, New Haven (CT) 1976, pp. 27-37.Schafer 1977Schafer, Edward H., Pacing the Void: T’angApproaches to the Stars, University of Califor-nia Press, Berkeley - Los Angeles 1977.Schiltz 2001Schiltz, Veronica (a cura di), L’Or des Amazo-nes, Peuples Nomades entre Asie e Europe, (VIe
siècle av. J.-C. - IVe siècle ap. J.-C.), MuséeCernuschi, Editions Findakly, Paris 2001.Schulten 2005Schulten, Caroline, “Some Notes on the Use of
Bronze Mirrors in the Tomb of Zhang Wenzao,Liao Period”, in Brown, Chou 2005, pp. 68-89.Sen 1999Sen, Tansen, “Astronomical Tomb Paintingsfrom Xuanhua: Maṇḍalas?”, Ars Orientalis, n.29, Washington 1999, pp. 29-54.Sen-oku 2004Sen-oku Hakuko. Kyōkan hen (Collezione Sen-oku: gli specchi), Sen-oku Hakukokan, Kyoto2004.Sen-oku 2006Dō kyō (Specchi Tang), Sen-oku Hakukokan,Kyoto 2006.Shang Chengzuo 1957Shang Chengzuo, Changsha chutu Chu qiqitulu (Catalogo delle lacche del regno di Churinvenute a Changsha), Zhongguo gudianyishu chubanshe, Beijing 1957.Shanghai 2005Chen Xiejun - Wang Qingzheng (a cura di),Lianxing shenzhi, yingzhi lianggong: Shanghaibowuguan cang tongjing jingpin (AncientBronze Mirrors from the Shanghai Museum),Shanghai shuhua chubanshe, Shanghai 2005.Shanxi 1993Shanxi sheng kaogu yanjiusuo, Houma zhutongyizhi (Siti per la fusione del bronzo a Houma),2 voll., Wenwu chubanshe, Beijing 1993.Shen 2006Shen, Hsueh-man, “Image in a Mirror, Moonin the Water: Liao Period Bronze Mirrors Inci-sed with Buddhist Images”, Orientations, vol.37, n. 6, Hong Kong 2006, pp. 58-64.Shen Congwen 1958Shen Congwen, Tang Song tongjing (Specchidi bronzo Tang e Song), Zhongguo gudianyishu chubanshe, Beijing 1958.Shen Congwen 2005Shen Congwen, Tongjing shihua (Storia deglispecchi di bronzo), Wanjuan chuban gongsi,Shenyang 2005.Shimizu, Mifune 2007Shimizu, Yasuji - Mifune, Haruisa, “Caoye wenjing fan yanjiu de xianzhuang he keti (Stato del-l’arte e problematiche a riguardo degli stampidegli specchi ornati con il motivo ‘a erbe efoglie’)”, in Bai Yunxiang, Shimizu 2007, pp.190-197.Simpson, Hermann 1995Simpson, St. John - Hermann, Georgina,“‘Through the Glass Darkly’ Reflections onSome Ladies from Merv”, Iranica Antiqua, vol.30, Gent 1995, pp. 141-158.Smith 1998Smith, Judith G. (a cura di), Arts of Korea,Metropolitan Museum of Art, New York 1998.Soper 1966Soper, Alexander C., La collezione Auriti: bron-zi cinesi, coreani, giapponesi, Museo Nazionaled’Arte Orientale, Roma 1966.Soper 1967Soper, Alexander C., “The ‘Jen Shou’ Mir-rors”, Artibus Asiae, vol. 29, fasc. 1, Ascona1967, pp. 55-66.Stafutti 2007Stafutti, Stefania, “Specchio”, in Invernizzi,Antonio - Messina, Vito (a cura di), Sulla via diAlessandro. Da Seleucia al Gandhara, SilvanaEditoriale, Cinisello Balsamo 2007, p. 225.Steinhardt 1997Steinhardt, Nancy S., Liao Architecture, Uni-versity of Hawaii Press, Honolulu 1997.Sun Kerang 1998Sun Kerang, “Tangdai zhu jing jiri kao (Studio
237
RIFLESSI 228-240:099��17-11-2012��11:58��Pagina�237
238
sui giorni fausti per la fusione degli specchi inepoca Tang)”, Shoucangjia - Collectors, n. 29,Beijing 1998, pp. 56-57.Sun Shuyun et al. 1992Sun Shuyun - Ma Zhaoceng - Jin Lianji,“Turang zhong de fuzhisuan dui tongjing biao-mian ‘heiqigu’ xingcheng de yingxiang(Influenza degli acidi umici del suolo nella for-mazione della superficie ‘nero lacca antico’degli specchi in bronzo)”, Wenwu, n. 12, Bei-jing 1992, pp. 79-89.Sun Shuyun et al. 1996Sun Shuyun - Zhou Zhongfu - Li Qianmao -Han Rufen - Ke Jun, “Tongjing biaomian ‘hei-qigu’ zhong ‘hen xiang’ de yanjiu. ‘Heiqigu’xingcheng jili yanjiu zhi er (Ricerche sullastruttura pseudomorfica del ‘nero lacca antico’sulla superficie degli specchi in bronzo. Secon-da ricerca sui meccanismi di formazione della‘nero lacca antico’)”, Ziran kexue shi yanjiu, n.2, Beijing 1996, pp. 179-187.Taiping guangjiTaiping guangji (Ampio resoconto dell’EraTaiping), compilato da Li Fang (925-996), ed.Zhonghua shuju, Beijing 1986.TaishoTaishō Shinshū Daizōkyō (Il Grande Canone[Buddhista], nuova compilazione dell’EraTaishō), ed. Takakutsu Junjirō e WatanabeKaikyoku, 100 voll., Taishō issaikyo kankōkai,Tokyo 1924-1935.Takeuchi 1911Takeuchi, Kimpei, “Ancient Chinese BronzeMirrors”, The Burlington Magazine for Con-noisseurs, vol. 19, n. 102, London 1911, pp.311-313, 316-319.Tan Derui 1989Tan Derui, Canlan de Zhongguo gudai shila fazhuzao (Splendide produzioni con il metododella cera persa nella Cina antica), Shanghaikexue wenxian chubanshe, Shanghai 1989.Tan Derui et al. 1996Tan Derui - Wu Laiming - Shu Wenfen - XuKexun, “Dong Han ‘shuiyinqin’ tongjing biao-mian chuli jishu yanjiu (Ricerche sul tratta-mento della superficie degli specchi in bronzocon la tecnica del ‘bagno di mercurio’ al tem-po degli Han Orientali)”, in Ma Chengyuan (acura di), Shanghai bowuguan wenwu baohukexue lunwenji (Collezione di saggi scientificiper la conservazione dei beni culturali delMuseo di Shanghai), Shanghai kexue jishuxianchu chubanshe, Shanghai 1996, pp. 96-108.Tan Derui et al. 1997Tan Derui - Wu Laiming - Tang Jingjuan - SuLimin, “Gu tongjing ‘shuiyinqin’ biaomianxingcheng jili de yanjiu” (Ricerche sui mecca-nismi di formazione delle superfici a ‘bagno dimercurio’ degli specchi in bronzo), Wenwubaohu yu kaogu kexue, n. 1, Shanghai 1997,pp. 1-9.Tanaka 1992Tanaka, Migaku, “Tsubai Ōtsukayama: Mir-rors within a Burial Mound”, in Pearson,Richard (a cura di), Ancient Japan, GeorgeBraziller, Washington 1992, pp. 216-219.Tanaka, Tsuboi 1977Tanaka, Migaku - Tsuboi, Kiyotari, Taku, Ken,Kagami (Campane, spade, specchi), Nihonbijutsu taikei vol. 4, Kōdansha, Tokyo 1977.Tang huiyaoTang huiyao (Compendio essenziale sui Tang),
compilato da Wang Pu (922-982) nel 691, 2voll., Shanghai guji chubanshe, Shanghai 1991.Taube et al. 2008Taube, Michelle - King, Alexander H. - Chase,Thomas III W., “Transformation of AncientChinese and Model Two-phase Bronze Surfa-ces to Smooth Adherent Patinas”, Phase Tran-sitions, n. 81, London 2008, pp. 217-232.Testa 1988Testa, Aurora, “Gli specchi Tang. Note sullacronologia e tipologia”, in Forte, Antonino (acura di), Tang China and Beyond. Studies onEast Asia from the Seventh to the Tenth Centu-ry, Italian School of East Asian Studies, Kyoto1988, pp. 205-250.Thompson 1967Thompson, Nancy, “The Evolution of theT’ang Lion and Grapevine Mirrors”, ArtibusAsiae, vol. 29, fasc. 1, Ascona 1967, pp. 25-54.Tianchang, Tianchang 2006Tianchang shi wenwu guanlisuo - Tianchangshi bowuguan, “Anhui Tianchang Xi Han mufajue jianbao (Rapporto breve di scavo di unatomba Han Occidentale a Tianchang, Anhui”,Wenwu, n. 11, Beijing 2006, pp. 4-21.TNM 1983Nihon no Kinkō (Japanese Metalwork SpecialExhibition), Tokyo National Museum, Tokyo1983.TNM 1988Nihon no Kōkogaku (Archeologia del Giappo-ne), Tokyo National Museum, Tokyo 1988.Tomita 1931Tomita, Kojiro, “Chinese Bronze Mirrors ofthe Second Century B.C.”, Bulletin of theMuseum of Fine Arts, vol. 29, n. 173, Boston1931, pp. 36-39.Trousdale 1961Trousdale, William, “A Chinese Handle-BearingMirror form Northern Afghanistan”, ArtibusAsiae, vol. 24, fasc. 1, Ascona 1961, pp. 11-19.Turner 1979Turner, Diana (a cura di), 5000 Years of Kore-an Art, Asian Art Museum of San Francisco,San Francisco 1979.Umehara 1935Umehara Sueji, Kan izen no kokyō no kenkyū(Ricerche sugli specchi antichi prima degliHan), Toho Bunka Gakuin Kyoto Kenkyujo,Kyoto 1935.Umehara 1954Umehara Sueji, “Sengoku jidai no saiga kyō(Specchi dipinti dell’epoca degli Stati Combat-tenti)”, Bijutsu kenkyū, vol. 178, Kyoto 1954,pp. 153-172.Vainker 2004Vainker, Shelagh, Chinese Silk, a CulturalHistory, The British Museum Press, London2004.van Berchem, Strzygowski 1910van Berchem, Max - Strzygowski, Josef, Ami-da, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung -Ernest Leroux, Heidelberg - Paris 1910.Vandermeersch 1960Vandermeersch, Léon, Les Miroirs de Bronzedu Musée de Hanoi, Publication de l’ÉcoleFrançaise d’Extrême-Orient vol. 46, ÉcoleFrançaise d’Extrême-Orient, Paris 1960.Villar 2008Villar, Francisco, Gli indoeuropei e le originidell’Europa, Il Mulino, Bologna 2008.Waley 1955Waley, Arthur, The Nine Songs: A Study of
Shamanism in Ancient China, Allen & Unwin,London 1955.Wang 1994Wang, Eugene Y., “Mirror, death, and Rheto-ric: Reading Later Han Chinese Bronze Arti-facts”, The Art Bulletin, vol. 76, n. 3, NewYork 1994, pp. 511-534.Wang 2005Wang, Eugene Y., “Mirror, Moon, and Memo-ry in Eight-Century China: From Dragon Pondto Lunar Palace”, in Brown, Chou 2005, pp.42-67.Wang et al. 1995Wang Changsui - Lu Bin - Zhang Shenghui -Tan Shun - Suzuki, Minoru - Chase, W. Tho-mas, “Structural and Elemental Analysis onthe Nanocrystalline SnO
2in the Surface of
Ancient Chinese Black Mirrors”, Nanostructu-red Materials, n. 4, vol. 5, Amsterdam 1995,pp. 489-496.Wang Changsui et al. 1989Wang Changsui - Xu Li - Wang Shengjun - LiHuhou, “Gu tongjing de jiegou chengfen fen-xi” (Analisi dei costituenti della struttura deglispecchi in bronzo), Kaogu, n. 5, Beijing 1989,pp. 476-480.Wang Jianzhong, Shan Xiushan 1990Wang Jianzhong - Shan Xiushan, Nanyangliang Han huaxiangshi (Le raffigurazioni supietra di epoca Han a Nanyang), Wenwu chu-banshe, Beijing 1990.Wang Mingfang 2009Wang Mingfang, “Xinjiang bowuguan xinshoucang de fangzhipin (Tessuti pervenuti direcente al Museo del Xinjiang)”, Wenwu, n. 2,Beijing 2009, pp. 83-89.Wang Shaoquan 1982Wang Shaoquan, “Hubei Xiangyang Leigutaiyi hao mu fajue jianbao (Rapporto breve discavo della tomba numero 1 del sito di Leigu-tai presso Xiangyang, Hubei)”, Kaogu, n. 2,Beijing 1982, pp. 147-154.Wang Shilun, Wang Mu 2006Wang Shilun - Wang Mu (a cura di), Zhejiangchutu tongjing (Specchi rinvenuti nel Zhe-jiang), Wenwu chubanshe, Beijing 2006.Wang Zhongshu 1981Wang Zhongshu, “Guanyu Riben sanjiaolushenshoujing de wenti (Sugli specchi giappone-si con [decoro a] Spiriti e Animali e bordo trian-golare), Kaogu, n. 4, Beijing 1981, pp. 346-358.Wang Zhongshu 2000Wang Zhongshu, “Lun Riben ‘fangzhi sanjiao-lu shenshoujing’ de xingzhi ji qi yu suo wei“bozai sanjiaolu shenshoujing” de guanxi (Sul-le caratteristiche degli ‘specchi giapponesid’imitazione con [decoro a] Spiriti e Animali ebordo triangolare” e il loro rapporto con i cosìdetti “specchi d’importazione con [decoro a]Spiriti e Animali e bordo triangolare)”, Kaogu,n. 1, Beijing 2000, pp. 78-88.Ware 1966Ware, James, Alchemy, Medicine, and Religionin the China of AD 320: The Nei-p’ien di KoHung, MIT Press, Cambridge (MA) 1966.Watson 1995Watson, William, The Arts of China to A.D.900, Pelican History of Art Series, Yale Uni-versity Press, New Haven-London 1995.Wei Jian 1998Wei Jian (a cura di), Nei Menggu zhongnanbuHandai muzang (Tombe di epoca Han nellaparte centro-meridionale della Mongolia
Interna), Zhongguo dabaike quanshu chuban-she, Beijing 1998.Weitz 2002Weitz, Ankeney, Zhou Mi’s Record of Cloudsand Mist Passing Before One’s Eyes. An Anno-tated Translation, Brill, Leiden 2002.Welch 2008Welch, Patricia B., Chinese Art: A Guide toMotifs and Visual Imagery, Tuttle Publishing,Singapore 2008.White, Bunker 1994White, Julia M. - Bunker, Emma C., Adornmentfor Eternity: Status and Rank in Chinese Orna-ment, Denver Art Museum in association withthe Wood Publishing Company, Denver 1994.Wieczorek et al. 2004Wieczorek, Alfried - Steinhaus, Werner - NaraBunkazai Kenkyūjo - Reiss-Engelhorn-Muse-en - Martin-Gropius-Bau, Zeit der Morgenrö-te: Japans Archäologie und Geschichte bis zuden ersten Kaisern, [Bd.1] Katalogband,Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim 2004.Williams 20064
Williams, Charles A.S., Chinese Symbolism andart Motifs: a Comprehensive Handbook on sym-bolism in Chinese Art through the ages, TuttlePublishing, Hong Kong 2006 (4a ed. riv.).Wong 1988Wong, Yangchung, “Bronze Mirror Art of theHan Dynasty”, Orientations, vol. 19, n. 12,Hong Kong 1988, pp. 42-53.Wong 2001Wong, Yanchung, “Bronze mirror art of the HanDynasty”, in Chinese Bronzes: Selected Articlesfrom Orientations 1983-2000, OrientationsMagazine Ltd., Hong Kong 2001, pp. 56-67.Xi’an 2004Xi’an shi wenwu baohu kaogusuo, “Xi’an shiChang’an qu Xibei Zhengfa xueyuan Xi HanZhang Tang mu fajue jianbao (Rapporto brevedi scavo della tomba di Zhang Tang [di perio-do] Han Occidentale all’Istituto di ScienzePolitiche e Legislative del Nordovest, distrettodi Chang’an, città di Xi’an)”, Wenwu, n. 6,Beijing 2004, pp. 22-28.Yang 1947Yang, Lien-sheng, “A note on the so-calledTLV mirrors and the game Liu-po“, HarvardJournal of Asiatic Studies, vol., 9, fasc. 3/4,Cambridge (MA) 1947, pp. 202-206.Yang 1952Yang, Lien-sheng, “An Additional Note on theAncient Game Liu-po”, Harvard Journal ofAsiatic Studies, vol. 15, fasc. 1, Cambridge(MA) 1952, pp. 124-139.Yen 2005Yen, Chuan-ying, “The Decorative Motifs onTang Dynasty Mirrors”, in Brown, Chou 2005,pp. 1-10.Yen Chuan-ying 1989Yen Chuan-ying, “Tangdai tongjing wenshi zhineirong yu fengge (Contenuto e stile delledecorazioni sugli specchi di epoca Tang)”,Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuojikan (Bulletin of the Institute of History andPhilology at Academia Sinica), Taibei 1989,pp. 289-366.Yetts 1939Yetts, Walter P., The Cull Chinese Bronzes,University of London-The Courtauld Instituteof Art, London 1939.Zhang Deqin 1992Zhang Deqin, Zhongguo wenwu jinghua (Il
RIFLESSI 228-240:099��17-11-2012��11:58��Pagina�238
meglio dei beni culturali cinesi), Wenwu chu-banshe, Beijing 1992.Zhao Kuanghua 1987Zhao Kuanghua, “Zhongguo lidai ‘huangtong’kaoshi (Studi sull’ ‘ottone’ nel corso della storiacinese)”, Ziran kexue shi yanjiu 4, Beijing 1987,pp. 323-331.Zheng 1996Zheng, Zhenxiang, “The Royal Consort Fu Haoand Her Tomb”, in Rawson 1996, pp. 240-247.Zhongguo 1959Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo,Shangcunling Guoguo mudi (Necropoli dellostato di Guo a Shangcunling), Kexue chuban-she, Beijing 1959.Zhongguo 1962Zhongguo lishi bowuguan kaogu zu (a cura di),“Yan Xiadu chengzhi diaocha baogao” (Rela-zione sugli studi del sito della città Xiadu diYan), Kaogu, n. 1, Beijing 1962, pp. 10-19, 54.Zhongguo 1985Zhongguo meishu quanji bianji weiuyuanhui,Zhongguo meishu quanji. Gongyi meishu bian4. Qingtongqi 1 (Raccolta completa di belle artidella Cina. Arti applicate, vol. 4. Bronzi parte1), Wenwu Chubanshe, Beijing 1985.Zhongguo 1986aZhongguo meishu quanji bianji weiuyuanhui,Zhongguo meishu quanji. Gongyi meishu bian5. Qingtongqi 2 (Raccolta completa di belle arti
della Cina. Arti applicate, vol. 5. Bronzi parte2), Wenwu Chubanshe, Beijing 1985.Zhongguo 1986bZhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuoHenan di’er gongzuodui, “Henan Yanshi Xing-yuancun de liuzuo jinian Tang mu (Sei tombeTang datate a Xingyuancun presso Yanshi,Henan), Kaogu, n. 5, Beijing 1986, pp. 429-457.Zhongguo 1991Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo(a cura di), Zhongguo kaoguxue zhong tan 14niandai shujuji (1965-1991) (Raccolta dati subase annuale degli studi archeologici rispettoall’esame al carbonio 14, periodo 1965-1991),Wenwu chubanshe, Beijing 1991.Zhongguo 1998Zhongguo qingtongqi quanji bianji weiyuanhui,Zhongguo qingtongqi quanji 16: tongjing (Rac-colta completa dei bronzi cinesi vol. 16 - Spec-chi di bronzo), Wenwu chubanshe, Beijing1998.Zhongguo 2004Zhongguo zhixiu tu wenshi quanji bianjiweiyuanhui, Zhongguo zhixiu tu wenshi quanji1 (Raccolta completa di motivi decorativi su tes-suti e ricami della Cina, vol. 1), Tianjin renminmeishu chubanshe, Tianjin 2004.Zhongguo 20052
Zhongguo qingtongqi quanji bianji weiyuanhui,Zhongguo qingtongqi quanji 16 - tongjing (Rac-
colta completa dei bronzi cinesi vol. 16 - Spec-chi di bronzo), Wenwu chubanshe, Beijing 2005(2a ed.).Zhongguo 2007Zhongguo guojia bowuguan (a cura di), Zhong-guo guojia bowuguan cang wenwu yanjiu con-gshu: huihua juan – fengsuhua (Collezione distudi sui beni culturali conservati presso ilMuseo Nazionale di Cina: rotoli dipinti - pittu-ra di genere), Shanghai guji chubanshe, Shang-hai 2007.Zhongguo, Riben 2007Zhongguo Shandong sheng wenwu kaogu yan-jiusuo - Riben Nailiang xianli Jiangyuan kaogu-xue yanjiusuo (a cura di), “Shang bian. LinziQiguo gucheng chutu jing fan ziliao jicheng(Parte I. Compendio sui materiali degli stampidegli specchi rinvenuti nel sito di Linzi, dell’an-tica città dello stato di Qi)”, in Bai Yunxiang,Shimizu 2007, pp. 1-92.ZhouWeirong 1991Zhou Weirong, “Zhongguo gudai yong xin lishixin tan (Nuova indagine storica sull’impiegodello zinco nella Cina antica)”, Ziran kexue shiyanjiu, n. 3, Beijing 1991, 259-266.Zhou Ya 2005Zhou Ya, “Tongjing shiyong fangshi de kaoguziliao fenxi (Using Methods of Bronze Mirrorsin Archaeological Evidence)”, in Shanghai2005, pp. 54-67.
239
RIFLESSI 228-240:099��17-11-2012��11:58��Pagina�239




















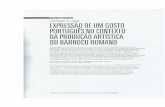

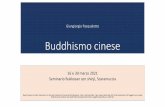

![Il Modenese: archeologia di una provincia dalla preistoria all’età moderna, in Modena una provincia allo specchio, Milano 2003, pp. 16-44 [Donato Labate]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631f1f7ddbf7564007029943/il-modenese-archeologia-di-una-provincia-dalla-preistoria-alleta-moderna-in.jpg)













