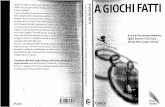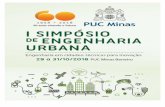Gli ottant'anni di F.P. Casavola: cronaca di due giornate, in SDHI. 78 (2012) pp. IX-LXI
Il XVI Centenario Costantiniano del 1913. Cronaca e significati di un evento, in «Archivio italiano...
Transcript of Il XVI Centenario Costantiniano del 1913. Cronaca e significati di un evento, in «Archivio italiano...
Francesco tacchi
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913
cronAcA e SIgnIFIcATI dI un evenTo*
Pochi forse rilevano la singolarità di questo fatto: che cioè nel secolo XX si celebri con tanto fervore e studio un avvenimento del Iv secolo, della cui cen-tenaria commemorazione non si ha, che mi consti, notizia nei sedici secoli già trascorsi. Perché mai fremono oggi i cuori, come al tocco di arpa magica, ad un ricordo, che durante sedici secoli non fu rievocato né per tempeste d’odio, né per entusiasmi di amore? È gravissima e terribile, o signori, la risposta a questa domanda1.
nel momento in cui l’avvocato Stefano Scala – direttore del quotidia-no cattolico intransigente L’Italia Reale2 – pronunciava queste parole, le feste commemorative del XvI centenario della promulgazione dell’edit-to di milano, oggetto del suo discorso, erano ormai entrate nella loro fase culminante. da qualche mese, infatti, i cattolici di tutto il mondo – ma in particolare i cattolici d’Italia – stavano dando luogo a manifestazioni volte a ricordare i successi dell’Imperatore costantino – in primis la sua vittoria su massenzio a Ponte milvio – e soprattutto la libertà legale da lui accordata alla chiesa: l’editto, secondo la retorica impiegata durante il centenario, avrebbe infatti coinciso con il primo dei trionfi storici cono-
* Il presente contributo è stato realizzato nell’ambito di un corso seminariale tenuto dal prof. daniele menozzi presso la Scuola normale Superiore di Pisa nell’a.a. 2012-2013, e discusso in data 16 aprile 2013. Successivamente si è provveduto a revisioni e aggiornamenti in vista della pubblicazione.
1 Il significato religioso e sociale delle odierne commemorazioni costantiniane. Conferenza tenuta a Foglizzo Canavese l’8 giugno 1913 dall’ Avv. Stefano Scala, Torino, Tip. P. casalegno e c. valentino, 1913, p. 5.
2 Stefano Scala (1848-1923) è stato uno dei principali animatori del giornalismo cattolico d’area piemontese fra otto e novecento: il suo nome è legato soprattutto a quello de L’Italia Reale, di cui fu lo storico direttore. Su tale figura manca uno studio biografico: alcuni utili informazioni si trovano tuttavia in g. dotta, “La Voce dell’Opera-io”. Un giornale torinese tra Chiesa e mondo del lavoro (1876-1933), Torino, effatà, 2006, pp. 11-12.
«Archivio italiano per la storia della pietà», XXVII (2014)© 2014 Edizioni di Storia e Letteratura – www.storiaeletteratura.itISSN (paper): 1128-6768 ISBN (paper): 978-88-6372-713-5 ISBN (e-book): 978-88-6372-714-2
FrAnceSco TAcchI244
sciuti dalla Sposa di cristo, da quel momento capace di dispiegare senza ostacoli la propria missione civilizzatrice fra i popoli della terra3.
l’osservazione di Scala era corretta: nei quindici anniversari che ave-vano preceduto il 1913, le gesta di costantino non erano state oggetto di commemorazione alcuna. Perché, dunque, si era deciso di dar corso a questo unicum? Secondo il giornalista piemontese, fra i tempi del primo imperatore cristiano ed il presente sarebbe esistita una particolare analo-gia, «l’analogia dell’antitesi»4:
Allora il mondo si moveva, da pagano qual era, a diventare ufficialmente cristiano; oggi, cristiano da tanti secoli, è spinto ufficialmente a ridiventare pagano. (…) Allora i cristiani, benché numericamente in minoranza, erano, per divina grazia, riusciti a saturare, diciam così, tutto l’ambiente sociale del pen-siero cristiano: oggi sono i settarii, che, minoranza numerica, hanno imbevuto del pensiero pagano l’aria stessa che si respira dalla maggioranza cristiana del popolo. Allora la marea grigia, incolore, fluttuante, della popolazione nata nel paganesimo, trovavasi però predisposta a convertirsi a gesù cristo, e potea bastare, per molti, ad indurveli una spinta dell’autorità civile; oggi la massa della popolazione nata nel cristianesimo è predisposta pur troppo all’apostasia, l’enorme influsso del giornalismo paganeggiante ve la predispone ognor più, e la spinta ufficiale ve la trascina. non vi pare, o signori, ch’io abbia un po’ di ragione nel dire che i tempi nostri hanno con quelli di costantino l’analogia del rovescio della medaglia? 5
ricordare l’età costantiniana dopo sedici secoli si sarebbe dunque rivelata una necessità imprescindibile, e ciò per l’essere in atto un processo inverso rispetto a quello che aveva condotto la società pagana a divenire cristiana: di fronte all’avanzata di un neopaganesimo da identificare con la temperie secolarizzatrice, all’esistenza del ‘moderno’ Stato laico – e dunque ateo –, visto come un’ aberrazione colpevole di aver limitato la libertà della chiesa, rievocare l’epoca del passaggio dalle catacombe alle basiliche, dalle persecuzioni al pieno riconoscimento dei cristiani per opera di costantino – instinctu divinitatis, ossia mosso dalla divina Provvidenza – sarebbe ser-
3 cfr. «la civiltà cattolica», 1 (1913), Le feste centenarie dell’editto costantiniano, p. 6: «Quel giorno (…) apriva, con l’editto costantiniano, un’era nuova di pace e di libertà, e perciò di trionfi e di conquiste, alla chiesa!».
4 Il significato religioso e sociale delle odierne commemorazioni costantiniane, p. 6.5 Ibidem, pp. 6-7. Affermazioni volte a sottolineare un legame fra Iv e XX secolo si
trovano di frequente negli interventi di parte cattolica dedicati alle feste costantiniane: nel gennaio 1912, ad esempio, La Civiltà Cattolica parlò di una «ricorrenza sedici volte centenaria così viva e palpitante di terribile attualità, che raramente ce ne porge un altro [sic!] simile la storia» («la civiltà cattolica», 1, 1912, Il XVI centenario della pace costan-tiniana, p. 8. corsivo così nel testo).
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 245
vito a compattare l’orbe cattolico attorno alla Santa Sede ed a lanciare un forte messaggio di opposizione e di alternativa all’incalzante rivoluzione6; nella forma e nel significato generale, quindi, le feste costantiniane si pose-ro in continuità con la prassi dei centenari e dei giubilei straordinari che aveva caratterizzato i pontificati di Pio IX e leone XIII7.
la commemorazione della libertà accordata alla chiesa ebbe un carat-tere universale, coinvolgendo le diocesi di tutto il mondo: ciò nonostante, lo sguardo di coloro che di essa furono promotori e organizzatori rimase sempre ben fisso sull’Italia, dove le feste assunsero il maggior rilievo; la genesi ed il significato delle celebrazioni stesse, del resto, possono essere pienamente compresi soltanto facendo riferimento alle vicende che dall’unità avevano caratterizzato la storia della penisola: in virtù di questo, sarà il solo contesto italiano – e soprattutto romano – ad essere oggetto del mio contributo, da considerare come una proposta d’indagine8
6 con il termine rivoluzione (solitamente minuscolo, per non confonderlo con la Rivoluzione francese quale evento storico ben determinato) il mondo cattolico italiano – e soprattutto la sua ala intransigente – si riferiva a «tutte le idee e gli avvenimenti che [avevano] sconvolto le tradizioni politico-religiose della società cristiana in europa» (P. g. camaiani, Il diavolo, Roma e la rivoluzione, «rivista di storia e letteratura religiosa», 3, 1972, p. 489): in questo senso, rivoluzione andava di fatto a coincidere con secola-rizzazione, comprendendo in sé anche elementi fra loro eterogenei quali liberalismo, socialismo, massonismo e libero pensiero.
7 cfr. r. rusconi, Santo Padre: la santità del Papa da san Pietro a Giovanni Paolo II, roma, viella, 2010, pp. 415-431.
8 la documentazione alla base del presente contributo è in massima parte a stam-pa; fa eccezione il materiale archivistico proveniente dall’Archivio Arcivescovile di Pisa, diocesi retta all’epoca del centenario dal cardinale Pietro maffi, il quale rivolse notevole attenzione alla vicenda qui presa in esame. una fonte fondamentale – finora rimasta inutilizzata – si è rivelato il Bollettino edito a cura del consiglio Superiore responsabile delle manifestazioni costantiniane (intitolato XVI Centenario della pace della Chiesa 313-1913), dove vennero via via riportate le cronache delle celebrazioni romane, italiane ed estere, e più in generale ogni informazione relativa all’evento. In tutto ne furono realizzati 15 numeri fino al dicembre 1913 – più un supplemento –: la prima pagina di ciascuno recava il monogramma costantiniano e la scritta In hoc signo vinces. Parallelamente al Bollettino, fu «l’osservatore romano» a fungere in qualche modo da ‘organo ufficiale’ del centenario: di qui l’imprescindibilità dell’analisi di tale quotidiano per il presente articolo, cui si è affiancato lo spoglio dei principali periodici cattolici dell’epoca. Sul piano ‘locale’ si è scelto invece di ricorrere principalmente a tutta una serie di opuscoli e di lettere Pastorali editi nelle singole diocesi fra il 1912 ed il 1914: una tipologia di fonte spesso considerata ‘minore’ dagli studiosi, e tuttavia dalle notevoli potenzialità euristiche. la base documentale relativa al centenario può e deve ad ogni modo essere ampliata – per questo ho parlato di «proposta d’indagine» –, soprattutto attraverso un’esplorazione attenta degli Archivi vaticani che ricostruisca più in dettaglio il ruolo ed il punto di vista della Santa Sede in merito alla vicenda.
FrAnceSco TAcchI246
su di un evento che solo recentemente – nella propria ricorrenza centena-ria – ha riscosso qualche attenzione da parte della storiografia9.
1. La genesi del Centenario (1906-1912).
l’idea di una commemorazione cominciò a circolare fra i cattolici italiani già alcuni anni prima del 1913: nel settembre 1906, infatti, questa possibilità fu discussa a milano durante un congresso dell’Associazione italiana per la tutela giuridica degli interessi religiosi; a lanciare e sostenere la proposta fu Filippo meda, segretario del sodalizio10. Per dar forza al proprio progetto, nel 1907 meda ricercò la collaborazione della Società cattolica italiana per gli studi scientifici e dell’Unione popolare fra i cattolici d’Italia: in questo modo, il giornalista milanese coinvolse nell’iniziativa alcune personalità di spicco dell’azione cattolica italiana, fra cui il pro-prio ‘padre spirituale’ giuseppe Toniolo11. Il 5 aprile 1907 venne diffuso
9 I primi contributi specialistici dedicati al centenario sono apparsi infatti solo nel 2013: cfr. S. de nardis, 1913. L’Italia e il XVI centenario dell’editto di Milano, in Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto editto di Milano 313-2013, roma, Istituto della enciclopedia Italiana, 2013, vol. 3, pp. 447-460; r. Pertici, «Libertà del Papa», «libertà dei cattolici». Il XVI centena-rio costantiniano (1912-1913) e la politica italiana, «Studium», 3 (maggio-giugno 2013), pp. 378-406; g. Zanchi, Il centenario dell’editto di Milano (313) in don Angelo Roncalli, «Joannes XXIII. Annali della Fondazione Papa giovanni XXIII», 1 (2013), pp. 9-44 (dove per la parte introduttiva dedicata al centenario, prima di focalizzarsi sulle rifles-sioni del giovane roncalli, Zanchi riprende esplicitamente da Pertici). meritano inoltre d’essere qui menzionati alcuni studi dedicati alle Settimane Sociali dei cattolici italiani, giacché quella del 1913 si pose esplicitamente a suggello dell’anno costantiniano: cfr. Le settimane sociali dei cattolici italiani (1907-1991), a cura di g. di capua, roma, edizioni ebe, 1991, pp. 39-48; soprattutto La cultura sociale dei cattolici italiani alle origini: le “settimane” dal 1907 al 1913. Materiali documentari per una ricostruzione degli atti, a cura di A. robbiati, milano, vita e Pensiero, 1995, vol. 3, 1912-1913, pp. 123-483.
10 cfr. «l’unione cattolica», 24 dicembre 1911, Il centenario della libertà cristiana. Sul profilo e sul ruolo di meda nell’ambito del cattolicesimo italiano d’inizio novecento è stato – giustamente – scritto molto: mi limito solo a rimandare al contributo di g. de rosa, Filippo Meda e l’età liberale, Firenze, le monnier, 1959, e alla voce relativa in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia (1860-1980), vol. 2, I protagonisti, casale monferrato, marietti, 1982, pp. 354-363.
11 Proprio Toniolo fornisce una conferma di come la ‘paternità’ dell’idea della commemorazione costantiniana debba essere ascritta a meda: in un articolo pubbli-cato sulla Rivista internazionale nel 1913, il professore riconobbe infatti al giornalista milanese «il merito di [aver] propo[sto], forse primo in Italia, da parecchi anni tali studi commemorativi dell’odierna ricorrenza costantiniana» (g. Toniolo, Problemi e ammaestramenti sociali dell’età costantiniana, «rivista internazionale di scienze sociali e
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 247
un appello dal titolo Il centenario della libertà cristiana, firmato non sol-tanto da meda e dal professore trevigiano, ma pure, fra gli altri, da mons. Pietro maffi, Arcivescovo di Pisa, da Salvatore Talamo, direttore della Rivista internazionale di scienze sociali, e da giuseppe nogara, direttore de La Scuola Cattolica; in esso comparivano già alcuni di quei riferimenti che avrebbero costituito i cardini della retorica cattolica durante le cele-brazioni del 1913:
In una età, come la nostra, in cui il fondamentale problema della libertà reli-giosa e dei rapporti fra la chiesa e gli Stati, s’è posto in termini preoccupanti; in una età nella quale si elaborano, inconsce le genti, forse, elementi nuovi di vita sociale, e si intravedono per il cattolicesimo compiti gravissimi, ai quali non sarà inadeguata ogni maggior preparazione intellettuale e morale, l’attingere ispirazione ed energie risalendo collo spirito agli inizi della libertà cristiana, non può che essere salutare: tanto più se si rifletta che dopo sedici secoli la chiesa è condotta ancora ad invocare dai governi che si rispetti in lei, e nei suoi figli, quel diritto primordiale alla esistenza che un rinato paganesimo politico vorrebbe ritoglierle12.
malgrado le incoraggianti premesse, tuttavia, nel giro di pochi mesi l’iniziativa andò incontro a naufragio; perché la proposta di una com-memorazione fosse di nuovo formulata convintamente si sarebbe dovu-to attendere il settembre 1910: allora, parlando nel duomo di milano durante le feste centenarie di san carlo Borromeo, mons. carmelo Pujia, Arcivescovo di Santa Severina, «salut[ò], alla fine del [proprio] discorso, il grande centenario, che, nel 1912 e 1913, [avrebbe] dov[uto] stringere intorno alla croce i popoli civili del mondo13». Alle parole del prelato non seguirono azioni concrete, e tuttavia esse sono indicative di come già all’epoca, fra i cattolici d’Italia, fosse radicato il proposito di non lasciar passare il 1912 – anniversario di Ponte milvio – ed il 1913 – anniversario dell’editto costantiniano – senza aver dato luogo ad una qualche forma di commemorazione.
con la fine del 1911 il centro dell’iniziativa si spostò da milano a Torino: da quel momento, infatti, a farsi strenuo banditore della proposta di ricor-dare le gesta di costantino fu L’Italia Reale di Stefano Scala. nel primo
discipline ausiliarie», maggio 1913, p. 26 – in nota – ); si veda pure g. Toniolo, Lettere, vol. 3, 1904-1918, città del vaticano, comitato Opera Omnia di giuseppe Toniolo, 1953, pp. 101-102 (lettera del 15 aprile 1907 a giorgio castelli).
12 l’appello del 1907 è riportato in «l’unione cattolica», 24 dicembre 1911, Il cen-tenario della libertà cristiana.
13 La Chiesa di Gesù Cristo nel grande Centenario – Lettera Pastorale di Mons. Carmelo Pujia, Arcivescovo metropolitano di Santa Severina, assistente al soglio pontificio, prelato domestico di S.S. e conte per la quaresima del 1912, roma, descléè, 1912, p. 5.
FrAnceSco TAcchI248
articolo dedicato dal foglio piemontese al tema costantiniano – in data 19 novembre –, se da un lato si affermava di non sapere «che cosa [avrebbe] fa[tto] l’Italia ed il mondo cattolico per celebrare la liberazione di roma e dell’Italia dalla tirannide di massenzio fatta da costantino il grande»14, dall’altro si dava però per sicuro il tenersi di tale celebrazione, al contempo lasciandosi sfuggire una frase assai significativa: «certo conviene che tra le feste italianissime e le cattoliche ci passi qualche tempo in mezzo»15.
Il bersaglio di tale allusione erano le manifestazioni andate in scena per il 50° anniversario dell’unità d’Italia nelle ‘tre capitali’ Firenze, roma e Torino – in quest’ultima la grande esposizione Internazionale si era conclusa solo alla fine di ottobre. Il riferimento polemico a tali festeg-giamenti non fu un tratto esclusivo del quotidiano piemontese: appena poche settimane più tardi, infatti, La Civiltà Cattolica avrebbe parlato «per l’Italia ufficiale [di] una festa di frivolezza che va a finire nel lutto di una guerra, che per quanto guerra di popolo civile contro un barbaro, è sempre dolorosa causa di stragi»16; La Scuola Cattolica del gennaio 1912 avrebbe addirittura opposto esplicitamente le auspicate feste costantinia-ne alle celebrazioni del cinquantenario:
Le feste centenarie di quest’anno e dell’anno prossimo sono – e non possono non esserlo – in assoluto contrasto colle feste appena terminate: così come il 312 e il 313 sono storicamente l’antitesi del 1861 e del 1870. (…) la breccia di Porta Pia e la anteriore proclamazione dell’unità d’Italia in Firenze da alcuni – e forse questo poté anche essere nello spirito di chi diresse i fatti – si vorrebbe che denotassero per la chiesa il termine della parabola grandiosa che aveva avuto il suo inizio nel trionfo di costantino; mentre questi stessi recenti avvenimenti segnerebbero il formarsi, o meglio il riprendersi di un’altra parabola ascendente, quella del pensiero laico, strettamente ricollegantesi collo spirito pagano, perito già nei gorghi del Tevere con massenzio, l’ultimo dei dominatori pagani (…). Il contrasto quindi c’è: anzi sarà questo appunto che darà maggior rilievo alle nostre feste, perché esse saranno l’affermazione in faccia al mondo che il cristianesimo non è ancora morto, ma che vive prospera e ascende tuttavia17.
14 «l’Italia reale», 19 novembre 1911, Torino e il XVI Centenario della vittoria di Costantino.
15 Ibidem. corsivo così nel testo.16 «la civiltà cattolica», 1 (1912), Il XVI Centenario della pace costantiniana, p. 4.
Il riferimento è ovviamente alla guerra italo-turca. la rivista dei gesuiti sarebbe tornata sulla critica delle feste nazionali nel 1914, parlando di «quei festeggiamenti cinquante-nari dell’anno 1911, a cui si volle dare disgraziatamente l’impronta dell’opposizione alla chiesa» («la civiltà cattolica», 2, 1914, Costantino, Carlomagno e Napoleone – Lezioni di centenari, 814-1814-1914, p. 129).
17 «la Scuola cattolica», anno Xl (gennaio 1912), p. 144. Il corsivo è mio.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 249
Si è visto come l’idea della celebrazione costantiniana abbia prece-duto, cronologicamente, il 1911: proprio tale anno, tuttavia, deve essere considerato come il brodo primordiale alla base delle iniziative comme-morative messe in campo dai cattolici d’Italia – e di riflesso del resto del mondo – nel biennio successivo. non credo di andar lontano dal vero, infatti, affermando che il XvI centenario costantiniano finì per confi-gurarsi anche come la risposta della chiesa – su scala universale – alle feste cinquantenarie dell’unità d’Italia, durante le quali esaltazione dello Stato laico risorgimentale ed acuirsi dei toni anticlericali avevano forma-to uno stretto connubio; ciò ad ogni modo non esclude che la polemica contro la statolatria, principale topos delle celebrazioni costantiniane, si sia nutrita pure di esempi extra-italiani: penso alla Francia di Émile combes, così come al Portogallo repubblicano che nell’aprile del 1911 arrivò a votare la legge di separazione fra Stato e chiesa18.
lo stesso Papa Pio X, in un’allocuzione pronunciata il 27 novembre, ebbe a commentare negativamente le feste cinquantenarie: «l’anno che ormai volge al tramonto è stato per noi, in modo particolare luttuoso: e tutti lo intendono. non ci fermeremo qui a rilevare il profondo dolore che a noi ed a ogni devoto figlio della chiesa ha recato la clamorosa commemorazione di avvenimenti dai quali, come è a tutti manifesto, ebbero principio tante e sì gravi offese ai diritti della Sede Apostolica, quante ne furono inflitte fino ad oggi»19. nessuna sorpresa, dunque, se L’Osservatore Romano del 1° dicembre, commentando l’allocuzione papa-le, affermava che i recenti festeggiamenti avevano «ribollito di proposito per far sentire al Papato che esso [era] sotto ostile dominazione»20.
Alla fine del 1911, tuttavia, nelle stanze del vaticano ci si stava ormai muovendo per giungere all’allestimento di quella commemorazione centenaria a lungo invocata e attesa: ma perché questo lavorio sotter-raneo venisse alla luce, si dovette attendere fino al 25 gennaio 1912. Quel giorno, L’Osservatore Romano pubblicò il testo di una lettera con cui rafael merry del val, Segretario di Stato di Pio X, aveva comuni-cato a Francesco di Paola cassetta, cardinale e vescovo di Frascati, la decisione del Papa di costituire un consiglio Superiore che si occupasse di organizzare le feste commemorative del XvI centenario dell’editto di milano: per volere del Pontefice stesso, il cassetta avrebbe dovuto
18 Al carattere di ‘risposta’ assunto dal centenario costantiniano allude anche r. Pertici, «Libertà del Papa», «libertà dei cattolici», p. 382.
19 Il testo dell’allocuzione è riportato in «l’osservatore romano», edizione straor-dinaria del 27 novembre 1911.
20 «l’osservatore romano», 1° dicembre 1911, L’anima papale.
FrAnceSco TAcchI250
assumere la carica di ‘alto protettore’ di tale organo21. nella lettera si rendeva noto come la proposta della celebrazione centenaria fosse stata presentata a Pio X da due associazioni romane, il Collegium Cultorum Martyrum22 e la Primaria Associazione della SS. Croce23: il consiglio Superiore nominato dal Papa risultò essere in buona parte un’emana-zione di questi due sodalizi, vedendo al proprio interno rappresentanti della nobiltà ‘nera’ romana – come i colonna e i chigi – a fianco di sacerdoti e laici con interessi e competenze nell’ambito dell’archeologia e della storia sacra24. Avviata la macchina organizzativa, già il 1° marzo il consiglio Superiore fu in grado di rendere noto il proprio Programma, che fin dall’apertura si preoccupava di inquadrare l’oggetto dell’ormai prossima commemorazione:
nell’anno 1913 ricorrerà il XvI centenario della libertà e della pace donata alla chiesa mediante il riconoscimento ufficiale del cristianesimo e dei diritti più essenziali inerenti alla società cristiana, proclamato dall’Imperatore costantino con l’editto di milano nella primavera del 313. Questo gran fatto, preceduto dalla vittoria riportata da costantino sopra massenzio presso le mura di roma il 28 ottobre del 312, ebbe un’importanza ed un significato altissimo nella storia ed è degno che sia ricordato, specialmente ai nostri giorni25.
21 la lettera di merry del val recava la data del 24 gennaio. Su Francesco di Paola cassetta (1841-1919), vescovo di Frascati dal novembre 1911, si veda F. malgeri, Dizionario Biografico degli Italiani, roma, Istituto della enciclopedia Italiana, 1978, vol. 21, pp. 457-458.
22 Il Collegium era stato fondato nel febbraio 1879 da una schiera di archeo-logi e studiosi di antichità sacra, fra cui Armellini, hytreck, Stevenson e orazio marucchi – quest’ultimo nominato Segretario del consiglio Superiore –; prin-cipali attività del sodalizio erano la promozione del culto dei martiri e l’attività scientifica di ricostruzione della loro vita e opere. oggi l’associazione continua a vivere con il nome di Pontificia Accademia cultorum martyrum. Si veda la pagi-na www.vatican.va/roman_curia/ pontifical_academies/cult-martyrum/documents/rc_pa_martyrum_20020924_storia_it.html.
23 la Primaria Associazione della SS. Croce, con sede nella Basilica Sessoriana di Santa croce in gerusalemme, era nata nel 1896 in occasione delle feste per celebrare l’vIII centenario della prima crociata; informazioni su tale sodalizio si trovano in «l’osservatore romano», 31 gennaio 1912, La morte di Don Marcantonio Colonna.
24 Fra questi spiccava la figura di Anton de Waal (1837-1917), rettore del campo Santo Teutonico; nel 1876 egli era stato promotore del Collegium Pium, istituto votato agli studi archeologici e di storia della chiesa, interessi che coltivò per tutta la vita. cfr. e. gatz, Anton de Waal (1837–1917) und der Campo Santo Teutonico, rom, Freiburg, Wien, herder, 1980. la lista dei membri del consiglio Superiore è elencata da merry del val sempre nella lettera del 24 gennaio.
25 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 1 (settembre 1912), pp. 3-4.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 251
Il Programma stabiliva poi i due obiettivi principali da raggiungere nel periodo dei festeggiamenti: «1. erigere un monumento sacro presso il Ponte milvio, dove l’Imperatore costantino sconfisse massenzio, che ricordi alle generazioni future quei gloriosi fatti e soddisfaccia altre-sì ai bisogni spirituali della popolazione di quel nuovo quartiere; 2. Promuove[re] dappertutto in Italia e fuori solenni azioni di grazie a dio e speciali festeggiamenti e pubblicazioni scientifiche e popolari di circo-stanza che facciano conoscere a tutti l’importanza del gran fatto religioso e storico che si commemora»26.
Al fine di contribuire alla riuscita dell’evento, i vescovi di tutto il mondo furono invitati a formare nelle proprie diocesi un comitato locale – anche a roma ne fu costituito uno, emanazione del consiglio Superiore – «sicché da ogni parte si concorr[esse] a ricordare un tanto avvenimento nel modo che, secondo le intenzioni dei luoghi, si [fosse] cred[uto] più conveniente»27; gli ordinari diocesani avrebbero dovuto inoltre preoccuparsi di raccogliere offerte da destinare alla costruzione dell’annunciato «monumento sacro» – la futura Basilica di Santa croce a Ponte milvio28 –, e di organizzare pel-legrinaggi a roma per l’anno 1913.
la grande commemorazione del centenario costantiniano sarebbe stata motivo di gioia per «le nazioni cattoliche, e specialmente l’Italia, che più delle altre sentì il benefico influsso della nuova civiltà portata dal cristianesimo»29; gli occhi del mondo e degli italiani erano però tenuti a convergere in un punto ben preciso: «Fra tutte le città d’Italia deve roma esultarne perché, sede dei successori di Pietro, effuse con nuova gloria i suoi raggi di supremazia, di fede, di giustizia e di carità in tutto il mondo civile»30. e roma, la roma di Pio X da un lato, del sindaco ernesto nathan31 e del laico governo italiano dall’altro, fu appunto il centro delle feste costantiniane.
26 Ibidem, p. 4. Il Programma reca la firma di orazio marucchi, Segretario del consiglio Superiore, e del Principe mario chigi, Presidente.
27 Ibidem.28 l’idea di un monumento commemorativo a Ponte milvio si trova già in un artico-
lo de La Civiltà Cattolica del gennaio 1912 (Il XVI Centenario della pace costantiniana, p. 19): «Ai festeggiamenti (…) noi vorremmo che andasse unito un intento pratico e un frutto duraturo. Tale sarebbe fra gli altri omaggi, un monumento perenne a cristo vin-citore eterno su quei campi che videro, primi nella polvere, i vessilli del paganesimo con le sgominate schiere del tiranno». mi pare possibile ipotizzare una filiazione diretta fra tale proposta e l’iniziativa presentata dal consiglio Superiore.
29 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 1 (settembre 1912), p. 4.30 Ibidem.31 ernesto nathan (1845-1921), di famiglia ebrea, fu sindaco di roma dal 1907 al
novembre 1913, gran maestro del grande oriente d’Italia fra il 1896 e il 1904 – e poi
FrAnceSco TAcchI252
2. Le celebrazioni romane.
le feste allestite nel cuore della cattolicità furono il frutto dell’azio-ne coordinata del consiglio Superiore e del comitato romano; il Programma dei festeggiamenti locali era pronto già alla metà del 1912: in base ad esso, fra marzo e giugno dell’anno seguente si sarebbe rag-giunto l’apice delle celebrazioni con un ciclo di feste religiose «nelle basiliche costantiniane e in quegli antichi cimiteri cristiani ove si con-serva memoria dei due grandi pontefici milziade e Silvestro che vissero al tempo di costantino»32; funzioni solenni erano previste anche in momenti successivi fino all’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, data di chiusura del centenario costantiniano. Accanto al programma delle feste religiose si stabilì di ricordare la vittoria di Ponte milvio (28 otto-bre 1912) e di allestire una serie di conferenze ripartite in due categorie, ossia di alta cultura e popolari, finalizzate a diffondere la consapevolezza dell’«importanza del grande avvenimento della proclamazione della pace della chiesa»33. Alcune iniziative, tuttavia, precedettero l’inizio ufficiale dei festeggiamenti: già nel gennaio 1912, nella chiesa di san marcello cominciò un ciclo di conferenze domenicali volto ad illustrare i temi del centenario; il 1° luglio, invece, nel quartiere casilino fu posta la prima pietra della chiesa parrocchiale di santa elena, aperta al culto nel 191434.
malgrado queste ‘anticipazioni’, si dovette attendere il mese di otto-bre perché il consiglio Superiore ed il comitato romano presiedessero ufficialmente alle celebrazioni. Il 17 ebbe luogo la solenne cerimonia di posa della prima pietra della nuova basilica costantiniana, il cui progetto era stato affidato ad Aristide leonori, architetto scelto dal Pontefice35: dedicata alla Santa croce, la chiesa sarebbe stata finanziata in parte a spese della curia, in parte attraverso le oblazioni dei fedeli36; l’onore di
dal 1917 al 1919 –, e uno dei fondatori della “Società dante Alighieri”; cfr. n. ciani, Da Mazzini al Campidoglio: vita di Ernesto Nathan, roma, ediesse, 2007.
32 «l’osservatore romano», 8 maggio 1912, Le feste centenarie della proclamazione della pace della Chiesa (313-1913).
33 Ibidem.34 cfr. «l’osservatore romano», 2 luglio 1912, Solenne posa di prima pietra della
Chiesa di S. Elena.35 Su Aristide leonori (1856-1928), specializzato nella progettazione di edifici religio-
si, si veda F. di marco, Dizionario Biografico degli Italiani, 2005, vol. 64, pp. 626-627. 36 A tal proposito merita di essere segnalata l’iniziativa dell’Unione fra le donne
cattoliche d’Italia, che scelse di erigere a proprie spese la cappella di santa elena all’in-terno della nuova basilica. cfr. «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 4 (gennaio 1913), p. 17.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 253
compiere la cerimonia spettò al cardinal cassetta, in quanto ‘protettore’ del consiglio Superiore37.
Pochi giorni dopo ricorse l’anniversario della vittoria ottenuta da costantino a Ponte milvio. Inizialmente si era pensato di commemo-rare tale evento ponendo un’iscrizione nel luogo della battaglia, «ma in seguito il consiglio Superiore, volendo dare a questa commemorazione la maggior solennità possibile e desiderando che ad essa intervenissero il Sacro collegio degli e.mi cardinali, il corpo diplomatico accredita-to presso la Santa Sede, il Patriziato e le rappresentanze degli Istituti scientifici e religiosi, decise che tale commemorazione si facesse in luogo chiuso e fu stabilito di tenerla nel Palazzo lateranense»38, ossia in quella che era stata la prima residenza dei Papi all’indomani dell’editto del 313. durante la commemorazione presero la parola le più alte cariche del consiglio Superiore, fra cui l’avvocato carlo Santucci, vicepresidente della Primaria Associazione della S. Croce: questi volle sottolineare nel proprio discorso che «mentre la libertà e la civiltà sono il vanto e l’aspi-razione suprema del secol nostro, da un lato le divisioni degli animi, la lotta di classe, le rivalità nazionali, gli antagonismi di razza, sfruttate da sette anticristiane e antisociali, tengono in continua trepidazione i popoli, dall’altro la chiesa, spogliata dei più sacri diritti, sconosciuta nella sua sociale e santa missione, ha non solo cessato di essere ascoltata come ispiratrice di vera civiltà dai pubblici poteri, gelosi del suo ministero di pace, ma le si contrasta perfino di governare le anime, d’insegnare, di predicare»39. l’autunno e l’inverno seguenti passarono senza che fossero previste celebrazioni ufficiali40: con il mese di marzo, tuttavia, le feste
37 cfr. «l’osservatore romano», 18 ottobre 1912, La nuova basilica costantiniana – La posa della prima pietra.
38 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 2 (ottobre-novembre 1912), p. 4, Solenne commemorazione della Vittoria di Costantino tenuta nel Palazzo Lateranense il 28 ottobre 1912.
39 Ibidem, p. 19.40 In quel periodo risulta tuttavia essere stato attivo a roma un «comitato di
Signore e Signori cattolici, sotto l’alta Presidenza di e.mi ed ecc.mi Personaggi», costi-tuitosi al fine di «offrire al Beatissimo Padre un ricordo stabile di tanto avvenimento», ossia un Patronato Cattolico Costantiniano, «con oratorio maschile e femminile, e asso-ciazioni di assistenza operaia, e d’azione cattolica», da erigere nella parrocchia di san giovanni in laterano, la cui popolazione versava «in bisogni spirituali e morali più urgenti forse, che in qualsiasi altra parte di roma». Al fine di raggiungere il proprio obiettivo, nel gennaio del 1913 il comitato sollecitò alcuni vescovi italiani affinché inviassero offerte in denaro; venne pure istituito un comitato d’onore composto da prelati che avevano appoggiato l’iniziativa, in cui figuravano, fra gli altri, i cardinali cassetta, respighi e richelmy. Tutto ciò lo si apprende da un documento rinvenuto
FrAnceSco TAcchI254
romane per il centenario costantiniano entrarono nel vivo, favorite anche dall’intervento della Santa Sede.
l’8 marzo, infatti, Pio X indisse con la lettera Apostolica Magni faustique eventus un giubileo straordinario, destinato ad aprirsi il 30 del mese ed a concludersi il giorno dell’Immacolata: in definitiva, esso sarebbe andato a coincidere con il periodo per il quale erano state pro-grammate le solenni feste religiose nelle basiliche costantiniane. con ogni probabilità, tale atto mirava a far affluire a roma una miriade di pellegrini da tutte le parti del globo proprio durante il climax delle com-memorazioni centenarie, circostanza che avrebbe proiettato all’esterno un’immagine nitida di compattezza e di effervescenza del mondo cattoli-co riunito attorno alla Santa Sede, certo funzionale al messaggio politico veicolato dal centenario. la volontà di ‘attirare’ al soglio pontificio non solo i cattolici, ma tutti gli esseri umani, era peraltro espressa a chiare lettere nella stessa Magni fustique eventus, coerentemente con il progetto di Papa Sarto di Instaurare omnia in Christo:
consentaneum igitur esse ducimus, hac felici occasione, qua tam egregium fac-tum recolitur, deum, virginem eius genetricem et reliquos caelites, Apostolos praesertim, etiam atque etiam adprecari, ut populi universi decus et honorem ecclesiae instaurantes, ad tantae matris gremium confugiant, errores, quibus inconsulti fidei inimici eius claritati tenebras obducere nituntur, pro viribus depellant, romanum Pontificem summa observantia colant, in catholica denique religione omnium rerum praesidium et columen fidenti animo intueantur41.
Il giorno di apertura del giubileo, come detto, coincise con l’inizio delle solenni feste religiose: il 30 marzo – domenica dopo la Pasqua – il Collegium Cultorum Martyrum e il consiglio Superiore presenziarono ad una cerimonia presso le catacombe di san callisto, «per commemorare i martiri, i quali con il loro sangue prepararono il trionfo del cristianesimo, e per commemorare altresì i due Papi del periodo costantiniano, milziade e marco, che furono sepolti in quel medesimo cimitero42»; sette giorni più tardi ebbe invece inizio un ottavario nella Basilica di san giovanni in laterano, durante il quale rimase esposta alla venerazione dei fedeli
presso l’Archivio Arcivescovile di Pisa, Fondo curia Arcivescovile, Atti Diversi, cartella n. 164, Centenario Costantiniano.
41 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium officiale, roma, Tip. Poliglotta vaticana, 1913, p. 90.
42 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 7 (aprile 1913), p. 6, La solenne funzione alle catacombe romane. Si noti come sempre in marzo avessero avuto inizio, nel 1911, le celebrazioni ufficiali per il 50° anniversario dell’unità: il 17 a Torino, il 27 a roma.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 255
l’immagine del Santissimo Salvatore conosciuta come Acheropita. Funzioni religiose si tennero sempre in aprile fra San Pietro e San Paolo Fuori le mura, mentre ad inizio maggio toccò alla Basilica Sessoriana di Santa croce ospitare un Triduo solenne; veramente suggestivi dovettero apparire poi i festeggiamenti dell’11 maggio, giorno di Pentecoste: il Programma aveva previsto una cappella Papale43 in San Pietro, ed a seguire l’illumi-nazione delle principali basiliche di roma e di tutte le croci sovrastanti le chiese ed i campanili della città, così come l’apposizione del monogramma costantiniano sulla facciata degli edifici di culto; Pio X tuttavia non poté presenziare alla celebrazione, risentendo ancora dei postumi di una bron-chite 44: il tutto si svolse quindi in una forma parzialmente diversa da quella pensata in origine, ed il «r.mo capitolo vaticano unitamente alla Società Primaria Romana per gli Interessi Cattolici si fecero iniziatori di un solenne Te Deum alla Basilica vaticana per la detta domenica di Pentecoste in rin-graziamento al Signore per la recuperata salute del santo Padre Pio X»45: al rito parteciparono più di trentamila persone. Subito dopo le chiese furono illuminate come da copione, con i simboli della croce e del monogramma costantiniano a rischiarare la notte della capitale.
I successivi appuntamenti andarono in scena in alcune basiliche mino-ri intitolate a martiri dei primi secoli: il 18 maggio la commemorazione centenaria fece tappa alla Basilica di Sant’Agnese, il 25 a quella di San lorenzo Fuori le mura, l’8 giugno alla chiesa dei SS. Pietro e marcellino a Tor Pignattara. le solennità religiose, ad ogni modo, non furono l’uni-ca forma di festeggiamento messa in campo dal consiglio Superiore: la prima parte del 1913 fu caratterizzata pure dal tenersi di conferenze erudite. Tra febbraio e giugno ebbe luogo un ciclo di sette conferenze di alta cultura presso l’Aula magna della cancelleria Apostolica: gli oratori furono in massima parte professori universitari, fra cui il salesiano Paolo ubaldi, ulisse de nunzio e, in aprile, giuseppe Toniolo46. Se i messaggi
43 Funzione solenne, in genere messa o vespri, che prevede la celebrazione o l’assi-stenza da parte del Pontefice nella cappella dei palazzi apostolici, oppure nelle basiliche o chiese, con l’intervento del collegio cardinalizio, dei vescovi, dei prelati e di quanti, a diverso titolo, abbiano a partecipare alla cappella stessa.
44 Papa Sarto, viste le proprie condizioni di salute, dovette sospendere in aprile le udienze ai pellegrini giunti a roma, venendo per lo più sostituito da merry del val: ciò fino al 25 maggio, quando il Pontefice, perfettamente ristabilito, ammise alla sua presenza l’Arciconfraternita viennese di San michele Arcangelo. cfr. «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 9 (giugno 1913), p. 7.
45 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 8 (maggio 1913), p. 4.46 ubaldi tenne una conferenza sul Movimento letterario greco-cristiano nel quarto
secolo; de nunzio parlò invece delle Basiliche costantiniane della Palestina. Sul contenuto dell’intervento di Toniolo, Problemi e ammaestramenti dell’età costantiniana, ritornerò
FrAnceSco TAcchI256
di tali interventi erano indirizzati ad un pubblico ristretto, molto più ampia era invece la platea delle conferenze popolari, tenute in genere dai parroci nelle chiese della città: tali interventi si configuravano a tutti gli effetti come un veicolo capace di far pervenire a diversi gruppi sociali, attraverso la narrazione delle gesta di costantino e dei primi martiri cristiani, i messaggi politici connessi alla commemorazione centenaria; lo stesso comitato romano, del resto, si curò di raccomandare al clero che «il popolo a[vesse] cognizione piena del grande avvenimento che si v[oleva] commemorare e ne apprezz[asse] tutta la importanza che esso ebbe per la pace della chiesa»47.
Il mese di settembre non fu caratterizzato da appuntamenti sacri o da esposizioni erudite, bensì dal confluire nella capitale dei giovani iscritti alla Federazione delle associazioni sportive cattoliche – richiamati da un concorso ginnastico – e di quelli della Società della Gioventù Cattolica Italiana, giunti in pellegrinaggio. la presenza dei ginnasti fu all’origine di incidenti che vennero presentati da L’Osservatore Romano quale ulte-riore testimonianza della mancanza di libertà per i cattolici d’Italia: gli atleti furono infatti coinvolti in scontri «provocati dalla teppa bruniana», artefice, a detta del giornale, di «gesta bestiali e incivili»48; aggressioni a ginnasti cattolici si ebbero pure a civitavecchia alcuni giorni più tardi, per opera di «teppisti e (…) facchini anticlericali»49. Questi episodi rap-presentarono ad ogni modo un’ eccezione nell’ambito di festeggiamenti svoltisi per lo più senza inconvenienti, e che conobbero i propri momenti conclusivi in dicembre.
le solennità religiose si conclusero con un Triduo dedicato alla madonna nella Basilica di Santa maria maggiore: nel pomeriggio dell’8 dicembre, mons. Pietro la Fontaine, Segretario della congregazione dei riti – e futuro Patriarca di venezia – tenne un discorso con cui rivolse «alla vergine Immacolata umile preghiera affinché il Figliuolo divino otten[esse] che, respinti gli attacchi del serpente infernale, contro cui ferve la pugna e non contro gli uomini, la Plebs Dei e l’Episcopus po[tessero] trovarsi insieme a ringraziare dio di nuovi trionfi»50. la
più avanti. In veste di oratore intervenne anche orazio marucchi il 5 giugno, parlando dei Donativi di Costantino alle chiese di Roma. cfr. «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 9 (giugno 1913), pp. 22-26.
47 «l’osservatore romano», 5 marzo 1913, Roma nel XVI Centenario della pace della Chiesa.
48 «l’osservatore romano», 8 settembre 1913, La libertà del Papa e dei cattolici d’Italia – Oltraggi e violenze contro i ginnasti italiani ed esteri.
49 «l’osservatore romano», 12 settembre 1913, Teppismo bestiale a Civitavecchia.50 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 15 (dicembre 1913), p. 4.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 257
figura di maria si prestava bene alla commemorazione centenaria: dal momento che «della libertà della chiesa» essa era sempre stata «scudo potente»51, l’invocazione alla madre di cristo aveva potuto configurarsi, nei mesi dei festeggiamenti, quale efficace veicolo di una – certo ormai tradizionale – «mistica controrivoluzionaria»52.
Il Triduo in Santa maria maggiore non fu tuttavia l’ultimo atto del 1913 costantiniano: le celebrazioni ufficiali avevano avuto come prodro-mo la posa della prima pietra della chiesa di Santa croce a Ponte milvio, e l’anno del centenario si chiuse con la sua solenne inaugurazione. A causa delle «studiate e malevole lungaggini dell’Amministrazione bloc-carda che doveva rilasciare il permesso»53, i lavori di costruzione avevano potuto cominciare solo a febbraio; nel giro di dieci mesi erano comunque stati portati a termine, così che il 30 dicembre la Basilica poté essere inaugurata. una monumentale croce in bronzo, alta più di tre metri, fu condotta processionalmente fin dentro la chiesa per poi essere innalzata e fissata al centro dell’Altare maggiore, eretto grazie ad una sottoscri-zione del periodico Sacred Heart Review di Boston54. conclusasi la ceri-monia, vincenzo Bianchi-cagliesi, Assistente ecclesiastico del consiglio Superiore, prese la parola per rievocare il cammino percorso nei mesi dei festeggiamenti: a suo parere, il centenario aveva costituito una tappa importante per la chiesa e per la fede cattolica nella loro proiezione verso il futuro, futuro – Bianchi-cagliesi non aveva alcun dubbio – che sarebbe stato prodigo di nuovi successi per la croce:
la commemorazione costantiniana, qui, nella nuova basilica, eretta in così breve tempo dalla carità di cristo che urge all’apostolato, assume ed esprime intera la sua significazione, piena di non fallaci promesse. Il cattolicismo ha appena sorriso e benedetto alle sue glorie millenarie che già volgesi all’avvenire e provvede ai nuovi mezzi di conquista, con la giovinezza di sedici secoli fa, e con uguale fervore costruisce i templi che accoglieranno i voti e le preghiere, le amarezze e le speranze delle generazioni future. I lontani eredi della nostra fede assisteranno ad altri e maggiori trionfi cristiani e qui, ad ogni trionfo, con-verranno e inneggeranno alla croce. la basilica sarà segnacolo di vittoria, sarà tutta un labaro trionfale, nel cui mezzo starà l’albero della vita, la croce, salda nel bronzo come la nostra speranza, immensa come l’amore di dio55.
51 Ibidem, p. 2.52 cfr. camaiani, Il diavolo, Roma e la rivoluzione, p. 503.53 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 15 (dicembre 1913), p. 10.54 la Basilica presentava poi due Altari laterali, uno in cornu Epistolae costruito a
spese del Sacro ordine costantiniano di san giorgio, ed uno in cornu Evangelii realizza-to grazie al contributo dell’Unione fra le Donne Cattoliche d’Italia. cfr. Ibidem, pp. 8-9.
55 Ibidem, pp. 12-13.
FrAnceSco TAcchI258
Il lessico utilizzato dal sacerdote non lasciava spazio a fraintendi-menti: l’avvenire avrebbe visto ancora il cattolicesimo conoscere trionfi, vittorie, mezzi di conquista; i nemici di dio non sarebbero riusciti ad avere la meglio: ciò che si comunicava ai fedeli, in definitiva, era un’ottimistica e fideistica certezza circa il destino della chiesa, e, conseguentemente, circa l’esito della battaglia combattuta per essa.
3. Il Centenario Costantiniano in Italia.
dopo la pubblicazione del Programma dei festeggiamenti da parte del consiglio Superiore, la macchina organizzativa si mise in moto nelle varie diocesi italiane: già nei primi mesi del 1912 molti vescovi diedero comunicazione ai propri sacerdoti e fedeli – tramite apposite lettere Pastorali – delle imminenti feste centenarie, provvedendo poi il più delle volte a costituire, come richiesto da roma, un comitato responsabile di organizzare le commemorazioni in ambito diocesano; alla fine di otto-bre l’iniziativa del centenario aveva riscosso l’adesione di oltre tremila centri in tutto il mondo, ma la penisola faceva ovviamente la parte del leone: fra le prime diocesi a dotarsi di un comitato locale vi furono quelle di Ascoli Piceno, Fiesole, chieti, venezia, Siena, Asti, gubbio, modigliana e Treviso56.
Il consiglio Superiore lasciò ai singoli comitati una totale libertà di scelta quanto ai tempi e ai modi delle celebrazioni; alcune diocesi decisero quindi di muoversi con largo anticipo rispetto alle iniziative romane: nella Palermo del cardinal lualdi, ad esempio, un primo ciclo di festeggiamenti si svolse già nel giugno 1912, mentre ad Amelia e Biella vennero organizzati pellegrinaggi verso i santuari diocesani nel mese di settembre. come previsto e voluto dalla Santa Sede, tuttavia, il clou dei festeggiamenti si ebbe ovunque durante i mesi del 1913; quanto alle iniziative messe in campo, mi sembra che possano individuarsi alcune tipologie di attività che caratterizzarono le celebrazioni in pressoché tutte le diocesi italiane: funzioni religiose (Tridui, processioni, ottavari, Pontificali solenni, tanto nelle chiese parrocchiali quanto nella chiesa cattedrale); pellegrinaggi (diocesani o interdiocesani, alla volta di san-tuari locali o della città di roma); conferenze erudite; raccolte di offerte
56 cfr. «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 3 (dicembre 1912), p. 10. dopo l’Italia, quanto ad adesione pratica all’iniziativa delle feste costantiniane, fu la Spagna a distinguersi: già nell’ottobre 1912 erano attivi comitati locali in centri come ciudad-real, coria, madrid, orense, Segovia e Siviglia.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 259
da inviare alla Santa Sede (come obolo di San Pietro o per la Basilica di Santa croce a Ponte milvio); erezione di opere commemorative (solita-mente chiese o croci monumentali).
volendo scendere nel concreto, mi limiterò a considerare solo alcuni casi specifici che ritengo esemplificativi. nella diocesi di Bergamo, il comitato locale mise a punto il programma dei festeggiamenti nel 1912: in base ad esso, il primo atto delle commemorazioni avrebbe coinciso con una conferenza organizzata in Seminario nel gennaio dell’anno seguente; era inoltre previsto un pellegrinaggio a roma – tenutosi poi nel giugno 1913, quando circa 500 pellegrini sarebbero stati condotti dinanzi al Papa dall’Arcivescovo radini Tedeschi –, così come pel-legrinaggi parrocchiali o vicariali a santuari diocesani, e l’erezione di un monumento «consistente in un tempio in Bergamo, presso la malpensata, in onore della esaltazione della SS. croce»57. Il circolo della gioventù cattolica decise poi di promuovere una serie di confe-renze storico-religiose, di cui si incaricò un giovane Angelo roncalli58; infine, nelle commemorazioni bergamasche ebbero rilievo le Feste eucaristiche costantiniane (24-26 agosto 1913), presiedute dall’Arcive-scovo di milano Andrea Ferrari59.
Quest’ultimo si impegnò affinché le manifestazioni centenarie nella sua diocesi assumessero un’importanza seconda solo a quella delle feste romane: del resto, già scrivendo privatamente a Stefano Scala nel dicembre 1911, il cardinale aveva sottolineato come la città di milano avesse «un titolo e un dovere speciale»60 di commemorare l’editto cui aveva dato i natali. nel gennaio del 1913, dunque, Ferrari incaricò alcuni collaboratori di organizzare due pellegrinaggi a roma durante l’anno: alla fine furono stabilite le date del 31 marzo e del 31 agosto. Quanto al resto, fra aprile e maggio la città fu animata da solenni funzioni religiose in duomo, culminate, nel giorno della festa dell’Invenzione della Santa
57 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 4 (gennaio 1913), p. 11.58 cfr. Ibid. Sul rapporto del futuro papa giovanni XXIII con le feste costantiniane
cfr. Zanchi, Il centenario dell’editto di Milano (313) in don Angelo Roncalli.59 cfr. «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 14 (novembre 1913), pp.
11-12.60 cfr. «l’Italia reale», 24 dicembre 1911. la peculiarità di milano nella feste
costantiniane venne segnalata anche da un manifesto affisso alle porte delle chiese ambrosiane nel gennaio 1913: «la città prescelta dalla divina Provvidenza per la firma di quel decreto, esulta all’aprirsi di questo nuovo anno, e sente la sua grandezza dinanzi alla storia, la gloria sua in quella fede che, qui liberata col sangue dei martiri, svolse al cospetto del mondo la bandiera della libertà». Il testo è riportato in «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 5-6 (febbraio-marzo 1913), p. 31.
FrAnceSco TAcchI260
croce, con la processione del Santo chiodo – «preziosa reliquia ed insie-me cimelio costantiniano»61.
un’importanza particolare nell’ambito delle commemorazioni ambro-siane fu assunta dalla XvIII Festa federale dei cattolici milanesi, la quale si tenne il 28 settembre: ad essa parteciparono oltre tredicimila persone, e fu l’occasione per deplorare pubblicamente i fatti di roma e civitavecchia, ossia gli «attentati recentissimi alla libertà dei ginnasti cattolici»62; al termine di tale manifestazione, il cardinal Ferrari posò la prima pietra della nuova chiesa di Santa croce, progettata proprio a ricordo del centenario costantiniano: situata nella zona dell’Acquabella, sarebbe stata aperta al pubblico alla fine del 1917. l’atto più importante dei festeggiamenti milanesi fu ad ogni modo l’ultimo: a partire dal 30 novembre, infatti, il capoluogo lombardo ospitò l’vIII Settimana Sociale dei cattolici Italiani, evento d’importanza decisiva per comprendere i significati politici dell’anno costantiniano63.
I primi giorni del 1913 coincisero con l’avvio delle celebrazioni in molte città italiane: fra queste, napoli e venezia. Per iniziativa del cardinal Prisco, le feste nel capoluogo campano ebbero inizio il giorno 5, con una funzione sacra che vide la presenza di tutti i giovani dell’opera cattolica; in maggio si tenne il pellegrinaggio diocesano a roma, mentre per il 14 settembre, giorno dell’esaltazione della croce, furono organiz-zate solenni feste religiose nella chiesa di Santo Spirito, dove si espose «una grande tela dipinta raffigurante la visione della croce all’Imperato-re costantino col fatidico motto: In hoc signo vinces»64. la città lagunare, per parte sua, vide le feste centenarie essere inaugurate il primo giorno dell’anno da un Pontificale del cardinale Patriarca nella chiesa di san Silvestro; pochi giorni dopo, il comitato locale inviò un proclama ai «cattolici veneziani», perché si disponessero a considerare i meriti acqui-siti dalla chiesa a seguito dell’editto:
la chiesa libera attuò la più grande rivoluzione morale, che mente di uomo ricordi; fece scomparire lagrimevoli disuguaglianze sociali; convertì le orde barbariche al culto del vero dio, ai benefici della vera civiltà; sollevò l’umanità alla coscienza della propria dignità, dei suoi intangibili sacrosanti diritti; la
61 «la Scuola cattolica», anno XlI, numero straordinario del maggio-giugno 1913, Nel XVI Centenario della libertà della Chiesa, 313-1913, p. 319.
62 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 14 (novembre 1913), p. 21.63 Al riguardo si veda infra, pp. 269-274.64 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 14 (novembre 1913), p. 22.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 261
croce, che diede vittoria a costantino contro massenzio, vince e trionfa su ogni barbarie, su ogni despotismo, su ogni ingiustizia sociale65.
Alla fine di marzo ebbe inizio un ciclo di feste religiose: il giorno di Pasqua si cantò il Te Deum in tutte le chiese parrocchiali mentre le campane della città suonavano a distesa; dalla settimana successiva cominciarono invece i pellegrinaggi delle singole decanie alla Basilica di san marco: i festeggiamenti si conclusero in maggio, dapprima con un Triduo in cattedrale, e poi con il pellegrinaggio a roma.
nella Pisa del cardinale maffi e di Toniolo, invece, le feste costan-tiniane ebbero luogo fra marzo e novembre: già in gennaio, tuttavia, la città era stata tappezzata con un volantino realizzato dai giovani del circolo salesiano “don Bosco”, nel quale s’indicava il dovere dei cattolici nell’anno del centenario:
viene dunque proposto il xvi centenario costantiniano per far vibrare le fibre dell’anima umana e per invitare tutti i credenti ad un’azione efficace. Poiché mentre l’indipendenza ed il Supremo magistero della chiesa sono inceppati, dove con la violenza, dove col dileggio e coll’ipocrisia, mentre si strappa il cristo dalla scuola e si avvelena l’anima ingenua dei nostri fanciulli e si profana il fiore della gioventù, mentre si apparecchiano a dissacrare la famiglia, noi cristiani gelosi della grandezza e della potenza della Patria, siamo chiamati alle solenne rivendicazioni della libertà della nostra Fede e a vivere della chiesa e ad operare con essa66.
nella diocesi di Pisa non si costituì un comitato: il programma dei festeggiamenti venne concordato dall’Arcivescovo stesso con i presidenti delle locali associazioni cattoliche67; nessuna di queste – come scrisse maffi in una circolare del 4 marzo – avrebbe dovuto lasciar «passare l’an-no costantiniano senza una speciale commemorazione, che, celebrando l’opera dei padri, rinvigoris[se] alle prove l’animo dei figli e dei nepoti»68. I festeggiamenti cominciarono pochi giorni dopo, con una conferenza tenuta nel Palazzo Arcivescovile dall’archeologo giorgio Schneider graziosi – membro del Collegium Cultorum Martyrum – a proposito della Storia e monumenti delle catacombe romane; il 24 marzo fu invece Toniolo a parlare dinanzi al pubblico dei Problemi e ammaestramenti dell’età
65 Sul complesso delle celebrazioni veneziane, si veda «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 4 (gennaio 1913), pp. 15-16.
66 manifesto a cura del “circolo v. d. giovanni Bosco” di Pisa, con data 5 gennaio, custodito presso Archivio Arcivescovile di Pisa, Fondo curia Arcivescovile Atti diversi, cartella n. 164, Centenario Costantiniano..
67 cfr. circolare n. 51 del 4 marzo 1913, p. 2, conservata in ibidem.68 Ibidem, p. 5.
FrAnceSco TAcchI262
costantiniana, tenendo un intervento che avrebbe replicato a roma il mese successivo. Se le feste pisane diedero ampio spazio alle celebrazioni religiose ed alle conferenze erudite – in novembre sarebbe intervenuto in città anche orazio marucchi –, esse non furono tuttavia solo questo: non mancarono infatti i pellegrinaggi parrocchiali verso santuari diocesani e le raccolte di offerte da destinare a roma per la Basilica di Ponte milvio, così come l’erezione di un monumento che commemorasse il centenario – una croce monumentale sulla sommità del monte Forato, non lontano da Pietrasanta. In origine si era previsto anche un pellegrinaggio a roma per il mese di ottobre: tale progetto non arrivò tuttavia a concretizzarsi.
Proprio l’esperienza del viaggio verso la città eterna fu, in generale, il tratto saliente delle feste centenarie, tanto che L’Osservatore Romano arri-vò a riservarle un’apposita rubrica. All’inizio del marzo 1913, il consiglio Superiore aveva già ricevuto richieste per circa 70 pellegrinaggi da tutto il mondo, i quali avrebbero cominciato ad affluire a roma subito dopo Pasqua. giunti in città, i pellegrini ricevevano una medaglia commemo-rativa e la tessera del comitato romano, necessaria per ottenere l’ingresso gratuito ai musei vaticani e, soprattutto, per essere ammessi in udienza da Pio X; della loro assistenza religiosa venne incaricato il circolo dell’Imma-colata, che già aveva svolto tale funzione durante i giubilei del 1900 e del 190469. Fu proprio il circolo a far pubblicare un piccolo «vade mecum» in cui erano spiegate le modalità per ottenere l’Indulgenza plenaria: le conseguenze dei peccati sarebbero state cancellate per chi, durante l’anno giubilare, avesse visitato due volte ciascuna le Basiliche di San giovanni in laterano, San Pietro e San Paolo Fuori le mura, ed al contempo si fosse confessato, comunicato ed avesse fatto elemosina ai poveri; ultima condizione, poi, era la preghiera secondo le intenzioni del Papa, ossia «per la prosperità ed esaltazione della chiesa cattolica e della Sede Apostolica, per l’estirpazione delle eresie, e per la conversione di tutti i peccatori, per la concordia dei Principi cristiani e per la pace ed unione di tutto il popo-lo cristiano»70: intenzioni – dalla matrice antica, utilizzata dai pontefici già nel corso del XIX secolo – che appaiono in linea con quel progetto di restaurazione cristiana veicolato efficacemente dalle feste centenarie.
ottenere l’Indulgenza era alla portata anche di coloro che non aveva-no la possibilità di recarsi a roma: questi avrebbero dovuto visitare per sei volte «la chiesa o le chiese del loro paese, da designarsi una volta tanto
69 cfr. Vade mecum per il giubileo concesso da S.S. Pio X in memoria della pace data dall’imperatore Costantino Magno alla Chiesa – Pubblicato a cura del Circolo dell’Imma-colata, roma, libreria Pontificia Federico Pustet, 1913, p. 3.
70 Ibidem, p. 6.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 263
dall’ordinario, e compi[ere] interamente le altre opere di pietà» previste per i pellegrini romani71; è chiaro come tutto ciò contribuisse a stimolare la partecipazione dei fedeli ai festeggiamenti organizzati su scala locale dai comitati diocesani.
I pellegrinaggi a roma proseguirono senza sosta fino a dicembre inol-trato: alcuni si tennero addirittura a giubileo ormai concluso72. Alla fine del centenario costantiniano, i promotori della manifestazione potevano ritenersi alquanto soddisfatti: nel giro di pochi mesi, a rendere omaggio al successore di Pietro si era recato quasi un milione di persone.
4. Libertà della Chiesa o panteismo di Stato: il messaggio del Centenario.
Quale dovesse essere il messaggio di fondo dell’anno costantiniano era stato chiaro già a coloro che fra 1906 e 1907 avevano concepito l’idea di una commemorazione: il Programma pubblicato dal consiglio Superiore il 1° marzo 1912 si preoccupò di riproporlo, in un momento in cui il tenersi delle feste era ormai divenuta cosa certa:
Più che mai opportuno si ritiene nei tempi presenti il ricordo di questo primo trionfo della chiesa, della libertà e della pace vera che n. S. gesù cristo ha recato nel mondo col segno vittorioso della croce, mentre le forze infernali rin-gagliardiscono da ogni dove la guerra contro la religione cristiana con tenden-za ed insinuazioni di un ritorno al paganesimo. (…) Questa commemorazione solenne della vittoria della croce deve essere anche la espressione del voto che, sotto questa insegna gloriosa, tutti gli uomini si uniscano a noi nella professione della vera fede e dell’amore sincero e ardente verso il redentore divino delle anime, e tutti siano fraternamente congiunti in quella cristiana carità che è l’arra migliore di una pace durevole e feconda di benefici morali e materiali73.
Il centenario veniva dunque ad assumere una funzione controrivoluzio-naria: esso doveva configurarsi come un’occasione per riaffermare i meriti della civiltà cristiana e della chiesa, per esaltare il ruolo di quest’ultima nella storia dell’umanità ed invocare il ritorno ad essa di quanti se n’erano allontanati o, peggio, la osteggiavano apertamente; in questo quadro, la temperie secolarizzatrice – neopagana – era presentata quale minaccia da arrestare, minaccia particolarmente evidente nel periodo storico in cui la commemorazione aveva luogo. Se tale fu il significato generale delle feste –
71 Ibidem, p. 7.72 cfr. «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 15 (dicembre 1913), pp.
23-24.73 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 1 (settembre 1912), pp. 4-5.
FrAnceSco TAcchI264
perfettamente il linea con l’idea di Instaurare omnia in Christo –, esse furo-no però soprattutto il veicolo di un messaggio più particolare e pregnante a proposito dei rapporti fra Stato e chiesa: si voleva denunciare «il cammino a ritroso»74 compiuto dal primo ai danni della seconda, quel processo che aveva condotto il potere civile a svincolarsi dal potere religioso e a pre-tendere addirittura d’imporsi su di esso; l’accusa era insomma allo Stato moderno, visto quale nemico e negatore di quella libertà che costantino aveva accordato e garantito alla chiesa delle origini. Tale accusa allo Stato panteista – in quanto d’ispirazione neopagana75 – ebbe come obiettivo prin-cipale lo Stato italiano, da pochi mesi uscito dai festeggiamenti che avevano esaltato il processo di unificazione risorgimentale – e dunque la fine del potere civile dei Papi –: il 7 aprile 1913, L’Osservatore Romano affermava appunto che «nemico della chiesa e del Papa è oggi lo Stato in roma, il quale se non riesce ad impedire la commemorazione della libertà ad essi riconosciuta per legge sedici secoli or sono, riesce tuttavia a procacciare la mostruosità di essere alieno da essa per opposizione metodica a quel riconoscimento e a quella sostanziale libertà»76. Ad aggravare la posizione dello Stato italiano di fronte all’opinione pubblica cattolica aveva da poco contribuito l’«ultimo attentato contro la coscienza dei cattolici» – così l’Arcivescovo di vercelli in una Pastorale dell’aprile 191377 –, ossia la legge di avocazione della scuola elementare allo Stato (legge daneo-credaro dell’11 giugno 1911, n. 407), tenacemente contrastata in Parlamento dai deputati cattolici e tuttavia approvata grazie ad una maggioranza composta di liberali, socialisti e repubblicani78: tale misura contribuì ad alimentare la percezione di uno Stato lesivo dei diritti della chiesa, mosso dalla volontà di assorbire completamente in sé tutta la vita dei cittadini, incurante di «preparare le nuove generazioni, completamente atee e pagane»79.
74 «l’osservatore romano», 12 gennaio 1913, Ribadendo.75 Tale topos è un classico della retorica cattolica controrivoluzionaria, già utilizzato
ampiamente all’epoca del Kulturkampf: a riguardo si veda o. Weiss, Il “Kulturkampf ” tedesco (1871-1890) nell’opinione pubblica italiana, in Il “Kulturkampf ” in Italia e nei paesi di lingua tedesca, a cura di r. lill – F. Traniello, Bologna, Il mulino, 1992, pp. 283-326.
76 «l’osservatore romano», 14 aprile 1913, Se Costantino tornasse…77 Arcidiocesi di vercelli, Circolare al Ven. Clero – Centenario Costantiniano –
Giubileo – Festeggiamenti, [s. l.], 6 aprile 1913, p. 19. l’Arcivescovo in questione era Teodoro dei conti valfrè di Bonzo.
78 cfr. g. Bonetta, L’avocazione della scuola elementare allo Stato, in Storia della scuola e storia d’Italia, Bari, de donato, 1982, pp. 115-187.
79 Lettera collettiva dell’Episcopato lombardo – Il XVI Centenario dell’Editto di Milano e la libertà della Religione nelle Scuole, milano, Tip. Pontificia ed Arcivescovile S. giuseppe, 1912, p. 9. Tale lettera, redatta da Angelo roncalli, venne firmata da otto vescovi lombardi – con in testa il cardinale Andrea Ferrari – in data 21 settem-
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 265
esemplificativo della concezione e della critica cattolica allo Stato panteista è l’intervento tenuto da giuseppe Toniolo a roma nell’apri-le 1913 – nell’ambito delle conferenze di alta cultura organizzate dal consiglio Superiore –, poi pubblicato in tre diversi fascicoli della Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie80. A detta del profes-sore pisano, nelle varie civiltà pagane – ma soprattutto a roma – lo Stato si sarebbe caratterizzato per la tendenza a «stringere e confondere nei suoi poteri giuridico-coattivi anche l’autorità religiosa, e poi ad assorbire nell’unità del suo organismo politico e nella sua azione onnipotente tutto intero l’uomo ed ogni derivazione e manifestazione della vita sociale»81: tale sarebbe stata l’essenza del panteismo di Stato, con il conseguente annullamento della libertà spirituale dell’individuo. A questa situazione avrebbe rimediato il cristianesimo: «date a cesare ciò che è di cesare e a dio ciò che è di dio. vi ha un regno terreno, che deve tenersi distinto da quello celeste, e d’ora innanzi la Chiesa non si confonderà con lo Stato; ecco la nuova dottrina, per la quale era per sempre ferito nel cuore il paganesimo politico religioso dello Stato pagano»82. Solo con costantino, tuttavia, la chiesa sarebbe arrivata a godere della piena libertà di svolge-re la propria missione nel mondo, e, più in generale, l’età costantiniana avrebbe posto i criteri fondamentali delle relazioni fra Stato e chiesa: distinzione – non separazione83 –, indipendenza e coordinamento; un coordinamento da attuarsi però secondo una «cospirazione gerarchica, per cui il bene ultimo e religioso conferisce al bene prossimo ed infe-riore civile e viceversa»84. Quello descritto da Toniolo, in definitiva, non si configurava come un rapporto di parità: la chiesa avrebbe avuto un diritto a compiere la propria missione – condurre le anime alla salvezza –,
bre 1912. Il testo integrale è riportato anche in Angelo Roncalli chierico e storico a Bergamo. Antologia di scritti (1907-1912), a cura di F. mores, roma, edizioni di Storia e letteratura, 2008, pp. 109-145.
80 g. Toniolo, Problemi ed ammaestramenti sociali dell’età costantiniana, «rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», maggio 1913, pp. 23-43; agosto 1913, pp. 3-20; novembre 1913, pp. 330-354. come già ricordato, Toniolo aveva tenuto l’intervento in questione una prima volta a Pisa in marzo, ripetendolo poi a roma il mese successivo. cfr. «l’osservatore romano», 28 marzo e 25 aprile 1913.
81 Ibidem, maggio 1913, p. 28. corsivo così nel testo.82 Ibidem, p. 30. corsivo così nel testo.83 Su Stato e chiesa come «indivisibili e paralleli» aveva insistito pure Sabatino
giani, vescovo di livorno, nella Pastorale del 1912 da lui dedicata alla ricorrenza costantiniana, Omaggio delle diocesi alla Santa Sede nel XVI Centenario delle vittorie di Costantino Magno, livorno, Tip. vesc. Fabbreschi, 1912, p. 18.
84 Toniolo, Problemi ed ammaestramenti sociali dell’età costantiniana, novembre 1913, p. 339.
FrAnceSco TAcchI266
mentre lo Stato il dovere «di non immischiarvisi e di rimuovere ogni osta-colo al pieno adempimento di essa»85. l’intrinseca superiorità del potere religioso su quello civile appare come un punto fermo della concezione tonioliana: il diritto naturale di cui la chiesa è garante, riflesso della legge di dio, è superiore al diritto positivo del legislatore umano86.
Pure se dedicate ai primi secoli dell’era cristiana, le parole di giuseppe Toniolo veicolavano di fatto un messaggio pensato per il tempo presente: lo Stato avrebbe dovuto arrestare il proprio regresso allo spirito pagano, dannoso per la libertà – in primis religiosa – dei singoli e della chiesa87, riconciliarsi con quest’ultima e coadiuvarla nella sua missione divina: è l’idea del «ruolo ministeriale» del potere civile verso il potere religioso88.
Altro leitmotiv delle celebrazioni del 1913, anch’esso presente nell’in-tervento del professore pisano, fu la dicotomia fra paganesimo-barbarie e cristianesimo-civilizzazione: la pretesa ‘modernità’ dello Stato laico, sprez-zante dei diritti e delle prerogative della chiesa, non avrebbe rappre-sentato un progresso, bensì un ritorno ai secoli delle persecuzioni; vera civilizzazione e vero progresso avrebbero potuto esservi, come in passato, solo a condizione di non porre limiti alla chiesa nella sua opera salvifica: «l’azione della chiesa, quando possa svolgersi incontrastata in seno alla
85 Ibidem, p. 340. 86 In merito alla questione della superiorità del potere religioso sul politico – cardi-
ne della teologia politica cattolica – rimando a g. Filoramo, Il sacro e il potere, Torino, einaudi, 2009.
87 mi pare interessante citare in questa sede alcune parole del cardinal Angelo Scola, Arcivescovo di milano, pronunciate il 6 dicembre 2012 – solennità dell’ordi-nazione di Sant’Ambrogio – nell’ambito di un intervento dal titolo L’editto di Milano: initium libertatis: Scola si è soffermato sul concetto di laicité francese, che a suo dire oggi avrebbe finito per diventare «un modello maldisposto verso il fenomeno religioso»; rifa-cendosi all’idea di neutralità, lo Stato di fatto sosterrebbe «una visione del mondo che poggia sull’idea secolare e senza dio. (…) Sotto una parvenza di neutralità e oggettività delle leggi, si cela e si diffonde – almeno nei fatti – una cultura fortemente connotata da una visione secolarizzata dell’uomo e del mondo, priva di apertura al trascendente. In una società plurale essa è in sé legittima ma solo come una tra le tante. Se però lo Stato la fa propria, finisce inevitabilmente per limitare la libertà religiosa» (cit. dal testo dell’intervento reperibile all’indirizzo http://www.chiesadimilano.it / cms / documenti-del-vescovo / scola / interventi / l-editto-di-milano-initium-libertatis-2012-1.68503). l’assonanza con le voci del 1913 è notevole: la laicità dello Stato – che non coinciderebbe con una neutralità in fatto di religione – è vista quale via passibile di ledere la libertà spirituale dell’individuo.
88 cfr. d. menozzi, La Chiesa cattolica e la secolarizzazione, Torino, einaudi, 1993, p. 23; si vedano inoltre le riflessioni in proposito di J. maritain, Umanesimo integrale, roma, Borla, 1980 [ed. or. 1936], pp. 183-184.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 267
società, non è che un ripetersi del passaggio avventuroso in mezzo agli uomini di cristo, del quale fu detto che passò beneficando e sanando tutti89». Il pericolo corso dalle società neo-paganeggianti era quello di sprofondare nel caos, nella barbarie90: solo un ritorno alla chiesa avrebbe potuto scongiurarlo, e, nel caso dell’Italia, tale ritorno avrebbe implicato la riconciliazione dello Stato con il capo visibile di essa.
Proprio Pio X volle fornire un «commento ufficiale alla commemora-zione costantiniana»91, rivolgendo un discorso ad un gruppo di pellegrini milanesi, mantovani e francesi ricevuti in udienza il 4 aprile 1913; tale intervento fu successivamente pubblicato in opuscolo e distribuito ai fedeli giunti nella capitale durante il periodo giubilare92.
Il Papa si curò dapprima di additare l’ipocrisia dei tempi moderni: tempi informati alle parole d’ordine di ‘progresso’, ‘scienza’, ‘civiltà’, nei quali tuttavia la chiesa non avrebbe avuto modo di svolgere la missione affidatale da dio, dispiegatasi compiutamente a partire dall’editto mila-nese; il Pontefice evocava dunque l’idea del ritorno, della restaurazione di quell’ordine del quale la chiesa era stata per secoli perno e garante, sottolineando come la natura e la missione del potere religioso fossero intrinsecamente superiori a quelle del potere civile:
la chiesa, questa grande società religiosa degli uomini, che vivono nella stessa fede e nello stesso amore sotto la guida suprema del romano Pontefice, ha uno scopo superiore e ben distinto da quello delle società civili, che tendono a rag-giungere quaggiù il benessere temporale, mentre essa ha di mira la perfezione delle anime per l’eternità. la chiesa è un regno, che non conosce altro padrone che dio ed ha una missione tanto alta che sorpassa ogni limite, e forma di tutti i popoli d’ogni lingua e d’ogni nazione una sola famiglia; non si può quindi
89 Lettera di S. E. Mons. Francesco Ciceri Vescovo di Pavia e amministratore apostolico della Diocesi di Lodi al Ven. Clero delle due Diocesi, Pavia, Scuola Tip. Artigianelli, 1913, p. 4.
90 «Potremmo con efficacia presentarci ai governi per dir loro: non violate le native libertà della Chiesa se non volete gettare gli Stati nella rivoluzione sociale»: così l’Arcive-scovo di modigliana luigi capotosti nella Pastorale del 1914 dedicata al centenario (I frutti dell’anno costantiniano – conforti e speranze – Lettera Pastorale di Mons. Luigi Capotosti al Ven. Clero e Popolo della Città e Diocesi di Modigliana – Quaresima 1914, modigliana, Tip. Sociale, 1914, p. 22. corsivo così nel testo).
91 Tale definizione si trova in «la Scuola cattolica», numero straordinario del maggio-giugno 1913, p. 315.
92 Discorso di Sua Santità Pio PP. X ai pellegrini convenuti in Roma in occasione del Giubileo Costantiniano, roma, Tip. Poliglotta vaticana, 1913. nell’opuscolo si trova indicata come data del discorso il 23 febbraio: deve trattarsi tuttavia di un errore di stampa, visto che tanto «la Scuola cattolica» quanto il Bollettino pubblicato dal consiglio Superiore per i festeggiamenti indicano invece il 4 aprile.
FrAnceSco TAcchI268
nemmeno supporre che il regno delle anime sia soggetto a quello dei corpi, che l’eternità divenga strumento del tempo, che dio stesso divenga schiavo dell’uomo93.
Il Papa affermava dunque l’inferiorità del ‘regno dei corpi’ – ossia dell’istituzione statale – rispetto ‘regno delle anime’ – la chiesa di cristo –, del diritto positivo rispetto al diritto naturale. conseguenza necessaria di tutto questo era l’inammissibilità di ogni misura volta a limitare l’azio-ne salvifica della chiesa:
dunque la chiesa ha da dio stesso la missione d’insegnare, e la sua parola deve pervenire alla conoscenza di tutti senza ostacoli che la arrestino, e senza imposizio-ni che la frenino. (…) la chiesa ha la missione di governare le anime e di ammini-strare i Sacramenti; e quindi, come nessun altro per nessun motivo può pretendere di penetrare nel Santuario, essa ha il dovere d’insorgere contro chiunque con arbitrarie ingerenze o ingiuste usurpazioni pretenda di invadere il suo campo94.
Tale ‘campo’ comprendeva ovviamente non solo l’ambito meramente spirituale, ma anche l’intricato insieme delle cosiddette materie miste, afferenti tanto al potere civile quanto a quello religioso: era questo il caso dell’educazione scolastica, di scottante attualità al momento del centenario. Il Papa rivendicava la piena facoltà d’insegnare per la chiesa, al pari del suo diritto a possedere beni, «perché è una società di uomini e non di angeli, ed ha bisogno di beni materiali ad essa pervenuti dalla pietà dei fedeli»95. esigere tali diritti di fronte allo Stato – colpevole, si potrebbe dire, d’ ‘insubordinazione’ –, rivendicare cioè la libertà della chiesa, appariva come imprescindibile al Pontefice: non farlo avrebbe significato cadere nell’apostasia, venire meno al mandato celeste ricevuto da cristo.
Proprio il tema della libertà appare centrale nell’intervento di Pio X. nelle parole del Papa si individuano almeno due elementi-chiave a proposito di tale questione: il falso concetto della libertà concessa dalle istituzioni liberali – da intendersi piuttosto come licenza96 – e la discri-minazione di trattamento nei confronti dei cattolici, i quali, per opera del potere civile, avrebbero subìto restrizioni cui non sarebbero stati sottoposti gli altri cittadini, inclusi i militanti dei partiti sovversivi. A detta del Papa, nelle società contemporanee v’era «libertà per ognuno di
93 Ibidem, p. 4.94 Ibidem.95 Ibidem, p. 5.96 «e di questo sono così persuasi i nostri avversari, che ripetono a parole, esservi
all’ombra della loro bandiera ogni sorta di libertà; infatti però la libertà, o meglio la licenza, è per tutti, ma non la libertà per la chiesa» (ibidem).
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 269
professare il proprio culto, di manifestare i propri sistemi; ma non per il cattolico, come tale, (…) fatto segno a persecuzioni e dileggi. (…) libertà d’insegnamento, ma soggetta al monopolio dei governi, che permettono nelle scuole la propagazione e la difesa di ogni sistema e di ogni errore, e proibiscono perfino ai bambini lo studio del catechismo. libertà di stampa, (…) ma non al giornalismo cattolico, che difendendo i diritti della chiesa e propugnando i principi della verità e della giustizia, dev’es-sere sorvegliato»97: causa di tale disparità persecutoria, appunto, sarebbe stata la distorsione del giusto concetto di ‘libertà’.
Pio X si rifaceva abbondantemente all’enciclica Libertas (1888) del proprio predecessore, documento antesignano dei temi del 1913: leone XIII aveva infatti messo in guardia contro l’«assurda e pretta licenza98» garantita dai governi laici, forma di libertà corrotta e di fatto via alla schiavitù morale; libertà vera sarebbe stata solo quella conforme alla legge eterna – che sul piano dei rapporti sociali si traduceva nella legge naturale99 –: di conseguenza, il potere civile avrebbe dovuto offrire «tute-la e aiuto» al potere religioso, «affinché si po[tesse] più agevolmente vive-re secondo le norme della legge eterna»100. In tale prospettiva non poteva darsi alcuna separazione fra Stato e chiesa, bensì una ‘collaborazione’ nei termini che si sono visti espressi da Toniolo.
Il discorso di Pio X ai pellegrini, nel complesso, si configurava come una forte e convinta rivendicazione dei diritti di Dio di bonaldiana memo-ria101: libertà per la chiesa era libertà d’informare nuovamente l’ordine civile in tutti i suoi rami, con il politico non svincolato dal religioso. cosa fare, tuttavia, in un presente ben lontano da tale prospettiva idealizzata? compito dei cattolici, secondo il Papa, sarebbe stato «evitare il contagio»
97 Ibidem, pp. 5-6.98 Tutte le Encicliche dei Sommi Pontefici, milano, corbaccio, 1940, Libertas, p.
501.99 daniele menozzi ha parlato, a proposito dell’enciclica Libertas, di una «costruzio-
ne della legge naturale» (d. menozzi, Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni, Bologna, Il mulino, 2012, p. 77). Tale documento avrebbe proclamato «la coincidenza della legge naturale con quella legge divi-na di cui la chiesa, depositaria della rivelazione, non poteva che essere la sola interprete autentica. dall’altro lato affermava che la chiesa aveva sempre proposto tale legge naturale come fondamento dell’organizzazione della vita collettiva» (ibidem, p. 76), e dunque quale «supremo criterio ordinatore per la società contemporanea» (ibidem, p. 79).
100 Tutte le Encicliche dei Sommi Pontefici, p. 498.101 «la rivoluzione iniziata con la dichiarazione dei diritti dell’uomo, non finirà
che con la dichiarazione dei diritti di dio»: così louis de Bonald in Législation primi-tive (Œuvres complètes, genève-Paris, Slaktine, 1982, vol. 2, p. 250); si veda in merito menozzi, Chiesa e diritti umani, pp. 43-55.
FrAnceSco TAcchI270
e dar corso ad un «ben fruttuoso apostolato»102: operare oggi, insomma, per costruire il futuro trionfo.
Il tema della libertà della chiesa fu oggetto anche dell’vIII Settimana Sociale dei cattolici Italiani, svoltasi a milano fra il 30 novembre ed il 6 dicembre 1913. la scelta del luogo non fu ovviamente casuale: «Sede più adatta non poteva scegliersi»103, visto che proprio il capoluogo lombardo aveva dato i natali all’editto costantiniano, della cui centenaria comme-morazione l’incontro voleva essere «suggello»104.
Poco prima dell’apertura dei lavori, il conte giuseppe dalla Torre aveva diramato una circolare per informare il pubblico dell’oggetto della Settimana Sociale, la quale doveva richiamarsi «al memorabile discorso Pontificio ai lombardi, ove tutti i nostri diritti ed i nostri desideri sono sintetizzati»105: a detta del presidente dell’Unione Popolare, i cattolici avrebbero dovuto sciogliere l’«equivoco» alimentato da «fervore anti-religioso di sette» e da «spirito di laicismo», per cui si attribuiva loro il «desiderio di invadenza del potere religioso nel campo civile, a danno dei diritti dello Stato»106; al contempo, però, ad essi toccava riaffermare «i diritti imprescrittibili ed inoppugnabili di un popolo che crede e vuole riconosciuta la patria fede in tutte le manifestazioni della propria vita pubblica e rispettata la missione della chiesa la quale non può essere in contrasto ed ostacolo a quella dello Stato, ma che, ad essa alleata, la integra, l’avvalora, la facilita»107.
già da questa circolare emerge un elemento che caratterizzò la Settimana Sociale ed il suo rapporto con l’opinione pubblica italiana: una studiata accortezza – nei contenuti e nel linguaggio – nel porre il problema delle libertà della chiesa e dei cattolici in generale, sintomo di una ricerca di dialogo – o meglio, dopo le elezioni politiche dell’ottobre 1913, della volontà di proseguire un dialogo – con il mondo moderato che potesse condurre ad una discussione sulle questioni sollevate nel corso
102 Discorso di Sua Santità Pio PP. X ai pellegrini convenuti in Roma in occasione del Giubileo Costantiniano, p. 6.
103 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 15 (dicembre 1913), p. 36.104 Questo il termine utilizzato dal cardinal merry del val in una lettera inviata
– il 14 novembre 1913 – al conte dalla Torre, presidente dell’Unione popolare. da tale missiva si apprende come per Pio X i temi scelti per la Settimana fossero «della più alta importanza e rispond[enti] molto bene alle presenti feste centenarie». la lettera è ripor-tata in «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 14 (novembre 1913), p. 33.
105 Ibidem, p. 34.106 Ibidem.107 Ibidem.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 271
dei lavori; è impossibile non notare, ad esempio, come le parole di dalla Torre si riferissero ad una «missione della chiesa» passibile di integrare e potenziare quella civile dello Stato: si è visto tuttavia come nella reto-rica cattolica – a partire da Pio X – tale rapporto fosse rovesciato, con la chiesa a dover essere sostenuta dalle istituzioni temporali. Assumere una posizione del genere a livello di dibattito pubblico, però, avrebbe certo impedito di creare qualunque base per un confronto o collaborazione: di questo erano perfettamente consapevoli quanti parteciparono alla Settimana Sociale.
degli interventi susseguitesi a milano, due soprattutto meritano attenzione: quello di apertura – tenuto dall’Arcivescovo di udine Anastasio rossi – e quello di chiusura di dalla Torre108. monsignor rossi esordì affermando come l’editto di costantino avesse riconosciuto liber-tà alla chiesa, non semplice tolleranza – in quanto quest’ultima «esclude il diritto a sussistere nell’ente tollerato»109 –: e libertà avrebbe voluto dire «esplicazione per diritto insito e naturale, della propria vita, delle pro-prie facoltà, dei propri poteri, della propria missione pel fine in ordine al quale l’essere sociale è costituito»110; di fronte ad un soggetto dotato di tale libertà, lo Stato avrebbe dovuto «rinuncia[re] di far valere le sue pretese, e lungi dal sopprimere, garanti[re] e protegge[re]»111: concetti in linea con la posizione espressa da Pio X solo pochi mesi prima. Proprio su quest’ultimo andò a focalizzarsi il discorso dell’Arcivescovo di udine,
108 di seguito il programma della Settimana, rinvenibile in «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 14 (novembre 1913), p. 35: 30 novembre, Il Centenario Costantiniano e la libertà della Chiesa (Anastasio rossi, Arcivescovo di udine); 1° dicem-bre, Il potere religioso e il potere civile nella loro naturale distinzione e nelle loro rispettive relazioni (giovanni Battista Blavaschi); Il diritto dei cittadini ad esigere l’osservanza del 1° articolo dello Statuto (Italo rosa); 2 dicembre, La libertà nel Sacro Ministero, nel diritto naturale e nel diritto positivo italiano (Alberto mazza); Libertà di insegnamento (giacomo maria dei conti radini Tedeschi, vescovo di Bergamo); 3 dicembre, Libertà di associazio-ne (giovanni Piccioni, Arciprete della cattedrale di Pistoia); Diritto della Chiesa e degli enti che ne dipendono al possesso di beni (gerolamo Biasetti Sani); 4 dicembre, Il diritto alla insolubilità delle nozze (Filippo crispolti); 5 dicembre, La libera facoltà di testare in ordine alle istituzioni e fondazioni pie (Antonio renier); Il diritto di rappresentanza delle organizzazioni cattoliche nei Corpi Consultivi dello Stato (giorgio luigi colombo); 6 dicembre, Il diritto alla tutela della pubblica moralità, delle cose e persone sacre (egilberto martire); discorso di chiusura del conte dalla Torre.
109 Autore, «l’osservatore romano», 1° dicembre 1913, Solenne apertura della VIII Settimana sociale dei Cattolici italiani nel XVI Centenario della libertà della Chiesa. Il testo integrale dell’intervento di rossi è reperibile La cultura sociale dei cattolici italiani alle origini, pp. 127-147.
110 Ibidem. corsivo così nel testo.111 Ibidem.
FrAnceSco TAcchI272
dal momento che «non [era] neppure concepibile la libertà della chiesa senza la libertà del papa»112. Tale libertà avrebbe dovuto essere:
Reale ed effettiva e non fittizia; non un titolo di onore e di preminenza, ma una vera autonomia.dev’essere manifesta e insospettabile, perché potere spirituale e universale […].dev’essere piena e completa, rispetto a tutti gli atti del suo ministero spirituale e universale.dev’essere non precaria, ma stabile e intangibile.Suffragata da una malleveria o caparra internazionale, interessando questa libertà i cattolici di tutte le nazioni113.
Per secoli, riconosceva rossi, l’indipendenza della Santa Sede era stata garantita dal principato civile dei Papi; finito ormai quel tempo, occorreva porre al centro del dibattito pubblico la questione della liber-tà del Pontefice, libertà negata in un’epoca storica di fatto neopagana: «nessuna pregiudiziale adunque, nessun interdetto contro una leale e serena discussione del problema»114. nelle parole dell’Arcivescovo non vi era un riferimento al potere temporale come soluzione della questione romana, e tuttavia ciò dovette dipendere non da un reale convincimento del prelato, quanto piuttosto da una precisa scelta ‘tattica’: non a caso, nelle proprie memorie giuseppe dalla Torre avrebbe scritto che rossi si era soffermato sui «caratteri necessari di una stabile ed intangibile garan-zia per la Santa Sede, anche se diversa da quella secolare, per le difficoltà del momento»115.
Al presidente dell’Unione Popolare spettò di chiudere i lavori: egli si soffermò sul concetto di laicità dello Stato, concetto a suo modo di vede-re spinto all’estremo fino a divenire laicismo, «il quale non solo astrae dalla religione del popolo, ma costituisce lo Stato nel diritto di sovrasta-re, più o meno direttamente, alle coscienze religiose»116. Tale laicismo o ateismo di Stato, recrudescenza dello spirito pagano, non avrebbe mai potuto essere accettato dai cattolici, i quali invece sarebbero stati pronti ed ammettere un principio di laicità inteso come «distinzione di poteri» e «naturale delimitazione di due campi» fra Stato e chiesa117. È chiaro come le parole di dalla Torre andassero sempre nella direzione di non
112 Ibidem.113 Ibidem. corsivo così nel testo.114 Ibidem.115 g. dalla Torre, Memorie, milano, mondadori, 1965, p. 26. 116 «l’osservatore romano», 7 dicembre 1913, L’equivoco della laicità. Testo integra-
le in La cultura sociale dei cattolici italiani alle origini, pp. 466-483.117 Ibidem. Per una contestualizzazione di tale problema rimando a d. menozzi,
Dalla “peste del laicismo” alla “sana laicità”. L’itinerario novecentesco della chiesa cattolica
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 273
acuire i contrasti, bensì di favorire un dialogo col mondo moderato circa la questione della libertà del Papa118.
Quanto emerso durante la Settimana Sociale generò effettivamen-te un dibattito sulla stampa nazionale. In risposta ad alcuni giornali non cattolici intervenuti sull’incontro appena concluso, L’Osservatore Romano pubblicò un importante articolo – Dopo la Settimana Sociale di Milano. Interpretazioni e commenti, in data 20 dicembre – per offrire la lettura ‘ufficiale’ di quanto affermato durante la riunione milanese. l’organo della Santa Sede rivendicò per la Settimana un compito emi-nentemente di studio119: «Tale, e non altro, è il significato di siffatti con-vegni, nei quali non si tratta di risolvere problemi, ma di studiarli, non di prendere deliberazioni, ma di svolgere delle tesi»120; ciò che si era voluto evidenziare era la condizione di assenza di libertà per il Papa, dunque il bisogno inderogabile di discutere sulle opportune soluzioni a tale problema. l’interlocutore ovvio era lo Stato italiano, invitato a trovare guarentigie per la Santa Sede «equipollenti a quella millenaria assegnatale dalla Provvidenza»121; a tale garanzia – che, visto il carattere del Papato, avrebbe dovuto avere una portata internazionale –, sarebbe stato auspi-cabile giungere «per iniziativa spontanea, per un’azione diretta dell’Italia stessa e per costituzionale volontà del paese»122. Se la Settimana Sociale aveva voluto rimettere al centro del dibattito pubblico la soluzione della questione romana, essa però aveva anche sancito un ‘rovesciamento delle parti’ sottolineato con orgoglio da L’Osservatore Romano:
In passato (…) era la stampa liberale che rimproverava ai cattolici italiani di essere, per così dire, cristallizzati nella rivendicazione pura e semplice del principato civile dei Papi, senza ammettere od accettare in proposito qualsiasi discussione. ora siamo invece noi, cattolici italiani, che, non solo accettando, ma aprendo per conto nostro la discussione sul grave argomento, ci sentiamo rispondere dalla stampa liberale il quod scripsi, scripsi; senza pensare che questo scritto, che si pretende proclamare inviolabile, è quell’informe provvedimento
davanti allo stato laico, in Laicità e democrazia. Una questione per la teologia, a cura di l. casula, milano, glossa, 2011, pp. 181-208.
118 Tale discorso ebbe «tutte le opportune, benché segrete approvazioni. l’aveva rivisto il cardinale merry del val, e con poche cancellature pienamente accettato», come si legge in dalla Torre, Memorie, p. 26.
119 ciò si ritrova anche in dalla Torre, Memorie, p. 27: «la settimana era anzitutto di studio; in secondo luogo si era sollecitato lo stato a riconoscere il persistere della questione [romana]».
120 «l’osservatore romano», 20 dicembre 1913; l’articolo è riportato anche in «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 15 (dicembre 1913), pp. 39-41.
121 Ibidem.122 Ibidem.
FrAnceSco TAcchI274
della legge delle guarentigie la quale non ha potuto essere efficacemente appli-cata neanche dai suoi stessi autori, giacché qualche timido tentativo che se ne è fatto non è servito che a dimostrarne l’insufficienza123.
nell’anno costantiniano, i cattolici italiani assumevano dunque uffi-cialmente un ruolo propositivo nell’ambito della questione romana: que-stione internazionale, esattamente come il carattere delle feste centenarie. Queste ultime, del resto, con ogni probabilità furono concepite anche quale elemento di pressione sul governo italiano: le turbe recatesi a roma in pellegrinaggio da ogni parte del mondo avrebbero dovuto sottolineare la vitalità e la forza del Papato, colpito ma non prostrato dalla temperie secolarizzatrice, capace ancora di aggregare moltitudini compatte attorno a sé e di schierarle a propria difesa. Qualora poi il centenario non avesse prodotto effetti immediati, esso avrebbe comunque rappresentato un monito per il futuro: la sua «eco si [sarebbe] riperc[ossa] nella mente e nella coscienza dei popoli cattolici, e precipuamente degli italiani»124.
5. In hoc signo vinces: lo spirito del Centenario.
la critica allo Stato panteista e paganeggiante fu, come detto, la punta di lancia di una censura più ampia avente per oggetto il processo di seco-larizzazione, al quale si opponeva l’ideale del ritorno alla societas chri-stiana. A tal proposito, nella retorica utilizzata dall’episcopato italiano in merito al centenario – fra 1912 e 1914 – si possono individuare alcuni stilemi ricorrenti che rivelano lo spirito con cui, a detta della gerarchia, i cattolici avrebbero dovuto prender parte alle feste costantiniane.
I fedeli dovevano in primo luogo essere coscienti di come dio non avrebbe mai abbandonato la propria chiesa, specie nelle avversità maggio-ri; i nemici potevano combatterla in ogni modo, tuttavia i loro sforzi sareb-bero sempre risultati vani: «venuta l’ora di dio, all’insorgere di un nuovo massenzio non mancherà mai un nuovo costantino», scrisse nel febbraio 1914 il vescovo di carpi125. Il tema non era nuovo, ed attingeva alle stesse parole del vangelo, a quel portae inferi non prevalebunt adversus eam citato in molte Pastorali dell’epoca. corollario di ciò, era la certezza del trionfo
123 Ibidem.124 «l’osservatore romano», 10 dicembre 1913, La chiusura e gli effetti dell’anno
costantiniano.125 Il Vescovo di Carpi al Clero e Popolo della Diocesi in occasione della Quaresima 1914
– Torniamo all’antico! Ossia: ricordi e insegnamenti del XVI Centenario Costantiniano, Tip. gualdi e Figli, carpi, 1914, p. 16. Il vescovo era mons. Andrea righetti.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 275
finale della chiesa: su questo punto l’episcopato italiano insisté particolar-mente, al fine di comunicare ai propri fedeli un senso di ottimistica fiducia verso l’avvenire, immaginato migliore del presente neopagano. ovvio era il parallelismo con l’epoca costantiniana, momento del passaggio dalle cata-combe alle basiliche: l’editto era venuto dopo tre secoli di persecuzioni ed a ridosso della peggiore di esse, quella dioclezianea; i cattolici, dunque, non avrebbero dovuto temere la ‘persecuzione’ del secolo XX, proprio per-ché memori di quanto occorso in passato: «la chiesa di gesù cristo, e noi con lei e per lei, non siamo mai così vicini al trionfo come allora che ogni cosa sembra per noi irrimediabilmente perduta»126. le feste costantiniane sarebbero servite proprio a far rivivere ai cattolici lo spirito dei primi secoli del cristianesimo, rincuorandoli in vista delle sfide future127.
la vittoria era certa: ma solo dio ne avrebbe decretato il momento opportuno. l’editto stesso era succeduto a tre secoli di sangue, che tut-tavia, a detta dell’Arcivescovo di Pisa Pietro maffi, erano stati «concessi da dio come ammaestramento ai suoi nemici di tutti i tempi»128:
Tre secoli attese il Signore, ma poi si alzò potente, gridò: “basta!” e con la sua mano disperse in polvere i nemici. monito, questo, a quanti nei secoli futuri avrebbero voluto tentare di offendere la chiesa; monito grave e prezioso anche per noi, ai quali tre secoli di persecuzioni dicono come tutti dobbiamo ammi-rare i disegni del Signore anche quando non li comprendiamo, e per questo è da noi con ogni sforzo cooperarvi129.
Tale concetto fu ripreso da maffi anche nella Pastorale per la Quaresima 1914: i persecutori della chiesa avrebbero dovuto convincersi che se neppure l’Impero romano, «la forma più grande di potere (…) che mai sia stata sulla terra», per tre secoli «al servizio dell’inferno»130, era riuscito ad abbattere la Sposa di cristo, di fatto ogni loro sforzo si sareb-be rivelato inutile, la loro condanna essendo già scritta: «Alla chiesa i secoli; voi [persecutori] no, non passerete alla posterità, e le opere vostre e i sogni vostri si dissiperanno rapidi con voi»131.
nutriti di questa fiducia, i cattolici avrebbero dovuto preparare nuovi trionfi alla chiesa, ossia «la bramata restaurazione di ogni cosa in gesù
126 Ibidem, pp. 18-19.127 cfr. «XvI centenario della pace della chiesa», supplemento al n. 15, p. 1, Due
parole di conclusione. 128 «Il messaggero Toscano», 25 marzo 1913. Il giornale riporta l’omelia tenuta da
maffi per la Pasqua 1913.129 Ibidem.130 card. Pietro maffi, Arcivescovo di Pisa, Moniti del Centenario Costantiniano –
Quaresima 1914, Tip. orsolini-Prosperi, 1914, pp. 3-4.131 Ibidem, p. 9.
FrAnceSco TAcchI276
cristo, augurale sospiro del supremo pastore della chiesa»132: la loro sarebbe stata, a tutti gli effetti, «una riconquista»133. Quale modello di comportamento adottare per compiere tale opera? la risposta offerta dal centenario era univoca: quello del martire.
le feste costantiniane si caratterizzarono per una vera e propria marti-rofilia: le figure eroiche dei primi secoli del cristianesimo furono oggetto di culto e di studio, e le stesse manifestazioni tesero a valorizzarne il valore paradigmatico; a ciò contribuirono ovviamente gli impulsi provenienti da roma, in particolare dal Collegium Cultorum Martyrum. Se nella capitale si riservò speciale attenzione ai luoghi di sepoltura dei primi testimoni della fede, in altre località si diede grande importanza alla venerazione delle loro reliquie: un caso eclatante fu quello della diocesi di nepi e Sutri, dove il 24 agosto 1913 vennero portati in processione i corpi di san Tolomeo, di san romano e dei loro trentotto compagni, «per primi in occidente vittime della persecuzione pagana. (…) le casse con i corpi dei martiri erano por-tate su barelle artistiche coperte di velluto cremisi e frange d’oro, ciascuna delle quali era portata da quattro giovani vestiti in costume del I secolo mentre altri giovani portanti ceri e palme circondavano il corteo. Questo era preceduto dal nuovo labaro costantiniano in seta e oro avente le imma-gini di costantino e elena»134. I temi dell’esemplarità dei martiri e della disposizione al martirio connotarono gli interventi dei vescovi italiani fra 1912 e 1914: il trionfo dell’editto era stato d’altronde preparato dall’età delle persecuzioni, e la stessa civiltà cristiana era una civiltà «santificata nel battesimo del sangue de’ martiri, e venuta su alla luce, lasciando le tenebre delle catacombe»135. I cattolici moderni avrebbero dovuto rifarsi allo spirito di chi era passato attraverso ‘la grande tribolazione’ per testi-moniare la fede in cristo, ricordandosi che se oggi erano accusati di essere nemici della patria, i loro predecessori erano stati a loro volta bollati come nemici dell’ Impero136. Sarebbero occorsi insomma «cattolici di carattere»137, pronti ad agire nella società al fine di risanarla, disposti al sacrificio di sé:
132 Alfonso maria mistrangelo, Arcivescovo di Firenze, Feste costantiniane 1912-1913 – Lettera circolare, Firenze, Tip. Arcivescovile, 1912, p. 8.
133 La Chiesa di Gesù Cristo nel grande Centenario – Lettera Pastorale di Mons. Carmelo Pujia, Arcivescovo metropolitano di Santa Severina, p. 44.
134 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 14 (novembre 1913), p. 22.135 La Chiesa di Gesù Cristo nel grande Centenario – Lettera Pastorale di Mons.
Carmelo Pujia, Arcivescovo metropolitano di Santa Severina, p. 7.136 cfr. «l’Italia reale», 4 gennaio 1912, La costanza odierna dei cattolici e il cente-
nario costantiniano.137 I frutti dell’anno costantiniano (conforti e speranze) – Lettera Pastorale di Mons.
Luigi Capotosti, p. 17.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 277
un sacrificio descritto in molte Pastorali quale passibile di spingersi fino al sangue, proprio come accaduto ai martiri. Il vescovo di Arezzo invitò così i propri fedeli a ricordare l’esempio dei primi cristiani, «ed imitando quei gloriosi padri nostri colla preghiera, colla immolazione preparare alla chiesa di gesù cristo novelli trionfi»138; pure il cardinal maffi affermò nella Pasqua 1913 che «figli dei martiri, pensiamo che è imitando i martiri che prepareremo altre glorie alla chiesa»139; alcuni mesi più tardi fu anche più esplicito: «Siate cristiani e siate tali esemplarmente: – questo il dovere vostro: – ma che la vostra vita passi tra le pene o nel gaudio, nelle prove o nel trionfo – che la vittoria oggi vi arrida o a domani si ritardi; questo non è e non deve essere preoccupazione per voi: dovere vostro essere santi, combattere e, se piacesse a dio, anche morire»140.
Il tema del martirio, classico del patrimonio retorico cattolico, ebbe dunque una larga diffusione nei mesi del centenario, presentandosi come svincolato dal riferimento all’eroismo militare che era stato ricor-rente durante la guerra italo-turca: il martirio ora evocato dai vescovi italiani era un martirio puramente contro-rivoluzionario, propedeutico alla restaurazione cristiana della società.
Se il modello veicolato dalle feste costantiniane risultò essere quello del martire, il loro simbolo fu senz’altro la croce: quella croce che, apparsa a costantino con il motto In hoc signo vinces, ne aveva decretata – secon-do il racconto di eusebio – la conversione al cristianesimo141. essa fu ovunque nelle feste romane – inizialmente si pensò pure di erigerne una monumentale sul monte cavo, nell’ambito delle solennità religiose142 – e al contempo caratterizzò le iniziative delle altre diocesi della penisola. la presenza del simbolo della fede in cristo si concretizzò soprattutto in due forme: con l’erezione di croci monumentali, appunto, e con l’organizza-zione di processioni ad esso dedicate; il 13 aprile 1913, ad esempio, per le vie di Anguillara Sabazia venne portata in trionfo la reliquia del Santo
138 Lettera Pastorale di Mons. Vescovo d’Arezzo al Clero e al Popolo della Diocesi, contenuta in XVI Centenario dell’Editto Costantiniano, bollettino diocesano pubblicato presso la Tip. Scheggi di Arezzo, 1913. Il vescovo in questione era giovanni volpi.
139 «Il messaggero Toscano», 25 marzo 1913.140 card. Pietro maffi, Arcivescovo di Pisa, Moniti del Centenario Costantiniano,
pp. 12-13.141 Proprio la croce rappresentata nell’arte italiana fu il tema di un Almanacco artistico
illustrato del 1913 – Ricordo del Centenario Costantiniano, Firenze, A. razzolini editore, 1913.
142 l’inaugurazione del monumento doveva avvenire il 4 maggio 1913; il tutto fu però rimandato all’autunno per problemi relativi alla proprietà del terreno sul quale si doveva procedere ai lavori (cfr. «l’osservatore romano», 27 aprile 1913): non ho trova-to, ad ogni modo, alcuna notizia relativa ad un’effettiva realizzazione dell’opera.
FrAnceSco TAcchI278
legno della croce, seguita da un corteo dove «si ammiravano gruppi di bambini e bambine rappresentanti i martiri più conosciuti dell’epoca anticostantiniana, recanti in mano i simboli del loro martirio e le palme verdeggianti»143; scene simili si ripeterono in molte altre località italiane.
nell’ambito del centenario, la croce assunse un significato ben pre-ciso: non simbolo di sofferenza, ma di trionfo, di vittoria 144; come aveva guidato costantino ad aver ragione di massenzio, così avrebbe condotto la chiesa di cristo al trionfo finale nell’epoca del redivivo paganesimo; viceversa, i suoi nemici non potevano sperare nel successo: «Se infatti in quel Segno è la vittoria, non può questa aversi all’infuori di lui, o peggio ancora, contro di lui. di questa anzi, non può, né deve mai tenersi sicuro chi nei privati negozi, alla croce ed ai suoi insegnamenti volga brusca-mente le spalle, o chi nel reggere le sorti della città e degli Stati neghi ad essa l’ossequio, il rispetto, la venerazione dovuta»145.
la vittoria della croce avrebbe dovuto coincidere con l’esaudirsi del voto pontificio di Instaurare omnia in Christo146: compito dei cattolici, dunque, quello di stringersi idealmente quanto più possibile al suo legno, resistendo alle prove ed alle ‘persecuzioni’ del presente con lo spirito dei primi martiri, animati dalla fiducia nel trionfo finale. la croce innalzata da costantino non sarebbe stata atterrata fino alla fine dei tempi, ferma di fronte all’urto di ogni nemico: per sottolineare questo messaggio, alcuni vescovi arrivarono addirittura a citare nelle proprie Pastorali il motto dell’ordine certosino, Stat crux dum volvitur orbis. È chiaro come una retorica del genere fosse funzionale al compattamento delle fila cattoliche attorno alle autorità ecclesiastiche – in primo luogo alla Santa Sede –, spingendole al contempo ad agire in seno alla società civile: il centenario costantiniano rinnovò di fatto l’invito a combattere la guerra apertasi con la rivoluzione, fungendo da sorgente cui attingere energie per le battaglie del presente e del futuro.
143 «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 9 (giugno 1913), p. 37.144 la croce come segno di vittoria e di affermazione dell’impero di cristo aveva
già caratterizzato gli anni finali del pontificato di leone XIII, che nell’enciclica Annum Sacrum (1899) aveva peraltro fatto esplicito riferimento in tale accezione a costantino ed all’apparizione dell’ In hoc signo vinces. cfr. d. menozzi, Sacro Cuore. Un culto tra devozione interiore e restaurazione cristiana della società, roma, viella, 2001, pp. 212-224.
145 «l’osservatore romano», 5 aprile 1912, In hoc signo vinces!146 cfr. «XvI centenario della pace della chiesa 313-1913», 2 (ottobre-novembre
1912), p. 5.
Il XvI cenTenArIo coSTAnTInIAno del 1913 279
6. Conclusioni.
concepita inizialmente in ambienti conciliatoristi, l’iniziativa del XvI centenario costantiniano fu in seguito fatta propria e sviluppata da set-tori dell’intransigentismo vicini alla curia, finendo in questo modo per coinvolgere e mobilitare l’intero cattolicesimo italiano nel quadro di una manifestazione dal carattere universale. la commemorazione ebbe come tema centrale il rapporto fra chiesa e moderno Stato laico, tanto che la Settimana Sociale del 1913 si propose di avviare un dibattito pubblico circa le possibili soluzioni alla questione romana; ad ogni modo, il centenario si configurò più in generale come una critica ed una risposta alla temperie secolarizzatrice, alla rivoluzione colpevole di aver spazzato via la societas christiana, e come un tentativo di rinfrancare – anche tramite potenti riferi-menti simbolici – le forze cattoliche infondendo loro uno spirito di fiducia circa l’esito della battaglia combattuta sotto il vessillo della croce.
l’anniversario costantiniano offre molteplici spunti per la riflessione: la ricerca storiografica, colpevole di aver a lungo trascurato tale vicenda, potrà e dovrà fare ulteriormente luce sui diversi aspetti che lo caratteriz-zarono. rimane da capire, ad esempio, l’eventuale incidenza che le feste ebbero sul percorso di ricomposizione della frattura fra Stato italiano e Santa Sede147. A tal proposito, è impossibile non notare l’ambiguità del centenario: se infatti i cattolici riuniti a milano cercarono – con il consenso della curia – degli spiragli per un confronto/dialogo con il potere civile, così da tentare di giungere a un superamento della scissione presente nella società italiana dal 1870, tuttavia tale tentativo si inserì in un contesto generale di feroce critica al modello di Stato partorito dalla rivoluzione, e di rinfacciamento al laico Stato italiano delle sue ‘colpe’ verso la chiesa e la religione cattolica. Per comprendere il perché di questo, credo che debbano essere considerati soprattutto due fattori: il crescente desiderio dei cattolici di inserirsi nella nazione, figlio di un genuino sentimento patriottico che la vicenda della guerra libica aveva ben palesato148; il persistere, soprattutto presso la gerarchia ecclesiastica, dell’orizzonte dello Stato confessionale, di quel connubio – tuttavia non
147 In merito, Pertici afferma in «Libertà del Papa», «libertà dei cattolici», p. 406, che la storia dei Patti lateranensi «non comincia col celebre incontro fra mussolini e il card. gasparri del gennaio 1923, ma rinvia all’ultimo decennio dell’Italia liberale».
148 cfr. m. caponi, Mourir dans une guerre »sainte«? Les catholiques italiens et la con-quête de la Libye (1911-1913), «Francia. Forschungen zur westeuropäischen geschichte», Xl (2013), pp. 445-454; g. cavagnini, Soffrire, ubbidire, combattere. Prime note sull’epi-scopato italiano e la guerra libica (1911-1912), «rivista di storia del cristianesimo», 1 (2011), Sacrificarsi per la patria, pp. 27-44.
FrAnceSco TAcchI280
paritario – fra potere religioso e potere civile rispecchiato nella forma più pura dalla cristianità medievale149. Stando così le cose, una qualche forma di ‘conciliazione’ sarebbe stata possibile, nel 1913, solo al prezzo di un abbandono del principio di laicità da parte dello Stato: in sostanza, quin-di, di una resa di quest’ultimo. I tempi non erano ancora maturi: sarebbe-ro passati degli anni prima della comparsa del ‘nuovo costantino’, di quel Benito mussolini firmatario dei Patti lateranensi150. Tale problematica, qui soltanto accennata, merita ad ogni modo di essere approfondita, così come del resto l’intera vicenda del centenario: la ricerca storiografica, specie se sostenuta da nuove acquisizioni documentali, può avere ancora ampi margini di sviluppo lungo questa direzione.
aBstract
The 16th Constantinian Centenary in 1913. Chronicle and Meaning of an Event
In 1913, the catholic church held a global celebration of the 16th centenary of the edict of milan, with which the emperor constantine conceded freedom of cult to christians after the age of persecution. While the subject of com-memoration was centuries-old, the message of the centenary was very much conceived for the present: the traditional catholic criticism of the process of secularisation – countered with an ideal return to the societas Christiana – was, first and foremost, articulated in the form of criticism of the relationship between the church and the modern State, with the latter accused of limiting the freedom of the former. In Italy, the centenary was therefore an opportunity for the catholic world to return the roman question to the centre of debate, presenting it is a stage along the journey of reorganisation of the fracture caused by the Breach of Porta Pia.
149 Per dirla con le parole di Jacques maritain, il persistere della concezione cristiana sacrale del temporale. Si veda in proposito Umanesimo integrale, p. 182.
150 cfr. l. Braccesi, Costantino e i Patti Lateranensi, in «Studi Storici», gennaio-marzo 1991, pp. 161-167. Si veda anche il recente contributo di A. guasco, Il “Nuovo Costantino” fascista. Immagini e utilizzi dell’imperatore tra Chiesa cattolica e regime, in Costantino I. Enciclopedia costantiniana,, vol. 3, pp. 469-480.