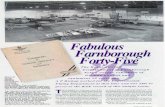Una tessera nummularia dal Palatino in Roma
Transcript of Una tessera nummularia dal Palatino in Roma
La tessera nummularia di Rufio è una piccola tessera d’avorio ritrovata sul Palatino, nei pressi del Tempio della Magna Ma-ter, durante gli scavi condotti dal prof. Pensabene. La tessera è stata rinvenuta in un preciso contesto stratigrafico (Saggio GJ). Lo schiavo Rufio esercitava il mestiere di nummularius, durante la seconda metà del I sec. a.C. (60-46 a.C.), e il suo lavoro può essere messo in relazione all’intensa attività economica che si svolgeva intorno al santuario, soprattutto per quanto riguarda il cambio di monete. Rufio è uno “schiavo-manager” che gestiva una serie di attività per conto del suo dominus. La storia degli studi sulle tesserae nummulariae è iniziata con il lavoro di R. Herzog nel 1919; poi è proseguita con un aggiornamento nelle ILLRP di Degrassi nel 1963, fino ai più recenti lavori sistematici di Andreau nel 1987 e 1999. La tessera più antica è datata al 96 a.C., mentre la più antica attestazione dei nummulari è confermata da un’iscrizione dedicatoria nel santuario di Praeneste, risalente all’ultimo decennio del II secolo a.C.
The tessera nummularia of Rufio is a little ivory card found in the north-west hill of Palatino, nearby the Magna Mater shrine, during an excavation campaign of P. Pensabene equipe. The tessera found in a precise stratigraphic context, and it is an important specimen that help us to know more about the nummularii activity. From the informations obtained, we know that Ru-fio practiced the profession of nummularius during the second half of first century B.C. (60-46 B.C.), and he probably belonged to the status of “slave-manager”. And his work be connected to the intense economic activity certified on the area.
The story of studies on the tesserae starts from the work of R. Herzog in 1919; and passing throughDegrassi reports on his ILLRP in 1963, the most recent systematic work about them is Andreau one in 1987 and 1999. The
most ancient tessera is from the 96 B.C, and in roman field the first presence of nummularii is confirmed from a dedicatory in-scription in the Praeneste area dating from the last decade of the 2nd century BC.
WIN - atti I 1 Roma e l’Italia
La tessera nummularia dall’area del Tempio della Ma-gna Mater
Sulle pendici nord-occidentali del Palatino, nei pressi dell’area del Santuario della Magna Mater, in un ambiente che molto probabilmente si apriva sulla strada proveniente da est, e che conduceva al recinto sacro, è stata rinvenuta una tessera nummularia, durante una campagna di scavo della Sapienza-Università di Roma, condotta dall’équipe di Patrizio Pensabene, del Dipartimento di Scienze dell’an-tichità. Essa si trovava nel riempimento di terra (Saggio GJ) datato, in base ai materiali ceramici, tra la metà/terzo quarto del I sec. a.C.1
L’area di ritrovamento è compresa tra il c.d. Augura-torium e il muro in opus reticulatum che costituiva il rial-zamento della suddetta strada, coincidente con le strutture immediatamente dietro l’Auguratorium stesso (Figura 1)
Si ringraziano gli studenti Gabriele Lepri, Sara Saccoccia, Davide Servolini per aver contribuito con la loro attiva partecipazione e elabo-rato i grafici, rispettivamente 1, 2 e 3, con le relative didascalie.
1 Pensabene 1987, pp. 69-76.
.Figura 1. Area del tempio della Magna Mater e indicazione
del luogo ritrovamento tessera nummularia (da Pensabene XXX).
UNA TESSERA NUMMOLARIA DAL PALATINO IN ROMA
Patrizia Calabria - FranCesCo Di Jorio
Una tessera nummolaria dal Palatino in Roma
WIN - atti I 2 Roma e l’Italia
La tessera d’avorio è di forma parallelepipeda (alt. cm 3, base cm 0,8x0,7), con appendice arrotondata, nella quale è praticato un foro passante (Figura 2). Presenta il seguente testo:
faccia 1: RVFIOfaccia 2: VEVEIfaccia 3: SP(ECTAVIT) K(ALENDIS) INT(ERCA-
LARIBVS)faccia 4: CN(EO) PO(MPEIO) M(ARCO) LI(CINIO
CRASSO) [CONSVLIBVS] II
Figura 2. Tessera nummularia dal Palatino (da Pensabene 1987, 71, fig. 1).
Dai dati si ricava che alle calende del mese intercalare, nel 55 a.C., durante il secondo consolato di Gn. Pompeo e M. Licinio Crasso, lo schiavo Rufio2, che forse appartene-va a un esponente della gens Veveia, e svolgeva l’attività di nummularius, ha controllato il quantitativo di monete presenti nel sacchetto, in seguito sigillato.
In base all’esame delle fonti letterarie ed epigrafiche, i nummulari (schiavi o liberti) attivi a Roma e nelle pro-vince dell’impero praticavano una serie di operazioni ban-carie, come il deposito/prestito e cambiavalute. Avevano i loro banchi nelle zone più frequentate della città (ad es. fora, o nei pressi dei santuari). A Roma uno di questi luo-ghi può identificarsi proprio con l’area del tempio della Magna Mater, dove affluivano anche pellegrini non solo dalla penisola, ma soprattutto dalle province orientali, come attesta la documentazione epigrafica3. Un nummula-rius Rufio, nelle tessere nummularie a noi note, è menzio-nato altre due volte4, e non sappiamo con certezza se svol-gesse le operazioni di deposito/prestito, cambio di monete o solo alcune di esse per conto di uno o più padroni. Infatti, nel caso si trattasse della stessa persona, questi controlla-va il denaro di almeno tre esponenti di famiglie diverse: Petelli, Vevei, Sertori, e la sua attività è databile tra il 60 e il 46 a.C. Tuttavia il ritrovamento di una sola tessera nummularia non fornisce elementi certi per affermare che nell’area del tempio ci fosse il solo Rufio a svolgere questo lavoro, oppure anche altri nummulari. La tessera riporta sulla faccia 2 il gentilizio Veveii. Il personaggio più noto è P. Veveius Papus, le cui attestazioni si trovano sia a Delo, presumibilmente come negotiator, che a Terracina, come
2 Kajanto 1982, 37, 120-122. In questa sede si precisa la lettura del nome del nummulario. Pensabene impiega il nome Rufius, mentre per noi quello più corretto di Rufio.
3 Castrén, Lilius 1970, 67-81. 4 Herzog 1937, n. 46, Rufio/Sertori, 60 a.C.; col. 1427, n. 72, Rufio/
Petilli, 46 a.C.
proprietario di un praedium dove si producevano anfore del tipo Dressel 1 e 2-4, attività connessa all’esportazione di vino. Infatti a Terracina, in località Canneto, sono state rinvenute circa duecento anfore, datate al 50 a.C., di cui alcune presentano un bollo in cartiglio rettangolare con scritto P. VEVEI.PA[PI] (Figura 3). Inoltre è da ricordare come il gentilizio Veveius fosse molto raro: ne esistono in tutto solo dieci attestazioni epigrafiche.
Figura 3. Bollo con cartiglio VEVEI.PA[PI]
(da Harsnad 1976, 167, fig. 4).
La datazione dell’attività svolta da Rufio (60-46 a.C.) è infatti confermata anche dai ritrovamenti monetari già noti, e dallo studio ancora inedito del materiale numisma-tico rinvenuto sul Palatino, con la presenza di assi, semis-si, quadranti e denari5. Questi dati confermano, dunque, l’intensa attività economica che si svolgeva attorno al san-tuario, in età repubblicana, e che richiedeva la presenza di personale specializzato alle dipendenze dei ricchi padroni che vi esercitavano i loro affari. Di fatto l’attività di de-posito/prestito e cambiavalute non risulta in contrasto con quella principale svolta dal ricco commerciante romano.
Patrizia Calabria
Considerazioni sulle tessere nummularie conosciute. Storia degli studi
Nella classe dell’instrumentum domesticum rientra una tipologia di oggetti definiti, fino agli inizi del secolo scor-so, come tessere consolari o gladiatorie6. Il primo studio sistematico è stato intrapreso da R. Herzog (1871-1953) nel 1919, che fu il primo a impiegare il termine tesserae nummulariae, con il quale sono conosciute fino a oggi. Tale definizione tuttavia non trova riscontri in nessuna fonte an-tica. Successivamente, nel 1937, alla voce nummularius, nella RE, approfondì l’argomento, catalogando tutte le tes-sere fino a quel momento note, per un totale complessivo di 145, includendo anche quelle di incerta attribuzione, e precisandone la funzione, ovvero quella di controllo del
5 Comunicazione presentata da P. Calabria, F. Coletti al XIII Congreso Internacional de Numismàtica (Madrid 15-19 septiembre 2003).
6 Per tutta la bibliografia precedente cfr. Pedroni 1995, 161-162.
Patrizia Calabria - Francesco Di Jorio
WIN - atti I 3 Roma e l’Italia
denaro custodito nel sacchetto al quale erano legate7. In seguito A. Degrassi (1887-1969) nel 1963 pubblicò nelle ILLRP tutte le tessere nummularie di età repubblicana8, mentre nei supplementi al CIL dell’AE (dal 1967 al 1970) sono state pubblicate altre tessere nummularie, classifica-te ancora come tesserae consulares9. Nel 1981 A. Dona-ti pubblicò alcune tessere rinvenute a Rimini, e ritenute, anche se con qualche riserva, autentiche10. Nel 1986 il lavoro di Degrassi è stato aggiornato nel supplemento al CIL I2 da H. Krummrey11; un anno dopo, nel 1987, è stata rinvenuta la tessera sul Palatino12. In seguito L. Pe-droni, nel 1995 pubblicò due tessere inedite provenienti da una collezione privata13. Nel 2001 la pubblicazione di altre due tessere, da parte di J. Andreau, conservate nel Ca-binet des Medailles, a Parigi14, infine si segnala l’esem-plare conservato al Fitzwilliam Museum di Cambridge15. Sempre Andreau nel 1987 e successivamente nel 1999 ha delineato un quadro esauriente su tutta la problematica che si è sviluppata intorno alle tessere nummularie e alla figura del nummularius16.
Luoghi di ritrovamento delle tesserae nummulariae
Le tesserae nummulariae finora note sono 165, e la maggior parte di esse sono state rinvenute a Roma o in Italia; sei provengono dalle province (Agrigento, Hadru-metum, Arles, Vieille-Toulouse, Virunum ed Efeso); men-tre ancora non si conosce la provenienza di quella con-servata a Cambridge (Fitzwilliam Museum). Quasi il 30% delle tessere fanno parte dalla collezione di W. Fröhner (1834-1925). Le altre sono conservate nei musei di Roma (Museo nazionale Romano), Parigi (Bibliothèque nationa-le de France), Londra (British Museum), Cambridge (Fi-tzwilliam Museum), Berlino (Staatliche Museen) e Vienna (Kunsthistorisches Museum). Allo stato attuale è difficile ricostruirne la provenienza (scavo, ritrovamento fortuito, acquisto), eccetto che della tessera nummularia del Palati-no, rinvenuta in un contesto stratigrafico definito.
7 Herzog 1919; Herzog 1937, coll. 1415-1455 (in part. coll. 1417-1418 per il termine tessera nummularia). Di queste: 138 certe, 2 di datazione imprecisata, 5 dubbie.
8 ILLRP, 257-278.9 AE 1967, 153, n. 486; AE 1968, 200-201, n. 619; AE 1969-1970, 7,
n. 6. 10 Donati 1981, 144-153.11 CIL I2, 961-963. Krummrey utilizza ancora il termine tesserae con-
sulares.12 Pensabene 1987, 69-76.13 Pedroni 1995, 161-197.14 Andreau 2001, 329-336.15 www.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/89457 (Loan Ant.103.143,
(Antiquities) (id: 89457; input: 2003-03-25; modified: 2012-01-13).16 Andreau 1987, 177-219, 485-525; Andreau 1999, 80-89.
Le tesserae nummulariae: aspetto, caratteristiche ed evoluzione
La tessera nummularia ha la forma di piccolo parallele-pipedo, d’avorio od osso (in pochi casi steatite o bronzo), lungo cm 3-10, largo cm 1-1,3, e con uno spessore di cm 0,7-1,2; la parte superiore presenta un’appendice separata da una piccola gola o listello, provvista di un foro passante che serviva a legarla al sacchetto di monete17. Come ha rilevato Andreau la parte superiore non ha sempre la stessa forma: inizialmente quelle di età repubblicana erano tutte uguali, poi assunsero quella di un cilindro; si assistette a un altro cambiamento in età augustea, quando si appiattì, assumendo l’aspetto di un tronco di piramide18. Su ognu-na delle quattro facce presenta un’iscrizione incisa19.
Sulla faccia 1 è indicato il nome del nummularius20 al nominativo, invece in un solo esemplare (n. 149) al posto del nummulario è raffigurato un tridente.
Sulla faccia 2 il gentilizio del padrone è al genitivo, il quale in alcuni casi può essere seguito dall’iniziale del praenomen e dalla lettera s(ervus) (nn. 1, 2, 31, 35, 70, 84), o solo dal praenonem (n. 142). In otto tessere (nn. 87, 90, 93, 94, 107, 119, 136, 149) il gentilizio è al nominativo, e tra esse tre (nn. 87, 94, 107) presentano i tria nomina21. In tre tessere è presente un nome femminile (nn. 103, 108, 127), mentre sussistono forti dubbi, avanzati anche da An-dreau, per la n. 79, dove compare il nome dell’imperatrice Livia, e la D5 per la presenza di due nomi di donna22. Tre tessere menzionano schiavi appartenenti a delle socie-tas publicanorum (nn. 5, 10, 106). In particolare la n. 10 indica l’esistenza di una società per lo sfruttamento delle miniere di ferro.
Sulla faccia 3 è riportato il verbo spectavit, abbreviato con sp in 124 casi, con spect (nn. 9, 12, 18, 80, 88, 101) in sei esemplari, spectavit (nn. 1-6, 8, 10, 11) in nove casi. Meno comuni sono le abbreviazioni spe, spec, specta, spectat; seguite l’indicazione del giorno e mese dell’av-venuto controllo. La faccia 4 riporta i nomi dei consoli in carica. Alcune tessere presentano, sulle facce 3 e 4, dei simboli come: corona, ramo di palma, delfino, tridente, caduceo, folgore e altare23 (nn. 1-4, 11, D14), oppure al-cuni cerchi (D2, D3): secondo Andreau i cerchi potevano indicare un sacchetto contenente semissi, trienti o qua-
17 I numeri delle tessere nummularie indicati tra parentesi si riferiscono a quelli della tabella 1; le tessere dubbie, elencate nella tabella 2, hanno la lettera D seguita dai numeri da 1 a 16.
18 Andreau 2001, 332.19 Per convenzione i lati sono denominati: faccia 1, faccia 2, faccia
3, faccia 4.20 Petrucci 1991, 255-256 e note 11, 12.21 Fabre 1981, 93.22 Andreau 1999, 83, in riferimento alle tessere di Herzog nn. 5 (= D5)
e 78 (= n. 79).23 Non è possibile confermare l’ipotesi di Herzog che queste raffigu-
razioni fossero gli attributi di divinità protettrici dei commerci e della navigazione: Herzog 1937, coll. 1434-1436; Andreau 1987, 494.
Una tessera nummolaria dal Palatino in Roma
WIN - atti I 4 Roma e l’Italia
dranti24. Pur non escludendo a priori tale ipotesi, i dati in nostro possesso non permettono di confermare questa supposizione, infatti queste tessere sono prive del verbo spectare e della data di controllo, e già Herzog aveva dub-bi in proposito25.
Per quanto riguarda i nummularii, solo in 14 casi lo stesso nummulario sembra lavorare per più di un padrone: Amphio (nn. 39, 64), Antiocus (nn. 36, 57), Celer (nn. 85, 123), Diocles (nn. 8, 17), Felicio (nn. 108, 111), Hilario (nn. 77, 78), Maximus (nn. 134, 143), Pelops (nn. 52, 54), Salvius (nn. 37, 44), e Suavis (99, 109) prestano servizio per due padroni; Faustus (nn. 49, 60, 104), Philargurus (nn. 30, 40, 61), Pilodamus (nn. 20, 25, 58),Rufio (nn. 42, 53, 72) per tre padroni; mentre di cinque tessere non si conosce il nome del nummulario (nn. 46, 128, 141, 146, 147).
Le gentes nominate nelle tessere sono molteplici e dif-ficilmente le troviamo ripetute più volte; esse compaiono una sola volta eccetto in alcuni casi: le gentes Autronia (nn. 75, 91), Caecilia (nn. 62, 78), Fabia (nn. 56, 131), Licinia (nn. 44, 138), Sextia (nn. 118, 146), Valeria (nn. 124, 143) e Volcacia (nn. 65, 82) compaiono per due vol-te; la Hostilia (nn. 23, 100, 125), Iulia (nn. 58, 129, 144), Manlia (nn. 49, 66, 76), Petillia (nn. 55, 72, 110) per tre; la Fulvia (nn. 3, 40, 68, 85) per quattro volte.
Le tessere con una datazione certa sono 137 e coprono un arco cronologico compreso tra il 96 a.C. e 88 d.C. La loro concentrazione risulta maggiore tra il 77 e il 42 a.C. con 57 esemplari, e tra il 27 e l’1 a.C. con 19 esemplari; tra il 3 e il 39 d.C. con 45 esemplari.
La presenza dei nummularii, in ambiente romano, è at-testata per la prima volta da un’iscrizione dedicatoria posta nel santuario della Fortuna Primigenia a Praeneste, datata all’ultimo decennio del II sec. a.C.26, mentre la tessera più antica risale al 96 a.C. (n. 9). L’attività dei nummulari nell’ambito di templi ove affluivano pellegrini provenienti da regioni lontane, oltre che a Praeneste è documentata anche a Roma, nell’area del tempio della Magna Mater, con il nummulario Rufio (n. 53). Tuttavia in alcuni san-tuari non c’erano solo nummulari addetti al cambio delle monete, ma nei pressi dell’area sacra era concessa anche la possibilità di gestire delle attività tipo cassa deposito/prestito27.
Confrontando le attestazioni epigrafiche e le tessere note, emerge che i nummulari cominciano ad aumentare a partire dalla seconda metà del I sec. a.C., dato ugualmente confermato dalle 52 tessere attestate tra il 59 e il 1 a.C. Un altro aumento si riscontra dalle epigrafi nella prima metà del I sec. d.C. ed ugualmente, le tessere dal 3 al 51 d.C. ammontano a 40. Dalla seconda metà del I sec. d.C. au-mentano le epigrafi, mentre le tessere, tra il 60 e 88 d.C.,
24 Andreau 1987, 493-495. La proposta è avanzata basandosi sul con-fronto di alcune emissioni bronzee di Cn. Cornelius Blasio: v. RRC, pa-gina, n. 296, 1a, 1h, 1i, 1k.
25 Herzog 1937, col. 1439. 26 ILLRP, n. 106 a: Nummular(i) Fort(unae) / Prim(igeniae) dant [- - -]
Mag(istri). 27 Per tutta la problematica v. Bodei Giglioni 1978, 57-58, 67-69.
sono solamente 11. Pertanto, dopo la fine dell’ultimo ven-tennio del I sec. d.C., mentre non abbiamo più attestazioni di tessere, la presenza epigrafica di nummulari continuerà fino alla prima metà del III secolo d.C.28
Considerando poi i tresviri monetales di epoca repub-blicana, tra il 96 a.C. e il 41 a.C., e mettendoli in relazione con le tessere dello stesso periodo, che sono 66, si rileva come 45 delle gentes menzionate sulle tessere hanno avuto tra i loro esponenti alcuni personaggi che ricoprirono que-sta carica29. La presenza dei magistrati monetari collegati con le gentes delle tessere non indica però che esse fossero emesse dalla zecca di stato, anzi lo stesso Herzog e in se-guito Andreau, lo hanno escluso30. Inoltre non è possibile stabilire l’esatta entità delle somme depositate, anche se Cary ha proposto che questi sacchi avessero un capienza prestabilita, e dunque non fosse necessario indicarne la ci-fra; mentre Herzog ipotizzò che al sacchetto fosse legata un’altra tessera con specificato la somma, il creditore e chi ha depositato il denaro31.
28 Andreau 1987, 304-306, solo per quanto riguarda le attestazioni epigrafiche.
29 Crawford 1974, 708-709, tab. LIX.30 Andreau 1999, 82.31 Cary 1923, 113; Herzog 1937, coll. 1420-1421.
Patrizia Calabria - Francesco Di Jorio
WIN - atti I 5 Roma e l’Italia
Grafico 1. Analisi cronologica delle tessere. I grafici mostrano la frequenza delle tessere nummularie: non si sono prese in considerazione le tessere attestate una sola volta in un anno. La più alta concentrazione di tessere nummularie la troviamo solamente nel 6 d.C. con ben sei esemplari attestati, mentre si riscontrato quattro tessere nel 71 a. C., 60 a. C., 56 a. C., 52 a. C. e 15 d. C. In nove anni diversi ne compaiono tre (70 o 55 a. C., 63 a. C., 62 a. C., 61 a. C., 54 a. C., 46 a. C., 19 a. C., 3 d. C. e 29 d. C.), mentre abbiamo diciassette anni in cui compaiono solamente due tessere (76 a. C., 59 a. C., 58 a. C., 57 a. C., 53 a. C., 50 a. C., 48 a. C., 26 a. C., 17 a. C., 5 d. C., 11 d. C., 13 d. C., 24 d. C., 32 d. C., 33 d. C, 44 d. C. 71 d. C.).
Grafico 2. Analisi frequenza tessere nei mesi. Il grafico mostra la frequenza delle tessere nummularie all’interno dei singoli mesi, senza prendere in considerazione gli anni. Come si può osservare, il mese più rappresentato risulta essere aprile con 25 esemplari; di seguito troviamo gennaio con 20, luglio con 16 e febbraio con 15 tessere. Il mese intercalare, poiché era inserito ogni due anni nel calendario pre-cesareo, presenta solo due tessere. Oltre a quello intercalare, i mesi meno rappresentati sono marzo e settembre con solo cinque esemplari. Dal grafico si può osservare che non c’è una distribuzione omogenea delle tessere nei mesi, ma ci sono periodi in cui l’attività del nummularius era decisamente più frequente rispetto ad altri.
Grafico 3. Analisi quantitativa delle tessere alle Kalendae, Nonae, Idus. Il grafico illustra la frequenza delle tessere nummularie alle calende, none e idi. Si può osservare come la frequenza della spectatio delle monete da parte del nummularius alle calende sia molto frequente rispetto agli altri giorni, essendo presente in 53 tessere; seguono le idi con 28 tessere e le none con 9. Gli altri giorni successivi o precedenti sono poco rappresentati nel materiale esaminato. È da sottolineare che il giorno più rappresentato, le calende, era quello riservato ai pagamenti e al saldo dei debiti.
Una tessera nummolaria dal Palatino in Roma
WIN - atti I 6 Roma e l’Italia
Tabella 1. Tesserae nummulariae autentiche. La tabella elenca tutte le 149 tesserae nummulariae di età repubblicana e imperiale ritenute autentiche, e tra esse sono incluse anche quella ritrovata rispettivamente nell’area del tempio della Magna Mater a Roma (n. 53), e quella conservata al Fitzwilliam Museum di Cambridge (n. 44). Le tessere nn. 1-8 sono state considerate da Herzog autentiche, e datate alla metà del II secolo a.C., in base agli elementi paleografici ed epigrafici32: tuttavia queste mancano dell’indicazione della coppia consolare. Dalla n. 9 alla n. 145 sono ordinate in base alla cronologia.
Faccia 1 Faccia 2 Faccia 3 Faccia 4
N. Nummularius Gens Controllo Data Consoli Datazione Bibliografia
1 GENTI PACONI T S SPECTAVITCorona lemniscata, ramo di palma
Tridente, caduceo Herzog 6; CIL I (suppl.) 948; ILLRP 994
2 PILEMO FVLVI Q S SPECTAVIT Folgore, altare, ramo di palma
Caduceo, tridente, delfino
Herzog 7; CIL I (suppl.) 949; ILLRP 997
3 PAMPILVS FVLVI SPECTAVIT Delfino Altare ardente Herzog 8; CIL I (suppl.) 2517; ILLRP 995
4 PILOMVSVS PERELI SPECTAVIT Ramo di palma Tridente Herzog 9; CIL I (suppl.) 950; ILLRP 998
5 PANPHIL. SOCIORVM SPECTAVIT Anepigrafe Anepigrafe Herzog 10; CIL I (suppl.) 951; ILLRP 996
6 PROTEMVS FALERI SPECTAVIT N-S Anepigrafe Herzog 11; CIL I (suppl.) 946; ILLRP 1000
7 DIODORVS DELI (BELI) SPEC Anepigrafe Anepigrafe Herzog 12; CIL I (suppl.) 947; ILLRP 993
8 DIOCLES VECILI SPECTAVIT A D V K FEBR Anepigrafe Herzog 13; CIL (suppl.) 945; ILLRP 999
9 CAPVTO MEMMI SPECT MEN NOVE CN DOMIT C CAS 96 a.C.Herzog 14; CIL I (suppl.) 889; ILLRP 1001
10 PILOXEN SOC FER SPECTAVIT N APR C COIL L DOM 94 a.C.Herzog 15; CIL I (suppl.) 2663a; ILLRP 1002
11 MENOPIL ABI SPECTAVIT Folgore C VAL M HER 93 a.C.Herzog 16; CIL I (suppl.) 890; ILLRP 1003
12 DARDA BAB SPECT NON FEBR L CORN L VAL 86 a.C. Herzog 17; CIL I (suppl.) 891; ILLRP 1004
13 COCERO FAFINI SP A D III N OC L CIN CN PA 85 a.C.Herzog 18; CIL I (suppl.) 892; ILLRP 1005
14 BATO ATTALENI SP A D IV N MAR L SVL Q MET 80 a.C.Herzog 19; CIL I (suppl.) 893; ILLRP 1006
15 .…A….. TARVTILI SP NON OCTOBR [D I]VNIO [M LEP] 77 a.C.Herzog 20; CIL I (suppl.) 943; ILLRP 1007
16 EVPOR MATRINI SP ID QVI CN OCT C CVR 76 a.C.Herzog 21; CIL I (suppl.) 894; ILLRP 1008
17 DIOCLES LONGIDI SP K SEP CN OCT C CVR 76 a.C.Herzog 22; CIL I (suppl.) 895; ILLRP 1009
18 PHILODAM DOSSE SPECT A D X K NOV M TEREN C CAS 73 a.C.Herzog 23; CIL I (suppl.) 896; ILLRP 1010
19 TEVPILVS MVNATI SP A D VI K SEX L GEL CN LENT 72 a.C.Herzog 24; CIL I (suppl.) 897; ILLRP 1011
20 PILODAMVS IVNI SP A D VI ID IA P LEN CN ORE 71 a.C.Herzog 25; CIL I (suppl.) 898; ILLRP 1012
32 Herzog 1937, col. 1433.
Patrizia Calabria - Francesco Di Jorio
WIN - atti I 7 Roma e l’Italia
Faccia 1 Faccia 2 Faccia 3 Faccia 4
N. Nummularius Gens Controllo Data Consoli Datazione Bibliografia
21 FLAC. NOVI SP K APR P LEN CN AVFID 71 a.C.Herzog 26; CIL I (suppl.) 899; ILLRP 1013
22 HYMNVS LVCRETI SP A D XV K MAI P LENT CN HOR 71 a.C. Herzog 27; ILLRP 1015
23 PILOTIMVS HOSTILI SP PR N SEX P LEN CN ORE 71 a.C. Herzog 28; CIL 900; ILLRP 1014
24 PILARGVRVS LVCILI SP A D VII ID AP CN PO M CRA 70 o 55 a.C.
Herzog 29; CIL 901; ILLRP 1016
25 PILODAMVS GELLI SP K QVI CN PO M CRA 70 o 55 a.C.
Herzog 30; CIL 902; ILLRP 1018
26 HERACLEO MVCI SP K QVIN CN POM MCR 70 o 55 a.C.
Herzog 31; CIL 903; ILLRP 1017
27 AESCINVS AXSI SP A D VII K AP Q HOR Q MET 69 a.C. Herzog 32; CIL 904; ILLRP 1019
28 EPAGATVS GAVI SP A D IV ID IAN Q REG L MET 68 a.C. Herzog 33; CIL 905; ILLRP 1020
29 GALLIO PEDICAE SP K SEP L IVL C FIG 64 a.C. Herzog 34; CIL906; ILLRP 1021
30 PHILARGVRVS EPILLI SP K IAN M TVL C ANT 63 a.C. Herzog 35; CIL907; ILLRP 1022
31 ANCHIAL SIRTI L S SPECTAT NVM MENSE FEBR M TVL C ANT COS 63 a.C. Herzog 36; CIL908;
ILLRP 1023
32 Anepigrafe Anepigrafe SP A D XIV K SEX M TVL C ANT 63 a.C. Herzog 37; CIL909; ILLRP 1024
33 HERACLIDA LOLLI SP K FEB D SIL L MVR 62 a.C. Herzog 38; CIL910; ILLRP 1025
34 FLACCVS RABIRI SP K APR D SIL L MVR 62 a.C.
Herzog 39; CIL911; ILLRP 1026; Andreau 1987, fig. 19
35 EVNVS FIDICLANI C S SP A D VI ID QVI D SIL L MVR 62 a.C.
Herzog 40; CIL2663b; ILLRP 1027; Andreau 1987, fig. 19
36 ANTIOCVS MAGVLNI SP ID MAI M PIS M MES 61 a.C. Herzog 41; CIL912; ILLRP 1028;
37 [PILAR]GVRVS [FIDIC]LANI Illeggibile ….QVI [M PV] M VA 61 a.C. Herzog 43; CIL914; ILLRP 1030
38 SALVI PERSI SP A D XVI K SEX M PIS M MES 61 a.C.
Herzog 42; CIL913; ILLRP 1029; Andreau 1987, fig. 19
39 AMPHIO INSTVMENNI SP A D IV K FEB L AFR Q MET 60 a.C. Herzog 44; CIL915; ILLRP 1031
40 PHILARGVRVS FVLVI SP A D IIX K APR L AFR Q MET 60 a.C. Pedroni 1995
41 APOLLONIVS PETICI SP K APR L AFR Q MET 60 a.C. Herzog 45; CIL916; ILLRP 1032
42 RVFIO SERTORI SP ID SEX L AFR Q MET 60 a.C. Herzog 46; CIL917; ILLRP 1033
43 PHILARGVRV PROCILI SP A D IX K AP C IVL M BIB 59 a.C. Herzog 47; CIL918; ILLRP 1034
44 SALVI LICINI SP ID.APR C IVL M BIB 59 a.C.
45 ELEVTHERVS TAMVDI SP PR ID QVI L PIS A GAB 58 a.C. Herzog 48; CIL919; ILLRP 1035
46 Illeggibile Illeggibile Illeggibile Illeggibile L PIS A GAB 58 a.C. Herzog 49; CIL920; ILLRP 1036
47 STEPANVS MAMMI SP A D IIX K AP P LEN Q MET 57 a.C. Herzog 50; CIL921; ILLRP 1037
48 [...] MEDES [CL]ODI [SP] K SEP [P LE]N Q MET 57 a.C. Herzog 51; CIL922; ILLRP 1038
49 FAVSTVS MANLI SP A D X K FEB CN COR L MAR 56 a.C. Herzog 52; CIL923; ILLRP 1039
segue Tabella 1
Una tessera nummolaria dal Palatino in Roma
WIN - atti I 8 Roma e l’Italia
Faccia 1 Faccia 2 Faccia 3 Faccia 4
N. Nummularius Gens Controllo Data Consoli Datazione Bibliografia
50 CHILO MVRRI SP A D VI K MAR CN COR L MAR 56 a.C. Herzog 53; CIL924; ILLRP 1040
51 ANTEROS ACILI SP ID QVI CN COR L MAR 56 a.C. Herzog 54; CIL925; ILLRP 1041
52 PELOPS PETILI SP ME QVI CN LE L PHIL COS 56 a.C. Herzog 55; CIL 926; ILLRP 1042
53 RVFIO VEVEI SP K INT CN PO M LI II 55 a. C. Pensabene 1987, pp. 69-76
54 PELOPS CASCELLI SP K IAN L DOM AP CLA 54 a.C. Herzog 56; CIL927; ILLRP 1043
55 PROTVS PETILLI SP A D VII K AP L DOM AP CLA 54 a.C. Herzog 57; CIL928 ; ILLRP 1044
56 THEOPROPV[S] FABI SP A D VII K OC[T] L DOM AP [CLA] 54 a.C. Herzog 58; CIL929; ILLRP 1045
57 ANTIOCVS SCRIBONI SP A D V ID IAN Anepigrafe (correggenza) 53/52? a.C. Herzog 59; CIL944;
ILLRP 1048
58 PILODAMVS IVLI SP A D III K FEB M VAL CN DO 53 a.C. Herzog 60; CIL930; ILLRP 1047
59 C OCTAVIVS Anepigrafe SP ID IVN Q MET INT 53 a.C.Herzog 61; CIL2663c; ILLRP 1046
60 FAVSTVS HETRILI SP K APR GN POM COS III 52 a.C. Andreau 2001
61 PHILARGVRVS ACONI SP PR K MAI CN POM COS TER 52 a.C.
Herzog 62; CIL931 ; ILLRP 1049; Andreau 1987, fig. 20
62 PHILEMO CAECILI SP ID IVN CN POMP COSIII 52 a.C. Herzog 63; CIL932; ILLRP 1050
63 PHILONICVS ALBANI SP ID SEP CN POMP Q ME 52 a.C. Herzog 64; CIL933; ILLRP 1051
64 AMPHIO LVRI SP ID IAN SER SVL M CLA 51 a.C.
Herzog 65; CIL934 ; ILLRP 1052; Andreau 1987, fig. 20
65 STABILIO VOLCACI SP K IAN L AEM C CLA 50 a.C. Herzog 66; CIL935; ILLRP 1053
66 EROS MANLI SP K OCT L PAVL C CLA 50 a.C. Herzog 67; CIL936 ; ILLRP 1054
67 HILARVS TVRPILIN SP ID QVI C IVL P SER 48 a.C. Herzog 68; CIL937; ILLRP 1055
68 SCVRRA FVLVI SP K OCT C IVL P SER 48 a.C.
Herzog 69; CIL938 ; ILLRP 1056; Andreau 1987, fig. 20
69 HERMIA Anepigrafe SP A D XV K DEC Q FVF P VAT 47 a.C. Herzog 70; CIL939; ILLRP 1057
70 PAMPHILVS SERVILI M S SPE K FEB C CAES M LEP 46 a.C. Herzog 71; CIL94071 THEVMNEST BAI SP ID INT C IVL M AEM 46 a.C. ILLRP 1059
72 RVFIO PETILLI SP ID NOV C IVL M AEM 46 a.C. Herzog 72; CIL941; ILLRP 1060
73 PHILOGEN ALFI SP ID SEX M ANT P DO 44 a.C. Herzog 73; CIL942; ILLRP 1061
74 MYRO CORNELI SP ID MAI M LEP L PLA 42 a.C. ILLRP 1062
75 PLOCAMVS AVTRONI SP K NOV L VIN Q LAR 33 a.C. Herzog 74; ILLRP 1063
76 [M]OSCHVS MANLI [SP] IX K APR IMP C VII M AGR III 27 a.C. Herzog 75
77 HILARIO ANNI SP K APR IMP C TAVR 26 a.C. Herzog 7678 HILARIO CAECILI SP III K NOV IMP C VIII T TAVR 26 a.C. Herzog 77
79 …..S L[I]V[IAE AVGV]STI SP K IAN IMP C[AES VIIII] M
SIL COS 25 a.C. Herzog 78
80 PHILOXENVS METEL SPECT K IVL IMP C X C NORB 24 a.C. Herzog 7981 HYPOLITVS SEPTIMI SP K IAN M LOLLIOCOS 21 a.C. Herzog 8082 AQVTVS VOLCACI SP K IAN C SENT SAT 19 a.C. Herzog 81
segue Tabella 1
Patrizia Calabria - Francesco Di Jorio
WIN - atti I 9 Roma e l’Italia
Faccia 1 Faccia 2 Faccia 3 Faccia 4
N. Nummularius Gens Controllo Data Consoli Datazione Bibliografia83 FELIX MVNDICI SP K APR C SENTIO 19 a.C. Herzog 8284 LEPIDVS MVMME IAN S SP M IVN C SENTIO COS 19 a.C. Herzog 8385 CELER FVLVI SP K APR C FVRN C SIL 17 a.C. Herzog 8486 DIORVS TREBONI SP K DEC C FVRN C SIL 17 a.C. AE 1968, n. 61987 L STLACCIVS BASSVS SP ID IVN M LICIN CN LENT 14 a.C. Herzog 85
88 IOLLA SALVIENI SPECT IV N MAR NER CLAVD T QVINT COS 9 a.C. Herzog 86
89 ANTHVS MARI SP ID APR C ASIN C CEN COS 8 a.C. Herzog 87
90 SERVILIVS CLEMENS SP K IAN T CLAV CN PISON 7 a.C. Herzog 8891 CALYX AVTRONI S K APR L PAS C CAL COS 4 a.C. AE 1967, n. 486
92 DEMETRIVS FADENI SP K IVN L LENT M MES COS 3 a.C. Herzog 89
93 FLORONIVS ROMANVS SP K DEC L CAN Q FABR COS 2 a.C. Herzog 90
94 M. PILIVS PHOENIX SP …K APR COSS LEN L PIS COS 1 a.C. Herzog 91
95 SYNEROS TONNI SP K APR L AEL M SERV COS 3 d.C. Herzog 92
96 PVDENS TITI SP NON APR L AEL M SERVIL COS 3 d.C. Herzog 93
97 FVRIVS GENER SP XVII K DEC P SIL L VOLVS COS 3 d.C. Herzog 94
98 CHRESIMVS VIRI SP ID IVN SEX AEL C SENT COS 4 d.C. NSc 1942
99 SVAVIS THYBRIDIS SP K IVL C VIB C ATEI COS 5 d.C. Herzog 95100 CINNAMVS HOSTILI SP X K AVG C VIB C ATEI COS 5 d.C. Herzog 96
101 VITALIS PAPIRI SPECT XVI K FEBR M LEPID L ARRVN CO 6 d.C. Herzog 97
102 HYLLVS CAEDICI SP K FEBR L ARRVN M [LEP COS] 6 d.C. Herzog 98
103 AMIANTHVS TRAGONIAE SP K MAR M LEP L ARR COS 6 d.C. Herzog 99104 FAVSTVS ANTONI SP K APR M LEP L ARR COS 6 d.C. Herzog 100105 INGENVOS ARRVNTI SP K OCT M LEP L NON COS 6 d.C. Herzog 101
106 PRIMVS SOCIORVM SP XIV K DEC M LEP L NONI COS 6 d.C. Herzog 102
107 C NVMITORIVS NORBANVS SP III K FEB A LIC Q CRET COS 7 d.C. Herzog 103
108 FELICIO RVPILIAE SP K APR M FVR SEX NON COS 8 d.C. Herzog 104
109 SVAVIS POBLICI SP K IVL SER LENT Q IVN COS 10 d.C. Herzog 105
110 OLYMPVS PETILLI SP N FEB M LEP T STAT COS 11 d.C. Herzog 106
111 FELICIO POMPONI SP ID OCT L CAS T STAT COS 11 d.C. Herzog 107112 ATHAMANS MAECENATIS SP K IAN C SIL L MVN COS 13 d.C. Herzog 108113 TYRANNVS TÌBERI SP ID FEB C SIL L MVN COS 13 d.C. Herzog 109
114 PLEBEIVS VARI SP N IAN DRVS C C NORB COS 15 d.C. Andreau 2001
115 CAPRATINVS CVRTIORVM SP ID IVN DRVS C C NORB CO 15 d.C. Herzog 110
116 CHRYSANTHVS SAVFEI SP ID AVG DRVS C M SIL COS 15 d.C. Herzog 111
117 FORTVNATVS CRVSTIDI SP K DEC DRVS C M SIL COS 15 d.C. Herzog 112
118 FRVCTVS SEXTI SP K FEB M SIL L NORB COS 19 d.C. Herzog 113
119 VALERIVS PRISCVS [SP] K IAN SER COL L VISE 24 d.C. Herzog 114120 REPENTINVS CANINI SP N IAN SER COL L VIS 24 d.C. Herzog 115121 PINVS DOMITI SP N SEP M ASIN C PET 25 d.C. Herzog 116122 OPTATVS VERGILI SP K MAI L RVB C FVF COS 29 d.C. Herzog 117123 CELER CLODI SP ID IVL L ASPR A PLAVT 29 d.C. Herzog 118
segue Tabella 1
Una tessera nummolaria dal Palatino in Roma
WIN - atti I 10 Roma e l’Italia
Faccia 1 Faccia 2 Faccia 3 Faccia 4
N. Nummularius Gens Controllo Data Consoli Datazione Bibliografia124 LIBANVS VALERI SP N OCT L ASPR A PLAVT C 29 d.C. Herzog 119125 CARVS HOSTILI SP VII K APR CAM ARR CN DOM 32 d.C. Herzog 120126 HELIODORVS CAVSINI SP XII K MAI CAM ARR CN DOM 32 d.C. Herzog 121127 MYRTILVS ATTIAE SP III N IVN L SVLL L SVLP 33 d.C. Herzog 122
128 Illeggibile Illeggibile Illeggibile Illeggibile L SVLP L SVLLA 33 d.C. Herzog 123; CIL I (suppl.)771
129 ECHIVS IVLI SP K IAN C CAES II L AP 39 d.C. Herzog 124
130 PINITVS ALLEI SP K FEB TI CL CAES II C CAEC COS 42 d.C. Herzog 125
131 PHOEBVS FABI SP K IAN T STAT C SAL 44 d.C. Herzog 126; CIL I (suppl.)776 y
132 CORINTHVS SCANTI SP ID IAN T STAT C SALL 44 d.C. Herzog 127133 PHILETVS RVTILI SP K APR TI PLAV ET COR 45 d.C. Herzog 128
134 MAXIMVS MANNEI SP V K OCT TI CLA V L CAL VET 51 d.C. Herzog 129; ILS
5161g135 HERMES VIBII SP KA[L ] AVG PATERC ET SALIN 60 d.C. Herzog 130136 CVRTIVS PROCVLVS SP VIII K DEC M VETTIO M AR 66? d.C. Herzog 131
137 MANLIVS MARTIALIS SP K IAN TI CATIO P GALLER 68 d.C. Herzog 132; CIL I
(suppl.)776d
138 DONATVS LICINI SP K FEB IMP CAES VESP III M C N 71 d.C. Herzog 133
139 SALVIVS CALPVRNI SP XIII K AVG L FLAVIO FIM C ATI 71 d.C. Herzog 134
140 CLEMEN[S] Illeggibile SP ID O[CT] M VIPST C RV 71/72? d.C. Herzog 135141 Illeggibile SILI SP ID DEC C [LIC T FL ]SA 72? d.C. Herzog 136142 APOLO T FAVSTI SP K I[...] C RVTILIVS 72/73 d.C. Donati 1981
143 MAXIMVS VALERI SP ID IAN T CAES AVG F IIII AELIAN II 74 d.C. Herzog 137
144 ARSINAS IVLI SP VIII K MAIC FISIO SABIN M ANNIO MASSAL COS
83 d.C. AE 1969-1970, n. 6
145 MODERATVS LVCCEI SP III NON OCT L MINIC L PLOTIO 88 d.C. Herzog 138146 Illeggibile SEXTI SP ID … …..COS Herzog 139147 Illeggibile RVBRI ? ? ? Herzog 140148 PAMPIL CREMVT SPECTA Palma Pedroni 1995149 Tridente M VLLIVS SP ID IVL Q VIBIO IVL Donati 1981
segue Tabella 1
Patrizia Calabria - Francesco Di Jorio
WIN - atti I 11 Roma e l’Italia
Tabella 2. Tesserae nummulariae considerate dubbie. Questo gruppo comprende tutte le tessere che non presentano sulla faccia 4 il verbo spectavit (eccetto D6, D7) e sulla cui autenticità sussistono dubbi.
Faccia 1 Faccia 2 Faccia 3 Faccia 4
N. Nummularius Gens Controllo Data Consoli Datazione Bibliografia
D1 ANDREA POMPON L. S Ramo di palma Corona con fascia Herzog 1; ILLRP 987
D2 LICCAIVS POMPON Anepigrafe
Coroma e fascia, ramo di palma, 3 doppi cerchi
4 doppi cerchi Herzog 2; ILLRP 988
D3 STATIS CLOIL. C 3 doppi cerchi 3 doppi cerchi 3 doppi cerchi Herzog 3; ILLRP 991
D4 PILON. NOVI Anepigrafe Anepigrafe Anepigrafe Herzog 4; ILLRP 989
D5 PHILOD RV SAB Anepigrafe ….. ….. Herzog 5; ILLRP 990
D6 ALBINVS ….. SP. K. IVN TI.ANTTIO Q.VIBIO
anteriore 83? d.C.
Herzog 141; CIL I (suppl.)776 a
D7 FELIX ANTONI SP. K. IVN FVLVO.COS anteriore 85? d.C.
Herzog 142; CIL I (suppl.)776 e
D8 ACVTI. BABVDI RASVR L. M. M. L S SERV ….. ….. ….. Herzog 143
D9 DAR….. ….. ….. A.D. X….. ? Herzog 144; CIL XII 5695,2
D10AMIANTHVS (graffito sopra RASVR)
….. ….. ….. ….. Herzog145
D11 RVTILIVS IVL G[…] ME DIV I[…] FL N[…] Donati 1981
D12 […]ESTVLA […]VINIA […]ID Q AD […]FA IV Donati 1981
D13 ACASTVS ALBI Q S Egger 1959; ILLRP 992
D14 BONO POMPO Ramo di palma Tralcio di vite Egger 1959
D15 MANDATVS S ANICETVS L COMINI SER Egger 1959
D16 L STLACCIVS L F SECVNDVS Egger 1959
Una tessera nummolaria dal Palatino in Roma
WIN - atti I 12 Roma e l’Italia
Il nummularius: uno schiavo manager
Lo sviluppo e intensificarsi dei traffici commerciali ha portato tra la fine del II e gli inizi del I sec. a.C. a una aumento dell’attività di saggio e cambio delle monete che fino a quel periodo era svolta dagli argentarii. Questo cam-biamento ha determinato la nascita di imprese specializza-te, mensae, e l’emergere della figura del nummularius.
Nelle fonti giuridiche romane il termine mensa indica un’attività economica organizzata e condotta professional-mente a fini di lucro, sia pubblica che privata. Nel caso dei nummulari si parla di mensa nummularia, mentre il luogo dove svolgeva il lavoro era designato taberna nummu-laria. La gestione privata di una mensa poteva essere sia individuale che collettiva, basata sulla praepositio (con-ferimento di poteri di gestione) di uno schiavo manager come institore. La gestione prevedeva cinque tipi di or-ganizzazione: 1) praepositio di uno schiavo manager; 2) praepositio di un liberto; 3) gestione attraverso il pecu-lium; 4) amministrazione diretta da parte del dominus; 5) esercizio collettivo33. Queste distinzioni sono importanti perché riguardavano la responsabilità del dominus sulle somme depositate presso la mensa e le eventuali azioni legali intraprese dai creditori. Solo nel primo e nel quarto caso il dominus rispondeva in solido delle somme di de-naro perse; mentre negli altri casi la sua responsabilità era solo parziale, invece nell’ultimo caso la forma era stabilita dal contratto di società stipulato34.
Dall’esame della Tabella 1 emerge con chiarezza che il tipo più diffuso era la gestione privata o collettiva della mensa nummularia con praepositio di uno schiavo mana-ger, in misura minore di un liberto, e in pochissimi casi direttamente dal dominus.
Questi schiavi manager avevano acquisito delle com-petenze specifiche, e godendo di ampia fiducia potevano gestire diverse attività finanziarie per conto del padrone, impiegando anche il peculium a loro riservato. Inoltre si delineavano così due figure di nummularius, quella del servus unius, ovvero lo schiavo manager che lavorava per un solo padrone, e il servus communis, colui che era alle dipendenze di più domini.
Infine, la scelta di gestire l’attività anche con il pecu-lium dello schiavo metteva al sicuro il dominus dal rispon-dere in solido nel caso di controversie legali. Tuttavia bi-sogna anche ricordare come i banchieri non godessero di una buona reputazione sociale, e dunque la scarsa presenza di cittadini liberi sulle tessere è un elemento che conferma tale situazione35.
33 Sull’intera questione: Di Porto 1984, in part. 31, 51-54, 58; Andre-au 1987, 447-448; Petrucci 1991, 20-62; Serrao 2000, 31-67; Petrucci 2003, 99-100; Andreau 2004, 123-125. Tuttavia non bisogna intendere questo tipo di organizzazione in senso troppo moderno, come evidenziato in Andreau 2004.
34 Andreau 1987, 177-178; Petrucci 2003, 102-120. 35 Sulla figura e l’attività di un banchiere di Pompei, L. Caecilius
Iucundus, v. Andreau 1974.
Tipo di attività svolta e luoghi
Il tipo di attività esercitata dai nummulari non era solo quella principale di cambiavalute, ma anche di cas-sa deposito e prestito, apertura a chiusura di conti, come è testimoniato in modo particolare dalle fonti giuridiche. Questa categoria lavorava in stretto contatto con altri ope-ratori di vari settori: commercio, trasporto, sfruttamento delle risorse minerarie. I nummulari non compaiono come intermediari nelle auctiones, ovvero nei crediti concessi durante le vendite all’asta, dove i soggetti preposti erano, invece, gli argentari o coactores argentari.
I luoghi di svolgimento della loro attività erano sia quelli consueti come fora o mercati, che i santuari più frequentati, come confermano l’epigrafe di Praeneste e la tessera del Palatino, dove la presenza del cambiavalute era più richiesta.
Da ultimo la scomparsa delle tessere nummularie, alla fine del I sec. d.C., non è da mettere in relazione a un pro-blema monetario, ma tuttavia l’attività del nummulario prosegue come è attestato dalla documentazione epigra-fica.
Patrizia Calabria - Francesco Di Jorio
WIN - atti I 13 Roma e l’Italia
Appendice: la tessera nummularia conservata al Fi-tzwilliam Museum (Cambridge)
Nella collezione del Fitzwilliam Museum di Cambri-dge si trova un’altra tessera nummularia (n. 44) che non risulta tra quelle fino a questo momento conosciute.
La tessera d’osso è di forma parallelepipeda (Figura 4). Presenta il seguente testo:
Faccia 1: SALVI(VS)Faccia 2: LICINIFaccia 3: S[P](ECTAVIT) ID(IBVS) APR(ILIS)Faccia 4: C(AIO) IVL(IO) M(ARCO) BIB(VLO)
[CONSVLIBVS]
Figura 4. Tessera Fitzwilliam Museum (riproduzione in cera e foto di Davide Servolini).
Dal testo si ricava che alle idi di aprile del 59 a.C., durante il consolato di C. Giulio Cesare e M. Calpurnio Bi-bulo, lo schiavo Salvius, appartenente a un esponente della gens Licinia, ha verificato e controllato il quantitativo di monete presenti nel sacchetto, successivamente sigillato.
Il nummularius Salvius non è menzionato nelle altre tessere fino a ora conosciute. Il nome risulta essere abba-stanza diffuso tra gli schiavi36. La tessera riporta sulla faccia 2 il gentilizio Licini. Uno tra gli esponente più noti della gens è il ricco Marcus Licinius Crassus Dives (114-53 a.C.).
Un passo di Plutarco riporta la presenza, tra gli schiavi dell’importante uomo d’affari e triumviro, una categoria con tale funzione37, e questo dato conferma l’esistenza di schiavi manager nummulari al servizio di esponenti dell’a-ristocrazia senatoria.
Francesco Di Jorio
36 Kajanto 1982, pp. 134, 177. 37 Plut., Crassus, 6,2; Andreau 1987, p. 503.
Bibliografia
Andreau, J. 1974, Les affaires de monsieur Jucundus, Rome.
Andreau, J. 1987, La vie financiere dans le monde romain: les metiers des manieurs d’argent (IV siecle av. J. C. - III siecle ap. J. C.), Rome.
Andreau, J. 1989, Il liberto, in Giardina, A. (a cura di), L’uo-mo romano, Roma-Bari, 187-213.
Andreau, J. 1999, Banking and Business in the Roman World, Cambridge.
Andreau, J. 2001, Deux tessères nummulaires inédites, in Re-vue numismatique, 157, s. 6, 329-336.
Andreau, J. 2004, Les esclaves “hommes d’affaires” et la ge-stion des ateliers et commerces, in Andreau, J., France, J., Pittia, S. (eds.), Mentalités et choix économique des Romains, Paris, 111-126.
Balbi De Caro, S. 1989, La banca a Roma, Roma.
Bodei Giglioni, G. 1977, Pecunia fanatica. L’incidenza eco-nomica dei templi laziali, in Rivista storica italiana 89, 33-76.
Cary, M. 1923, Tesserae gladiatoriae sive nummulariae, in The Journal of Roman Studies 13, 110-113.
Castrén, H., Lilius, H. 1970, Graffiti del Palatino, 2. Domus Tiberiana, Helsinki.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.
Crawford, M.H. 1974, Roman Republican Coinage, Cambri-dge.
Crawford, M.H. 1982, La moneta in Grecia e a Roma, Ro-ma-Bari.
Di Porto, A. 1984, Impresa collettiva e schiavo ‘manager’ in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.), Milano.
Donati, A. 1981, Su alcune tesserae nummulariae (?) di Ri-mini, in Gasperini, L. (a cura di), Scritti sul mondo antico in me-moria di Fulvio Grosso, Roma, 145-149.
Egger, R. 1959, Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1956 und 1957, in Carinthia I, 149, 156-159.
Fabre, G. 1981, Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la République romaine, Rome.
Hellmann, M.-C., Masson, O. 1994, Wilhelm Froehner nu-mismate, in Revue Numismatique 36, 308-329.
Hersnad, A. 1976, Note sur un atelier des amphores Dr. 1 et Dr. 2-4 près de Terracine, in Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Antiquité 89, 1, 157-168.
Herzog, R. 1919, Haus der Geschichte des Bankwesen im Altertum, tesserae nummulariae. Abhandlungen der Giessener Hochschulgesellschaft 1. Berlin.
Herzog, R. 1937. Nummularius, in Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 17,1, 1415-1455.
ILLRP = Degrassi, A., Inscriptiones latinae liberae rei publi-cae, Firenze, 1957-1963.
ILS = Dessau, H., Inscriptiones latinae selectae, 1-3, Berlin, 1892-1916.
Una tessera nummolaria dal Palatino in Roma
WIN - atti I 14 Roma e l’Italia
Invernizzi, A. 1994, Il calendario, Roma.
Kajanto, I. 1982, The Latin Cognomina, Roma.
Mainardis, F. 2001, Tesserae nummulariae tra Aquileia e Virunum. Gli esemplari di Iulium Carnicum, in Piccottini, G., Leitner, F.W. (eds.), Carinthia romana und die römische Welt. Festschrift für Gernot Piccottini zum 60. Geburtstag, Klagenfurt, 163-170.
Pedroni, L. 1995, Tessere da una collezione privata (con Appendice tecnica di G. Devoto), in Archeologia Classica 47, 161-201.
Pensabene, P. 1987, Tessera nummularia dall’area della Ma-gna Mater e della Vittoria sul Palatino, in Bollettino di Numi-smatica, 2, s. 4, 69-76.
Petrucci, A. 1991, Mensam exercere: studi sull’impresa fi-nanziaria romana (II secolo a.C.-metà del III secolo d.C.), Na-poli.
Petrucci, A. 2003, L’organizzazione delle imprese bancarie alla luce della giurisprudenza romana del Principato, in Lo Ca-scio, E. (a cura di), Credito e moneta nel mondo romano, Bari, 99-129.
Piccottini, G. 1991, Tesserae nummulariae, in Instrumenta inscripta latina: Das römische Leben im Spiegel der Kleinin-schriften. Ausstellungskatalog, Pecs, 83-85.
Serrao, F. 2000, Impresa, Mercato, diritto. Riflessioni mini-me, in Lo Cascio, E. (a cura di), Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano, Bari, 31-67.
Thébert, Y. 1989, Lo schiavo, in Giardina, A. (a cura di), L’uomo romano, Roma-Bari, 143-185.
Zehnacker, H. 1973, Moneta. Recherches sur l’organisation et l’art des émissions monétaires de la république romaine, 289-31 av. J.C., Rome.