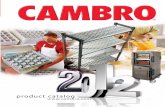In vivo Anti-Cancer Activity of Korean Angelica Gigas and its Major Pyranocoumarin Decursin
Angelica Kauffmann a Roma: l’attività per una clientela cosmopolita, in G. Mollisi (a cura di),...
-
Upload
uninsubria -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Angelica Kauffmann a Roma: l’attività per una clientela cosmopolita, in G. Mollisi (a cura di),...
282
di Laura Facchin*
7 novembre 1807: con una solenne cerimoniafunebre, organizzata e diretta da AntonioCanova, si concludeva la parabola terrena dellapittrice Angelica Kauffman1. L’artista vennesepolta nella chiesa romana di S. Andrea delleFratte, di fianco al consorte, il pittore AntonioZucchi2, secondo la sua precisa disposizionetestamentaria. La funzione aveva visto la parte-cipazione di artisti, letterati, personalità emi-nenti ed era stata annunciata e descritta daiprincipali periodici romani: raramente ad unartista era stato tributato l’onore di avere il fere-tro accompagnato da due dei propri dipinti, piùprecisamente, il David e Nathan e la Samarita-na al pozzo 3, “come il solo Raffaelle ottenne;altri vi aggiungono il Cav. d’Arpino”, precisavaGiuseppe Antonio Guattani nelle MemorieEnciclopediche Romane sulle Belle Arti 4. Il suc-cessivo passo, nel programma di celebrazionedell’artista, ebbe luogo l’anno successivo quan-do, su interessamento del cugino, JohannKauffman, un suo busto ritratto in marmo,opera di Peter Kauffman, anch’egli parentedella pittrice, venne collocato nel Pantheon,“presso quelli dei più celebri uomini, di cui sivantino le Arti”, tra cui, in anni non lontani,erano stati posti quelli di Joahnn Joachim
Winckelmann e Anton Raphael Mengs, perso-nalità ormai universalmente riconosciute comepadri del “rinnovamento” delle arti figurativeavvenuto a partire, circa, dal quinto/sestodecennio del Settecento e con le quali, in tempie modi diversi, la stessa Angelica aveva avutomodo di confrontarsi 5. Nuovamente si era svol-to “un magnifico funerale”, che aveva accom-pagnato il collocamento della scultura, comesottolineava Giovanni Gherardo De Rossi nellasua biografia dedicata alla pittrice, edita aFirenze due anni dopo, nel 1810, ultima tappanel processo di consacrazione della pittrice allastoria delle arti 6. Negli ultimi venticinque annidella sua vita, Angelika Kauffman, come atte-stano innumerevoli fonti coeve, più o menoripetutamente utilizzate della ormai copiosabibliografia sulla pittrice, incrementatasi in que-sto stesso anno, in occasione della celebrazionedel bicentenario della morte7, era stata fuori diogni dubbio una dei grandi protagonisti di quel-la Roma cosmopolita che si era venuta creandodalla metà del Settecento8, ed era riuscita amantenere salda la sua posizione anche attra-verso la “bufera” del passaggio dell’esercitofrancese e del suo successivo insediamento che,ella stessa, aveva visto con preoccupazione,
*Università degli studi dell’Insubria
L’attività per una clientela cosmopolitaAngelica Kauffman a Roma
283
come testimonia un suo scritto del 1792: “LaFrancia, purtroppo agita l’Europa intera. CheDio ci protegga da una guerra generale…”9.Dal 1766 residente in Inghilterra, la pittriceacquisì rapidamente una larga fama internazio-nale, tanto che, in una lettera dell’ottobre 1781,il poeta Friedric Gottlieb Klopstock, alle cuiopere la stessa Kauffman più volte si ispirerà neisuoi lavori, poteva affermare “The whole worldis angelicamad” 10. Insieme al marito AntonioZucchi, ormai consacrata “decima Musa”,prese la decisione, tra il 1781 e il 1782, di tra-sferirsi in Italia, pensando inizialmente a Napo-li 11, ove non mancarono i ripetuti inviti dellaregina Maria Carolina d’Asburgo, affinchéAngelica si risolvesse ad accettare la proposta didiventare pittrice di corte, optando, però, inbreve tempo, più opportunamente, per la Capi-tale delle arti. Assai benestante e già carica di pubblici ricono-scimenti, dal diploma dell’Accademia del Dise-gno di Firenze, ottenuto in giovane età, alla piùrecente nomina di membro onorario in quella diVenezia, conferitale da Giandomenico Tiepolo,senza dimenticare che essa stessa era stata a
Londra tra i fondatori della Royal Academyinsieme a Joshua Reynolds12, Angelica nel mag-gio del 1782 ritornava trionfalmente in quellaRoma che le era “sempre in pensiero”13, nellaquale, nella prima metà degli anni sessanta, nonsolo aveva, secondo una prassi ormai divenutaimprescindibile, potuto perfezionarsi nell’ambi-to del tradizionale viaggio di studio per le prin-cipali città d’Italia, ma dove aveva ottenuto iprimi, significativi riconoscimenti, quali lanomina di accademico di S. Luca14, e importan-ti commissioni, e aveva avuto l’opportunità diintraprendere significative conoscenze, special-mente tra i personaggi provenienti dall’areatedesca, ma ormai naturalizzatisi nella capitale,da Johann Friedrich Reifenstein (pittore eacquafortista, ma più noto come cicerone emercante d’arte, figura chiave di intermediarionei rapporti tra gli artisti residenti a Roma e ifacoltosi viaggiatori di cui indirizzava le visiteagli studi15), a Winckelmann. La giovane pittri-
Angelica Kauffman, David e Nathan, 1797,Bregenz, Voralberger Landesmuseum.
ce aveva avuto l’occasione di eseguire il ritrattodel celebre studioso, forse anche grazie alle rac-comandazioni del conte Carlo Gottardo Fir-mian, come è stato più volte ipotizzato16, cheper lei, come ricorda De Rossi, aveva una “par-ticolare affezione”. Governatore plenipotenzia-rio della Lombardia asburgica, fu convintosostenitore del progetto di riforma della politi-ca artistica viennese, tesa al “risorgimento delbuon gusto, e delle Belle Arti”, in direzione diun aggiornamento sulla cultura figurativaromana17. Winckelmann, apprezzando forte-mente il lavoro della Kauffman e l’incisione daesso derivata, con grande sensibilità ne avevatracciato un profilo, in qualche modo premoni-tore, in una lettera del 18 agosto 176418. Erapertanto assolutamente evidente nelle aspettati-ve di tutto quel variegato mondo delle artiromano, costituito non solo dagli artisti e dal
vasto pubblico del Grand Tour, ma anche daiconoscitori, dai letterati, dai mercanti/agenti,figure che spesso assommavano in sé più di unruolo con estrema versatilità, che la pittricefosse giunta nella capitale per giocare un ruoloda protagonista, pronta a mettersi in competi-zione anche con l’ottuagenario Principe dell’Ac-cademia di S. Luca, Pompeo Batoni19.
Numerose le testimonianze di questo primomomento: dall’elegante e noto omaggio di Giu-seppe Volpato, che dedicò alla Kauffman la suastampa de l’Aurora, da Guido Reni20 e che, uni-tamente alla sua famiglia, fu una figura di rife-rimento costante durante il soggiorno romanodell’artista, tanto da essere menzionato tra isuoi esecutori testamentari21, all’inedito com-mento di Tommaso Puccini22, futuro direttoredella Galleria degli Uffizi e dell’Accademia diBelle Arti fiorentina, allora figura di spicco nel-l’ambito dei conoscitori e dei salotti romani, inuna lettera all’amico casalese Ignazio De Gio-vanni del luglio 1783: “Angelika Kauffmancelebre pittrice si è stabilita in Roma questa set-timana, e ha dato scacco alla maggior parte deipittori. Io frequento la sua compagnia, e la fre-quentereste anche voi, se foste in Roma, e forse
Sopra, Peter Kauffman, Ritratto di Angeli-ca Kauffman, 1808, Roma, ProtomotecaCapitolina.A fianco, Angelica Kauffman, Ritratto diJohann Joachim Winckelmann, 1763, Züri-ch, Kunsthaus.
284
285
troppo” 23. Il rapporto con la poliedrica perso-nalità dello studioso pistoiese, non segnalatodalla critica recente, era destinato a durare neltempo. La pittrice gli era stata raccomandatadall’architetto Giannantonio Selva che, proba-bilmente, aveva avuto modo di conosceredurante il soggiorno veneziano del 1781/8224,dal momento che, nel diario del viaggio inInghilterra, avvenuto nel 1781, l’artista, purcitando ripetutamente la Kauffman, in procintodi lasciare il Regno Unito, non sembra avereavuto con lei rapporti di personale conoscen-za25. Nei mesi di permanenza a Venezia, tutta-via, la pittrice, grazie ai legami del marito edella sua famiglia, dovette stringere una serie diimportanti relazioni, attestate non solo dalle,pur varie, committenze per ritratti di esponentidel patriziato veneziano, ricordati dalla stessaAngelica nella nota Memoria delle Pitture. Traquesti spicca il successivo e poco noto ritratto diAndrea Memmo, sofisticata figura di commit-tente e trattatista, per la nomina a procuratoredi S. Marco26. Costanti furono i rapporti di soli-darietà e comunanza con la “colonia” di artistiprovenienti dalla Serenissima, quali il già men-zionato Volpato e il giovane Antonio Canova,giunto a Roma nel 1781 e, in quegli anni, forte-mente legato all’entourage dell’incisore bassa-nese27. Lo stesso Puccini fu tra i primi entusiastisostenitori dello scultore nei confronti del qualeintrattenne, anche dopo la partenza da Roma,regolari contatti epistolari 28, analogamente aquanto avvenne con la Kauffman. Purtroppo, ledodici lettere di mano della pittrice, solo mini-mamente menzionate nell’articolo monograficodi Alfredo Chiti, edito nel 1907, e dallo studio-so ricordate nella raccolta di manoscritti pucci-niani presso la Biblioteca Forteguerriana diPistoia, risultano da tempo perdute29. Dallerapide citazioni, tuttavia, emergono informa-zioni di notevole rilievo, oltre ad una, probabil-mente assidua, frequentazione durante il sog-
giorno romano del celebre “salotto” della pit-trice, ricordata con forte nostalgia negli annifiorentini, (“gli ameni giorni e le conversazionipiacevoli” 30). Assai evidente risulta il periodicoscambio e la circolazione di notizie circa i lavo-ri e le commissioni di comuni conoscenze, comenella lettera dell’ottobre 1804 in cui la Kauff-man informava Puccini del passaggio di LuisaStolberg, contessa d’Albany, nota committentee pittrice dilettante, da Roma per visionare,nello studio di Canova, il modello in gesso delmonumento funebre da erigersi a S. Croce, inmemoria di Vittorio Alfieri, impresa in cui l’eru-dito pistoiese ebbe un ruolo non secondario31.Al di là dell’autentico entusiasmo che la stessapittrice aveva manifestato nei confronti della‘città eterna’, appare evidente che il ritorno aRoma fosse stato accuratamente pianificato,molto probabilmente anche per interessamentodel marito che, come noto, sposando la Kauff-man in età matura, sebbene piuttosto accredita-to come pittore presso la committenza britanni-ca in qualità di decoratore e paesaggista, consa-
A fianco, Angelica Kauffman, Corneliamadre dei Gracchi, 1785, collezione privata. Sotto, Carlo Antonio Porporati, Cupido/Gardes a vous!, (1785/1790).
286
pevole del diverso e non confrontabile ruoloricoperto dalla consorte, preferì rinunciare allapropria carriera per affiancare Angelica nellasua frenetica attività32. Nell’ottica di un crescen-te accreditamento della pittrice, al di là di unplausibile sentito omaggio anche a livello pro-fessionale e sentimentale, la scelta di acquisirel’abitazione in cui era vissuto Mengs, da pochianni deceduto, risulta essere un vero capolavo-ro di auto promozione della propria immagi-ne33.
Come attesta la Memoria delle Pitture,soprattutto all’inizio della permanenza in Italia,il numero più considerevole di commissioniricevute dalla pittrice si annoveravano nell’am-bito della ritrattistica. Queste però non eranolimitate all’orbita dell’immagine-ricordo delGrand Tour, anche grazie, evidentemente, allacommissione del ritratto della famiglia reale diNapoli 34, immagine ufficiale, sebbene svincola-ta, per la scelta dell’ambientazione agreste el’abbigliamento dei protagonisti, da alcuni dei
canoni ufficiali normalmente richiesti per que-sto genere di opere. Da qui traspare la volontàdella Kauffman, già evidente dalla sua stessaformazione, come faceva notare, non disinteres-satamente, il De Rossi 35, e nella produzioneinglese, di affermarsi come pittrice in quelloche, ormai da secoli, la cultura accademicaaveva decretato come il più alto tra i generi incui un artista potesse cimentarsi, ovvero la pit-tura di storia36. Sin dal 1784-1785 appaiono, intale direzione, assai opportune le recensionidelle opere esposte nel suo studio che compar-vero sui due nuovi periodici dedicati alla cono-scenza dell’antico e alla promozione dell’artecontemporanea: le Memorie per le Belle Arti e ilGiornale per le Belle Arti. Specialmente nellaprima pubblicazione, fondata da GiovanniGherardo de Rossi, e curata, per la pittura e lascultura, dallo stesso, grande sostenitore dellaKauffman e in buoni rapporti con lei, dalmomento che per la compilazione della biogra-fia della pittrice, probabilmente concepita, inaccordo con l’artista stessa, prima della suamorte, egli potè accedere a documentazionepersonale della pittrice37, le opere selezionatenegli articoli risultano esclusivamente affronta-re temi di storia antica. Sin dall’edizione dell’a-prile 1785, dopo un’ampia introduzione sullepresenze femminili nella pittura dal Cinquecen-to al presente (introdotta dai versi di LudovicoAriosto della seconda stanza del 20° canto del-l’Orlando Furioso38), l’erudito destinava alcunepagine della rivista a descrivere analiticamentele opere da lui stesso osservate nello studio dellapittrice, la Morte di Virgilio e Cornelia madredei Gracchi per il collezionista George Bowles,a Londra39. Il commento conclusivo all’articolo,al di là di un’evidente propensione verso Ange-lica, dovuta a un’effettiva consentaneità digusto e di obiettivi nella produzione artistica, sirivela, a tutt’oggi, così come quelli contenutinella stessa biografia, stante l’unanime pareredella storiografia40, come una delle letture piùattente e sensibili dei lavori dell’artista: “Leopere della Signora Kauffman hanno una certauniversalità di bellezza, dalle quali si deduce,che questa donna oltre un impegno vasto, e fer-tile ha avuto dalla Natura il dono rarissimo
Sopra, Angelica Kaufmann, Ritratto diDomenica Volpato, Vercelli, Museo Borgo-gna e, nella pagina accanto, ancora undisegno del Ritratto di Domenica Volpato,Bregenz, Voralberger Landesmuseum.
287
delle Grazie. Di queste essa adorna ogni partedelle sue pitture, nelle quali perciò si veggonofisionomie tanto eleganti, espressioni così vere,e felici, atteggiamenti tanto gentili, ed effetto, edaccordo così grande nel chiaroscuro, e nel colo-rito. Il suo gusto nel comporre è vaghissimo,giacchè accoppia ad un certo lampo di anticasemplicità, quella feconda chiarezza d’invenzio-ne, di cui andrebbero più gloriose le scuoleveneziana, e fiamminga, se non ne avesserofatto abuso. Noi non aduliamo la sig. Angelicachiamandola la Pittrice delle Grazie, e qual raromerito siano queste in un Artista lo dimostra ilvedere, che per questo pregio le tele di AntonioAllegri emulano quelle di Raffaello, e bel loconobbe Carlo Maratta, quando nel suo dise-gno della Scuola della Pittura rappresentò leGrazie, che scendono dal Cielo, e scrisse sottodi esse: Senza le Grazie indarno è ogni fatica” 41.A distanza di soli quattro mesi, De Rossi torna-va a illustrare dipinti della Kauffman, ora occu-pata a realizzare un soggetto tratto dalla storiaromana, di grande impegno, sia per le imponen-ti dimensioni, non usuali alla pittrice che, piùfrequentemente, anche per opere di soggettoimpegnato, prediligeva il piccolo formato dettoalla “poussina”, sia per la committenza di unagrande protagonista della storia europea “illu-minata”, Caterina II di Russia42. La tela del“Servio Tullio fanciullo adormentato sopra unsedile nell’appartamento del Re Tarquinio Pri-sco” appariva “disegnata con bella facilità, lefisionomie sono eleganti, giusta è la disposizio-ne delle figure, armonioso l’effetto del chiaro-scuro, e il colorito è vivace, brillante, e vero,accompagnato da un tocco di pennello franco,e sicuro” 43. L’opera inaugurava una lunga seriedi richieste per la corte di Pietroburgo, sollecita-te anche dall’architetto di corte Giacomo Qua-renghi, deciso sostenitore della pittrice44, e con-fermava le scelte della coppia imperiale, PaoloPetrovich (futuro Zar di Russia) e la consorteMaria Fëdorovna, in viaggio, in incognito, nel1782, in tutta Europa, sotto lo pseudonimo diConti del Nord, che avevano avuto occasione diconoscere personalmente Angelica durante ilsoggiorno veneziano45, e di numerosi esponentidella nobiltà russa che costituiranno per lungo
tempo un filone di committenze privilegiato perla pittrice. Tra gli aristocratici viaggiatori delNord, per la continuità di apprezzamento e perl’indiretta attività di promotore delle operedella Kauffman, è senza dubbio da ricordare ilconte Nicolaj Borisovich Jusupov: dal 1784 al1790 nella Memoria delle Pitture sono menzio-nate ben otto tele di vario soggetto, dai ritrattiai frequenti soggetti mitologici di tematica amo-rosa46. Le sue vaste collezioni, conservate, per lamaggior parte nel palazzo cittadino e nelladimora di Archangelskoe, presso Mosca, furo-no incamerate dallo stato sovietico nel 1925, eper lo più trasferite nel museo dell’Ermitage,annoverando, per quanto attiene all’arte con-temporanea, opere di Batoni, Canova e David47. Negli anni tra il 1783 e il 1789, nonostante iripetuti viaggi a Roma e Napoli, ove potè per-sonalmente incontrare la pittrice, Jusupov svol-geva l’incarico di ambasciatore straordinariopresso la corte del Regno di Sardegna che dapochi anni, con la scelta di Laurent Pécheux alladirezione della nuova Accademia, esprimeva lavolontà del nuovo sovrano, Vittorio AmedeoIII, di imporre una radicale svolta nella politicadi promozione artistica dello stato48. Sin dalleprime committenze per le residenze reali, quali,tra il 1778 ed il 1784, la decorazione dell’anti-
288
ca Biblioteca di Palazzo Reale49, lo stile del pit-tore lionese, apprezzato dallo stesso Jusupov,che gli commissionò Pigmalione innamoratodella sua statua, allineato ad un classicismocolto e severo, frutto dell’elaborazione di ele-menti attinti dalla contemporanea cultura figu-rativa parmense, francese, ma soprattuttoromana, attenta alle più mature elaborazionidel Mengs (che era stato di passaggio a Torinonel 177450), si era rivelato estremamente adattoa tradurre in immagini un ambizioso program-ma iconografico che gli permetteva di dimostra-re la propria erudizione. Tale clima di rinnova-mento era stato percepito dagli stessi conti delNord che, durante la visita a Torino, avevanorichiesto alcune sculture e copie delle decorazio-ni per i nuovi ambienti di corte51, destinati adospitare i principi di Piemonte, ovvero il futuroCarlo Emanuele IV e la consorte, Maria Adelai-de di Borbone, e i futuri duchi d’Aosta, VittorioEmanuele e Maria Teresa d’Austria-Este, figliadell’arciduca Ferdinando d’Asburgo, personag-gi che, a diverso titolo apprezzarono le operedella Kauffman52. Benché dimenticato dallabibliografia recente53, i primi due, in esilio aRoma nel 1802, come ricordato con precisionedal De Rossi “anch’essi informati del rarotalento, e del personal merito di Angelica, volle-
ro visitare il suo studio, e conoscerla da vicino,e coi più affabili modi applaudirono i suoi lavo-ri” 54, secondo una prassi ormai consolidata,come attesta, ad esempio, il diario di SofiaAlbertina di Svezia del 1793, che prevedeva, trai momenti caratterizzanti del viaggio romano, lavisita agli atelier degli artisti 55. Per la novellasposa, Maria Teresa, nell’imminenza dellenozze, nel 1789, tra gli importanti doni si eradeciso di commissionare un’incisione al valenteCarlo Antonio Porporati, già richiesto dallacorte viennese56, tratta da un dipinto dellaKauffman recentemente giunto nell’abitazionetorinese del conte Jusupov, ove, evidentemente,prima del definitivo trasferimento in Russia,dovevano essere stati allestiti gli importantiacquisti effettuati nei viaggi romani e napoleta-ni 57. Tali presenze, seppure temporanee, sebbe-ne non determinassero specifiche commissionida parte della corte, contribuirono forse allaconoscenza delle opere dell’artista da parte del-l’aristocrazia sabauda, che in quegli stessi anniin prima persona, o attraverso agenti, aggiorna-va e incrementava le proprie collezioni conacquisti presso «l’unico emporio del bello e iltempio del vero gusto» 58. Ne sono testimonian-ze le stesse note della Memoria delle Pitture: senel 1791 la contessa Paola Perrone di San Mar-tino si limitava a commissionare un elegante,ma tradizionale, ritratto a mezza figura59, assaisimile nell’impostazione e negli elementi dimoda a quello di Domenica Volpato, oggi con-servato presso il Museo Borgogna di Vercelli 60,la marchesa di Priero ordinò alla Kauffman unatela di soggetto sacro, tema ancora raramenteaffrontato dalla pittrice a tali date: «Un quadroalto palmi 5.9, largo 4.7, con figure di tre palmie mezzo, rappresentanti Abramo ch’intima aAghar di partirsene con suo figlio Ismaele». L’o-
A fianco, Angelica Kauffman, Abramo cac-cia Agar e Ismaele, collezione privata. Nella pagina a fianco, Angelo Testa, Auto-ritratto in costume del Bregenzerwald,incisione pubblicata in G. De Rossi, Vita diAngelica Kauffman Pittrice, Pisa, 1811, daun dipinto di A. Kauffman, 1781.
289
pera, incisa da Alessandro Contardi, fu oggettodi una singolare predilezione da parte dellanobildonna che la portò spesso con se’ durantei ripetuti cambi di residenza tra Firenze eRoma61. Fu la stessa Polissena, nel luglio 1793,a richiedere con insistenza al marito che il suoreferente nella capitale, l’architetto piemonteseBartolomeo Cavalleri, si interessasse per procu-rarle una copia in gesso di un busto della Kauf-mann che uno scultore inglese andava compien-do, probabilmente riferendosi al ritratto scolpi-to dall’irlandese Cristopher Hewetson, artistacon cui la Kauffman ebbe un rapporto di fami-liarità62. Stante la forte predilezione nei con-fronti della pittrice, non è da escludersi che lamarchesa frequentasse, durante i soggiorniromani, il ‘salotto’ culturale creato dall’artista,dal momento che, stabilitosi alla fine del 1796,dopo molti rinvii e perplessità, di spedire a Tori-no tutto il materiale acquistato e custodito peranni a Roma dal Cavalleri, il marito, GiovanniAntonio Francesco, forse su suggerimento dellastessa Polissena, invitasse l’architetto a chiedereconsiglio alla pittrice riguardo al modo piùopportuno di imballare dipinti, arredi, stampe esculture63.
Numerose sono le fonti che attestano l’affabi-lità e disponibilità della pittrice, ma anche la suaversatilità nei confronti delle possibili attività diconsulenza correlate alla vera e propria praticaartistica. Ripetutamente la pittrice risulta coin-volta nella segnalazione e promozione dellamanifattura di biscuit dei Volpato presso il pub-blico inglese64, così come nei primi dell’Otto-cento essa figura quale tramite per acquisti sulmercato romano di dipinti antichi per i suoiaffezionati committenti napoletani65, e la stessa,poco prima della partenza dell’ammiratoGoethe, per il quale aveva più volte fatto da“cicerone”, lo dissuadeva dall’acquistare unaMusa danzante dal mercante d’arte AntonioRega, come attestato dal suo diario di viaggio66.È ben noto che la stessa pittrice avesse allestitonell’abitazione romana una piccola, ma estre-mamente selezionata raccolta di dipinti cheannoveravano anche il S. Gerolamo di Leonar-do da Vinci, poi passato alle Raccolte Vatica-ne67, e la sua capacità come conoscitrice doveva
essere nota, dal momento che il senatoreAbbondio Rezzonico aveva sottoposto al giudi-zio della pittrice un autoritratto eseguito daCanova a imitazione di Giorgione68.
Nell’ambito della molteplicità di richieste chepotevano essere presentate ad un artista dallaraffinata committenza del Grand Tour, attentanon solo ad acquisire preziosi oggetti d’arte, maanche a improntare al nuovo indirizzo classici-sta l’intero allestimento delle proprie abitazioni,non mancavano quelle per l’ideazione e la pro-gettazione di elementi di arredo. È ben nota lapartecipazione della Kauffman a tali commit-tenze durante il soggiorno londinese69, ma taliimpegni risultano documentati anche durantegli anni romani, come attesta nel 1792 la forni-tura di disegni per un centrotavola con partiscultoree destinato al doge di Genova, Miche-langelo Cambiaso70. Il committente fu una figu-ra molto attenta ai cambiamenti del gusto inatto negli ultimi decenni del Settecento, comedimostra anche la commissione del suo ritrattoufficiale ad Anton von Maron71, in linea con iltotale rinnovamento della Sala del MaggiorConsiglio del Palazzo Ducale di Genova72. Intale contesto si inserisce il ritratto di PaoloFrancesco Spinola di S. Luca, in veste da came-ra, secondo i nuovi modelli della ritrattistica,
290
pagato alla Kauffman ed eseguito durante ilsoggiorno romano del marchese nel 179373,mentre sono state del tutto ignorate due telettecon soggetti “di genere”, tipici della pittrice,specialmente durante la permanenza inglese,che rappresentano, rispettivamente, una Sibillache si svela e una Sibilla che legge, provenientidalle collezioni Durazzo, dal 1833 alla GalleriaSabauda di Torino74.La vastità di campi d’azione e la quantità diopere realizzate e a tutt’oggi esistenti, sottoposela pittrice ad un’attività continua, come già rile-vava, con una certa acredine, lo stesso Goethe:“Ella non è felice quanto meriterebbe, dato ilsuo grande talento e con quel patrimonio ches’accresce di giorno in giorno. È stanca di dipin-gere per commissione, ma al suo vecchio mari-
to non par vero di veder entrare tanto denaroper lavori qualche volta di così poco momento.Ella amerebbe di lavorare a piacer suo, con piùagio e maggior studio e preparazione; e potreb-be anche” 75. L’attività artistica doveva essereminuziosamente organizzata, come attestano iritrovamenti di specifiche liste di prezzi a stam-pa76, ed è noto che lo Zucchi collaborasse allefasi di preparazione delle opere. Nonostante letestimonianze coeve contrarie a tale ipotesi, dalmomento che, a più riprese, la pittrice avevarifiutato la presenza di allievi e potenziali aiutinel suo studio, è stato recentemente propostoche la pittrice potesse essersi avvalsa della colla-borazione del trevigliese Giovanni Battista del-l’Era, che le era stato raccomandato nel 1786dal cardinale Francesco Carrara, già tramite diun’importante commissione pubblica per lacittà di Bergamo77. In effetti, come si evinceanche dal carteggio intercorso tra il pittore e ilQuarenghi per alcune commissioni per il palaz-zo di Pietroburgo78, negli anni del suo soggior-no romano, il giovane artista dovette mantene-re costanti rapporti con la pittrice, suggeriti nonsolo da tali indicazioni documentarie, ma anchedai puntuali rimandi alla produzione dellaKauffman nei lavori eseguiti in quegli anni79. Inquesto caso, per quanto le testimonianze sianolimitate, se il giovane non ricevette direttamen-te insegnamenti dalla pittrice, tuttavia Angelica,nel 1789, si fece garante dei suoi progressidurante la permanenza romana, ma non neiconfronti dei suoi protettori bergamaschi, bensìverso la corte asburgica, costantemente intentaa vagliare le possibilità di opportunamentedevolvere i fondi, spesso condivisi, dell’Accade-mia di Brera e di quella di Vienna, per finanzia-re i soggiorni romani dei sudditi meritevoli,nonché per formare nuovi professori. In unarelazione del barone Pietro de Giusti, consiglie-re del Magistrato camerale, al ministro plenipo-tenziario di Lombardia, Johann Joseph Wilc-zeck, del mese di maggio, nell’ambito di unaserie di considerazioni relative alla mancanzanella sede milanese di un professore di Incisionee alle possibilità di rintracciare un valido sog-getto, veniva menzionato anche il Dell’Era,aspirante ad ottenere il pensionato, sul conto
Angelica Kauffman, Sacra Famiglia, 1789,Bergamo, Cappella Colleoni.
291
del quale, oltre a una segnalazione di Lesteve-nan de Berckenroder, era giunta una letteradella Kauffman che ne sottolineava i “saggidistinti”, sino ad ora eseguiti, che lo rendevanoun giovane di “non ordinaria aspettativa” 80. Ilparere della pittrice, nata a Coira, nel Cantonedei Grigioni, ma sempre dichiaratasi originariadel Bregenzerwald, luogo di provenienza dellafamiglia paterna e facente parte della vastacompagine asburgica81, e, come tale, considera-ta suddito dell’impero, era ritenuto, come sievince dal tono della lettera, decisamente rile-vante e il pittore trevigliese ottenne la sovven-zione82.
La stima goduta dall’artista presso la corte diVienna, al di là dei giovanili soggiorni milanesi,è attestata dal ben noto episodio della visita alsuo studio romano da parte dell’imperatoreGiuseppe II nel 1784 che le richiese, per primo,due opere di destinazione pubblica, ovveroErmanno e Tusnelda e Enea piange la morte diPallante, destinate ad essere esposte nel primomuseo pubblico dello Stato, la “Galleria Impe-riale”83. L’importante avvenimento trovò la giu-sta promozione, nuovamente, nelle pagine delleMemorie per le Belle Arti, ove, oltre alle con-suete descrizioni, non si mancarono di sottoli-neare due elementi di estrema novità nella ride-finizione dei rapporti tra artista e committenteche, in quegli anni, cominciavano appena a deli-nearsi, ovvero il fatto che l’imperatore avessedovuto attendere il completamento di lavori perl’imperatrice Caterina II, prima di vedere soddi-sfatta la propria richiesta, e la possibilità con-cessa alla pittrice di scegliere personalmente isoggetti da rappresentare84. Ancora una volta,in conclusione, il De Rossi lamentava la man-canza di commissioni pubbliche alla pittricenella capitale85. Come noto, l’auspicio del lette-rato doveva rimanere disatteso e, ad eccezionedel cartone per uno dei mosaici destinati allaSanta Casa di Loreto, rappresentante l’Educa-zione della Vergine, oggetto di numerose repli-che86, alla Kauffman mai giunsero altre com-
mittenze pontificie, sia da parte di Pio VI chedel suo successore.
Tuttavia, a partire dagli anni novanta, nonmancarono le richieste per opere di soggettosacro da parte di cardinali e prelati residenti inRoma. La prima fu, nel 1789, la pala con laSacra Famiglia per la cappella Colleoni di Ber-gamo, per la quale si fece mediatore il già ricor-dato cardinale Carrara87, e che fu oggetto diassai positivi commenti, sia durante l’esposizio-ne in Roma che all’arrivo nella città lombarda,all’epoca sottoposta alla Serenissima. Un effettosimile produsse la presentazione in pubblico,nel 1806, della tela con la Nascita di S. Giovan-ni Battista per la cappella privata della famigliaTosio in Brescia, ottimamente pubblicizzata,prima dell’invio al nord, da un foglio a stampadel De Rossi 88. L’opera, come narra lo stessobiografo, venne realizzata per l’abate FrancescoMartinengo da Barco, con la mediazione delcardinale Giulio Cesare Della Somaglia, “giustoestimatore dei di lei meriti” 89. Non sono maistati effettuati approfondimenti sui possibilirapporti tra la pittrice e il religioso, appartenen-te al ramo piacentino di un’antica famiglia
Nascita di S. Giovanni Battista, Brescia,1806, Galleria d’Arte Moderna.
292
milanese, né sugli interessi artistici del prelato,ma pare opportuno segnalare che nel 1775 eglicompose un’orazione per la consueta premia-zione degli artisti in Campidoglio che venneanche pubblicata sul periodico Efemeridi lette-rarie diretto da Giovanni Ludovico Bianconiche contava sottoscrittori ed estimatori anche aldi fuori della penisola90. Nel 1796, il vescovo diMunster, Baron Sufraganico Druste, le richiesedue grosse pale che, per certi aspetti, precorro-no il gusto per i primitivi che sarà proprio disuccessive generazioni di artisti, un’Annuncia-zione e un Cristo che benedice i fanciulli, ed ese-guì il ritratto per il cardinale Firrao91. Anche ilcardinale Antonio Dugnani, membro di un’im-portante famiglia milanese, come menzionafuggevolmente il De Rossi, richiese ad Angelicauna Testa di santo92. La commissione costitui-sce una delle poche indirette testimonianze diuna possibile continuità di rapporti con la Lom-bardia Asburgica, territorio nel quale era avve-nuta la formazione della pittrice e con il qualenon dovette interrompere i contatti, dalmomento che non solo mantenne affezionatiricordi dell’infanzia a Como, ma vi ritornò, nel1802, per la convalescenza, a seguito di unagrave malattia, intrecciando contatti con Gio-vanni Battista Giovio, erudito committente diopere aggiornate sugli indirizzi romani, conambiziosi programmi iconografici celebratividelle lettere e delle arti 93.
Proprio per essere collocato in una villa sullago, a Varenna, la pittrice eseguì nel 1794 il
dimenticato ritratto del conte Angelo Serpon-ti 94, i cui giardini “moderni”, in quegli stessianni, venivano elogiati dal Giovio, così comeper due assai differenti personaggi lombardifurono destinate due tra le ultime opere dellaKauffman. Nel 1804 liquidava Augusto e Cleo-patra, presentato nella rivista romana MemorieEnciclopediche Romane sulle Belle Arti 95, dainviarsi nella residenza parigina di GiambattistaSommariva, ove era stata allestita la raccolta diopere di pittura contemporanea, da Pierre-PaulPrud’hon a François Gérard, da Jacques-LouisDavid a Girodet, esponenti di una nuova e piùagguerrita declinazione del gusto neoclassico,artisti di generazioni più giovani, rispetto allaKauffman, che poteva però trovare un adegua-to termine di riferimento negli amati marmirichiesti all’amico Antonio Canova96. Una Mad-dalena penitente, tema canoviano per eccellen-za e testimonianza di quel costante interscam-bio tra pittura e scultura che caratterizzò anchela produzione romana della Kauffman97, fu l’ul-tima opera eseguita nel 1807. Prontamenterecensita nel periodico del Guattani, ancora unavolta fu richiesta da un committente bergama-sco, il conte Antonio Pezzoli, incontrato anniprima a Roma e amico del Beltramelli, che,come molti di coloro che avevano avuto mododi conoscere personalmente la Kauffman, inquegli stessi mesi, richiedeva al giovane FilippoAlbacini, figlio dell’amico scultore e restaurato-re Carlo, un ritratto dell’ormai anziana, maancora amabile pittrice98.
(1) G. G. De Rossi, Vita di Angelika Kauffman Pittrice, Pisa, 1811, p. 105; B. Baumgärtel, Leben und Werk von Angelica Kauffman, in B.Baumgärtel (a cura di), Angelika Kauffman 1741-1807 Retrospektive, catalogo della mostra, Düsseldorf, 1998, p. 38.
(2) Il pittore (Venezia, 1726-Roma, 1795), dopo una formazione presso lo zio Carlo, maestro di Piranesi, trascorse un periodo in Roma, trail 1761 e il 1766, anno nel quale si trasferì a Londra, su interessamento di Robert Adam, ai cui cantieri collaborò assiduamente, svilup-pando un decorativismo di gusto classicista con venature rococò, e specializzandosi in dipinti con soggetti architettonici e rovine. Nel 1770fu associato alla Royal Society. Nel corso dell’ottavo decennio del Settecento i suoi rapporti con la Kauffman si intensificarono, il fratelloGiuseppe Carlo aveva realizzato varie incisioni da suoi dipinti, e nel 1781 si sposarono, cfr. voce biografica in O. Sadner (a cura di), Angel-ica Kauffman e Roma, catalogo della mostra, Roma, 1998, p. 73.
(3) Il primo fu realizzato nel 1797 per il cardinale Zelada e il secondo nel 1796, su commissione del “Principe e Abatte di S. Biaggio in Ger-mania” cfr. Baumgärtel, op. cit., 1998, pp. 430-431, nn. 269-270.
(4) Memorie Enciclopediche Romane sulle Belle Arti, tomo III, 1807, pp. 94-95.(5) De Rossi, op. cit., 1811, p. 105; Baumgärtel, op. cit., 1998, pp. 38-39. Sul busto della Kauffman, trasferito, come gli altri ritratti illustri,
nel 1820 nella prima sala della Promoteca Capitolina, cfr. P. Coen, scheda n. VII.26, in F. Mazzocca, E. Colle, A. Morandotti, S. Susinno(a cura di), Il Neoclassicismo in Italia da Tiepolo a Canova, catalogo della mostra Milano, 2002, p. 472. Il busto di Winckelmann venneeseguito nel 1781 da Friedrich Wilhelm Doell (Veilsdorf, 1750-Gotha, 1816), quello di Mengs da Christopher Heweston (Thomastown,Co. Kilkenny, 1736 ca.-Roma, 1798) nello stesso anno, cfr. P.Coen, schede nn. VII.20 e VII.21, in Ibidem, pp. 468-469.
(6) Il letterato e conoscitore (Roma, 1754-1827) dedicò scritti, a tutt’oggi fondamentali, sugli artisti a lui contemporanei, sia monografici,come nel caso della Kauffman che nella rivista da lui fondata su sollecitazione del principe Abbondio Rezzonico, Memorie per le BelleArti, cfr. A. Rita, voce, De Rossi, Giovanni Gherardo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 1991, vol. 39, pp. 214-281; L. Bar-roero, L’occhio critico di Giovanni Gherardo De Rossi sulle belle arti, in F. Mazzocca, G. Venturi (a cura di), Antonio Canova. La cul-
293
tura figurativa e letteraria dei grandi centri italiani. 1. Venezia e Roma, atti della settimana di studi, Bassano del Grappa, 2005, pp. 281-295.
(7) Al momento della stesura del presente scritto è in corso, presso il Vorarlberger Landesmuseum, Bregenz, il Bünder Kunstmuseum in Chure nel paese di Schwarzenberg, la mostra, Angelica Kauffman a woman of immense talent, a cura di T. G. Natter, con catalogo bilingue.Recentemente è uscita anche la monografia di Angela Rosenthal, Angelica Kauffman art and sensibility, New Haven e London, 2006.
(8) Per una bibliografia recente riguardo al ruolo paradigmatico di Roma nel corso del XVIII secolo per artisti, intellettuali, viaggiatori, inparticolare come irrinunciabile punto di riferimento per tutti coloro che aderissero alle istanze di una cultura classicista, E. Borsellino, V.Casale (a cura di), Roma “Il tempio del vero gusto”. La pittura del Settecento romano e la sua diffusione a Venezia e a Napoli, atti delconvegno internazionale di studi, Firenze, 2001; L. Barroero, S. Susinno, Roma arcadica capitale delle arti del disegno, in “Studi di Storiadell’arte”, n. 10, 1999, pp. 89-148, versione italiana del saggio contenuto in E. P. Bowron, J. J. Rischel (a cura di), Art in Rome in theEighteenth Century, catalogo della mostra London, 2000; A. Cipriani (a cura di), Æqua Potestas. Le arti in gara a Roma nel Settecento,catalogo della mostra Roma, 2000. Con particolare riferimento agli ultimi decenni del Settecento, F. Mazzocca, E. Colle, A. Morandotti,S. Susinno (a cura di), Il Neoclassicismo in Italia da Tiepolo a Canova, catalogo della mostra, Milano, 2002, per una visione d’insieme;L. Barroero, S. Susinno (a cura di), La città degli artisti nell’età di Pio VI, in “Roma moderna e contemporanea”, Anno X, n. 1-2, gen-naio-agosto 2002, con interessanti ed innovativi approfondimenti.
(9) Nel 1798, quando le truppe francesi occuparono Roma, la pittrice ottenne la protezione del generale Augustin Lepinasse (Preully, 1737-Parigi, 1816), di cui eseguì il ritratto, cfr. O. Sadner, Roma come destino, in O. Sadner (a cura di), op. cit., 1998, p. XVI e scheda n. 76;Baumgärtel, op. cit., 1998, p. 37.
(10) Baumgärtel, op. cit., 1998, p. 31.(11) In una lettera da Venezia del 22 febbraio 1782, a Joseph Anton Metzler, la pittrice affermava che nel giro di tre settimane sarebbero giun-
ti a Roma e da lì si sarebbero trasferiti a Napoli, dove speravano di stabilirsi, cfr. W. Maierhofer, Art, fame, sentimente and self: construc-tions of identity in text and image, in Natter (a cura di), op. cit. 2007, p. 24, per lo scritto e Baumgärtel, op. cit., 1998, pp. 33-34.
(12) L’onorificenza fiorentina risaliva al 1762, anno in cui fu onorata anche dall’Accademia Clementina di Bologna; il riconoscimento dell’Ac-cademia di Venezia ebbe luogo nel 1781, durante il soggiorno con il marito prima del trasferimento a Roma. La fondazione della RoyalSociety ebbe luogo nel dicembre 1768.
(13) La citazione, tratta da una lettera scritta durante la permanenza londinese, ha dato il titolo a un significativo saggio di Anthony M. Clarkedito nel catalogo della prima mostra monografica di Bregenz/Vienna del 1968-1969, cfr. A. M. Clark, Roma mi è sempre in pensiero, inAngelika Kauffman und ihre Zeitgenossen, Bregenz, 1968, pp. 5-17.
(14) Il riconoscimento risale al 1764; in tale occasione la pittrice realizzò un ovale rappresentante La Speranza, più volte inciso, che donò all’ac-cademia come pezzo di ammissione, inaugurando un filone tematico di figure allegoriche ideali che ebbe grande fortuna commerciale,soprattutto attraverso le traduzioni in incisioni, cfr. S. A. Meyer, scheda I. 19, in A Cipriani (a cura di), op. cit., 2000, pp. 32-33.
(15) L’incontro tra la Kauffman e l’eclettico personaggio (Ragnit, 1719-Roma, 1793), consigliere aulico presso le corti di Gotha e Russia,avvenne a Firenze nel 1762, quando la pittrice ne eseguì un primo ritratto. Stabilitosi nel 1764 a Roma, divenne una delle figure più poten-ti nel complesso mondo del commercio d’arte; dal 1782 fu tra i personaggi più strettamente legati all’artista, cfr. voce biografica in Sad-ner (a cura di), op. cit., 1992, p. 120; C. Frank, Plus il y en aura, mieux ce sera, Caterina II di Russia e Anton Raphel Mengs. Sul ruolodegli agenti «cesarei» Grimm e Reiffenstein, in Mengs La scoperta del Neoclassico, a cura di S. Roettgen, catalogo della mostra, Venezia,2001, pp. 87-95.
(16) Sadner, op. cit., 1998, p. XIX.(17) De Rossi, op. cit., 1811, p. 11. Sugli interessi collezionistici del conte (Trento, 1718-Milano, 1782), dal 1752 al 1758 ministro plenipoten-
ziario dell’Impero a Napoli, con il medesimo incarico, dal 1759 al 1782, a Milano e vicegovernatore di Mantova, e sulla politica artisti-ca intrapresa dal governo asburgico, cfr. L. Facchin, Carlo Firmian e la politica artistica della corte viennese nel settimo-ottavo decenniodel Settecento. Alcune considerazioni, in Annali di Storia moderna e contemporanea, Milano, 2005, pp. 261-284.
(18) Baumgärtel, op. cit., 1998, p. 129. Il dipinto si conserva presso la Kunsthaus di Zürich.(19) Deceduto Mengs nel 1779, era noto a tutti i viaggiatori che ormai l’indiscusso primato nell’ambito della pittura venisse riconosciuto a
Batoni; si veda, a titolo di esempio, la testimonianza, non molto nota, del gesuita Juan Andres che, pur affermando di non essere un esper-to e di preferire le opere di Mengs, nel 1786 dichiarava nelle sue memorie di viaggio che nel 1785 “sin disputa algunia” il miglior artistafosse il pittore lucchese; il religioso riferiva anche della Kauffman che purtroppo non aveva potuto conoscere, trovandosi a Napoli, e cheaveva da poco ricevuto il “aplauso universal” per una tela dipinta per Caterina II di Russia, cfr. J. Andres, Cartas familiares del abate DonJuan Andres a su hermano Don Carlo Andres, dandole noticia del viage que hizo a varis ciudades de Italia en el año 1785, Madrid, 1786,vol. II, pp. 65-66.
(20) Cfr. G. Marini (a cura di), Giovanni Volpato 1735-1803, catalogo della Bassano del Grappa, 1988, pp. 151-152, 154, n. 278.(21) V. Manners, C. G. Williamson, Angelica Kauffman, R.A. her life and her works, New York, 1976, p. 245. Dal momento che il celebre
incisore (Bassano del Grappa/VI, 1735-Roma, 1803) premorì alla pittrice, al suo posto venne nominato lo scultore e restauratore CarloAlbacini (Roma, 1735-1813?) che risulta essere stato anch’egli in ottimi rapporti con la Kauffman con la quale condivise le commissioniper la clientela inglese e per Caterina II di Russia, cfr. G. Vaughan, Albacini and his english patrons, in “Journal of the history of collec-tions”, , vol. 3, n. 2, 1991, pp. 183-197.
(22) La vivace figura di Tommaso Puccini (Pistoia, 1749-Firenze, 1811) fu oggetto di un pionieristico articolo cfr. A. Chiti, Tommaso Puccini,in Bullettino Storico Pistoiese, fasc. 4, 1906, pp. 151-192, fasc. 1-2. 1907, pp. 1-53, fasc. 3, 1907, pp. 85-122; è stato ripetutamente ogget-to di ricerche da parte di Ettore Spalletti, soprattutto in relazione agli incarichi ricoperti per le istituzioni fiorentine, cfr. E. Spalletti, Qualchenota sui rapporti tra Tommaso Puccini e Antonio Canova, a Roma e oltre: alcune certezze e molti problemi ancora insoluti, in pp. 225-233, con bibliografia precedente, ma ancora molti aspetti restano da approfondire, soprattutto per gli anni romani che si conclusero nel1792 quando venne chiamato a Firenze, sui quali si veda anche M. C. Mazzi, Tommaso Puccini: un provinciale “cosmopolita”, in Bollet-tino d’Arte, 37-38, 1986, pp. 1-30, con particolare attenzione per il viaggio a Napoli intrapreso nel 1783 con la contessa Gabriella Scagliadi Verrua.
(23) Accademia delle Scienze di Torino, Biblioteca, Corrispondenza Puccini De Giovanni, carteggio n. 19794. Ringrazio per la gentile seg-nalazione il dott. Luca Mana che ha in corso uno studio sulla figura dell’erudito e poeta (Moncalvo/AT, 1729-Casale Monferrato/AL,1801), canonico della cattedrale di Casale, e sulle sue committenze artistiche, strettamente connesse alla cultura figurativa elaborata inRoma negli ultimi decenni del Settecento. Il De Giovanni soggiornò a Roma al seguito del conte Pietro Giuseppe Graneri (Torino, 1730-1797), ambasciatore per la corte sabauda.
(24) Chiti, op. cit., 1906, p. 171, il Selva definiva la pittrice “donna rara e per la sua bravura nel dipingere e per la sua cultura e per laerudizione.”
(25) Il viaggio di studio del giovane Selva (Venezia, 1751-1819), futuro progettista del Teatro La Fenice di Venezia e grande diffusore di una
294
cultura architettonica neoclassica internazionale, ebbe inizio nel 1778, con un soggiorno a Roma, e coinvolse la Francia, l’Olanda, il Bel-gio e l’Inghilterra, cfr. S. Rudolph, Dai diari inediti di Giannantonio Selva: il viaggio in Inghilterra, in Labyrinthos, 576, 1984, pp. 218-249. L’architetto aveva potuto ammirare i dipinti realizzati dalla pittrice per la decorazione di Somerset House, all’epoca sede della RoyalAcademy.
(26) C. Knight (a cura di), la Memoria delle pitture di Angelica Kauffman, Roma, 1998, p. 35. L’opera venne regalata al Memmo (Venezia,1729-1792), allievo del razionalista padre Carlo Lodoli (Venezia, 1690-Padova, 1761), di cui divulgò l’insegnamento nel trattato Principid’architettura lodoliana, pubblicato nel 1786, allora ambasciatore a Roma per la Serenissima. Il dipinto, attualmente disperso, è documen-tato anche da un’incisione coeva, cfr. G. Pavanello, scheda 13, in E. Bassi, A. Dorigato, G. Mariacher, G. Pavanello, G. Romanelli (a curadi), Venezia nell’età di Canova, catalogo della mostra, Venezia, 1978, pp. 18-19.
(27) Cfr. G. Pavanello, Rapporti tra Venezia e Roma in età neoclassica, in Borsellino, Casale (a cura di), op. cit., 2001, pp. 245-262.(28) Rimane ancora fondamentale l’articolo di A. Chiti, Tommaso Puccini e Antonio Canova, in Rivista d’Arte, 1-2. 1907, pp. 1-11.(29) Chiti, op. cit., 1906, p. 156. Ringrazio per l’interessamento e le precisazioni la dott.ssa Teresa Dolfi, direttrice della Biblioteca Forteguer-
riana.(30) Chiti, op. cit., 1907, p. 21, lettera al canonico De Giovanni del 24 gennaio 1797.(31) Chiti, op. cit., 1907, pp. 88-89. La lettera (20 ottobre 1804) assume particolare importanza perché documenta l’inedito rapporto con la
contessa D’Albany (Mons, 1752-Firenze, 1824) che risulta aver anche visitato più volte lo studio della pittrice. Si notino, inoltre, le cor-rispondenze con lo stesso Canova in cui lo scultore sottopose al Puccini il modello del monumento. Sul mausoleo di S. Croce, la cui labo-riosa genesi ebbe inizio nel 1804 e la cui realizzazione si concluse nel 1810, M. Lafranconi, schede III.15, III.16, in R. Maggio Serra, F.Mazzocca, C. Sisi, C. Spantigati (a cura di), Vittorio Alfieri. Aristocratico ribelle (1749-1803), catalogo della mostra Milano, 2003, pp.94-95.
(32) Baumgärtel, op. cit., 1998, pp. 31-32; Sadner, op. cit. 1998, p. XV.(33) L’abitazione si trovava nella centralissima via Sistina, al n. 72, vicino a Trinità dei Monti ed era stata abitata dal pittore tra il 1752 e il
1756, cfr. Baumgärtel, op. cit., 1998, pp. 32-33; Sadner, op. cit. 1998, p. XV. Sui rapporti tra l’opera di Mengs e la Kauffman, S. Roettgen,Die “Mengsische Akademie” in Rom. Anton Raphael Mengs, seine Schule und Angelika Kauffman, in Baumgärtel, op. cit., 1998, pp. 52-59.
(34) La tela fu la prima commissione per la corte dei Borboni di Napoli e fu oggetto di una meditata elaborazione attraverso una serie di schizzie disegni dei numerosi componenti della famiglia reale che vennero eseguiti dalla pittrice nell’estate 1782. L’opera nella sua stesura defin-itiva venne compiuta a Roma e fu accompagnata personalmente dalla Kauffman a Caserta nel marzo 1784. Allo stesso periodo sono ricon-ducibili anche due ritratti della coppia reale in abiti di parata con insegne regali, cfr. I. di Majo, schede IX.5, IX.6, IX.7, in Mazzocca,Colle, Morandotti, Susinno (a cura di), op. cit., 2002, pp. 483-484.
(35) De Rossi, op. cit., 1811, p. 14.(36) Baumgärtel, op. cit., 1998, pp. 27-28.(37) De Rossi stesso nelle “Avvertenze al lettore” precisava le fonti da cui ha ottenuto il materiale per la biografia, pp. VII-VIII. Si notino inoltre,
le considerazioni esposte a introduzione della pubblicazione integrale e in lingua originale, l’italiano delle Memorie delle pitture, cfr.Knight, op. cit., 1998, pp. 5-10, in cui si rileva come gli elenchi selezionati di opere inclusi nella terza e quarta parte del manoscritto, auto-grafi, non abbiano natura, come la prima porzione, di libro contabile, ma costituiscano opportune liste di opere finalizzate a essere con-segnate per fini pubblicistici.
(38) Non si tratta, tuttavia, di una citazione originale. Alcuni anni prima il conte Felice Durando di Villa, in qualità di segretario della ricosti-tuita Regia Accademia di Pittura e Scultura di Torino, pubblicava, in occasione dell’inaugurazione, i Ragionamenti, breve opera eruditacon biografie dei principali artisti attivi nel Regno di Sardegna, non dimenticando di inserire un paragrafo dedicato alle donne pittrici cheterminava con la citazione dei medesimi versi, cfr. F. Durando di Villa, Ragionamento pronunciato il 18 aprile 1778 per servire all’isti-tuzione dell’Accademia di Pittura e di Scultura di Vittorio Amedeo III, premesso ai regolamenti della R. Accademia, in Regolamenti dellaReale Accademia di pittura e scultura di Torino, Torino, 1778 , p. 58.
(39) I due dipinti vennero eseguiti durante il quarto soggiorno napoletano, cfr. Knight, op. cit., 1998, pp. 30-31. Il Bowles, oltre a commission-arie varie opere alla pittrice, fu anche intermediario per commissioni per altri esponenti dell’aristocrazia inglese. La vicenda di Cornelia,madre dei Gracchi, che mostra orgogliosa i suoi figli, fu ripetutamente rappresentato dalla pittrice; contemporaneamente alla commissioneinglese, la Kauffman eseguiva lo stesso tema anche per la regina Maria Carolina, cfr. Baumgärtel, op. cit., 1998, p. 34, e schede 226, 227,228 e 230.
(40) Barroero, op. cit., 2005, p. 289.(41) Memorie per le Belle Arti, tomo I, 1785, p. LIV.(42) Knight, op. cit., 1998, p. 28.(43) Memorie per le Belle Arti, tomo I, 1785, p. CXX. (44) Quarenghi (Rota Fuori/ BG, 1744-Pietroburgo, 1817), dopo una formazione e attività che avevano compreso anche soggiorni romani, dal
1779 si trasferì in Russia, al servizio dell’imperatrice; per le menzioni elogiative della Kauffman in varie lettere tra la fine del nono e l’iniziodell’ultimo decennio del Settecento, cfr. M. Zanardi, Le pitture della Cappella Colleoni nella seconda metà del XVIII secolo, in I PittoriBergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Settecento, Bergamo, 1996, vol. IV, pp. 525-528.
(45) De Rossi, op. cit., 1811, p. 54; Knight, op. cit., 1998, p. 11; Sadner, op. cit., 1998, p. XV. Tre furono i dipinti acquistati dalla coppia impe-riale: due scene di storia inglese e la Morte di Leonardo da Vinci.
(46) Kinght, op. cit. 1998, pp. 24, 27, 29, 32, 45, 52.(47) Il conte (1751-1831) era stato assegnato dalla stessa Caterina II al seguito della coppia granducale durante il viaggio in Europa; le sue
collezioni, tra le più ricche d’Europa, comprendevano dipinti di scuola francese, nordica, italiana. Batoni realizzò Venere che accarezzaamore (1784), opera dallo stesso artista molto apprezzata, Canova nel 1794 compì per lui il gruppo di Amore e Psiche giacenti. Più tardal’opera di Jacques Louis David, Saffo Faone e l’Amore (1808), cfr. M. di Macco, Il soggiorno dei Conti del Nord a Torino nel 1782. Sedi diplomatiche e collezioni di ambasci-atori, in S. Pettenati (a cura di), San Pietroburgo 1703-1825. Arte di corte dal Museo dell’Ermitage, catalogo della mostra Milano, 1991,pp. 426-431.
(48) Sulla situazione delle arti figurative nel Regno di Sardegna sotto Vittorio Amedeo III, cfr. S. Pinto, La promozione delle arti negli Stati ital-iani dell’età delle riforme all’Unità. Il Regno di Sardegna, in Storia dell’arte italiana, parte III, vol. II, Torino, 1982, pp. 976-889; P. Astrua,Le scelte programmatiche di Vittorio Amedeo duca di Savoia e re di Sardegna, in S. Pinto (a cura di), Arte di corte a Torino da CarloEmanuele III a Carlo Felice, Torino, 1987, pp. 65-100; F. Dalmasso, La cultura artistica da Vittorio Amedeo III a Carlo Emanuele IV, inG. Ricuperati (a cura di), Storia di Torino. Dalla città razionale alla crisi dello Stato d’Antico Regime (1730-1798), Torino, pp. 777-798;con particolare attenzione alla circolarità dei modelli culturali tra le corti e i loro reciproci rapporti, M. di Macco, Il Regno di Sardegna:
295
la corte, in Mazzocca, Colle, Morandotti, Susinno (a cura di), op. cit, 2002, pp. 307-310.(49) Vittorio Amedeo III aveva posto particolare cura a ricostruire il patrimonio librario privato del sovrano dopo che, nel 1720, Vittorio
Amedeo II aveva donato la biblioteca regia all’Università di Torino.(50) Astrua, op. cit., 1987, pp. 92-93, Mengs era passato da Torino in occasione del viaggio verso la Spagna. Invano, la corte sabauda aveva
cercato di impegnare l’artista per qualche commissione.(51) Le sculture in marmo, eseguite dai piemontesi fratelli Ignazio e Filippo Collino, rappresentavano una Vestale, perduta durante la seconda
guerra mondiale, ed il Ratto di Proserpina, a tutt’oggi conservato nella residenza di Pavlosk, delle quali esistono presso la Pinacoteca del-l’Accademia Albertina di Torino i bozzetti preparatori in terracotta; i disegni citati, presso la Biblioteca Reale di Torino, furono eseguitidal progettista e ornatista Leonardo Marini (1737-post 1806), cfr. Di Macco, op. cit., 1991, p. 426.
(52) Il matrimonio del principe ereditario era stato celebrato nel 1775; per il secondogenito di Vittorio Amedeo III era stata preferita unaprincipessa asburgica, secondo una tradizionale politica di alleanze matrimoniali, al fine di bilanciare la prima scelta, orientata verso laFrancia.
(53) La notizia è riportata in A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, Torino, 1966, vol. II, p. 586.(54) De Rossi, op. cit., p. 97.(55) S. Rolfi, Roma 1793: gli studi degli artisti nel Giornale di viaggio di Sofia Albertina di Svezia, in L. Barroero, S. Susinno (a cura di), La
città degli artisti nell’età di Pio VI, in Roma moderna e contemporanea, X, 1-2, 2002, pp. 48-89. La principessa visitò l’atelier del Kauff-man più volte nel corso del suo soggiorno romano. Si veda anche S. Rolfi Ozvaldz, Rotture e continuità: sistemi di pubblicizzazione del-l’arte moderna a Roma sullo sfondo della crisi degli anni Novanta del XVIII secolo, in Mazzocca, Venturi (a cura di), op. cit., 2006, p
(56) L. Facchin, Una famiglia di scultori piemontesi, i Bernero, ed i loro rapporti con la Lombardia asburgica, in Studi Piemontesi, 2004/1, pp.58-59. L’incisore (Volvera/TO, 1741-Torino, 1816), tra il 1768 e 1773 soggiornò a Parigi; nel 1773 venne nominato membro dell’A-cadémie Royale de Peinture et Sculpture e, proprio grazie a tale riconoscimento, venne contattato dal governo austriaco. Tuttavia, la trat-tativa non andò a buon fine e l’artista intraprese una lunga carriera presso la corte sabauda. Nel 1773 venne posto a capo della Scuola diincisione di Torino, fu nominato, poi, regio incisore nel 1774, “gardes des dessins du Roi” nel 1776 e professore all’Accademia nel 1778.
(57) Jusupov abitava nella casa Cigliè, davanti alla chiesa di S. Maria di Piazza. L’opera Una figura di Cupido seduto in atto di meditare qualcheastuzia o intrico amoroso venne acquistata nel marzo del 1785, cfr. Knight, op. cit., 1998, p. 29; Baumgärtel, op. cit., 1998, .p. 368, n.213. Porporati fu richiesto, successivamente, per incidere una seconda opera della pittrice, il Nathan che rimprovera David, cfr. Ibidem,p. 430, n. 269.
(58) E. Q. Visconti, Due discorsi inediti di E. Q. V. con alcune sue lettere e con altre a lui scritte che ora per la prima volta vengono pubbli-cate, Milano, 1841, p. 28.
(59) Knight, op. cit., 1998, p. 57. L’opera è stata recentemente rintracciata in collezione privata torinese e pubblicata, cfr. A. Cifani, F. Monet-ti, Un inedito ritratto di Angelika Kauffman, in Neoclassico, 17, 2000, pp. 85-88. Non sono emersi, tuttavia, dati riguardo alle circostanzedella committenza.
(60) L. M. Galli Michero, Il Museo Borgogna a Vercelli. Guida alle Collezioni, Umberto Allemandi & C., Torino 2000, s.p.; A. Schiavi, Lecollezioni del Museo, in Museo Borgogna. Storia e collezioni, a cura di C. Lacchia e A. Schiavi, Cologno Monzese, 2001, pp. 50-51.L’opera fu acquistata da Antonio Borgogna (Stroppiana/VC, 1822-Vercelli, 1906) dai fratelli Grandi di Milano; il collezionista possedevaanche un album di stampe della pittrice nelle sue eclettiche raccolte, frutto di acquisizioni sul mercato europeo effettuate negli ultimi decen-ni dell’Ottocento, cfr. C. Lacchia, Orientamenti di gusto nel collezionismo privato a Vercelli: Antonio Borgogna e la formazione delle rac-colte d’arte moderna, in V. Natale (a cura di), Arti figurative a Biella e a Vercelli. L’Ottocento, Biella, 2006, pp. 129-142. Dal dipinto, dicui si conservano anche alcuni disegni preparatori, venne derivata una più nota incisione, cfr. Baumgärtel, op. cit., 1998, p. 266, n. 134.
(61) L. Facchin, Bartolomeo Cavalleri agente dell’aristocrazia sabauda a Roma nell’ultimo quarto del XVIII secolo, in Percorsi. Rivista dellaBiblioteca di Storia e Cultura del Piemonte «Giuseppe Grosso», 7, 2004, p. 26, lettera dell’8 ottobre 1793; Knight, op. cit., 1998, p. 62.La tela, commissionata nel 1792, venne saldata al 12 giugno del 1793 per 150 zecchini. Del dipinto si conservano alcuni disegni , op. cit.,1998, p. 427, n. 265. L’originale è passato più di una decina di anni fa sul mercato torinese, cfr. V. Natale, scheda, in G. Romano (a curadi), Roma Torino Parigi 1770-1830, catalogo della mostra, Torino, 1993, pp. 28-29. Polissena Gamba della Perosa (Torino, 1764-Pinero-lo/TO, 1844) e il marito, Giovanni Antonio Turinetti di Priero (Torino, 1762-1801), furono una coppia di aggiornati committenti ecollezionisti d’arte; il marchese, accanito amatore di stampe, acquistò, in questi stessi anni, la raccolta di Tommaso Puccini.
(62) Facchin, op. cit., 2004, p. 26, lettere del 19 luglio e 2 agosto 1793. Bartolomeo Cavalleri fu agente, conoscitore e architetto; soggiornò aRoma dal 1788 al 1797 circa. Il busto era destinato alla chiesa di Voralberg; sullo scultore Christopher Heweston, precocemente trasfer-itosi a Roma e molto apprezzato dai protagonisti del Grand Tour per le sue capacità di ritrattista, M. Baker, voce Christopher Heweston,in Bowron, Rischel (a cura di), op. cit., 2000, pp. 254-255. La datazione dell’opera, riferita tradizionalmente al 1795/96, va pertanto retro-datata, cfr. voce biografica in Sadner (a cura di), op. cit., 1998, 104.
(63) Facchin, op. cit., 2004, p. 27, lettera del 30 novembre 1796. L’attenzione del Cavalleri nei confronti della scelta dei corrieri a cui affidarele diverse tipologie di beni e l’estrema cura per il loro imballaggio, si evince ripetutamente nelle corrispondenze con i vari committentipiemontesi.
(64) C. Teolato, La manifattura romana di Giovanni Volpato, in H. Honour (a cura di), I Trionfi di Volpato. Il centrotavola del Museo di Bas-sano del Grappa e il biscuit neoclassico, Cinisello Balsamo, 2003, pp. 76, 90.
(65) P. Fardella, Tra antico e moderno: Antonio Canova e il collezionismo napoletano, in Mazzocca, Venturi (a cura di), op. cit., 2006, p. 324.(66) G. Todini, Cronologia del viaggio, in R. Venuti (a cura di), Goethe in Italia. Disegni e acquerelli da Weimar, Roma, 1995, p. 40. Goethe
era partito improvvisamente alla volta dell’Italia nel settembre 1786; giunse a Roma alla fine di ottobre e, alternando soggiorni in varielocalità, compreso il viaggio a Napoli, vi si trattenne sino all’aprile 1788. Costante fu la frequentazione dell’ambiente culturale della Kauff-man che nell’estate-autunno del 1787 lo accompagnò a visitare numerosi siti e collezioni della capitale, cfr. Ibidem, pp. 36-39. Per i rap-porti, anche di carattere professionale tra la pittrice e lo scrittore e poeta, cfr. Sadner, op. cit., 1998, pp. XXXIV-XLIV.
(67) Baumgärtel, op. cit., 1998, .p. 33.(68) Barroero, op. cit., 2005, p. 282. Nell’expertise vennero coinvolti anche il De Rossi, Gavin Hamilton, Giuseppe Volpato, Giuseppe Cades
e Antonio Cavallucci. Il Rezzonico richiese alla pittrice un ritratto postumo del cardinale Giambattista (1788) che venne collocato nellastessa sala con i ritratti di famiglia precedentemente eseguiti da Batoni e Mengs, cfr. G. Pavanello, I Rezzonico: committenza e collezion-ismo fra Venezia e Roma, in Arte Veneta 52, 1998, p. 92.
(69) M. Forbes M. Mauchline, Kauffman’s, “Decorative work in W. Wassyng Rowort, Angelica Kauffman. A continental Artist in GeorgianEngland, London, 1992, pp. 113-140.
(70) R. Valeriani, Neoclassicismo-scheda n. 64, in E. Colle, A. Griseri, R. Valeriani (a cura di), Bronzi decorativi in Italia. Bronzisti e fonditoriitaliani dal Seicento all’Ottocento, Milano, 2001, p. 228. Le parti litiche furono eseguite dallo scultore ligure Francesco Ravaschio, i bronzicon figura allegoriche furono gettati da Francesco Righetti a Roma “sotto la direzione della rinomata pittrice”; il disegno di insieme era
296
dell’architetto genovese Santino Tagliafichi. Si tratta di un tipo prodotto dell’indotto del Grand Tour romano dell’ultimo quarto del Set-tencento.
(71) C. Di Fabio, scheda VI. 69, in P. Boccardo, C. Di Fabio (a cura di), El Siglo de los Genovenses e una lunga sotria di arti e splendori nelPalazzo dei Dogi, catalogo della mostra, Milano, 1999, p. 241. Il Cambiaso (Genova, 1738-1813), tra le personalità politiche più emi-nenti del passaggio tra Ancien Regime e età napoleonica in Genova, si formò a Roma; fu accanito bibliofilo e collezionista. Il ritratto fudipinto da Maron (Vienna, 1733-Roma, 1808) nel 1792 e ne furono realizzate, dal pittore stesso, quattro repliche.
(72) C. Olcese Spingardi, F. Sborgi, “Solidità, comodità e decoro”: l’intervento di Simone Cantoni a Palazzo Ducale dopo l’incendio del 1777,in Boccardo, Di Fabio (a cura di), op. cit., 1999, pp. 408-413. Il rinnovo dell’ambiente più rappresentativo del palazzo, caratterizzato daelementi decorativi monumentali e un ricco apparato plastico, venne affidato al giovane architetto ticinese (Muggio di Mendrisio, 1739-Milano, 1818) con la collaborazione del Tagliafichi al termine di un decennio che aveva visto importanti cantieri di aggiornamento neo-classico nelle dimore patrizie cittadine.
(73) Knight, op. cit., 1998, p. 64; il dipinto si conserva nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.(74) Cfr. M. di Macco, La Galleria Sabauda. Guida al terzo settore. Collezioni dinastiche: da Carlo Emanuele III a Carlo Felice 1730-1831,
Torino, 1991, pp. 47.48. La coppia fu acquisita, con numerose altre opere, nel 1824, quando il re Carlo Felice decise di destinare palaz-zo Durazzo a residenza reale genovese, acquistando, con l’immobile, anche l’arredo e le opere d’arte.
(75) O. Sadner (a cura di), Omaggio a Angelika Kauffman, catalogo della mostra, Milano, 1992, p. 12.(76) Baumgärtel, op. cit., 1998, p. 30. Il valore dell’opera, come tradizionalmente avveniva, era calcolato in base al numero delle figure rapp-
resentato, alla loro dimensione e complessità di posa; gli stessi parametri venivano opportunamente applicati sia alla pittura di storia cheal ritratto.
(77) Zanardi, op. cit., pp. 521-529, sia per la commissione della pala di Bergamo (1789) che per le richieste da parte di varie personalità berga-masche per raccomandazioni e proposte di allievi, come nel caso della contessa e poetessa Paolina Secco Suardo che le chiese di accogliereil proprio “pupillo”, il pittore Francesco Roncalli. Il tramite per i vivaci rapporti con l’area bergamasca fu, molto probabilmente, GiuseppeBeltramelli, conosciuto a Londra nel 1774. Sui rapporti tra la Kauffman e Dell’Era cfr. E. Calbi, Relazioni illustri: protettori, maestri ecommittenti e Nell’atelier della Kauffman, in E. Calbi (a cura di), Giovan Battista Dell’Era (1765-1799). Un artista lombardo nella Romaneoclassica, catalogo della mostra, Milano, 2000, pp. 55-56 e pp. 67-68. Il pittore (Treviglio/BG, 1765-Firenze, 1799) era giunto a Romanel 1785; presto venne in contatto, forse proprio attraverso la Kauffman, con il consigliere Reiffenstein che gli procurò numerose com-missioni per la corte russa che lo impegnarono per buona parte dell’ultimo decennio del Settecento. Nel 1798 lasciò Roma per Firenze ovelavorò per la Reale Galleria e per la decorazione del duomo di Arezzo prima di essere colto da morte prematura.
(78) Zanardi, op. cit. 1996, p. 528, lettera dell’11 luglio 1791, in cui l’architetto chiede al Reiffenstein che il pittore esegua uno dei quadrettiad encausto che gli erano stati commissionati su copia di un’opera della Kauffman.
(79) Si veda, oltre al noto disegno con Ritratto di gruppo in un giardino, ritenuto un ricordo di una gita di Goethe e della pittrice a Frascati, atitolo di esempio, lo schizzo a penna con Venere indica a Enea e Acate la città di Cartagine, che rimanda alla tela di analogo soggetto dip-inta dalla pittrice nel 1768, cfr. Calbi, op. cit., 2000, pp. 64-65 e p. 76.
(80) Archivio di Stato di Milano, Studi P. A. 195, Accademia di Brera P.G. 1763-1789, lettera dell’11 maggio 1789.(81) Sadner, op. cit. 1998, p. XVII; si noti che anche il De Rossi, nella scelta del ritratto da includere nella monografia, optò per un’incisione
derivata dall’autoritratto eseguito nel 1781, che rappresenta la Kauffman nel costume locale; su tali tematiche cfr. A. Rosenthal, Image ina distant sail: the self-portraits of Angelica Kauffman, in Natter (a cura di), op. cit., 2007, pp. 13-16 con riferimenti a bibliografia prece-dente.
(82) N. Fabbri, Cronologia, in Calbi (a cura di), op. cit., 2000, p. 264.(83) Sadner, op. cit., 1998, pp. XV, XXVIII; Baumgärtel, op. cit., 1998, schede nn. 236-237. Il sovrano pagò ben 900 zecchini per le due tele,
piuttosto che i 600 richiesti da Batoni per un dipinto di storia. Le opere vennero concluse nel settembre 1786, cfr. Knight, op. cit., pp. 37-39.
(84) Memorie, op. cit., 1787, aprile, pp. 73-77.(85) L’erudito specificava, in nota: “delle private la sorte è tanto istabile, che poco si può contare su di esse.”, ricordando che Roma aveva già
perso molte opere di artisti di insigne valore al posto delle quali erano state collocate “deboli copie”, forse alludendo alla recente (1786),discussa, vendita in Inghilterra dei Sette Sacramenti di Nicolas Poussin, dipinti per Cassiano Dal Pozzo, passati nel Settecento, per eredità,ai Boccapaduli, cfr. B. Contardi, La Stanza dei Sacramenti, in F. Solinas (a cura di), I Segreti di un Collezionista. Le straordinarie raccoltedi Cassiano dal Pozzo 1588-1657, catalogo della mostra, Roma, 2001, pp. 187-191.
(86) Knight, op. cit., 1998, pp. 53-54; Baumgärtel, op. cit., 1998, p. 37. L’opera venne richiesta dal cardinale Segretario di Stato, Ignazio Buon-compagni, su indicazione del Pontefice, nel gennaio 1791 per la cappella Svizzera della Santa Casa. Vi furono coinvolti numerosi altriartisti: Cristoforo Unterberger, Cavallucci, Gaspare Landi e Anton von Maron.
(87) Knight, op. cit., 1998, p. 50, l’opera è definita “Composizione graziosa e devota”. Il cardinale (Ghisalba, 1716-Roma, 1793) che ricoprìanche la carica di prelato della fabbrica di S. Pietro (1757-1780), fu ripetutamente tramite per acquisizioni di opere da parte del fratello,Giacomo (Bergamo, 1714-1796), noto collezionista e membro attivo del consiglio della Cappella Colleoni, il cui rinnovamento artistico,promosso sin dagli anni sessanta, con un tentativo di coinvolgimento di Batoni e addirittura di Mengs, oltre alla Kauffman, vide impeg-nati, negli stessi anni, Antonio Concioli e Gaspare Landi. Sul religioso, creato cardinale nel 1785, si veda anche F. Raco, voce Carrara,Francesco, in Dizionario Biografico, op. cit., 1977, vol. XI, pp. 663-664.
(88) De Rossi, op. cit., 1811, p. 99; R. Stradiotti (a cura di), Dai Neoclassici ai Futuristi ed oltre. Proposte per una civica galleria d’arte mod-erna e contemporanea, catalogo della mostra, Brescia, 1989, p. 30, n. 2. Il De Rossi, immediatamente dopo la conclusione dell’opera diedealle stampe una Decrizione del dipinto (1807). Lo stesso scrisse anche una recensione in Memorie Enciclopediche Romane sulle Belle Arti,Tomo II, 1806, pp. 88-90.
(89) Il cardinale (Piacenza, 1744-Roma, 1832), elevato alla porpora nel 1795, arrestato ed esiliato durante il periodo napoleonico, tenne il gov-erno di Roma in attesa del Pontefice dal marzo al giugno 1815, fu vescovo di Ostia e di Velletri (1820) e Segretario di Stato (1823-1828),cfr. Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi (1730-1799), Padova, 1958, vol. VI, p. 87; Dizionario Ecclesiastico, Torino, 1953, vol.I, p. 833.
(90) Sul rapporto tra la letteratura, gli esponenti dell’Arcadia e l’Accademia di S. Luca, cfr. S. Susinno, Artisti gentiluomini nella Repubblicadelle Lettere, in Cipriani (a cura di), op. cit., 2000, pp. 14-18; E. Mancuso, Recensioni nelle «Efemeridi letterarie di Roma» sotto ladirezione di Giovanni Ludovico Bianconi, in Ricerche di Storia dell’Arte, 90, 2006, pp. 57-60.
(91) Knight, op. cit., pp. 75-76; Sadner, op. cit., 1998, p. XLV, per la prima committenza; per il cardinale Firrao, cfr. De Rossi, op. cit., 1811,p. 91.
(92) De Rossi, op. cit., 1811, p. 72, senza indicazione della data. Sul Dugnani (Milano, 1748-Roma, 1818), a Roma dal 1770, nunzio apos-tolico in Francia tra il nono e l’ultimo decennio del Settecento, creato cardinale nel 1794, cfr. G. Pignatelli, voce Dugnani, Antonio, in
Fonti riferite alle immagini:
David e Nathan: Angelika Kauffman 1741-1807 Retrospektive, a cura di B. Baumgärtel, catalogo della mostra (Düsseldorf, Künst-museum, 15 novembre 1998-24 gennaio 1999; München, Haus der Kunst, 5 febbraio-18 aprile 1999; Chur, Bünder Kunstmuseum,8 maggio-11 luglio 1999), Düsseldorf, Gerd Hatje, 1998, p. 430.
Peter Kauffman, Ritratto di Angelica Kauffman: F. Mazzocca, E. Colle, A. Morandotti, S. Susinno (a cura di), Il Neoclassicismo inItalia da Tiepolo a Canova, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2 marzo-28 luglio 2002), Milano, Skira, p. 92, scheda IV.7
Ritratto di Johann Joachim Winckelmann: W. Wassyng Roworth, Angelica Kauffman: a continental artist in Georgian England, Lon-don, Reaktion Books, 1992, p. 26, fig. 9
Cornelia madre dei Gracchi: Angelika Kauffman 1741-1807 Retrospektive, a cura di B. Baumgärtel, catalogo della mostra (Düssel-dorf, Künstmuseum, 15 novembre 1998-24 gennaio 1999; München, Haus der Kunst, 5 febbraio-18 aprile 1999; Chur, Bünder Kun-stmuseum, 8 maggio-11 luglio 1999); Düsseldorf, Gerd Hatje, 1998, p. 381, scheda n. 226
Carlo Antonio Porporati, Cupido: Angelika Kauffman 1741-1807 Retrospektive, a cura di B. Baumgärtel, catalogo della mostra(Düsseldorf, Künstmuseum, 15 novembre 1998-24 gennaio 1999; München, Haus der Kunst, 5 febbraio-18 aprile 1999; Chur, Bün-der Kunstmuseum, 8 maggio-11 luglio 1999), Düsseldorf, Gerd Hatje, 1998, p. 368, n. 213
Ritratto di Domenica Volpato, Vercelli, tela: L. Galli Michero, Il Museo Borgogna a Vercelli. Guida alle Collezioni, Umberto Alle-mandi & C., Torino 2000, s.p.
Ritratto di Domenica Volpato, disegno: Angelika Kauffman 1741-1807 Retrospektive, a cura di B. Baumgärtel, catalogo della mostra(Düsseldorf, Künstmuseum, 15 novembre 1998-24 gennaio 1999; München, Haus der Kunst, 5 febbraio-18 aprile 1999; Chur, Bün-der Kunstmuseum, 8 maggio-11 luglio 1999), Düsseldorf, Gerd Hatje, 1998, p. 266, scheda n. 134
Abramo caccia Agar e Ismaele: G. Romano (a cura di), Roma Torino Parigi 1770-1830, catalogo della mostra, Torino, 1993, p. 29
Autoritratto in costume del Bregenzerwald, incisione pubblicata in G. De Rossi, Vita di Angelica Kauffman Pittrice, Pisa, 1811,antiporta
Sacra Famiglia: F. Mazzocca, E. Colle, A. Morandotti, S. Susinno (a cura di), Il Neoclassicismo in Italia da Tiepolo a Canova, catal-ogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2 marzo-28 luglio 2002), Milano, Skira, p. 210, scheda n. VII.26
Nascita S. Giovanni Battista: R. Stradiotti (a cura di), Dai Neoclassici ai Futuristi ed oltre. Proposte per una civica galleria d'arte mod-erna e contemporanea, catalogo della mostra, Brescia, 1989, p. 29, fig. 2
Dizionario Biografico, op. cit., 1992, vol. 41, pp. 802-805.(93) Baumgärtel, op. cit., 1998, p. 38. Si deve al nobile e letterato comasco (Como, 1748-1814) la committenza per il rinnovamento del palaz-
zo cittadino in Como (1794) e della residenza di villeggiatura sul lago, a Breccia (1790), a Simone Cantoni, cfr. N. Ossanna Cavadini,Simone Cantoni architetto, Milano, 2003, pp. 171-174, 227-239.
(94) Knight, op. cit., p. 69. La recente trascrizione riporta erroneamente il nome “Serpenti”. Poche le notizie biografiche sul conte (1750-1802),ricordato per innovative, quanto azzardate imprese finanziarie, alla cui morte la villa di Varenna venne venduta al barone Carlo Innocen-zo Isimbardi, cfr. F. D’Alessio, Serponti di Mirasole. Vicende di un grande casato lecchese tra Varenna, Milano e Germanedo, in Archividi Lecco e della Provincia. 2, 2006, pp 106-107.
(95) Memorie Enciclopediche Romane sulle Belle Arti, tomo II, 1806, pp. 20-21.(96) Il Sommariva (Lodi, 1760-Milano, 1826), nel 1800, con una carriera rapidissima, tanto quanto lo fu la durata delle sue fortune politiche,
divenne presidente del Comitato di Governo della II Repubblica Cisalpina, e fu, sino al 1802, il vero padrone di Milano. Il 14 febbraio diquello stesso anno, con la proclamazione della Repubblica Italiana, fu nominato vicepresidente il suo grande avversario, Francesco Melzi.In tale breve tempo ebbe modo di accumulare un enorme patrimonio, buona parte del quale fu utilizzato nella sua attività di collezionistae mecenate. La vasta raccolta comprendeva anche pitture antiche, collocate, oltre che nella residenza parigina, nella villa di Tremezzo, giàproprietà dell’importante famiglia Clerici, sul lago di Como. Minuziosamente documentata dal Sommariva attraverso le riproduzioni delleopere in smalti, incisioni su pietra dura e cammei, buona parte della pinacoteca - nella totalità per quanto riguarda i dipinti antichi - andòdispersa dopo la morte del collezionista. Il dipinto della Kauffman, perduto, è documentato da uno smalto su rame di Adèle Chavassieudel 1814, cfr. F. Mazzocca, Neoclassico e troubadour nelle miniature di Giambattista Cigola, catalogo della mostra Milano, 1978, p. 55,n. 14, e da un cammeo inciso da Giovanni Beltrami (calco presso il Museo di Cremona), cfr. L. Pirzio Biroli Stefanelli, Avea il marcheseSommariva una sua favorita idea. II. Le incisioni di Giovanni Beltrami, in Bollettino dei Musei Comunali di Roma, n.s., XI, 1997, p. 120,n. 245.
(97) Si noti che una Maddalena fu eseguita da Canova proprio per il Sommariva nel 1796, cfr. F. Mazzocca, Villa Carlotta, Milano, 1983, p.77. Opera emblematica del particolare rapporto di stima e comunanza di gusto tra il Canova e la pittrice fu il noto ritratto del conte JosepJohann von Fries (1787), raffigurato con Teseo vincitore del Minotauro, acquistato dallo stesso nobile austriaco (cfr. R. Pancheri schedaXV.9, in Mazzocca, Colle, Morandotti, Susinno (a cura di), op. cit. 2002, p. 517), mentre il modello dell’Ercole e Lica (1795) è la scul-tura che compare nel ritratto dello scultore eseguito dalla Kauffman, cfr. Sadner, op. cit., 1998, p. XLV.
(98) De Rossi, op. cit., 1811, p. 100; Memorie Enciclopediche, op. cit., Tomo III, 1807, p. 95; Memorie Enciclopediche, op. cit., Tomo V, 1808,p. 27. L’anno successivo venne tratta un’incisione del dipinto da Giovanni Folo (Bassano, 1764-Roma, 1836). In Zanardi, op. cit., 1996,p. 526, si cita la presenza del busto ancora presente nella collezione di famiglia a Bergamo come di ignoto autore. Filippo Albacini (Roma,1777-1858) collaborò assiduamente nella bottega paterna, accostandosi poi a Canova, cfr. M. Pepe, voce Albacini, Filippo, in DizionarioBiografico, op. cit., 1960, vol. 1, pp. 588-589.
297