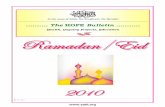2010 - Mario Torelli, La “Grande Roma dei Tarquini”. Continuità e innovazione nella cultura...
Transcript of 2010 - Mario Torelli, La “Grande Roma dei Tarquini”. Continuità e innovazione nella cultura...
a n n a l id e l l a f o n d a z i o n e
p e r i l m u s e o « c l a u d i o f a i n a »
volume Xvii
orvietonella sede della fondazione
edizioni quasar2010
estratto
isBn 978-88-7140-445-5
© roma 2010 - edizioni quasar di severino tognon srlvia ajaccio 41-43 - 00198 romatel. 0685358444, fax 0685833591www.edizioniquasar.it
Finito di stampare nel mese di novembre 2010 presso Arti grafiche La Moderna - Roma
Mario torelli
la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”CoNtiNUità e iNNovazioNeNella CUltUra reliGiosa
Già lo scorso anno in questa stessa sede, esaminando i prestiti di natura religiosa dal mondo latino a quello etrusco, avevo avuto modo di sottolineare come l’impianto e gli elementi costitutivi dell’in-tera religione latina sostanzialmente nascano da una realtà sociale e culturale di villaggio, che possiamo datare nella parte finale dell’età del Bronzo o al più tardi agli albori dell’età del Ferro1. se infatti si analizzano in dettaglio i presupposti ideali e materiali, nonché l’or-ganizzazione e il concreto svolgersi delle grandi feste collettive del calendario c.d. ’numano’, quelle cioè litteris maioribus, emergono con particolare evidenza dettagli che ci descrivono la vita di una società primitiva, fondata su di un’agricoltura povera, scandita da una serie di ricorrenze e di solennità, il cui obiettivo è quello di conservare la pax deorum, e soprattutto rassicurare la comunità sul sempre incerto presentarsi delle stagioni e dei raccolti, sulla conservazione del cibo, sul rispetto dei cicli biologici della riproduzione, come la nascita, il matrimonio e la morte, e sulla costruzione ideologica di grandi eventi sociali collettivi, come la guerra e i riti iniziatici. Un buon esempio di questo sfondo è offerto dalle feste dei Vestalia2, che celebrano l’annua-le pulizia del penus Vestae, con il medesimo richiamo alle capanne che riscontriamo nella forma stessa dell’aedes Vestae3. il rito descrive per-fettamente la natura del primitivo insediamento di roma, organizza-to con capanne munite di quella primitiva fossa nel piano pavimenta-
1 Torelli 2009.2 Una sintetica analisi della festa ho proposto in Torelli 1984, pp. 104-106.3 Sul significato dell’edificio, v. Ampolo 2006, 133.124; sull’edificio, v. ora CA-
prioli 2007.
306 Mario torelli
le detta appunto penus: queste capanne appartengono ad un tipo nato nell’età dl Bronzo Finale e vissuto fino allo sviluppo dei tetti pesanti a metà del vii secolo a.C., un range cronologico recentemente con-fermato dalla stratigrafia della capanna scavata dall’équipe del mio dipartimento guidata da l. Fiorini nell’area di vigna Marini vitalini, senz’altro prossima all’area forense di Caere4. Centro della festa è il penus, sorvegliato dai Penates, i Sondergötter preposti alla cura del suo contenuto5: il penus corrisponde alla cavità sul piano pavimentale della capanna, destinata alla conservazione del cibo, presente nelle capanne dell’età del Ferro non solo di area centro-italica, ma anche in altre zone dell’italia protostorica, come quella da poco esplorata della Basilicata interna di pieno vii secolo a.C.6 sempre di sapore quasi pre-urbano o comunque di una comunità appena avviata in direzione della città7 appare la localizzazione del rito, tra aedes Vestae e Por-ta Stercoraria, con tutta probabilità una postierla sul Campidoglio pertinente ad una cinta primitiva del colle, che ormai sappiamo in-tensamente abitato sin dall’età del Bronzo8. lo stesso si ricava anche dall’analisi storico-antiquaria di tutte quelle altre feste sulle quali abbiamo fonti che ce ne descrivono costume e ritualità, dai Lupercalia ai riti saliari, dai Fordicidia ai Cerialia, tutte cerimonie nelle quali la parte del leone è attribuita, oltre che al rex, a flamines e vestali, attivi pro populo e all’interno delle curie, o ancora a sodalitates pre-politiche, talora trasformate in gentilizie tra vii e vi secolo a.C. nel momento dello strapotere delle gentes e del rapace impossessamento da parte di queste delle fragili strutture sociali e religiose della comu-nità di villaggio originaria, come insegna il caso dei Luperci, divisi in Quinctii e Fabiani, ossia controllati dai due gruppi patrizi di Quinctii e dei Fabii. su questo nucleo si sono poi andate aggiungendo altre festività della città già sviluppata.
i calendari ci si presentano così come un ampio e intricato palin-sesto “aperto” e ogni tentativo di fissare i tempi della loro compilazio-ne e soprattutto di analizzare i criteri seguiti dai compilatori dei fasti numani nella selezione delle festività solenni esistenti nel territorio dell’Urbs primitiva da inserire nel calendario litteris maioribus temo sia argomento destinato a restare materia per le più ampie specula-
4 Torelli - Fiorini 2008, pp. 139-163.5 sui Penates, cfr. piCCAlugA 1961, pp. 81-97; rAdke 1981, pp. 343-373; du-
bourdieu 1989; pAlombi 1997, pp. 435-463; resCigno 2000, pp. 13-37 (non vidi); To-relli c.s. a.
6 b(ATTiloro) 2009, pp. 115-129.7 [gros] - Torelli 20073, pp. 81-92.8 CAzzellA - bAroni eT Alii 2007, pp. 803-812; più in generale, sulle ricerche
più recenti nell’area, v. Primi risultati delle indagini archeologiche in Campidoglio nell’area del Giardino Romano e del Palazzo Caffarelli 2001, pp. 261-364.
307la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
zioni possibili. alcuni culti, che anche agli occhi dell’antiquaria di i sec. a.C. rivestivano non soltanto un carattere di indubbia vetustà, ma anche un rilievo particolare per i riti e per le finalità che lo con-traddistinguevano, appaiono assenti da quella selezione. Per ricorda-re un caso per tutti, quello della religio della sodalitas dei Fratres Ar-vales con le sue cerimonie, il suo luogo di culto e la sua Dea Dia9, così peculiare e, malgrado l’indubbio intervento dell’antiquaria augustea, dall’aspetto così arcaico, non ha lasciato traccia nei calendari: è utile confrontare questo caso con la situazione di iguvium10, dove i rituali dei Fratres Atiedii, ossia di una sodalitas apparentemente analoga sul piano strutturale a quella degli Arvales romani, sono invece dive-nuti uno dei cardini della religione dell’intera touta e ineludibile pun-to di riferimento della vita civica e dell’identità “nazionale”, al punto di essere non solo incisi su tavole bronzee, ma addirittura aggiornati nella loro redazione scritta con il vincente alfabeto latino. Questo per quanto riguarda un culto di sicura alta antichità; ma pensiamo anche ai molti piccoli santuari scoperti negli ultimi trent’anni di rinnovati scavi nell’area palatino-forense11 vissuti tra l’epoca arcaica e la media e tarda repubblica e rimasti per noi del tutto anonimi, a fronte ai tanti sacelli, collocati nella stessa area e ricordati dalla tradizione antiquaria, come ad es. quello di Mutunus tutunus, che non riescono a trovare riscontro nella pur ricca documentazione archeologica.
Ancor più significativo appare il fatto che tutte le divinità cen-trali per la vita religiosa dell’alto arcaismo, come Marte o Minerva, hanno ricevuto un luogo di culto specifico quasi universalmente assai tardi e sempre in una collocazione diversa da quella per la quale le loro feriae hanno meritato la nota calendariale. tra i tanti possibili esempi ricordo qui, ancorché ignorato dai calendari, il santuario di Minerva sul Celio, un luogo di culto, come ci informa ovidio, che è l’unico a ricordarlo esplicitamente nei suoi Fasti12, posto sulla pro-paggine del Caelius Mons detta Caeliolus, quasi in piano, al termine della strada che scendeva dalla sommità del colle verso il basso. Poi-ché il dies natalis del santuario è il 19 marzo, lo stesso della solennità delle Quinquatrus, dobbiamo immaginare che si tratti di un sacello, non solo collegato con una celebrazione analoga a quella che - senza un vero e proprio santuario, per quel che è dato di sapere - aveva luogo nel foro, ma anche anteriore al primo tempio formale della dea sull’aventino, frutto dell’evocatio del culto poliadico di Falerii, votato
9 ChirAssi 1968, pp. 191-291; sul santuario, v. broise - sCheid 1993, pp. 145-157; sul collegio, sCheid 1990.
10 Cfr. da ultimo sisAni 2001.11 pAnellA - zeggio 2004, pp. 65-87; zeggio 2005, pp. 63-76.12 ov., Fast. iii, 335-338; cfr. Torelli 1984, p. 55 s.
308 Mario torelli
in occasione della conquista di quella città nel 264 a.C. (di qui l’ap-parente confusione di ovidio che chiama Capta la dea del Celio) e festeggiato il 19 giugno13. la piena corrispondenza tra le due date, quella delle solenni celebrazioni delle Quinquatrus e quella del dies natalis del santuario del Celio, parla per una stretta analogia di fun-zioni delle due cerimonie, sia pure con un grado diverso di solennità, ben marcato dalla diversità di trattamento riservata nei calendari ai due luoghi di culto: a mio avviso la Minerva del Celio è indissolubile dalla presenza nell’area delle Curiae Novae, che secondo la tradizione sarebbero state fondate sul Celio da tullio ostilio per accogliere gli abitanti dalla distrutta alba longa da lui deportati sul Vicus Fabri-cius e che per molte ragioni che non sto qui a spiegare vanno ricercate in piano, molto verosimilmente di fronte alle Curiae Veteres14. la “du-plicazione” della Minerva delle Quinquatrus sul Celio ha l’evidente scopo di attribuire ai nuovi cittadini un santuario capace di assolvere la stessa funzione che aveva nel Foro il signum della dea restaurato secoli dopo da augusto nel Calcidichum, espressione della presenza numinosa di Minerva nel delicato cerimoniale del riconoscimento dei cittadini da parte della comunità al termine del rituale iniziatico delle feste di Anna Perenna e dei Liberalia15. È evidente che a somiglianza di quanto accadeva ad atene all’interno delle fratrie per sanzionare il riconoscimento dei nuovi membri da parte della comunità, in questi rituali di iniziazione dovevano avere un ruolo proprio le curiae, come sappiamo accadeva con un altro rituale di riconoscimento di cittadi-ni, le feriae stultorum dei Fornacalia, celebrate curiatim, durante le quali le curiae certificavano l’appartenenza al corpo civico degli stulti, di quanti cioè quella appartenenza avevano “dimenticato”16. Questa situazione ci parla dunque di una fase, iscrivibile nel corso del vii secolo a.C., nel corso della quale si è avuta una crescita tumultuaria del giovanissimo organismo urbano, nella quale l’integrazione degli inurbati non è stata cosa né facile sul terreno politico né semplice sul piano del costume religioso, tanto più nel caso dei novi cives delle Cu-riae Novae, frutto, secondo la tradizione, di un trasferimento forzoso.
13 Per questa scadenza calendariale si parla di quinquatrus minores: così, ad es., l. vendiTTelli, in LTUR iii, 1996, p. 254, ma nelle fonti non c’è traccia di una tale definizione della festa del 19 giugno, una data evidentemente studiata in modo da essere percepita come festività in rapporto con il grande evento del 19 marzo, ma funzionalmente differente e quindi non coincidente con esso: la data del 19 giugno è soltanto il dies natalis del tempio, dedicato ad una dea profondamente diversa dalla preistorica Menerva, tanto è vero che l’allonimo della festa del tempio è dies artificum (FesT. p. 304 l).
14 v. M. Torelli, in LTUR i, 1993, p. 336.15 v. di recente Torelli 2004, pp. 63-109.16 mAyer 1954, pp. 51-57; bAudy 2001, pp. 32-39.
309la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
il progressivo consolidamento delle strutture urbane nel corso del vii secolo a.C. ha vieppiù irrigidito il tessuto socio-politico e il suo riflesso sul piano storico-religioso è fin troppo evidente. Se infatti muoviamo verso un contesto socio-politico di natura diversa da quel-lo appena analizzato, quello dell’ingresso degli stranieri nella città in rapporto alle esigenze mercantili, possiamo confrontare il diverso comportamento delle forme religiose tenuto dalla comunità romana nei confronti dell’ingresso fra i culti presenti a roma di due divinità straniere, il greco-fenicio Herakles-Hercules17 e l’etrusco Velthumna-Vortumnus18. Giunto sulle sponde del Portus Tiberinus nelle tenebre della prima età del Ferro, o al più tardi nell’iniziale vii secolo a.C., in una con l’emergere delle primitive forme dello scambio, Hercules rappresenta bene 19 la connotazione levantina, tanto ellenica quan-to fenicia dello scambio e dei protagonisti di questo, con il suo vol-to ancipite, ora greco di Herakles, ora fenicio di Melqart, un tratto del culto del velabro riconosciuto quattro decenni or sono da D. van Berchem. Coerentemente con questa origine, il dio dell’Ara Maxima viene celebrato Graeco ritu dai pretori urbani (ulteriore circostanza che denuncia la notevole antichità del santuario), i quali vi praticano una vera e propria ecatombe in occasione della grande festa del dio il 13 agosto, festa che però, tutt’altro che casualmente, non rientra tra le grandi solennità dei fasti calendariali, a lungo celebrata senza un vero e proprio tempio. Non sappiamo infatti se il primo edificio formale dedicato ad eracle accanto all’arcaica Ara Maxima sia l’aedes Herculis Aemiliana costruita da scipione emiliano durante la sua censura del 142 a.C., o se invece la aedes Herculis Pompeiana, pure lì accanto, debba la sua epiclesi non in seguito ad una costruzione ex-novo realizzata da Pompeo, ma al rifacimento di un antico tempio di età medio-repubblicana dedicato dal grande generale tardo-repubbli-cano. il dato di maggiore interesse è tuttavia offerto dalla tradizione che parla di un controllo esercitato sui riti ad Aram Maximam da due gruppi, quello dei Pinarii e dei Potitii. Frutto di un evidente frainten-dimento delle fonti antiche, il dato lascia comunque trasparire il ca-rattere gentilizio del culto, affidato (non sappiamo se sin dall’origine) ai Pinarii, una gens di cui si conoscono due rami: il più antico dei due è la stirpe patrizia dei Pinarii Mamercini, che si estingue con un l. Pinarius cens. 430 a.C., mentre quello più recente, apparentemente
17 su tutto il problema v. Torelli 2006c, pp. 573-620.18 La bibliografia sul dio e sui suoi luoghi di culto di Roma, è vastissima: v.
comunque puTnAm, 1967, pp. 177-179; CrisToFAni 1985, pp. 75-88; ColonnA 1987, pp. 55-66; J. Aronen, in LTUR iv, 1999, p. 310 s.; sAgArrA Crespo 2003, pp. 129-163.
19 vAn berChem 1967, pp. 307-338, lavoro anticipato poco prima dallo stesso van Berchem (vAn berChem 1960, pp. 61-68).
310 Mario torelli
plebeo, dei Pinarii Nattae si chiude un secolo dopo con l. Pinarius Natta mag. eq. 363 a.C. e pr. 349 a.C. secondo le fonti, ci sarebbe sta-ta una successione nel controllo sul culto dell’Ara Maxima, con una primitiva gestione gentilizia dei Pinarii; una volta estintisi costoro, sarebbe stata la volta dei Potitii. l’errore delle fonti, che hanno por-tato fuori strada una lunghissima schiera di moderni, sta nel ritenere i Potitii una gens: e infatti, dal momento che l’amplissimo regesto dei gentilizi latini costruito in base ai dati letterari e soprattutto epi-grafici non conosce un sol caso di questo nomen, i Potiti altro non sono che degli schiavi sacri frutto di cattura, come dice chiaramente il loro nome di potiti, participio passato di potiri. Possiamo dunque ricostruire una sequenza almeno dal v secolo a.C. che vede alla testa del culto i patrizi Pinarii. all’estinzione di costoro nel tardo v secolo ci sarebbe stata la successione del ramo plebeo dei Pinarii Nattae, i quali, giunti ad alte cariche cum imperio dopo le leggi licinie-sestie (come dimostrano le magistrature dell’ultimo loro esponente rivestite nel 363 e nel 349 a.C.), si estinguono subito dopo20, un evento que-sto che avrebbe fatto passare la gestione del culto nelle mani degli schiavi del tempio. la publicatio del culto attuata poco dopo da appio Claudio21 nel corso della sua rivoluzionaria censura nel 312 a.C., va evidentemente inquadrata nel rifiuto da parte del censore dell’uso che attribuiva a semplici ieroduli la gestione di un santuario, un uso arcaicissimo e ben noto negli empória, come insegna il caso della più insigne di queste strutture, Naucrati, ma in flagrante contraddizione con le logiche di un’economia monetata, che credo abbia mosso i primi passi proprio con appio Claudio22.
Dell’etrusco Velthumna-vortumnus invece non conosciamo alcun dettaglio circa eventuali forme ufficiali di culto, che stando alla scar-sissima documentazione letteraria potrebbe perfino non essere mai stato prestato nel luogo: per quanto ne sappiamo al dio era infatti
20 il Natta monetalis tra il 145 e il 138 a.C., secondo broughTon 1951, ii, p. 448, sarebbe un [Pinarius] Natta, congettura largamente plausibile, vista la riesuma-zione in epoca tardo-repubblicana del nomen seguito con quel cognomen con il senatore Pinarius Natta, noto figliastro di L. Licinius Murena, ricordato ripetutamente tra il 63 e il 56 a.C. da Cicerone (de dom. 177 ss., 134 s., 139), secondo un modello, largamente seguito tra la fine della repubblica e gli inizi dell’impero, di ripresa, perlopiù arbitra-ria, dell’onomastica di personaggi in vista della fase alto- e medio-repubblicana a fini evidentemente autocelebrativi.
21 su appio Claudio v. ora il lavoro esauriente di humm 2005, con alcuni altri suoi lavori precedenti: humm 1999, pp. 625-694, e id. 2000, 91-119.
22 Per la complessa questione, oltre ai classici lavori di r. thomsen e M. Craw-ford e r. thomsen, v. la sintesi di burneTT 1989, pp. 33-58, il nodo della questione resta sempre il problema della cronologia e della funzione della monetazione romano-campana, per la quale cfr. piATTelli 1987, pp. 15-29; hollowAy 1992, pp. 225-235; La monetazione romano-campana 1998.
311la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
eretto un signum, menzionato perlopiù perché in prossimità di esso il percorso del trionfo faceva una brusca svolta23. Non c’è comunque da dubitare circa la connessione del signum con il Vicus Tuscus e con gli adiacenti Vicus Iugarius e Vicus Aromatarius, che sappiamo popo-lato di prostitute, gioiellieri, argentieri, cambiavalute, librai, ma so-prattutto di thurarii ed aromatari: questo Vicus altro non è se non il fondaco degli emporoi provenienti dall’etruria, una terra in cui, sulla scorta dell’imponente produzione di contenitori di oli profumati etru-sco-corinzi e di bucchero di vii-vi secolo a.C., dobbiamo collocare una delle capitali mediterranee della profumeria arcaica, così ambita dalle classi dominanti della penisola, per non parlare di altre mercanzie di lusso pure smerciate nell’area e sempre di provenienza etrusca24. Dal momento che, con tutta verosimiglianza, il mercato di tale industria era largamente controllato da intermediari provenienti dall’etruria, è legittimo pensare che quel signum vada riconosciuto non come un monumento privo di valori sacrali, improbabile per un’epoca arcaica (e tanto meno come un limite della palude, concetto estraneo alla reli-giosità antica)25, ma come un’immagine, attorno alla quale la comunità etrusca di roma: all’epoca della “Grande roma dei tarquini”, questa comunità, oltre ad un numero forse non piccolo di gentes di rango, dove-va soprattutto comprendere mercanti e di artigiani di prodotti di lusso, i quali avevano certo necessità di ritrovarsi per prestare un culto che, pure essendo privo di ufficialità per la città ospitante, doveva essere capace di fornire adeguata protezione a quel gruppo straniero e al tem-po stesso di evocare fra i frequentatori sentimenti identitari, visto il carattere pan-etrusco del culto del dio titolare del Fanum Voltumnae. Come peraltro si ricava da un passo di un conoscitore di antichità come Porfirione, il luogo poteva essere chiamato sacellum26; da ciò discende la conseguenza che il signum Vortumni doveva marcare un luogo di culto non ufficiale, del genere di quelli collegati ad emporia, ben docu-mentati a Naucrati e a Gravisca. Le considerazioni analitiche fin qui fatte su questi due santuari avevano lo scopo di mettere in risalto la diversità di destino dei culti dedicati nello stesso Foro Boario a due di-vinità straniere, ma giunte in epoche molto diverse: mentre l’Ara Maxi-ma Herculis va probabilmente datata ad un momento piuttosto antico del vii secolo a.C., se non ad epoca addirittura anteriore, il Vortumnus del Vicus Tuscus, sulla scorta del più vicino esempio di Gravisca, deve essere una fondazione dell’epoca dei tarquini. l’Ara Maxima appare
23 pluT., Caes. 37: sul percorso del trionfo, vedi da ultimo lA roCCA 2008, pp. 34-55, partic. 40-42.
24 Cfr. ronCAlli 1985, pp. 69-73.25 suggerito da J. Aronen, in LTUR iv, 1999, p. 311.26 porphyr., Hor. epist. 1, 20, 1.
312 Mario torelli
integrata nella religione civica, pur senza assurgere, come era peraltro facile supporre, al rango di protagonista di una delle grandi feste del calendario “numano”; al contrario, malgrado la documentata presenza tra i sacerdotes antiquissimi di un flamen Volturnalis, del tutto estra-neo o quanto meno caratterizzato da un’estrema marginalità rispetto alla religione civica di roma appare il culto di vortumnus in epoca anteriore alla dedica del tempio aventino di Fulvio Flacco, eretto subito dopo il 264 a.C. in ricordo del trionfo del dedicante sulla città di volsi-nii. Da questo confronto si ricava facilmente che, com’era da attendersi, il prepotente sviluppo della realtà urbana e le connesse grandi trasfor-mazioni del corpo sociale verificatesi con la dinastia dei Tarquini han-no generato, rispetto ad un passato non lontano, un’ulteriore chiusura nei confronti di novità nel campo religioso.
Questo non significa che la “Grande Roma dei Tarquini” sia stata immobile in fatto di religione: al contrario, il periodo si qualifica come un momento di forti trasformazioni delle forme di culto, forse tra le più rilevanti per la storia di roma prima dell’avvento di Cristianesimo. le grandi novità di questa fase consistono essenzialmente in tre aspetti: in primo luogo la monumentalizzazione del culto, secondariamente l’intro-duzione di forme greche nelle architetture sacre, nelle pratiche cultuali e nell’immaginario degli dei con la definitiva ellenizzazione della “parte canonica” del pantheon etrusco-latino e infine l’uso del lusso nei riti e nelle cerimonie sull’esempio etrusco. a questi fenomeni, capaci di mu-tare in profondità le forme ideali e materiali della religione, si accompa-gnano trasformazioni imposte in campo sociale e politico dal progresso delle strutture urbane, che modificano assetti tradizionali, materiali e cerimoniali, collegati allo svolgimento delle pratiche religiose.
Ma andiamo con ordine. La novità più significativa di quest’epoca è forse la monumentalizzazione del culto. Com’è noto, la documenta-zione archeologica attesta che, a somiglianza di quanto avviene in tutto il Lazio e in Etruria, la data di nascita dei primi edifici di culto a roma si colloca in pieno sincronismo con l’avvio della c.d. monar-chia etrusca, nei decenni finali del VII secolo a.C.27, quando si assiste
27 il catalogo di G. Cifani (Architettura romana arcaica. Edilizia e società tra Monarchia e Repubblica, roma 2008), registra 10 strutture di epoca arcaica riferibili a templi o luoghi di culto costruiti con intenti monumentali, anche se di assai diversa entità: si tratta della aedes Iunonis Monetae in Arce (?) (75-78, n. 27: v sec. a.C.), della aedes I.O.M: Capitolini (80-109, n. 30: inizi vi sec. a.C.), dell’Ara Saturni in Foro (111, n. 33: fine VI sec. a.C.?), dei sacella del Comitium (113-118, n. 35: fine VII sec. a.C.), dell’aedes Castorum in Foro (119-123, n. 38: inizi v sec. a.C.), dei sacraria della Regia (126-139, n. 43; fine VII sec. a.C.), di un anonimo santuario arcaico delle pendici nord-orientali del Palatium (149, n. 52: 540 a.C.); della aedes Iunonis Sospitae in Palatio (?) (162 s., n. 63: inizi v sec. a.C.), dell’aedes Fortunae Reducis in Foro Boario (165-173, n. 67: prima metà del vi sec. a.C.), dell’Apollinar in Foro Boario (173 s., n. 68; vi sec. a.C. ?).
313la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
all’avvio sia di un’imponente edilizia sacra che di un’organizzazione complessa delle pratiche cultuali, documentata da immagini e soprat-tutto archeologicamente visibile: entrambe le cose costituiscono un salto di qualità di straordinaria portata rispetto alla fase protostorica, quando le tracce dell’attività cultuale sono talmente esili da rendere spesso assai difficile, per non dire impossibile, il riconoscimento del carattere sacrale del giacimento28. Un’altra delle principali novità della “Grande Roma dei Tarquini”, oltre alla nascita degli edifici di culto, è quella del tipo stesso di tempio, influenzato in maniera molto evidente dalle coeve architetture sacre del mondo greco, che hanno costituito un palese modello per tutte le realizzazioni templari del vi secolo a.C., un fenomeno di ellenizzazione come la collegata introduzione di pratiche di culto di tipo greco, con uso di thymiateria derivati direttamente dal mondo ellenico29 e di vasellame di servizio per i sacra, nei quali tipi greci, come l’olpe, lo skyphos o la kylix, si affiancano a tipi tradizionali indigeni come il kyathos o l’olla. L’accettazione, sia pur con modifica-zioni, dei tratti salienti dell’organizzazione dei grandi luoghi di culto propria del mondo ellenico da parte dell’etruria e del lazio, che vanno dall’aspetto esteriore del tempio agli edifici di servizio come le stoai, dalla collocazione degli altari entro gli spazi santuariali alla presenza di muri di temenos, potrebbe apparire questione di pura forma: in re-altà tutte queste novità sono servite da irresistibili veicoli per radicali trasformazioni del costume religioso. tali trasformazioni si sono in ge-nere risolte nell’introduzione di rituali che hanno finito per rivestire antichi cerimoniali di quel lusso, ingrediente fondamentale delle cultu-ra e della vita sociale dell’alto arcaismo, che tuttavia, rispetto alla fase dell’orientalizzante antico e medio, è ormai dilagato a livelli sociali fino a quel momento impensati. Naturalmente questi elementi di origine greca vengono ben presto a scontrarsi con precise e invalicabili limita-zioni frapposte dalla cultura “nazionale” all’influenza di modelli ester-ni. la resistenza si manifesta in tutto ciò che tocca i livelli profondi delle tradizioni religiose preistoriche indigene, sia latine che etrusche, particolarmente evidenti in quei casi che interferiscono con la dottri-na dell’auspicium e dell’augurium e che inducono etruschi e latini a modificare anche in modo radicale i modelli greci. Le manifestazioni più evidenti di tale interferenza sono ben leggibili soprattutto in ca-
28 Ne ho discusso analizzando sinteticamente la documentazione protostorica della Casa Romuli: Torelli 2000, pp. 63-67.
29 il primo documento dell’uso dell’incenso in italia è costituito dalla presenza di incenso nella tomba principesca di vii sec. a.C. da Casalmarittimo (cfr. Torelli 1999, pp. 247-259), ma l’introduzione del thymiaterion nel costume del lusso etrusco (e latino) non è anteriore al vi sec. a.C.: cfr. TesTA 1989, da consultare con zACCAgnino 1998.
314 Mario torelli
ratteristiche esteriori degli edifici templari e di tutti i loci inaugurati, che comportano diversità di scelta di orientamento di templi e altari e soprattutto l’attribuzione a templi e altari (Fig. 1) dell’anellenico podio, sentito come vera e propria pietrificazione del carattere di locus effatus acquisito da templi e altari in conseguenza del complesso cerimoniale indigeno dell’inauguratio, un rito cioè assolutamente estraneo alla tra-dizione religiosa ellenica.
Nel processo di ellenizzazione formale delle pratiche religiose dob-biamo collocare anche il completamento di quell’altra grandiosa ope-razione di meticciato culturale offertaci dall’interpretatio graeca delle divinità del pantheon locale, ancora una volta avvenuto su di un asse parallelo sia etrusco che latino, verificabile attraverso l’ellenizzazione dell’iconografia degli dei. È un argomento questo, che, essendo solo in parte compreso nei limiti cronologici del nostro incontro, ci obbliga a riandare ad epoche molto più antiche degli inizi del vi secolo a.C. e che richiede un certo tempo anche per procedere per soli accenni. È luogo comune della ricerca moderna attribuire questa complessa operazione di natura squisitamente culturale alla piena fase orientalizzante. l’ap-parizione del mito greco nell’imagerie etrusca è un fenomeno precoce che data sin dai primi decenni del vii secolo a.C.: anche se l’iconogra-fia latina è assai avara al riguardo, visti gli esiti, dobbiamo tuttavia supporre che per ciò che attiene la cultura religiosa i processi di ibri-dazione siano avanzati in parallelo in etruria e nel lazio. Detto questo occorre tuttavia ricordare che i miti hanno fatto la loro comparsa nella produzione figurativa etrusca in quanto mythoi, ossia in quanto racconti favolosi di eroi, che il mondo etrusco e quello latino hanno acquisito a scopo paradigmatico, grazie a probabili intermediazioni poetiche, che vanno dall’epica omerica e del ciclo fino al vasto e multiforme repertorio di canti relativi a vari eroi, come gli argonauti, eracle o teseo. Ma si tratta pur sempre di mythoi, di racconti tradotti nell’immaginario etru-sco in rappresentazioni sostanzialmente prive di presenze divine per quasi tutto il vii secolo a.C. la cosa non è credo casuale, perché l’inte-resse per questi racconti da parte delle aristocrazie indigene si basava su di un elementare processo di autoidentificazione con i protagonisti del mito, come è dimostrato ad usura dai nomi di Mamarce, Thesatei e Velelia attribuiti al terzetto di teseo, arianna e la nutrice nella celebre oinochoe di tragliatella (Fig. 2). la prima sicura rappresentazione di divinità greche in area tirrenica è la nota pisside di impasto rosso sovra-dipinto in bianco con la nascita di atena (Fig. 3) del 630-20 a.C., prove-niente da Caere e conservata al louvre30, dove compaiono tutti gli dei
30 mArTelli 1984, p. 13; eAd. 1987, p. 266 s.; mAssA pAirAulT 1992; meniCheT-Ti 1994, p. 74 s.; miCozzi 1994, pp. 110-112.
315la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
del mito, zeus, atena, Hermes ed efesto; nulla tuttavia ci assicura sul fatto che lo spettatore fosse già in grado di assegnare nomi indi-geni a quelle raffigurazioni di dei, e cioè di leggere Zeus come Tinia o Iuppiter e atena come Menerva o Minerva.
Per tentare di ricostruire il complicato andamento di questo pro-cesso di interferenza e di ibridazione tra esperienze religiose diver-se e lontane occorre andare ad un’epoca anteriore a quella al centro della nostra discussione, che copre i secoli viii e vii a.C. le ricerche recenti in fatto di iconografia tra età del Ferro ed Orientalizzante hanno constatata la notevole diffusione, sin dall’età del Bronzo Fi-nale, di credenze relative alle attese oltremondane dei membri della comunità, e in particolare di quelle eminenti, credenze che vedono in primo piano la relazione ierogamica con esseri sovrannaturali femmi-nili. Una più lontana testimonianza di queste concezioni ci è offerta dalle statuette (Fig. 4) presenti in tombe laziali ricche di connotati ideologici e magico-religiosi di Xi-iX secolo a.C., sulle quali mi sono intrattenuto già molti anni or sono e che costituiscono senz’altro la base principale a nostra disposizione per tentare di ricostruire i livelli del soprannaturale diffusi tra le popolazioni latine, che notoriamen-te possono fondarsi su documenti archeologici, oltre che su tenissimi dati letterari. il radicamento di queste concezioni è ben dimostrato dal fatto che analoghe attese oltremondane pervadono secoli dopo mo-numenti figurati famosi di fine VII e di pieno VI secolo a.C., dall’oino-choe da tragliatella (Fig. 2), con la sua duplice immagine di amplessi, uno terreno e uno oltremondano, fino alle sempre duplici processioni nuziali allusive a ierogamie terrene e ierogamie celesti rappresenta-te sulle lastre appartenenti alla decorazione di residenze principe-sche e di templi di pieno vi secolo a.C. (Fig. 5). l’unico documento certo in nostro possesso che comprovi l’antichità di siffatte idee ci è conservato soprattutto dal nome “erotico” dell’arcaica divinità della morte libitina, il cui culto a roma appare relazionato con la grande necropoli urbana unitaria dell’esquilino di viii secolo a.C.: la dea è stata appiattita in epoca mediorepubblicana sulla più recente figura religiosa di Venere e di fatto non è stata più compresa, finendo per essere ricordata solo per alcune curiosità antiquarie sui funerali ro-mani, incomprensibili all’epoca tardo-repubblicana quando si possono datare queste indagini sulle antichità romane.
Per la fase più antica l’interferenza con l’esterno si è tradotta in immagini ed oggetti, che di fatto risultano confinati alla sola docu-mentazione delle necropoli e sembra interessata non da credenze di ascendenza greca, ma piuttosto da elementi religiosi di origine orien-tale, in particolare con quelli propri del mondo siro-fenicio. e infatti per il pieno vii secolo a.C. le sole immagini che si possono attribu-
316 Mario torelli
ire a divinità sono la notissima statuetta di avorio di dea nuda dal Circolo degli Avori di Marsiliana e la triplice figura di dea anch’essa nuda, sbalzata su una coppia di ornamenti da veste in lamina aurea da Narce31, tutte figure riconducibili a rappresentazioni di tradizione orientale di divinità femminili nude, ben note alla cultura orienta-lizzante greca. la statuetta di Marsiliana (Fig. 6), un oggetto che ri-tengo realizzato in etruria da artigiani in possesso di un ben preciso repertorio orientale, ha un’iconografia che dipende direttamente da prototipi siro-fenici, ma ha subito un importante aggiustamento loca-le consistente nell’accettazione della moda, tutta etrusca, della lunga treccia sulle spalle. L’iconografia dell’avorio di Marsiliana è ben nota in opere di tutte le epoche di ambiente fenicio di madrepatria, di Ci-pro e delle colonie d’Occidente: il gesto che la figura compie con la mano sinistra, quello di strizzare la mammella, ritorna in statuette fittili32, come gli esemplari da akziv di viii secolo a.C. (Fig. 7). e da amrit (Fig. 8) e da Nora di v-iv secolo a.C. (Fig. 9), o in avori e ossi, come il manico di specchio da Cartagine di iii secolo a.C.33 (Fig. 10); il gesto che compie invece con la destra, quello di portare al seno destro un recipiente per riempirlo di latte è noto dalla celebre statuetta di vii secolo a.C. proveniente da Galera (Granada)34 e raffigurante una dea in trono in atto di recare un bacino alle mammelle (Fig. 9), nel quale era possibile raccogliere il liquido passato attraverso i seni in quel bacino, di fatto parte integrante della scultura. la nudità delle tre figure femminili sulle lamine auree di Narce (Fig. 10) rientra sen-za difficoltà nella stessa prospettiva culturale e ideologica. Sulla pre-senza di queste immagini di divinità nude nel repertorio arcaico greco sono stati di recente pubblicati due importanti lavori, quello di tipo più tradizionale di s. Böhm35 e quello invece fortemente innovativo di N. Marinatos36. Come ha dimostrato quest’ultima, gli adattamenti di significato, cui i Greci hanno piegato queste immagini sono molti e non univoci, ma la loro fonte è indisputabilmente fenicia, come mo-stra il noto ornamento bronzeo di cavallo (Fig. 11) con iscrizione ara-maica databile al iX secolo a.C., dedicato del re Haazel di Damasco nell’Heraion di samos37, nel quale incontriamo la figura di dea nuda, che sorregge due altre figure femminili nude.
31 M. Cristofani, in CrisToFAni - mArTelli 1983, 284, n. 111.32 a. CiAsCA, Fenicia, in mosCATi 1988, 150 (statuetta da amrit); a.M. bisi, Le
terrecotte figurate, in mosCATi 1988, p. 338 s. (statuetta da Nora); in quest’ultimo caso l’immagine è riferita erroneamente a una gestante.
33 M.l. uberTi, Gli avori e gli ossi, in mosCATi 1988, p. 416 s.34 s. mosCATi, La statuaria, in mosCATi 1988, pp. 288-291.35 böhm 1990.36 mArinATos 2000.37 mArinATos 2000, pp. 22-24, fig. 1.33-34; cfr. anche böhm 1990, p. 156, n. B 30-1.
317la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
Non si può non concludere che nei rari oggetti di lusso con questa iconografia presenti nel lontano Occidente, come la statuetta d’avo-rio di Marsiliana, si deve vedere certamente una precisa suggestione orientale, alla quale però non è lecito attribuire né nomi greci né nomi etruschi: la presenza della statuetta vetuloniese all’interno di una tomba orienta il significato dell’immagine in direzione della ieroga-mia, un tema insistentemente rappresentato in una serie di docu-menti di elevato valore ideologico, di cui si detto poc’anzi. Un recentis-simo, brillante lavoro di andrea Babbi38, che ha ripreso antiche osser-vazioni di G. Hanfmann39, ha potuto dimostrare che la stessa divinità (o altra affine) della Venere di Marsiliana, raffigurata nell’iconografia della siro-palestinese della “sich entschleiernde Göttin”, nota da sigilli e altri prodotti di origine siriana e anatolica di ii millennio40 (Fig. 12), è stata acquisita in ambiente tardo-villanoviano, dove è stata usata per decorare coppe bronzee di alta valenza cerimoniale (Fig. 13) e altri oggetti di pregio, sopravvivendo fino alla piena età orientalizzante41 (Fig. 14). la forza di una vasta gamma di modelli culturali orientali giunti in etruria e nel lazio in epoca assai antica, quasi certamente prima degli inizi dell’età del Ferro, è dunque stata assai cospicua: di recente M. Martelli ha giustamente sottolineato la centralità di que-sti apporti nella cultura orientalizzante etrusca e latina con dovizia di esempi materiali e di argomenti e con solide prospettive storiche e storico-culturali42. Questa influenza è durata almeno fino alla metà del vii secolo a.C. in serrata concorrenza con i modelli greci, peraltro attivi con sempre maggior vigore dalla fine dell’VIII secolo a.C. Negli anni a cavallo della metà del vii secolo a.C. nella sfera religiosa le suggestioni capaci di influenzare il processo di ibridazione culturale ancora pendevano in direzione del prestigiosissimo oriente: per que-sto ritengo che il deciso indirizzo verso un’ellenizzazione di una parte, certo la più rilevante, del pantheon etrusco e latino, si è verificata nella seconda metà del vii secolo a.C. con l’orientalizzante recen-te, quando si verifica il paradosso dell’arrivo della “lezte orientalisie-rende Welle”, interamente portata da intermediari greci e del tutto permeata dalla cultura greca, e cioè con la fase che appunto stiamo discutendo della “Grande roma dei tarquini”. e a dimostrare che questa ellenizzazione compiuta sia un fenomeno non univoco né in senso spaziale né in senso cronologico nella vasta area etrusco-latina basterà, sempre per restare nello stesso argomento dell’interpretatio
38 bAbbi 2009, pp. 13-29.39 hAnFmAnn 1936, p. 62 s.40 bAbbi 2009, figg. 4 b-e.41 bAbbi 2009, fig. 1 b.42 mArTelli 2008, pp. 121-139.
318 Mario torelli
graeca del pantheon etrusco e latino, fare il confronto tra le assemblee di divinità etrusche funzionali all’accoglimento fra gli dei del princeps della gens, rappresentate nelle due serie di lastre di Murlo (Fig. 15) e di roma-veio-velletri (Fig. 16): in quest’ultima serie la nettissima in-dividuazione iconografica in senso greco della più meridionale theon agorà romano-veiente (se ne vedano le immagini di zeus-Tinia-Giove, di apollo-Apulu e di Hermes-Turms-Mercurio), laddove nella poco più antica, ma assai più settentrionale Murlo, la corrispondenza dell’im-magine locale con quella greca diventa opaca e discutibile, come di-mostrano i tentativi non sempre riusciti di piegare quelle rappresen-tazioni a significati ora greci ora latini. Se nel 580-70 a.C. nell’Etruria settentrionale interna il processo di ellenizzazione del pantheon era ancora largamente incompleto, nel 530 a.C. tra roma e veio il lun-go cammino dell’ibridazione dell’immaginario divino era largamente concluso, un’ibridazione che significativamente mette nelle mani di un apollo assolutamente greco un assai indigeno lituo.
tutto ciò si accorda in maniera perfetta con gli episodi salien-ti che conosciamo per la storia religiosa del periodo della “Grande roma dei tarquini”. Non ci sono molti dubbi sul progetto politico che ha mosso prima tarquinio Prisco a fondare il tempio capitolino43 e poi servio tullio il tempio di Diana aventina44. le due operazioni avevano l’evidente scopo di importare all’interno di roma due tra i più prestigiosi culti del lazio, quello di Iuppiter Albanus45 e quello di Diana Nemorensis, secondo un preciso programma ideologico, rive-lato anche da altri dettagli, come l’identità di numero tra le curie e i populi Albenses, che consisteva nel far coincidere il populus dell’Ur-bs con l’insieme del nomen Latinum: parafrasando una celebre legge dell’evoluzione animale si può affermare che in questo caso la poleo-genesi si attuava ricapitolando l’etnogenesi. se si può dubitare che la costruzione della triade sia un modello introdotto dall’etruria (ma le triadi sono un fenomeno a larga diffusione anche in altre aree itali-che), non si può avere incertezze sull’aspetto interamente greco della Diana aventina, come è stato messo anni fa in risalto molto bene da C. ampolo46; del pari l’introduzione del culto di apollo a roma è certa-mente un episodio dell’epoca dei tarquini, cui si debbono una celebre ambasceria a Delfi e la connessa fondazione dell’Apollinar47, santua-rio tutt’altro che casualmente non lontano dalla Porta Carmentale e
43 v., da ultimo, sTemper 1998-99, 107-13 e murA sommellA 1997-98, pp. 57-79.44 v. di recente, sCodellAri 2003, pp. 417-433; Armellin - QuArAnTA 2004, pp.
279-298; vendiTTelli 2005, pp. 235-249.45 Da ultimo, dAvies 2006, pp. 186-189 (con bibl. prec.).46 Ampolo 1970, pp. 200-210; cfr. anche id. 1987, pp. 75-87.47 ampia discussione di CoArelli 1997, pp. 377-384.
319la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
dal sacello delle Carmente48. la spinta in senso ellenizzante del pan-theon, dei culti, di tutte le pratiche sacrali riceve adesso una piena sanzione, che va ben oltre questa seconda età regia, per espandersi in maniera decisa lungo tutto il primo trentennio di vita della repubbli-ca. Ma i documenti archeologici sulla religione di questa fase hanno ricevuto in epoca recentissima un ulteriore grande impulso grazie ad una scoperta che dobbiamo alla sagacia e all’occhio di grande esperta della coroplastica arcaica di anna sommella Mura; grazie alla squi-sita cortesia e alla antica amicizia della collega posso presentare in questa sede quanto lei stessa ha mostrato qualche settimana fa in occasione dell’importante Quarto Convegno Romano “Deliciae ficti-lies”49, dimostrando il sicuro attacco di una testa di provenienza igno-ta oggi a Copenhagen con un frammento di acroterio da s. omobono raffigurante il braccio di un personaggio maschile posato su di una spalla femminile. l’attacco le ha consentito di ricomporre un gruppo identificabile come Dioniso e Arianna (Fig. 17), grazie anche all’at-tribuzione al gruppo di due altri frammenti, il primo con una piccola pantera rampante che aderisce alla parte inferiore di una delle figure del gruppo e un secondo, rimasto finora inesplicato, costituito da un bastone intrecciato di vecchio trovamento, da identificare con l’ovvio attributo dionisiaco del tirso. Non è possibile qui analizzare un det-taglio la storica portata della scoperta, che consente di identificare con relativa sicurezza il tempio di appartenenza50 con quello serviano di Fortuna Redux51: le decorazioni acroteriali con l’ingresso di eracle all’olimpo (Fig. 18) e la teofania di Dioniso e arianna si collegano indissolubilmente al trionfo, colorando questa apoteosi tutta italica di un preciso sapore dionisiaco, consegnatoci dall’origine greca del-lo stesso nome thriambos-triumphus forse proprio in questa tempe-rie storica attribuito ad un’antica cerimonia preistorica52. vieppiù si comprende la complessa vicenda edilizia arcaica dell’edificio con i suoi rifacimenti e successive decorazioni promosse dai vari re per precise esigenze ideologiche, presumibilmente in occasione di trionfi: l’uso di consacrare agli dei una parte del bottino di guerra è antichissimo e le circostanze del dominio regio largamente assoluto hanno di sicuro spinto i re trionfatori dell’età dei tarquini a celebrare la divinità per-sonale con un nuovo volto dato al tempio, che è in tal modo finito per
48 sulla localizzazione del santuario, v. CAssATellA 2005, pp. 77-83; e mAzzei 2005, pp. 61-81.
49 murA sommellA c.s.50 Per un recente messa a punto dei dati, v. AdornATo 2003, pp. 809-835.51 Già aveva antiveduto la presenza del dio sul tetto del tempio pArisi presiC-
Ce 1997, pp. 167-177.52 Torelli 2008, pp. 84-89, con Torelli c.s. b.
320 Mario torelli
diventare anche uno dei capisaldi anche topografici della cerimonia trionfale, ancora un’altra innovazione di grande rilievo e altamente simbolica nel panorama della religione dell’epoca della c.d. monarchia etrusca. al rovescio, si comprendono anche le ragioni dell’abbandono di un santuario come questo di Fortuna, verificatosi all’inizio della repub-blica: sentito come un luogo di culto personale, non legittimato da pra-tiche religiose consuetudinarie della comunità, di cui si scorga traccia nelle registrazioni del calendario “numano”, l’abbandono dal santuario per oltre un secolo dopo la fine della monarchia risponde perfettamente alle logiche antisuntuarie della giovane repubblica e all’introduzione dell’ovatio in luogo delle pratiche tutte etrusche dell’ingresso trionfale su carro, pratiche ossessivamente replicate nell’imagerie delle residen-ze principesche e dallo stesso fregio fittile del tempio (Fig. 24). Fortuna dunque come espressione della Fors, del caso e della mobilità sociale (ed etnica) arcaica, un fenomeno ben conosciuto in lazio e in etruria meridionale del vi secolo a.C.53, ma che doveva toccare anche il mondo greco arcaico, soprattutto quello dell’est, se ben leggiamo la poesia di ipponatte54 e udiamo dalle fonti55 di una statua opera di Bupalos raf-figurante Tyche e collocata a Smirne, e cioè in una delle capitali della Grecia dell’est così legata agli approdi tirrenici; l’inusitato tratto icono-grafico della cornucopia della statua anticipa l’aspetto ellenistico della dea, così come il forte rimescolamento di ceti e classi di epoca arcaica sembra quasi preludere al quadro sociale dell’ellenismo.
53 l’argomento della mobilità sociale ed etnica del lazio e dell’etruria in età arcaica è stato trattato in numerosi lavori da C. ampolo: Su alcuni mutamenti sociali nel Lazio tra l’VIII e il V secolo, in DialArch 4-5, 1970-71, pp. 37-68; Gli Aquilii del V secolo a.C. e il problema dei fasti consolari più antichi, in ParPass, 1975, pp. 410-416; Demarato. Osservazioni sulla mobilità sociale arcaica, in DialArch 9-10, 1976-77, pp. 333-345; I gruppi etnici in Roma arcaica. Posizione del problema e fonti, in Gli Etruschi e Roma (atti dell’incontro di studi in onore di Massimo Pallottino, roma 11-13 dicem-bre 1979), roma 1981, pp. 45-70; Il lusso funerario e la città arcaica, in AnnAStorAnt 6, 1984, pp. 71-102; Il lusso nelle società arcaiche. Note preliminari sulla posizione del problema, in Opus 3, 1984, pp. 469-476; Roma arcaica tra Latini ed Etruschi. Aspetti politici e istituzionali, in Etruria e Lazio arcaico (atti dell’incontro di studio, roma, 10-11 novembre 1986), roma 1987, pp. 75-87; “La grande Roma dei Tarquinii” rivisitata, in Alle origini di Roma (atti del Colloquio, Pisa 18 e 19 settembre 1987), Pisa 1988, pp. 77-87; Onomastica e mobilità sociale. Da Strinpon a Stremponius. A proposito della iscrizione di Pontecagnano, in AnnAStorAnt 14, 1992, pp. 63-68; Greci d’Occidente, Etruschi, Cartaginesi. Circolazione di beni e di uomini, in Magna Grecia, Etruschi, Fenici (atti del XXXiii Convegno di studi sulla Magna Grecia, taranto 8-13 ottobre 1993), taranto 1996, pp. 223-252.
54 anche se l’antica interpretazione romantica che faceva di ipponatte un po-vero pitocco non ha più statuto (anche alla luce della connotazione aristocratica del nome del poeta e della caratteristica simposiaca ed eterica della poesia giambica: v. Aloni 2006, pp. 83-107), tuttavia i contesti stessi dell’invettiva giambica di ipponatte parlano della grande mobilità della società ionica di vi secolo a.C.; per i rapporti tra ipponatte e Bupalos, cfr. gAllAvoTTi 1984, pp. 135-142.
55 pAus. iv, 30, 6.
321la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
sempre per rapidi accenni posso riferire su di un argomento che richiederebbe da solo un’intera relazione, quello dell’influenza sulle pratiche religiose delle trasformazioni sociali e politiche verificatesi nel corso del VI secolo a.C. Il dato più significativo è quello del pro-gressivo esautoramento della figura del rex, come agente unico de-gli atti religiosi, politici e militari, rivelato dall’affiorare della coppia magister populi e magister equitum56 e del rex ad sacra già in età regia, un’idea in buona sostanza pienamente delineata dal celebre articolo di Bernardi sugli ausiliari del rex come origine delle magi-strature repubblicane57 e più di recente con buoni argomenti ripresa proprio per il rex sacrorum da t. Cornell58. l’estensione dei territori delle principali città-stato di etruria e del lazio nel vi secolo a.C. - e l’ager controllato da roma era certamente tra quelli più grandi del Lazio - difficilmente consentiva un regolare svolgimento di tutte le quotidiane incombenze, giudiziarie, militari, politiche e soprattutto religiose, che il mos prevedeva il rex svolgesse nella città: in caso di lunghe campagne lontane da roma il rex era obbligato a nominare dei sostituti per varie funzioni e dunque per le quotidiane attività religio-se previste per il re anche un “doppio” solo ad sacra, la cui antichità va dunque ben oltre l’inizio della repubblica.
Un altro capitolo complesso per l’età dei tarquini è anche co-stituito dall’evidente conflitto, determinatosi in questa fase del trionfo socio-politico delle gentes, tra la dimensione gentilizia del culto e la religione pubblica, un fatto documentato anche da im-portanti pezzi della tradizione, come la vicenda del conflitto tra tarquinio Prisco e atto Navio59, un fenomeno acuito dalla cresci-ta della struttura urbana che andava esaltando sempre più la di-mensione collettiva di vari fenomeni e imponendo limiti alle real-tà sacrali sotto controllo aristocratico. Questo aspetto della storia politico-religiosa tra la tarda protostoria e la fine dell’età arcaica e più precisamente la documentazione concreta, archeologica, del dominio gentilizio di culti ben precisi è costituito notoriamente dalla presenza di una capanna contenuta esattamente all’interno del perimetro di un edificio sacro arcaico è un dato che si registra tanto a satricum nel tempio di Mater Matuta60 quanto ad ardea
56 sugli aspetti istituzionali di queste magistrature, v. vAldiTArA 1989, che è peraltro intervenuto con pertinenza anche sui temi al centro di questo intervento: vAldiTArA 1986, pp. 395-434.
57 bernArdi 1952, pp. 3-58.58 Cornell 1995, pp. 233-236.59 oltre al saggio di piCCAlugA 1969, pp. 151-208, v. ora briQuel 2005, pp. 81-
82.60 Presentazione organica della successione dei templi di de wAele 1996, pp.
231-242: v. anche, da ultimo, smiTh 1999, pp. 453-475.
322 Mario torelli
nel tempio di Colle del Noce61, oltre ad essere indiziato anche in altre situazioni, come nel caso del santuario della Madonnella di la-vinio dalla presenza nell’area di più di una tomba62 (una delle quali sarebbe stata trasformata in heroon di enea), o nel caso del tempio di iuno Curitis a Falerii, dove si registrano tombe tra le più antiche del-la città63. tuttavia, mentre dobbiamo escludere una meccanica iden-tificazione della destinazione esclusivamente cultuale delle capanne sin dalla loro nascita, come dimostrano le tombe venute in luce in prossimità delle capanne, non siamo sempre in grado di delineare i tempi e i modi del progressivo distacco che attendono ancora di essere precisati in maniera chiara, le recentissime scoperte fatte da Fausto zevi e dalla sua équipe nello scavo del santuario Giunone sospita a lanuvio, presentate nel marzo 2010 all’annuale convegno su lazio e sabina, hanno aggiunto alla questione un importante capitolo. Queste esplorazioni hanno messo in luce, nel pronao del tempio tardo-arcaico (che ha sostituito un oikos di vii secolo a.C.), i resti sovrapposti di due capanne, una di viii secolo a.C. ed una dell’iniziale vii secolo a.C. accompagnate da due suggrundaria con sepolture infantili, risalenti rispettivamente al terzo quarto dell’viii secolo e al secondo quarto del vii secolo a.C.; la capanna di vii secolo a.C. mostra ad e, in asse con l’ingresso, un pozzo circolare costruito di presumibile uso sacrale. senza entrare nei dettagli dello scavo, di cui sono ancora inediti sia i materiali che le stratigrafie, sembra di poter concludere che l’uso dell’area come abitato è durata fino al momento del più tardo dei due suggrundia, nel secondo quarto del vii secolo a.C. e che la formaliz-zazione in senso cultuale del luogo va datata immediatamente dopo, con il risultato che la più tarda e più grande delle due capanne, con il relativo pozzo rituale (destinato ai serpenti sacri della dea ?), posto in asse con la porta, può con buoni argomenti essere ritenuta investita di carattere sacro. D’altro canto, con la loro articolazione architetto-nica e le loro decorazioni figurate, le grandi residenze principesche palesano il dichiarato intento dei proprietari di voler contenere al proprio interno quei sacra che essi considerano proprietà esclusiva o comunque tutti i cerimoniali collegati con l’apoteosi e con la continu-itas gentis: il caso già accennato dell’Ara Maxima Herculis prova che le gentes potevano gestire sacra che in nessun modo possiamo defini-re privati. la stessa Fortuna Redux alla Porta trionfale può essere considerata un divinità personale del rex e come tale se ne comprende
61 CresCenzi - TorToriCi 1983, pp. 89-93; v. ora di mArio 2007, pp. 21-24 (con bibl. prec.).
62 v. Torelli 1984, pp. 193-195.63 Comunicazione di F. zevi eT Alii nel convegno Lazio e Sabina 7 (Marzo
2010), c.s.
323la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
il fato con la fine dell’età monarchica, così come il frequente ricorso alla distruzione, che si fa agli inizi della repubblica, delle residenze di personaggi sospettati di adfectatio regni, da valerio Publicola a spurio Melio e a spurio Cassio, sostituiti quasi sempre da santuari e monumenti a destinazione religiosa. accanto a queste trasformazioni del costume e della mentalità religiosa che si palesano alla fine della dinastia dei tarquini possiamo mettere anche fatti meno appariscen-ti, ma non per questo meno significativi, che emergono dalla docu-mentazione archeologica. Il più significativo tra questi eventi è a mio avviso la fine della cerimonialità del temetum, del vino “nazionale” che ha preceduto la diffusione del vinum, la bevanda confezionata (e consumata) alla maniera greca, una fine giunta alla fine del VI secolo a.C. al termine di una silenziosa battaglia tra tradizione e in-novazione durata oltre due secoli: la conclusione di questo scontro tra culture è testimoniata dalla scomparsa dell’anfora e del bicchiere. che questa preistorica cerimonialità avevano incarnato, dalla fase dell’età del Ferro con l’anforetta schiacciata e la capeduncola con ansa bifora sopraelevata, all’epoca eorientalizzante con l’anforetta a spirale e il kyathos e fino all’epoca arcaica con le forme speciali “da esportazione” confezionate all’uopo al Ceramico di atene, l’anforetta nicostenica e il kyathos a figure nere. La scomparsa di queste forme dal repertorio sia locale che d’importazione e con essa la morte di un pezzo di tra-dizione che risaliva addirittura all’età del Bronzo non a caso avviene contemporaneamente alla transizione ai regimi repubblicani, quando le scelte ellenizzanti, maturate in maniera lenta nel secolo della c.d. monarchia etrusca. si fanno sempre più estese, devastando sempre più in profondità il costume indigeno: d’ora in poi, come nell’età stori-ca, il sacrum, il sacrificio si compirà thure et vino.
Concludendo perciò, nella vita religiosa della “Grande roma dei tarquini” rispetto al più nebuloso passato risultano meglio leggibi-li gli elementi di discontinuità, non meno di quelli di continuità. a fronte della grande continuità dell’impianto generale della religione preistorica per effetto del conservatorismo proprio delle categorie cul-tuali, risultano pienamente intellegibili come prodotto dell’evoluzione storico-sociale i fondamenti storici dei tre aspetti di novità elencati all’inizio, e cioè la monumentalizzazione dei santuari, l’ellenizzazione (parziale) del pantheon e del culto e l’introduzione del lusso nei ritua-li come prodotto dell’influenza etrusca64: nella fase immediatamente successiva dei primi tre decenni della repubblica si registra un’ac-centuazione dei primi due di questi tre fenomeni, come documenta
64 se ne veda l’evidente effetto sulle insegne del potere, registrato in maniera puntuale dalle fonti: Torelli 2006a, pp. 407-430.
324 Mario torelli
l’introduzione di grandi culti di origine greca come quelli dei Dioscuri, di Demetra e Core e di Hermes, questi ultimi due sotto le spoglie del-la triade aventina e di Mercurio, ma si assiste anche ad una decisa battuta di arresto sia del lusso etrusco che dell’invadenza di culti per-sonali nella sfera pubblica. Dopo il 470 a.C. verranno meno anche le grandi scelte monumentali e l’ufficializzazione di culti stranieri come effetto di una feroce stretta oligarchica, alla fine della quale all’inizio del iv secolo a.C. ritorneranno alla ribalta, sia pur in forma rinnova-ta, tutte le spinte che abbiamo visto in atto nella “Grande roma dei tarquini”. Ma questa è tutta un’altra storia.
325la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
reFereNze BiBlioGraFiCHe
AdornATo 2003 = G. AdornATo, L’area sacra di S. Omobono. Per un revi-sione della documentazione archeologica, in MEFRA 115, 2003, pp. 809-835.
Aloni 2006 = a. Aloni, La performance giambica nella Grecia arcaica, in Annali Online di Ferrara - Lettere, 1, 2006, pp. 83-107.
Ampolo 1970 = C. Ampolo, L’Artemide di Marsiglia e la Diana dell’Aven-tino, in ParPass 1970.
Ampolo 1987 = C. Ampolo, Roma arcaica tra Latini e Etruschi. Aspetti politici e istituzionali, in M. CrisToFAni (a cura di), Etruria e Lazio arcaico (atti dell’incontro di studio, roma 10-11 novembre 1986), roma.
Ampolo 2006 = C. Ampolo, Hestia, Vesta tra mondo greco e Roma, 1, in Teseo e Romolo. Le origini di Atene e Roma a confronto (atti del Convegno internazionale di studi, atene, 30 giugno - 1 luglio 2002), atene, 133.124.
Armellin - QuArAnTA 2004 = p. Armellin - p. QuArAnTA, Il tempio di Diana sull’Aventino, Nuove acquisizioni, in BCom 105, 2004, pp. 279-298.
bAbbi 2009 = a. bAbbi, Iconographic Traditions of the Hittite and Syrian “sich entschleiernde Göttin” and the Egyptian and Syrian-Palestinian “Qu-du-shu” in the Central Tyrrhenian Area from the 9th to the 7th Century B.C., in M. hArAri (a cura di), Icone del mondo antico (atti del seminario, Pavia 25 novembre 2005), roma.
bATTiloro 2009 = i. bATTiloro, Il saggio VII: l’edificio absidato di età arcaica, in M. osAnnA - b. serio, Progetti di archeologia in Basilicata. Banzi e Tito (siris, supplementi, 2), Bari, pp. 115-129.
bAudy 2001 = D. bAudy, “Der dumme Teil des Volks” (Ov. Fast. 2, 531). Zur Beziehung zwischen Quirinalia, Fornacalia und Stultorum feriae, in Mu-sHelv 58, 2001, pp. 32-39.
bernArdi 1952 = a. bernArdi, Dagli ausiliari del rex ai magistrati della res publica, in Athenaeum 30, 1952, pp. 3-58.
böhm 1990 = s. böhm, Die nackte Göttin, Mainz a.r.briQuel 2005 = D. briQuel, Considérations sur la légende de Attus Na-
vius, in ResAnt 2, 2005.broise - sCheid 1993 = h. broise - J. sCheid, Etude d’un cas. Le Lucus
Deae Diae à Rome, in Les Bois sacrés (actes du colloque international, Naples 23-25 novembre 1989), Napoli, pp. 145-157.
broughTon 1951 = t.r.s. broughTon, The Magistrates of the Roman Republic, ii, New York.
burneTT 1989 = a.M. burneTT, The Beginnings of Roman Coinage, in AnnIstNum 36, 1989, pp. 33-58.
CAprioli 2007 = F. CAprioli, Vesta aeterna. L’aedes Vestae e la sua deco-razione architettonica, roma.
CAssATellA 2005 = a. CAssATellA, Favisae Capitolinae, in a. ComellA - s. mele (a cura di), Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età arcaica a quella tardo-repubblicana (atti del Convegno, Perugia, 1-4 giugno 2000), Bari, pp. 77-83.
CAzzellA - bAroni eT Alii 2007 = A. CAzzellA - i. bAroni eT Alii, Testi-monianze della media età del Bronzo sul Campidoglio, in Strategie di inse-diamento fra Lazio e Campania in età preistorica e protostorica (atti della Xl Riunione scientifica, Roma, Napoli, Pompei, 30 novembre - 3 dicembre 2005. Dedicati ad amilcare Bietti), Firenze, pp. 803-812.
ChirAssi 1968 = i. ChirAssi, Dea Dia e Fratres Arvales, in StMatStorRel 39, 1968, pp. 191-291.
326 Mario torelli
CoArelli 1997 = F. CoArelli, Il Campo Marzio. Dalle orgini alla fine della repubblica, roma.
ColonnA 1987 = G. ColonnA, Etruria e Lazio arcaici, in M. CrisToFAni (a cura di), Etruria e Lazio arcaico (atti dell’incontro di studio, roma 10-11 novembre 1986), roma, pp. 55-66.
Cornell 1995 = t.J. Cornell, The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC), london, pp. 233-236.
CresCenzi - TorToriCi 1983 = l. CresCenzi - e. TorToriCi, Ardea. Imma-gini di una ricerca, roma.
CrisToFAni 1985 = M. CrisToFAni, Voltumna = Vortumnus, in AnnMuse-oFaina ii, 1985, pp. 75-88.
CrisToFAni - mArTelli 1983 = m. CrisToFAni - m. mArTelli (a cura di), L’oro degli Etruschi, Novara.
dAvies 2006 = P.J.e. dAvies, Exploring International Arena. The Tar-quins’ Aspirations for the Temple of Jupiter Optimus Maximus, in Common Grounds. Archaeology, Art, Science, and Humanities (Proceedeings of the 16th International Congress of Classical Archaeology, Boston, August 23-26, 2003), oxford.
de wAele 1996 = J.a.K.e. de wAele, The Lapis Satricanus and the Chronology of the Temples of Mater Matuta at Satricum, in Ostraka 5, 1996, pp. 231-242.
di mArio 2007 = F. di mArio, Ardea. La terra dei Rutuli tra mito e arche-ologia: alle radici della romanità, Nuovi dati dai recenti scavi archeologici, Nepi.
dubourdieu 1989 = a. dubourdieu, Les origines et le dévelopment du culte des Pénates à Rome, roma.
gAllAvoTTi 1984 = C. gAllAvoTTi, Ipponatte e gli scultori di Chio, in Lirica greca da Archiloco a Elitis (studi in onore di Filippo Maria Pontani), Padova, pp. 135-142.
gros - Torelli 2007 = P. gros - m. Torelli, Storia dell’urbanistica. Il mondo romano, roma-Bari 20073, 81-92.
hAnFmAnn 1936 = G. hAnFmAnn, Altetruskische Plastik, I. Die Menschli-che Gestalt in der Rundplastik bis zum Ausgang der orientalisierende Kunst, Würzburg.
hollowAy 1992 = r.r. hollowAy, The Romano-Campanian Coinage, in t. hACkens - m.d. hollowAy - r.r. hollowAy (edd.), The Age of Pyrrhus (Papers Delivered at The International Conference, Brown University, 8-10 april, 1988), louvain, pp. 225-235.
humm 1999 = M. humm, Le Comitium du Forum Romain et la réforme des tribus d’Appius Claudius Caecus, in MEFRA 111, 1999, pp. 625-694.
humm 2000 = M. humm, Spazio e tempo civici. Riforma delle tribù e rifor-ma del calendario alla fine del IV secolo a.C., in Chr. bruun (ed.), The Roman Middle Republic. Politics, Religion, and Historiography, c. 400-133 B.C. (Pa-pers from a Conference at the institutum romanum Finlandiae september 11-12, 1998), roma, pp. 91-119.
humm 2005 = M. humm, Appius Claudius Caecus. La république accom-plie, roma 2005.
La monetazione romano-campana 1998 = La monetazione romano-cam-pana (atti del X Convegno del centro internazionale di studi numismatici, Napoli 19-19 giugno 1993), Napoli.
327la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
lA roCCA 2008 = e. lA roCCA, La processione trionfale come spettacolo per il popolo romano. Trionfi antichi, spettacoli moderni, in e. lA roCCA - s. TorTorellA (a cura di), Trionfi romani (Catalogo della Mostra, roma 5 marzo - 14 settembre 2008), Milano, pp. 34-55, partic. 40-42.
mArinATos 2000 = N. mArinATos, The Goddess and the Warrior, london-New York.
mArTelli 1984 = m. mArTelli, Prima di Aristonothos, in Prospettiva 38, 1984.
mArTelli 1987 = M. mArTelli, La ceramica degli Etruschi, Novara.mArTelli 2008 = M. mArTelli, Il fasto delle metropoli dell’Etruria Meri-
dionale. Importazioni, imitazioni e arte suntuaria, in M. Torelli (a cura di), Etruschi. Le antiche metropoli del Lazio (Catalogo della Mostra, roma, 21 ottobre 2008 - 6 gennaio 2009), Milano, pp. 121-139.
mAssA pAirAulT 1992 = F.H. mAssA pAirAulT, Iconologia e politica nell’Italia antica: Roma, Lazio, Etruria dal VII al I secolo a.C., Milano.
mAyer 1954 = e. mAyer, Quirinalia. Stultorum festae, in AnnUnBud 2, 1954, 51-57.
mAzzei 2005 = P. mAzzei, Alla ricerca di Carmenta. Vaticini, scrittura e votivi, in BCom 106, 2005, pp. 61-81.
meniCheTTi 1994 = M. meniCheTTi, Archeologia del potere. Re, immagini e miti a Roma e in Etruria in età arcaica, Milano.
miCozzi 1994 = M. miCozzi, “White-on-Red”. Una produzione vascolare dell’orientalizzante etrusco, roma, pp. 110-112.
mosCATi 1988 = s. mosCATi (a cura di), I Fenici (Catalogo della Mostra, venezia 1988), Milano.
murA sommellA 1997-98 = a. murA sommellA, Le recenti scoperte sul Campidoglio e la fondazione del tempio di Giove Capitolino, in RendPontAcc lXXiX, 1997-98, pp. 57-79.
murA sommellA c.s. = a. murA sommellA, La dea col tutolo del tempio arcaico del Foro Boario, in Deliciae Fictiles iv (atti del Convegno internazio-nale, roma, 21-23 ottobre 2009), c.s.
pAlombi 1997 = D. pAlombi, Aedes Deum Penatium in Velia, in RM 104, 1997, pp. 435-463.
pAnellA - zeggio 2004 = C. pAnellA - s. zeggio, Tra Palatino e valle del Colosseo, in WorkACl 1, 2004, pp. 65-87.
pArisi presiCCe 1997 = C. pArisi presiCCe, Eracle e Dioniso nella deco-razione figurata del tempio arcaico di S. Omobono. Un’ipotesi eterodossa, in Deliciae Fictiles II (Proceedings of the second international Conference on Archaic Architectural Terracottas from Italy, Roma, 12-13 June 1996), Am-sterdam, pp. 167-177.
piATTelli 1987 = s. piATTelli, Circolazione delle monete romano-campa-ne di bronzo, in RItNum 89, 1987, pp. 15-29.
piCCAlugA 1961 = G. piCCAlugA, Penates e Lares, in StMatStorRel 32, 1961, pp. 81-97.
piCCAlugA 1969 = G. piCCAlugA, Attus Navius, in StMatStorRel 40, 1969, pp. 151-208.
Primi risultati delle indagini archeologiche in Campidoglio nell’area del Giardino Romano e del Palazzo Caffarelli 2001 = Primi risultati delle indagi-ni archeologiche in Campidoglio nell’area del Giardino Romano e del Palaz-zo Caffarelli (Giornata di studio presso l’istituto archeologico Germanico, 3 maggio 2001), in BCom 102, 2001, pp. 261-364.
328 Mario torelli
puTnAm 1967 = M.C.J. puTnAm, The Shrine of Vortumnus, in AJA 71, 1967, pp. 177-179.
rAdke 1981 = G. rAdke, Die Dei Penates und Vesta in Rom, in ANRW, 2, 17, 1, Berlin, pp. 343-373.
resCigno 2000 = r. resCigno, I Penates, tra Lares, Genius e Iuno, in Studi di storia e geostoria antica, Napoli 2000, pp. 13-37 (non vidi).
ronCAlli 1985 = F. ronCAlli, I santuari dei Duodecim Populi e i santua-ri orvietani, in AnnMuseoFaina ii, 1985, pp. 69-73.
sAgArrA Crespo 2003 = D. sAgArrA Crespo, Las coordenadoras espa-cio-temporales del dios Vertumnus, in Transcurrir y recorrer. La categoría espacio-temporal en las religiones del mundo clásico (atti del i seminario hi-spano-italiano de historia de las religiones, roma 16-17 de febrero del 2001), Madrid, pp. 129-163.
sCheid 1990 = J. sCheid, Romulus et ses frères. Le collège des frères Ar-vales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs, roma.
sCodellAri 2003 = e. sCodellAri, Le temple servien de l’Aventin. Essai de réinterpretation des données traditionelles, in Athenaeum 91, 2003, pp. 417-433.
sisAni 2001 = s. sisAni, Tuta Ikuvina. Sviluppo e ideologia della forma urbana a Gubbio, roma.
smiTh 1999 = C.J. smiTh, Reviewing Archaic Latium. Settlement, Bu-rials and Religion at Satricum, in JRA 12, 1999, pp. 453-475.
sTemper 1998-99 = J.W. sTemper, The Temple of Capitoline Jupiter in Rome. A New Reconstruction, in Hephaustos 16-17, 1998-99, pp. 107-113.
TesTA 1989 = a. TesTA, Candelabri e thymiateria (Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, Museo Gregoriano Etrusco, Cataloghi, 7), Roma.
Torelli 1984 = M. Torelli, Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia e storia, roma.
Torelli 1999 = M. Torelli, “Principi guerrieri” di Cecina: qualche osser-vazione di un visitatore curioso, in Ostraka 8, 1999, pp. 247-259.
Torelli 2000 = M. Torelli, Archeologia, religione e società romana ar-caica, in a. CArAndini - r. CAppelli (a cura di), Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città (Catalogo della Mostra, roma, 28 giugno - 29 ottobre 2000), Milano, pp. 63-67.
Torelli 2004 = M. Torelli, Atrium Minervae. Simbologia di un monu-mento e cerimonialità del congiarium, in ArchRel 6, 2004, pp. 63-109.
Torelli 2006a = M. Torelli, Insignia imperii. La genesi dei simboli del potere nel mondo etrusco e romano, in Ostraka 16, 2006, pp. 407-430.
Torelli 2006b = M. Torelli, Ara Maxima Herculis. Storia di un monu-mento, in MEFRA 118, 2006, pp. 573-620.
Torelli 2008 = M. Torelli, Quel funerale così simile al trionfo. Funus triumpho simillimum (Sen. Cons. Marc. 3,1), in e. lA roCCA - s. TorTorellA (a cura di), Trionfi romani (Catalogo della Mostra, roma 5 marzo - 14 settem-bre 2008), Milano, pp. 84-89.
Torelli 2009 = M. Torelli, Religione e rituali dal mondo latino a quello etrusco. Un capitolo della protostoria, in AnnMuseoFaina Xvi, 2009, pp. 119-154.
Torelli c.s. a = M. Torelli, La preistoria dei Lares, in M. bAssAni (a cura di), Culti domestici. Organizzazione e funzione (atti del colloquio, Pado-va, 8-9 giugno 2009), c.s.
329la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
Torelli c.s. b = M. Torelli, Fictilia tecta. Riflessioni storiche sull’arcai-smo etrusco e romano,, in Deliciae Fictiles iv (atti del Convegno internazio-nale, roma, 21-23 ottobre 2009), c.s.
Torelli - Fiorini 2008 = m. Torelli - l. Fiorini, Le indagini dell’Univer-sità di Perugia nella Vigna Marini-Vitalini, in Mediterranea v, 2008.
vAldiTArA 1986 = G. vAldiTArA, Aspetti religiosi del regno di Servio Tul-lio, in StDocHistIur 52, 1986, pp. 395-434.
vAldiTArA 1989 = G. vAldiTArA, Studi sul magister populi. Dagli ausi-liari del rex ai primi magistrati della repubblica, Milano.
vAn berChem 1967 = d. vAn berChem, Sanctuaires d’Hercule-Melqart. Contribution à l’étude de l’expansion phénicienne en Méditerranée, III. Rome, in Syria Xliv, 1967, pp. 307-338.
vAn berChem 1960 = d. vAn berChem, Hercule-Melqart à l’Ara Maxima, in RendPontAcc 1960, XXXii, pp. 61-68.
vendiTTelli 2005 = l. vendiTTelli, Il tempio di Diana sull’Aventino. Ipotesi di posizionamento e ricerca archeologica, in Italica Ars. Studi in onore di Giovanni Colonna per il premio “I Sanniti”, Piedimonte Matese, pp. 235-249.
zACCAgnino 1998 = C. zACCAgnino, Il thymiaterion nel mondo greco. Analisi delle fonti, tipologia, impieghi, roma.
zeggio 2005 = s. zeggio, Un santuario alle pendici nord-orientali e i suoi deositi votivi tra età arcaica e medio-repubblicana, in a. ComellA - s. mele (a cura di), Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età arcaica a quella tardo-repubblicana (atti del Convegno, Perugia, 1-4 giugno 2000), Bari, pp. 63-76.
330 Mario torelli
Fig. 1 - altare su podio mo-danato su una delle c.d. lastre Campana (Parigi, louvre).
Fig. 2 - Disegni tratti dall’oinochoe da taglia-tella, con teseo-Mamarce, arianna-Thesatei e nutrice-Velelia (a) e scena (b) di duplice am-plesso (roma, Museo dei Conservatori).
Fig. 3 - Pisside di impasto rosso sopradipinta (630-620 a.C.) con scena della nascita di athena da Caere (Parigi, louvre).
Fig. 4 - statuetta di impasto (X secolo a.C.) da una tomba laziale di s. loren-zo vecchio (dis. Müller Karpe).
331la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
Fig. 5 - Disegno di lastre (530-520 a.C.) con processioni nuziali di coppie della serie roma-veio-velletri (da torelli, Il rango, il rito e l’immagine).
Fig. 6 - statuetta di avorio dal Circolo degli avori di Marsiliana di albegna raf-figurante una dea nuda in atto di strizzarsi il seno e di portare al petto un vaso (Firenze, Museo archeolo-gico).Fig. 7 - Statuetta fittile di dea nuda (viii-vi secolo a.C.) da akziv (Parigi, lou-vre).
332 Mario torelli
Fig. 8 - Statuetta fittile di dea nuda (v secolo a.C.) da amrit (Bei-rut, American University, Archae-ological Museum).
Fig. 9 - statuetta in marmo di dea nuda (vii secolo a.C.) che ri-empie con il liquido dei suoi seni un bacino da Galera (Madrid, Museo archeologico Nazionale).
Fig. 10 - Lamina aurea (VII secolo a.C.) con raffigurazione di tre donne nude da Narce (roma, Museo di villa Giulia).
Fig. 11 - ornamento di cavallo in bronzo (iX secolo a.C.) dall’Heraion di samo con dedica in aramaico del re Haazel di Damasco e raffigurazione di dea nuda che ne sorregge altre due (samo, Museo).
333la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
Fig. 12 - sigilli siro-anatolici con il motivo della “dea che si svela” (ii-i mil-lennio a.C.) (da Babbi).
334 Mario torelli
Fig. 13 - Anse figurate di coppe bronzee villanoviane con il motivo della “dea che si.svela” (iX-viii secolo a.C.) (da Babbi).
Fig. 14 - oggetti di epo-ca orientalizzante con il motivo della “dea che si svela” (vii secolo a.C.) (da Babbi).
335la “GraNDe roMa Dei tarQUiNi”
Fig. 15 - lastra dal-la regia di Murlo con theon agorà (50-570 a.C.) (Murlo, Museo).
Fig. 16 - lastra con ingresso di eracle all’olimpo (530-20 a.C.) da velletri, chiesa delle stim-mate (Napoli, Museo Nazionale).
Fig. 17 - acroterio del tempio arcaico di s. omobono (540-30 a.C.) con Dioniso e arianna, ricostruzione di a. sommella Mura (roma, Museo dei Conservatori).
Fig. 18 - acroterio del tempio arcaico di s. omobono (540-30 a.C.) con l’ingresso di eracle all’olimpo (roma, Museo dei Con-servatori)