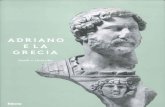Sul ruolo del giudizio estetico nel pensiero scientifico - Tesi di Laurea Triennale (2012)
Tesi Triennale in Archeologia Classica: "La Colmata Persiana dell'Acropoli di Atene: evidenze...
Transcript of Tesi Triennale in Archeologia Classica: "La Colmata Persiana dell'Acropoli di Atene: evidenze...
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Sede di Brescia
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Corso di Laurea in Lettere
Tesi di Laurea
ARCHEOLOGIA CLASSICA
La “Colmata Persiana” dell’Acropoli di Atene: evidenze archeologiche e
problematiche alla luce di recenti studi.
Relatore:
Ch. ma Prof.ssa Chiara Tarditi
Secondo lettore:
Ch. mo Prof. Marco Sannazaro
Candidato:
Andrea Merlini
Matricola N. 3907051
Anno Accademico 2012/2013
A mia sorella Laura
che mi è sempre stata da
esempio e mi ha preparato
la strada.
Alla mia famiglia che mi ha
sempre sostenuto.
“Fare i conti con il passato ci porterà via tutto il futuro.
Finalmente questa vita ha un senso.”
(Altan)
Ringraziamenti
Un grazie particolare alla Prof.ssa Chiara Tarditi per la sua attenta guida e il costante
appoggio.
Ringrazio inoltre il Prof. Marco Sannazaro per la disponibilità concessami.
Infine vorrei ringraziare Elisabetta Rubini per l’instancabile supporto morale, l’Ing. Rinaldo
Gorlani per i validi consigli e la Prof.ssa Cristiana Plebani per l’assistenza nelle traduzioni.
1
Indice
Introduzione 2
Capitolo 1. Storia delle ricerche
1.1 Gli scavi sull’Acropoli nel XIX e XX secolo 3
1.2 Cronistoria degli studi sull’Acropoli 13
Capitolo 2. La situazione precedente alle guerre persiane in Grecia e sull’Acropoli di
Atene
2.1 I Greci per la libertà 15
2.2 L’Acropoli pre 480 a.C. 16
Capitolo 3. L’Acropoli nel VI sec. a.C.
3.1 Gli elementi H e le decorazioni frontonali dell’Hecatompedon 18
3.2 Le fondazioni Dörpfeld e la difficile ubicazione del tempio H: secondo tempio di
Athena Poliàs o Urparthenon? 22
Capitolo 4. Perserschutt, Tyrannenschutt e Zerstörungsschutt
4.1 Definizione, localizzazione ed eventuali affinità compositive 31
Conclusioni 38
Ulteriori illustrazioni 41
Bibliografia 43
Elenco delle abbreviazioni 46
Lista delle illustrazioni 47
Siti internet consultati 48
2
Introduzione
Ho deciso di affrontare quest’argomento perché fortemente attratto dall’archeologia classica e
dalla cultura greca antica e in questo caso specifico dal vivo sentimento religioso che ha
spinto gli Ateniesi a conservare i resti degli edifici di culto distrutti dalla barbarie persiana.
La mia tesi di laurea, prettamente bibliografica, mi ha portato ad analizzare una questione in
prevalenza trattata da autori stranieri: tedeschi, inglesi e francesi su tutti e spero possa chiarire
ulteriormente gli eventi che hanno portato alla creazione della cosiddetta “Colmata Persiana”
sull’Acropoli di Atene, episodio e luogo tutt’altro che marginali nella storia del mondo greco,
ma proprio perché ritenuti basilari spesso trattati con eccessiva superficialità.
La mia intenzione è quella di analizzare le diverse teorie e ipotesi elaborate dagli archeologi e
studiosi nel corso degli anni partendo dalla metà dell’ottocento sino ai giorni nostri con una
particolare attenzione agli studi più recenti, poiché sconfessano, almeno in parte, le iniziali
teorie, spesso pregiudicate da campagne di scavo poco scientifiche e da un ampio ricorso a
fonti scritte non sempre attendibili, sottolineando ancora una volta la complessità del
problema che presenta ancora oggi luci e ombre e dove la parola “fine” non sembra ancora
pronunciabile.
Infine ho ritenuto opportuno integrare all’elaborato mappe e piante dell’Acropoli, delle
principali zone di scavo e di edifici o frammenti di essi recuperati negli anni sul pianoro,
evidenziando dove conosciuta, l’esatta posizione di rinvenimento.
3
Cap. 1. Storia delle ricerche
1.1 Gli scavi sull’Acropoli nel XIX e XX secolo
Come indicato nell’opera di F. Santi “I frontoni arcaici dell’Acropoli di Atene” del 20101, le
vicende che portarono al rinvenimento delle sculture frontonali e delle membrature
architettoniche pertinenti agli edifici sacri dell’Acropoli arcaica sono strettamente connesse
alla situazione storica creatasi all’indomani della proclamazione d’indipendenza greca
dall’impero ottomano nel 1833.
Sgomberata l’Acropoli dai Turchi, apparve subito necessario dar avvio ad una politica
d’intervento e di recupero dell’antico dopo che secoli di occupazione bizantina, franca,
fiorentina, veneziana e turca avevano profondamente modificato l’aspetto originario della
rocca.
Già nel maggio del 1833 l’archeologo greco K. Pittakis effettuò un primo scavo lungo il lato
settentrionale del Partenone, rinvenendo tre lastre del fregio partenonico.
Ma fu solo con l’architetto tedesco Leo von Klenze che si affermò un’idea di un recupero
globale dell’Acropoli come sito archeologico attraverso il restauro dei monumenti superstiti,
lo smantellamento delle superfetazioni delle epoche successive e la demilitarizzazione che
contemplava anche l’allontanamento dei soldati della guarnigione bavarese; il tutto sotto la
direzione di un Oberkonservator che fu il giovane archeologo tedesco L. Ross.
Questi intraprese due scavi, l’uno nell’area dei Propilei con il recupero delle membrature
architettoniche del tempietto di Athena Nike integrate in un muro di fortificazione turco,
l’altro intorno al Partenone; in quest’ occasione furono asportati i livelli più superficiali della
terrazza meridionale, mentre un sondaggio in profondità nella porzione sud-occidentale ne
rivelava la sua composizione per riempimenti.
La crisi dei rapporti tra Ross e le autorità elleniche portò alla sua destituzione nel 1836 e alla
nomina di Pittakis come nuovo sovrintendente. Questi, già a fianco di Ross durante i due
precedenti anni, proseguì l’opera dell’archeologo tedesco.
1 F. Santi 2010, p. 21.
4
Pittakis, sotto l’egida della Società Archeologica Greca, lavorò fino al 1860 sull’Acropoli con
interventi di restauro, anastilosi, smantellamento e scavo, condotti nella parte centrale della
spianata fino al raggiungimento dello strato geologico roccioso2.
Le operazioni di demolizione riguardarono l’area dei Propilei con l’abbattimento delle
fortificazioni franco-turche e quella compresa tra i Propilei, il Partenone e l’Eretteo, dove
furono successivamente condotti gli scavi di Pittakis; negli anni 1841-1842 venne distrutta
anche la piccola moschea insediatasi nel Partenone e successivamente l’abside della chiesa
bizantina ivi conservata.3
Vista la grande quantità di rinvenimenti, per lo più oggetti marmorei, accumulatisi durante le
operazioni di scavo, nel 1863 il governo greco decise la costruzione di un museo
sull’Acropoli stessa.
Gli scavi per la realizzazione delle fondazioni della nuova struttura, destinata a sorgere nella
porzione sud-orientale della spianata, là dove le fonti non menzionavano alcun edificio antico,
portarono al rinvenimento di alcuni pezzi particolarmente pregevoli tra i quali non si possono
non citare: il Moskophoros, l’Athena di Angelitos, il corpo dell’efebo di Kritios e la testa
della statua di Athena del frontone della Gigantomachia allora non ancora noto.
Dopo un’interruzione dei lavori a causa dei rinvenimenti e un tentativo di realizzare il museo
nell’area a nord-est dei Propilei, rivelatasi ancor più ricca di reperti, si decise di erigere la
struttura museale nella zona precedentemente scelta spostandola però leggermente più ad
ovest in modo da non farla sovrapporre ai resti del cosiddetto ergasterion, oggi identificato
con il santuario di Pandione4.
2 B. Holtzmann 2003, pp. 259-263. 3 J.M. Hurwit 1999, p. 299. L’ultima struttura medievale a scomparire fu la torre franca presso il lato
meridionale dei Propilei. 4 F. Santi 2010, p. 23.
5
Fig. 1. Fonte: J.M. Hurwit 1999.
Negli anni settanta del XIX secolo non mancarono interventi di scavo di minore portata5, ma
solo nel 1882 la Società Archeologica Greca decise di intraprendere un’indagine sistematica
di tutta l’Acropoli sotto la direzione dell’eforo Evstrastiadis.
Questi iniziò col ripulire l’area a sud del Partenone e a est del Museo dalle strutture post-
antiche ancora superstiti.
Nell’inverno del 1882-1883 lo scavo in questa zona portò al rinvenimento di alcune koraϊ, di
due sfingi, del cosiddetto frontone dell’hydra e del frammento principale del “frontone
rosso”6, la cui caratteristica denominazione deriva dal colore che ricopre integralmente il
frammento principale del piccolo frontone che raffigura la lotta tra Eracle e Nereo/Tritone7.
Sempre nel 1882 furono anche rinvenuti, nell’area antistante alla fronte orientale del tempio,
alcuni dei più significativi frammenti delle statue frontonali della Gigantomachia8.
5 F. Santi 2010, p. 23. 6 R. Heberdey 1919, p. 4. 7 R. Heberdey 1919, p. 13.
8 H. Schrader 1939, p. 345. Si tratta nello specifico: della spalla sinistra di Athena, di frammenti dell’egida e
della mano sinistra, di frammenti del gigante caduto e dei due giganti angolari.
In rosso è evidenziato il luogo di rinvenimento dei quattro reperti sopracitati in seguito ai lavori di creazione del Museo sull’Acropoli nella zona sud-orientale nel 1863.
NORD
In azzurro il santuario di Pandione.
6
Fig. 2. Fonte: J.M. Hurwit 1999.
Nel 1884 l’insoddisfazione della Società Archeologica per il lavoro di Evstrastiadis portò alle
dimissioni dell’eforo, cui subentrò nella prosecuzione e nella gestione dello scavo il greco P.
Kavvadias affiancato dall’architetto dell’Istituto Archeologico Germanico di Atene W.
Dörpfeld e dal suo allievo G. Kawerau9.
È di questo periodo il rinvenimento, nell’area compresa tra l’Eretteo e il Partenone, là dove
veniva riconosciuta una piattaforma identificata con il recinto sacro di Athena, delle
fondazioni del tempio di Athena Poliàs, che presero il nome dal loro scopritore e primo
editore, Dörpfeld appunto.
Al famoso archeologo tedesco va inoltre attribuita la creazione del termine Perserschutt10
,
vocabolo corrispondente all’italiano “Colmata Persiana”, utilizzato per la prima volta nel
1887.
Immediatamente adottato dai colleghi tedeschi, americani e inglesi, il termine identifica i
resti, di qualsiasi natura essi siano, che gli Ateniesi trovarono sull’Acropoli al loro ritorno
dopo le violenti distruzioni perpetuate dai Persiani nel settembre del 480 e nell’estate del 479
a.C.
9 B. Holtzmann 2003, p. 263.
10 W. Dörpfeld 1887, p. 60.
In rosso è indicata la zona di recupero di alcune koraϊ, di due sfingi, del cosiddetto frontone dell’hydra e del frammento principale del “frontone rosso” nel 1882-1883. In azzurro è invece segnalata l’area di rinvenimento di alcuni tra i più significativi frammenti delle statue frontonali della Gigantomachia sempre nel 1882.
NORD
7
Il vocabolo è dunque riferibile agli scavi del periodo 1882-189011
, tra i più importanti
sull’Acropoli, poiché ci hanno permesso di rinvenire molteplici materiali provenienti da due
scarichi principali: il primo a nord-ovest dell’Eretteo, mentre il secondo nella zona a sud e a
sud-ovest del Partenone.
Inizialmente ascritti entrambi al fenomeno della “Colmata Persiana”, è qui doveroso precisare
che, secondo gli studi più recenti12
, solo i reperti rinvenuti nel grande scarico a sud del
Partenone appartengono al deposito successivo al sacco persiano; gli altri scarichi, a ridosso
del muro nord dell’Acropoli, testimoniano un processo di seppellimento protrattosi negli anni
in seguito ai lavori di riordino della cittadella nel corso della prima metà del V secolo a.C.
Fig. 3. Fonte: F. Santi 2010.
I numerosi frammenti d’architettura, scultura e ceramica ritrovati nel corso degli scavi nei
terrapieni sul pianoro dell’Acropoli riportarono spesso segni del vandalismo persiano, come
mutilazioni o bruciature e sono stati utilizzati scompostamente come materiale di
riempimento dagli Ateniesi per i lavori di restauro della rocca.
11
B. Holtzmann 2003, p. 47. 12 A. Lindenlauf 1997, pp. 49, 54-55, 70.
In azzurro lo scavo addossato al muro nord dell’Acropoli che, secondo studi recenti, non è più attribuibile alla “Colmata Persiana”.
In rosso è evidenziato lo scavo a sud del Partenone che secondo gli ultimi studi è l’unico riconducibile alla Perserschutt.
NORD
8
La “Colmata Persiana” può essere definita quindi come un deposito sigillato che riceve un
prezioso termine ante quem dagli avvenimenti che portarono alla sua formazione: le statue e i
frammenti architettonici ivi contenuti sono tutti anteriori al 480-479 a.C.
Essi testimoniano dunque la qualità delle offerte del grande santuario poliade nell’ultima fase
dell’età arcaica.
Al di là dell’aspetto funzionale del riempimento, necessario al ripristino del santuario, vorrei
portare all’attenzione un evento alquanto singolare: mentre in questa prima fase le indagini si
concentrarono per lo più nell’area attorno all’Eretteo, nel 1866 si iniziò ad indagare l’area ad
est del cosiddetto Arrephorion.
Qui si rinvennero per la prima volta stratificazioni non intaccate da interventi post-classici,
ma, più di ogni altra cosa, il 5 e 6 febbraio 1886 si scoprì un gruppo di quattordici sculture, tra
cui nove koraϊ13
accuratamente deposte nel terreno, ritrovate fianco a fianco in una fossa
addossata al muro nord dell’Acropoli14
.
Episodio particolare vista la scrupolosa attenzione riservata alle statue, che forse può essere
spiegato dal significato rituale del loro seppellimento, rimarcando la loro grande valenza
religiosa per gli Ateniesi dell’epoca; un’altra soluzione interessante è invece quella proposta
da J.M. Hurwit15
che ipotizza la sepoltura della statue, dieci anni o più dopo il sacco persiano,
quando venne creato un nuovo muro a nord della cittadella, immaginando quindi una
contemporanea compresenza di materiali pre e post persiani sull’Acropoli che vennero
mescolati nei successivi terrapieni necessari alla
riorganizzazione.
Lo scavo dell’area permise inoltre di esaminare per
la prima volta la cortina interna del muro
settentrionale dell’Acropoli, nel quale, oltre ad
alcuni rocchi di colonna, due capitelli e una porzione
13
F. Santi 2010, pp. 24-25; J.M. Hurwit 1999, p.141. Tra le quattordici statue rinvenute spiccano: la Nike di Callimaco e la parte superiore della kore di Antenore. 14 B. Holtzmann 2003, p. 47. Sfortunatamente il luogo del rinvenimento non ha fornito alcuna indicazione circa il loro luogo d’esposizione, come suggerito da K. Karakasi 2001, pp. 130-132, fig. 19. 15
J.M. Hurwit 1999, p.141. Hurwit suppone che ci volle molto tempo per seppellire tutti i resti attribuibili alla “Colmata Persiana”, forse decenni, e che alcuni frammenti, come il Moschophoros e la testa di Athena della Gigantomachia, vennero forse seppelliti con materiale classico.
Fig. 4. Fonte: E. Lippolis, M. Livadiotti, G. Rocco 2007.
9
di trabeazione del tempio pisistratide di Athena Poliàs, erano stati reimpiegati anche agalmata
marmorei e bronzei, ennesimo simbolo di una ristrutturazione della rocca post invasione
persiana che volle mantenere visibili le distruzioni inflitte dai barbari16
.
L’area ad est dell’Eretteo rivelò invece resti di muri di epoca micenea che vennero
immediatamente ricondotti dagli scavatori ad una presunta struttura di tipo palaziale17
, ma
sebbene questa sia l’idea predominante ancora oggi, non tutti gli studiosi accettano il concetto
di un megaron miceneo sulla rocca, riconoscendo nei resti semplici terrazzamenti.18
Nella medesima zona, alle spalle del muro settentrionale, ma anche in prossimità di quello
orientale, furono invece rinvenuti non meglio specificati frammenti scultorei pertinenti al
frontone della Gigantomachia dell’Archaios Neos19
.
Fig. 5. Fonte: F. Santi 2010.
Dopo aver indagato dunque anche la porzione nord-orientale e orientale dell’Acropoli, nel
1888 s’iniziò lo scavo dell’ampia terrazza a sud del Partenone.
I rinvenimenti furono innumerevoli e di altissima qualità: un’enorme quantità di materiale
arcaico e tardo arcaico, danneggiato dall’invasione persiana del 480 a.C., riemerse dal
16 E. Lippolis, M. Livadiotti, G. Rocco 2007, pp. 366-367; J.M. Hurwit 1999, p. 142. 17
F. Santi 2010, p. 25; E. Lippolis, M. Livadiotti, G. Rocco 2007, p.184. 18
J.M. Hurwit 1999, pp. 67-69. 19 H. Schrader 1939, p. 345.
In rosso la zona di rinvenimento delle “fondazioni Dörpfeld” nel 1885, tra l’Eretteo ed il Partenone.
In azzurro l’area ad est dell’Arrephorion dove vennero rinvenute le nove korai in marmo nel 1886.
In verde la zona in cui emersero non meglio specificati frammenti scultorei della Gigantomachia sempre nel 1886.
NORD
10
terrapieno retrostante il muro meridionale dell’Acropoli, il cosiddetto “muro cimoniano”: resti
di diversi edifici con dipinti e decorazioni in poros, offerte in marmo e bronzo che
sconvolsero le conoscenze appena delineate della scultura arcaica e una grande quantità di
ceramica del periodo geometrico.
Furono rintracciati inoltre una serie di setti murari (detti S2, S3, S4) di difficile
identificazione20
, nonché due tronconi del muro di fortificazione miceneo, il cosiddetto
“pelargico”.
L’asporto del grande riempimento, che rivelò la storia dell’Acropoli anteriore al 480 a.C.,
avvenne però con eccessiva rapidità: nell’agosto del 1888, durante ventisei giorni di sterro,
furono rimossi più di mille metri cubi di terra senza che fosse registrato alcun rinvenimento o
fatta alcuna osservazione21
.
Lo scavo inoltre non fu corredato da una documentazione scientifica adeguata e soprattutto
non previde un’associazione tra il materiale ceramico e quello scultoreo, correlazione che
avrebbe potuto permettere di stabilire una cronologia delle diverse fasi di seppellimento dei
pezzi, consentendo di comprendere l’arco temporale di formazione dell’accumulo.
Le informazioni principali di cui disponiamo oggi ci provengono dai disegni e dalle
fotografie, soprattutto di Kawerau, conservati all’Istituto d’Archeologia Tedesco ad Atene e
dalle pubblicazioni preliminari di Dörpfeld presenti sui relativi AM intitolate “Der Alte
Athena-Tempel auf der Akropolis zu Athen” delle annate: 1885, 1886, 1887, 1890 e 1897, ma
è fuori discussione che le lacune furono molte.
Lo scavo fortunatamente permise almeno di mettere interamente in vista lo zoccolo di
fondazione dell’edificio prepartenonico.
20
F. Santi 2010, p. 30. W. Dörpfeld, R. Heberdey e per ultima A. Lindenlauf ritengono che i vari setti murari si resero necessari per l’attività cantieristica del Prepartenone e Partenone. 21 B. Holtzmann 2003, p. 263.
Fig. 6. Fonte: F. Santi 2010.
11
La stratigrafia del riempimento fu distinta, a posteriori, in tre livelli. Il superiore restituì per lo
più frammenti scultorei in marmo tra i quali devono annoverarsi anche altri elementi del
frontone della Gigantomachia22
; l’intermedio, il cosiddetto Porosschicht23
, composto
integralmente da terra e spezzoni di calcare, diede quasi tutti i resti scultorei ed architettonici
pertinenti ai frontoni ed agli edifici in poros; l’ultimo, a diretto contatto con la roccia,
costituito essenzialmente da terra, si caratterizzò per la scarsissima presenza di rinvenimenti24
.
Fig. 7. Fonte: J.M. Hurwit 1999.
Nel 1889 s’indagò l’area dei Propilei e lo scavo della Pinacoteca, l’ambiente principale
nell’ala settentrionale dei Propilei stessi, rivelò che i muri di fondazione dei lati sud ed est e
del prolungamento di questo ultimo verso nord riutilizzavano alcuni elementi dei geisa
orizzontali dell’edificio C, ma soprattutto gli ortostati e gli elementi della trabeazione
dell’edificio B.
Per quanto riguarda gli elementi marmorei pertinenti ai medesimi edifici, Hecatompedon ed
oikoi, R. Heberdey sottolineava che, ad eccezione di alcuni pezzi reimpiegati o riutilizzati con
altra funzione, la maggior parte si trovava in riempimenti differenti dal Porosschicht, in vari
punti dell’Acropoli.25
22 H. Schrader 1939, p. 345. 23
F. Santi 2010, pp. 30-31. 24
B. Holtzmann 2003, p. 263. 25 F. Santi 2010, p. 29.
In rosso l’ampia terrazza a sud del Partenone da cui emerse un’enorme quantità di materiale arcaico e tardo-arcaico danneggiato dall’invasione persiana del 480 a.C. nel 1888.
NORD
12
Alla fine del XIX secolo la spianata dell’Acropoli poteva dirsi integralmente scavata e le
indagini dunque proseguirono lungo le pendici settentrionali.
Negli anni compresi tra il 1896 e il 1900 Kavvadias e Kawerau si rivolsero in particolare
all’area tra l’Areopago e l’Acropoli per poi passare all’intero versante settentrionale di
quest’ultima26
.
Le pendici meridionali, dal teatro di Dioniso alla stoà di Eumene, erano state già indagate
dalla Società Archeologica in anni differenti compresi tra il 1841 e il 187827
.
Negli ultimi anni del XIX secolo fino al 1939, l’ingegnere greco N. Balanos fu incaricato dei
lavori di restauro degli edifici dell’Acropoli ed è nell’ambito di questi interventi che egli poté
intraprendere uno scavo nel bastione di Athena Nike smontato interamente nel 1935 e
ricomposto tra il 1938 e il 1940. Lo scavo del pyrgos nel 1936 rivelò le precedenti fasi di vita
del bastione, tra cui quella micenea28
.
Negli anni compresi tra il 1931 e il 1934 quattro campagne di scavo condotte dall’archeologo
americano O. Broneer sul versante settentrionale dell’Acropoli, in particolare nella porzione
più occidentale, portarono al raggiungimento del piano roccioso e al reperimento di una gran
quantità di materiale dall’epoca micenea a quella classica29
.
Nel 1937-1938 le indagini di Broneer si spostarono invece nella porzione più orientale delle
pendici, dove lo svuotamento di cinque pozzi, sigillati nel V sec. a.C., permise il rinvenimento
di frammenti ceramici e scultorei tra i quali una testa arcaica in poros, attribuita da Broneer
alla statua di Eracle in lotta con Nereo/Tritone nel gruppo angolare sinistro del frontone del
Barbablù, ultimo pezzo rintracciato delle sculture calcaree dei frontoni dell’Acropoli30
.
Nel corso del XX secolo i monumenti dell’Acropoli sono stati per lo più al centro di progetti
di conservazione e restauro31
; pochi sono stati invece i veri interventi di scavo.
Tra i più recenti si segnalano le indagini e i sondaggi di M. Korres nello stereobate del
Partenone32
e gli scavi di T. Tanoulas nell’area nord-occidentale dell’Acropoli che hanno
permesso di individuare altri elementi compositivi dell’edificio B33
.
26
P. Kavvadias, G. Kawerau 1906, coll. 45-50. 27
W. Dörpfeld 1896, pp. 1-2. 28 B. Holtzmann 2003, p. 267. 29 F. Santi 2010, p. 29. 30 F. Santi 2010, p. 29. 31
B. Holtzmann 2003, pp. 264-273. Sintesi dei lavori di restauro e conservazione dei monumenti sull’Acropoli. 32
M. Korres 1997a. 33 F. Santi 2010, p. 29.
13
Riassumendo possiamo affermare che lo scavo di Kavvadias (1884-1889) analizzando i
terrapieni creati intenzionalmente dagli Ateniesi nel V sec. a.C. ci ha restituito un buon
numero di blocchi architettonici e statue votive, in parte mutilate, che costituiscono un
insieme incomparabile di scultura arcaica.
Grazie al sacco persiano possediamo perciò maggiori informazioni sulle offerte arcaiche che
su quelle dei secoli successivi, le quali sono quasi del tutto scomparse senza lasciare tracce
nelle epoche seguenti.
L’importanza della Colmata è per di più testimoniata da un ulteriore dato, interessante
soprattutto per la storia dell’arte: per la maggior parte degli archeologi34
, anche se con qualche
eccezione35
, essa ha costituito una fonte preziosa non solo per il recupero di materiale
scultoreo, ma per meglio definire il sottile confine tra il periodo arcaico ed il primo stile del
periodo classico, lo “stile severo”.
1.2 Cronistoria degli studi sull’Acropoli
La storia degli studi riguardanti la “Colmata Persiana” non può che iniziare con il famoso
archeologo W. Dörpfeld che nell’AM del 1887 utilizzò per la prima volta il temine
Perserschutt.
Fondamentali i suoi scavi e le relative pubblicazioni riguardanti le campagne nella zona sud
del Partenone che ci hanno permesso di riscoprire moltissimi materiali di epoca arcaica, poi
associati, forse troppo frettolosamente, alla “Colmata Persiana”.
Il punto di partenza per ogni ricerca sulla colmata non possono che essere i suoi articoli
pubblicati sui vari AM nelle annate tra la fine dell’ottocento e l’inizio del XX secolo: 1885,
1886, 18871, 18872, 1890, 1897 e 1902.
Fondamentale il cambio di opinione presente nell’ultima annata sopracitata, nella quale
l’archeologo affermò l’anteriorità del Prepartenone alla distruzione persiana dell’Acropoli,
mentre solo dieci anni prima ne affermava invece la posteriorità.
34 A. Lindenlauf 1997, pp. 93-94. 35
B. Holtzmann 2003, p. 47. Holtzmann mette in discussione l’aiuto derivante dalla “Colmata Persiana” nel meglio definire il passaggio dall’arcaismo allo “stile severo”. Principalmente per via delle numerose lacune e della poca attendibilità degli scavi di fine ottocento.
14
Nel suo lavoro Dörpfeld venne accompagnato dal suo allievo G. Kawerau, i cui disegni
pubblicati nell’opera del 1906, hanno sopperito, anche se non totalmente, alla frammentaria e
lacunosa documentazione degli scavi di fine XIX secolo.
Una successiva testimonianza di rilievo la ritroviamo nel 1947 quando W.B. Dinsmoor ,per
primo, ipotizzò la fondazione dell’Hecatompedon sul futuro sito occupato dal Partenone,
escludendo quindi una sostituzione del tempio geometrico di Athena con il tempio H;
avvicendamento che avverrà invece con la costruzione del tempio di Athena ad opera dei
Pisistratidi nel VI sec. a.C.
Nel 1974 J.A. Bundgaard in un importante lavoro, oltre ad affermare la presenza di un sicuro
edificio palaziale sulla sommità dell’Acropoli micenea, esistenza tutt’altro che sicura, riporta i
ventisei giorni di sterro nel 1888 durante i quali non venne registrato alcun dato relativo agli
scavi; causando cosi le gravi lacune di cui si sono sempre lamentati gli studiosi negli anni.
Impossibile tralasciare il lavoro svolto a partire dagli anni ’90 da M. Korres, responsabile del
progetto di restauro dell'Acropoli di Atene: in particolare, in un suo contributo del 1997, oltre
a riprendere la questione della “Colmata Persiana” in senso stretto, ha rivalutato
definitivamente l’ipotesi Dinsmoor, che ancora oggi è quella approvata.
Anche l’archeologa A. Lindenlauf, sempre nel 1997, ha proposto un’opera interamente
dedicata alla colmata, arrivando ad affermare la presenza di una Auch-Perserschutt sul
pianoro, sebbene la localizzazione e la composizione siano incerte.
Recentemente anche J.M. Hurwit ha pubblicato uno studio in cui hanno trovato molto spazio
tutte le difficoltà relative alla colmata, riassumendo le varie teorie proposte fino ad allora.
Il frutto del lavoro di M.C. Monaco del 2004 ha riportato alla ribalta la grande difficoltà nella
definizione della “Colmata Persiana”, dimostrando come, dalla fine dell’800 ai giorni nostri,
siano poche le pubblicazioni che si sono realmente interessate alla colmata e non a
problematiche o questioni collaterali (come la datazione del Partenone), tema molto caro ai
primi archeologi che con la loro importanza hanno finito per influenzare un intero secolo, il
XX, di studi.
L’ultima opera di grande rilievo è quella di F. Santi del 2010 nella quale, anche se non tratta
direttamente il fenomeno della colmata, propone un’esauriente panoramica sul rinvenimento
dei pezzi sul pianoro durante i vari scavi, oltre a descrivere dettagliatamente il cosiddetto
15
Porosschicht, che G. Dickins ha poi ribattezzato Tyrannenschutt, alimentando l’ipotesi della
presenza di più colmate sull’Acropoli.
Capitolo 2. La situazione precedente alle guerre persiane in Grecia e sull’Acropoli di
Atene
2.1 I Greci per la libertà
La prima rivolta delle città ioniche contro i Persiani avvenne nel 499 a.C., nata
dall’insofferenza per l’esazione di un tributo da versare alle casse persiane o più
probabilmente per un desiderio di libertà.
La prima città ad insorgere fu Mileto, che chiedendo aiuto alla Grecia, ottenne risposta dalla
sola Atene (legata dalla comune origine ionica) e da Eretria.
Assunte sempre più proporzioni maggiori per il ribellarsi di tutte le città greche della costa,
insieme ai Cari ed ai Lici, la rivolta si consumò nello scontro navale di Lade del 494 a.C.,
vinto dai Persiani.
Le successive guerre persiane costituirono la logica conseguenza dello scontro tra i Persiani
ed i Greci della Ionia, sempre spalleggiati dai loro ardimentosi sostenitori Ateniesi.
La prima guerra persiana venne probabilmente progettata da re Dario come spedizione
punitiva contro Atene, ma nello scontro nella piana di Maratona (490 a.C.), dove sbarcò un
esercito persiano forte di circa 20.000 uomini, ebbero la meglio contro ogni previsione gli
opliti ateniesi.
Negli anni immediatamente successivi, mentre Serse, succeduto a Dario sul trono di Persia
nel 485 a.C., preparò una grossa controffensiva, questa volta diretta contro tutti i Greci, gli
Ateniesi guidati da Temistocle, incrementarono la flotta militare.
La seconda guerra persiana (480-479 a.C.), con gli epici scontri delle Termopili, dove si
consumò il sacrificio dei trecento Spartani di Leonida, di Salamina e di Platea, furono la
dimostrazione di una forte solidarietà nazionale che tuttavia si riscontrò solo nelle regioni
meridionali, sull’asse Atene-Sparta, dove la forma cittadina aveva conosciuto nei secoli un
maggiore sviluppo.
16
Il sacrificio degli Ateniesi che obbedendo ad un decreto lasciarono la loro città e si
rifugiarono sulle isole del Golfo Saronico, abbandonando così Atene al violento sacco
persiano, sarà poi ampiamente ripagato da una politica propagandistica che eleggerà Atene al
ruolo di salvatrice della Grecia e della sua libertà; così è detto esplicitamente da Erodoto (VII,
139): “chi dicesse che gli Ateniesi furono i salvatori dell’Ellade non si allontanerebbe dal
vero”.
Al termine delle scontro infatti Sparta, pur forte di un grande prestigio presso i Greci, rientrò
in una dimensione politica quasi regionale mentre Atene si avviò a consolidare la sua
posizione di prestigio internazionale, maturando una coscienza politica del proprio ruolo che
non si esaurì nella lotta contro il barbaro persiano, ma si espresse anche nella costruzione di
un nuovo modello politico, quello democratico.
2.2 L’Acropoli pre 480 a.C.
Nella millenaria storia dell’Acropoli le prime testimonianze della sua occupazione risalgono
all’età micenea: attorno al 1250 a.C. la costruzione di una cinta muraria in opera poligonale, il
cosiddetto “muro pelargico”, trasformò l’altura in una cittadella fortificata a difesa del palazzo
del wanax miceneo, che si ritiene esistesse sul pianoro36
.
Si è supposto inoltre che nel megaron del palazzo si celebrasse il culto di una divinità
femminile, identificabile con l’Athena dell’epoca storica37
.
Tuttavia solo a partire dall’età geometrica, grazie al ritrovamento di numerosi resti ceramici, è
accertato l’inizio di un’attività cultuale in aumento nel corso dell’VIII sec a.C., quando
sull’Acropoli, come nei più importanti templi e santuari greci, le offerte votive attestate sono
costituite prevalentemente da tripodi bronzei con appliques figurate.
Ma è solo al VII sec a.C. che, sulla base di seppur circoscritti rinvenimenti di materiali
architettonici38
, può essere riconosciuta un’edilizia sacra.
36
F. Santi 2010, p. 25; E. Lippolis, M. Livadiotti, G. Rocco 2007, p.184. 37
K.T. Glowacki 1998, pp. 79-81. 38 K.T. Glowacki 1998, pp. 81-84.
17
L’archeologo C. Nylander ha infatti attribuito ad un tempio di età orientalizzante le due basi
di colonna da lui rinvenute39
, insieme a S. Iakovides, nella parte orientale delle “fondazioni
Dörpfeld” ed i confronti con altri esemplari affini sembrano collocarle in un periodo
compreso tra il 700 ed il 630 a.C.40
E. Touloupa ha ipotizzato che un disco in bronzo raffigurante una gorgone fosse utilizzato
come acroterio per un antico tempio sull’Acropoli; l’elemento è datato al secondo quarto del
VII sec. a.C.41
Infine nel 1937, una larga placca di terracotta dipinta venne scoperta da O. Brooner nel pendio
a nord dell’Acropoli; il reperto è sempre riferibile ad un edificio templare e databile alla fine
del VII sec. a.C.42
L’esistenza di un tempio di Athena sull’Acropoli è rimarcata anche dall’Iliade43
e il
rinvenimento di terrecotte architettoniche databili tra il 620 a.C. ed il 570 a.C., che C.
Vlassopoulou attribuisce a tre differenti strutture44
, non fa che confermare la presenza di
edifici sacri di una certa importanza45
sull’Acropoli in un periodo con scarse testimonianze
come il VII sec. a.C; il tutto sembrerebbe quindi richiamare l’edificio in cui cercò rifugio
Cilone insieme ai congiurati46
.
Oltre ai dati archeologici si aggiungono poi le prime notizie fornite dalle fonti storiche da cui
si può già desumere l’avvenuta strutturazione dello spazio sacro nei suoi elementi compositivi
fondamentali47
.
Nel 636 a.C. il colpo di stato di Cilone è il primo episodio di natura storica che ha come teatro
l’Acropoli; l’evento è tramandato in maniere differenti, ma viene sempre citato un edificio
templare nel quale i congiurati cercarono invano di rifugiarsi.
Dalle fonti a nostra disposizione48
, come detto fra loro discordanti sullo svolgersi dei fatti,
risulta in ogni caso particolarmente evidente come il culto di Athena Poliàs negli anni trenta
39
F. Santi 2010, p. 47. Basandosi sulla tecnica costruttiva, le due basi di colonna vennero datate al tardo VIII o VII sec. a.C. 40
F. Santi 2010, p. 47. 41
K.T. Glowacki 1998, p. 82. 42
K.T. Glowacki 1998, p.82. 43 Omero HOM., Il. II, v.549. 44 F. Santi 2010, p. 47. 45 F. Santi 2010, p. 47. 46
F. Santi 2010, p. 45-46. 47
K.T. Glowacki 1998, pp.79-84. Sui votivi dedicati sull’Acropoli in età geometrica e sul loro significato: A. Scholl 2006, pp. 42-126, 138-167.
18
del VII sec. a.C. presentasse la tradizionale articolazione dello spazio sacro, con relativi
agalma e bomòs, anche se è l’altare in particolare a rivestire un ruolo assoluto perché su di
esso si svolge l’azione principale rivolta alla divinità, il sacrificio49
.
È evidente dunque che già in questo periodo l’Acropoli nella sua totalità aveva acquisito il
rango di santuario poliadico.
L’esistenza dell’agalma rende inoltre fortemente plausibile la presenza di un naòs che
ospitasse l’immagine di culto; infatti la statua è generalmente protetta dalle intemperie e solo
di rado è lasciata senza protezione o coperta da un semplice baldacchino50
.
Si tratta dell’antica statua in legno d’olivo che si voleva fosse caduta dal cielo, innalzata
sull’Acropoli da Erittonio e destinataria del peplo offerto durante le Panatenee51
.
Capitolo 3. L’Acropoli nel VI sec. a.C.
3.1 Gli elementi H e le decorazioni frontonali dell’Hecatompedon
Un problema di difficile risoluzione è l’aspetto dell’Acropoli nell’età di Pisistrato e in genere
prima che i Persiani nel 480 a.C. la mettessero a ferro e fuoco, costringendo gli Ateniesi
superstiti a seppellire nella “Colmata Persiana” i resti profanati dalla mano dei barbari.
La tesi oggi più accreditata, quella di W.B Dinsmoor del 1947, vede la presenza di due
edifici: il primo e più antico è detto Hecatompedon52
(ossia tempio di 100 piedi), del quale
sono stati rinvenuti i materiali, ma non si conosce l’esatta collocazione, mentre nelle
“fondazioni Dörpfeld” resterebbe da riconoscere l’Archaios Neos (cioè tempio antico).
Negli anni 1885-1888 negli scavi a sud e a ovest del Partenone, con maggiore presenza nel
livello di terreno poi denominato Porosschicht53
, vennero rinvenuti i resti delle membrature
48
F. Santi 2010, pp.45-46. 49
M. Osanna 2001, p. 321. 50
F. Santi 2010, p. 46. 51 F. Santi 2010, p. 46. 52 E. Lippolis, M. Livadiotti, G. Rocco 2007, p. 184. Si ritiene che l’appellativo Hecatompedon (lungo cento piedi) fosse da riferirsi in realtà al nucleo interno, così come si verificherà successivamente per il Partenone pericleo. L’Hecatompedon sorgeva in corrispondenza della parte più occidentale del Partenone e misurava circa 20 x 46 m. 53 F. Santi 2010, p. 30.
19
architettoniche in poros del Pireo e in marmo imettio di un monumentale tempio periptero di
età arcaica.
Basandosi principalmente sulle loro dimensioni Dörpfeld ipotizzò che questi frammenti, in
seguito ribattezzati “elementi H”, appartenessero ad un tempio di grandi proporzioni
identificato appunto nell’Hecatompedon; successivamente a tale riconoscimento si cominciò a
parlare di “elementi H” laddove la lettera alfabetica
rappresenta l’inizio della parola Hecatompedon54
, nota
dall’iscrizione detta “decreto Hecatompedon”55
(IG I3
4,
EM 6794) datata al 485/484.
Da ultimo l’archeologo M. Korres56
ha fornito un elenco dettagliato di tutti i pezzi che
rientrano sotto questa denominazione o che possono essere associati alla decorazione
scultorea dell’edificio templare57
.
Essi sono costituiti da:
Frammenti di rocchi di colonna
Frammenti di capitelli
Architravi reimpiegati nel muro meridionale dell’Acropoli
Metope
Triglifi di due tipi
Frammenti dei geisa
Sima in marmo
Acroteri
54 M. Korres 1997a, pp. 220-221. 55
J.M. Hurwit 1999, p. 51-52. 56
F. Santi 2010, p. 95. 57 M. Korres 1997a, pp. 229-235.
Il cosiddetto “decreto Hecatompedon”.
Fig. 8. Fonte: J.M. Hurwit 1999.
20
Oltre questi elementi vennero inoltre ritrovate anche parti di alcuni piccoli templi (chiamati
naiskos) come: il frontone dell’hydra, il “frontoncino dell’ulivo” e l’”apoteosi di Eracle”, tutti
databili alla metà del VI sec. a.C., ma non direttamente collegabili al tempio H.
Lo studio degli “elementi H” ha permesso di ottenere ricostruzioni grafiche sia dell’edificio
templare sia dei relativi frontoni, sebbene con grandi difficoltà e ipotesi non sempre
attendibili.
Una ricostruzione della composizione originaria del frontone est altamente plausibile è stata
proposta negli anni ’30 del secolo scorso da W.H. Schuchhardt, che per primo collocò al
centro del campo frontonale il grande gruppo scultoreo di due leoni che assalgono un toro58
.
L’estremità destra del triangolo frontonale è occupata da un mostro tricorpore alato, con la
parte superiore umana e quella inferiore anguiforme.
Le tracce di colore blu sulla barba sono la ragione del soprannome “barbablù” con il quale il
frontone è noto, mentre un frammento di panneggio attaccato all’ala destra del demone lascia
intuire la presenza di un personaggio verosimilmente in lotta proprio con il Barbablù.
Al vertice opposto dello stesso frontone Eracle combatte contro Tritone, il cui lungo corpo
occupa agevolmente il ristretto spazio dell’estremità triangolare.
Al centro si trovava un gruppo di due leoni che azzannano un toro, un evidente tema
apotropaico.
La ricostruzione dell’altro frontone presenta maggiori difficoltà e, vista la lacunosità
dell’insieme, rimane fortemente ipotetica.
Anche in questo caso però si può riconoscere la presenza di felini al centro del campo
frontonale, ma disposti simmetricamente rispetto all’asse mediano e non congiunti in un unico
grande gruppo come nel timpano opposto.
Le ipotesi ricostruttive sono varie e differenti59
, ma la soluzione più verosimile prevede ai lati
dell’asse mediano, a destra, una leonessa, a sinistra, un leone, mentre alle estremità
dovrebbero trovare spazio due serpenti in poros; risulta molto difficile accettare l’idea di I.
Beyer del 1974 che ipotizzò una grande gorgone centrale in corsa, affiancata da due leoni
accosciati, seguiti a destra dalla scena dell’”apoteosi di Eracle” e a sinistra quella di
un’ipotetica nascita di Athena.
58
F. Santi 2010, p. 108. 59 F. Santi 2010, pp. 132-133.
21
Nelle sculture frontonali ritroviamo le caratteristiche tipiche della scultura arcaica: occhi
oblunghi, il naso ampio alle narici e stretto all’attaccatura, gli zigomi alti e le sopracciglia
curve.
Bicipiti e polpacci sono molto accentuati, soprattutto nella figura di Eracle, che, nella postura
e nella prominenza richiama da vicino le forme dei più tardi giganti agli angoli del frontone
della Gigantomachia, presente nel timpano dell’Archaios Neos.
Le teste del Barbablù invece mostrano strette analogie con quella del Moskophoros60
, termine
di paragone obbligato, vista anche la vicinanza cronologica, per tutte le sculture frontonali in
poros a destinazione frontonali dell’Acropoli arcaica.
Proprio al maestro del Moskophoros si è voluta attribuire la paternità del frontone del
Barbablù61
, anche se analogie e somiglianze, proprio per quelle caratteristiche comuni alla
scultura attica di età arcaica, possono essere riscontrate in diverse opere, anche più tarde62
.
Fig.9. Fonte: J.M. Hurwit 1999.
60
G. Dickins 1912, p. 83; A. Stewart 1990, p. 114. 61
J. Boardman 1985, p. 193. 62 F. Santi 2010, p. 147.
A. Ricostruzione del frontone est, detto anche del “barbablù”, del tempio H secondo W.H. Schuchhardt.
B. Ricostruzione del frontone ovest del tempio H secondo I. Beyer, l’ipotesi è tuttavia molto contestata.
22
Fig. 10. Fonte: www.ancientathens3d.com.
3.2 Le fondazioni Dörpfeld e la difficile ubicazione del tempio H: secondo tempio di Athena
Poliàs o Urparthenon?
Nella zona compresa tra il Partenone e l’Eretteo W. Dörpfeld rintracciò nel 1885 le
fondazioni, che poi presero il suo nome, di un grande edificio templare, un periptero esastilo
di età arcaica con dodici colonne sui lati, unanimemente identificato come il tempio di Athena
Poliàs.
Fig. 11. Fonte: J.M. Hurwit 1999.
Le cosiddette “fondazioni Dörpfeld” e sullo sfondo l’Eretteo.
Ricostruzione dell’Acropoli nel VI sec. a.C.: in primo piano l’Archaios Neos, sullo sfondo l’Hecatompedon.
23
Le fondazioni esterne, pertinenti alla peristasi, sono in blocchi di calcare di Karà, le cui cave
si trovano ai piedi dell’Imetto ad una distanza di 3,5 km dall’Acropoli.
Le fondazioni della cella, di esecuzione meno accurata, sono realizzate con spezzoni irregolari
di poros dell’Acropoli, inferiori per dimensioni ai blocchi della fondazione esterna.
La particolarità della pianta si spiega invece con la pluralità dei culti che si svolgevano nel
tempio: la metà orientale ospitava il culto di Athena Poliàs, mentre quella occidentale era
probabilmente destinata ai culti di Poseidone-Eretteo, Efesto e Bute63
.
L’uso di materiale diverso nelle fondazioni della peristasi e in quelle della cella ha dato inizio,
fin dal momento della loro scoperta, ad un ampio dibattito sull’appartenenza delle une e delle
altre ad una stessa fase o a fasi cronologiche diverse.
Fu proprio Dörpfeld ad ipotizzare che la più rozza opera muraria della cella potesse spiegarsi
con una sua maggiore antichità rispetto alle fondazioni esterne.
L’idea di due differenti fasi costruttive fu accettata da Th. Wiegand che ipotizzò un primo
tempio in antis sulle fondazioni interne, successivamente sostituito dal periptero dei
Pisistratidi che avrebbe utilizzato le vecchie fondazioni per la cella e costruito le nuove per il
colonnato esterno64
. W.H. Schuchhardt riteneva invece in un primo momento che tutte le
fondazioni fossero databili attorno al 570 a.C. e potessero essere messe in relazione, in questa
fase, con gli elementi architettonici H, databili appunto a questo periodo e pertinenti ad un
tempio periptero: idea poi da lui stesso rifiutata per l’impossibilità di attribuire alle fondazioni
una cronologia così alta65
.
Alla base di questa ritrattazione vi fu il riconoscimento da parte di Dinsmoor di tracce di
gradina, uno scalpello dentato utilizzato per scolpire il marmo, sui blocchi di tutte le
“fondazioni Dörpfeld”, sia in quelle in calcare che in quelle di poros dell’Acropoli: secondo
lo studioso americano, l’impiego della gradina sarebbe attestato solo a partire dall’età dei
Pisistratidi, confermando così la datazione e la contemporaneità di esecuzione delle
fondazioni del grande periptero voluto dai tiranni attorno al 525 a.C.66
Secondo W.H. Plommer invece l’uso della gradina sarebbe documentato nella statuaria in
marmo già dal secondo quarto del VI sec. a.C., riabilitando la teoria di Schuchhardt.
63 W. Dörpfeld 1886, pp. 338-340,345; W.B. Dinsmoor 1947, pp. 113-114. 64
F. Santi 2010, pp. 80-81. 65
F. Santi 2010, p. 81. 66 W.B. Dinsmoor 1947, pp.116-177.
24
Da ultimo K. Kissas ha riconosciuto tracce di gradina sulle tegole marmoree del tetto di tipo
laconico dell’inizio del VI sec. a.C. rinvenute sull’Acropoli ed ha alzato definitivamente in età
alto-arcaica la data in cui in Grecia si iniziò ad usare lo strumento: ne deriva perciò la
possibilità di ubicare l’Hecatompedon sulle “fondazioni Dörpfeld”67
, dato che anche su alcuni
suoi elementi architettonici si trovano segni di scalpello68
.
Comunque, a prescindere da ciò, rimane certo che esse dovettero sostenere l’alzato del tempio
pisistratide di Athena Poliàs.
L’uso di differente materiale nella muratura delle fondazioni dell’edificio templare è quanto
meno singolare, anche se non privo di riscontri in altre costruzioni sacre di età arcaica.
L’impiego di calcare della zona dell’Acropoli, riconducibile al sistema geologico
dell’Acropoli e delle alture circostanti fino al Licabetto, sembrerebbe rimandare ad una fase
piuttosto antica della storia edilizia della città, quando generalmente veniva utilizzato il
materiale di cava più vicino: secondo gli odierni studi di F. Santi, che si è avvalso del lavoro
di Nylander, con esso vennero addirittura realizzati il presunto palazzo miceneo e il muro
pelargico69
.
Ma è anche vero che l’uso congiunto di calcare dall’Acropoli e di calcare di Karà si riscontra
nelle fondazioni e nel crepidoma del tempio di Dioniso Eleutero, presso l’omonimo teatro,
realizzato nell’ultima fase della tirannide di Pisistrato o durante quella dei suoi figli70
.
La commistione di calcare di Karà e di un non meglio specificato poros è attestato anche nelle
fondazioni del tempio di Zeus Olympios, il grande diptero voluto ed iniziato dai Pisistratidi71
.
Questi casi però non sono del tutto comparabili con quello in esame, perché non presentano
una netta distinzione dei materiali come si ha per le “fondazioni Dörpfeld”.
Inoltre pur potendosi pensare che si sia iniziato a cavare il calcare di Karà a partire dall’età dei
Pisistratidi, non si può escludere un rifacimento delle fondazioni esterne in relazione, forse,
alla trabeazione completamente marmorea che il tempio pisistratide di Athena Poliàs
prevedeva72
; il tutto quindi porterebbe a pensare ad un rimaneggiamento dell’edificio
templare in una seconda fase.
67 O. Palagia, R.S. Bianchi 1994, pp. 189-190. 68 F. Santi 2010, p. 82. 69 F. Santi 2010, p. 82. 70
W. Dörpfeld, E. Reisch 1896, p. 15; S. Angiolillo 1997, p. 38, nota 61, p. 71. 71
S. Angiolillo 1997, p. 38, nota 61, p. 75. 72 F. Santi 2010, pp. 230-238.
25
Lavori di rinnovamento del santuario che sembrerebbero avvalorare l’idea che
l’Hecatompedon (altrimenti detto tempio H) sia stato eretto proprio al posto dell’ipotetico
tempio di età geometrica dedicato alla dea.
In quest’ultimo d’altronde, cosi come poi avverrà nel tempio pisistratide e nell’Eretteo
classico, era conservato l’archaion agalma73
, l’antichissima statua di culto della divinità
femminile, alla quale veniva consegnato il peplo offerto al termine della processione
panatenaica.
La teoria oggi più accreditata è però quella dell’americano Dinsmoor74
e propone una
versione totalmente differente: il tempio H venne eretto sul sito del futuro Partenone e non
come sostenuto per ultimo da Kissas75
sia andato a sostituire il tempio di età geometrica
dedicato ad Athena Poliàs.
Avanzata dall’archeologo statunitense nel 1947, l’ipotesi è stata nuovamente riportata
all’attenzione dall’architetto greco M. Korres, il quale, contrariamente allo studioso
americano, torna a sostenere la natura di periptero dell’edificio templare ed ha individuato
possibili elementi indiziari a sostegno di questa tesi76
, tra cui spicca la presenza di un lungo
alloggiamento nella roccia sul lato occidentale del Partenone, esterno allo zoccolo di
fondazione del tempio e orientato diversamente rispetto ad esso (3,5° verso sinistra).
Questi elementi dunque, paralleli ad un’ipotetica struttura a pianta rettangolare,
indicherebbero l’esistenza di un tempio di età arcaica (terminato probabilmente entro il 566
a.C.), lungo almeno 20 m, la cui fronte occidentale si sarebbe trovata allineata con quella del
tempio pisistratide di Athena Poliàs, cronologicamente successivo (intorno al 520 a.C.).
Il quadro ricostruito da M. Korres per l’età arcaica prevedrebbe dunque la costruzione del
tempio H sul sito del futuro Partenone e la permanenza del tempio geometrico di Athena
Poliàs fino agli anni trenta del VI sec. a.C., quando venne sostituito dal tempio pisistratide
con i frontoni marmorei.
73 F. Santi 2010, pp. 45-46, 83. Erodoto parlando della congiura Ciloniana (circa 634 o 632 a.C.), accenna a una statua di culto presso la quale i congiurati cercarono rifugio (5.71; 5.82); Anche Plutarco (Vita di Solone, 12) menziona una statua. 74
W.B. Dinsmoor 1947, pp. 122-123. 75
F. Santi 2010, p. 82. 76 F. Santi 2010, p. 83.
26
Fig. 12. Fonte: J.M. Hurwit 1999.
Il tempio H sarebbe stato smantellato solamente sul finire del VI sec. a.C. quando il neonato
regime democratico avrebbe dato inizio alla costruzione di un imponente basamento per un
nuovo edificio templare (Prepartenone I), le cui dimensioni (31.39 x 76.82 m) avrebbero
dovuto superare ampiamente quelle del tempio pisistratide di Athena Poliàs.
Il basamento, sul quale attualmente si erge l’edificio partenonico, costituiva già di per sé
un’impresa costruttiva grandiosa: a nord appoggiato al suolo naturale, accuratamente
spianato, a sud era invece sostruito con un totale di 22 assise di blocchi, per una profondità di
10.67 m77
, venendo a costituire una massa piena di oltre 8000m3.
Tale enorme quantità di elementi calcarei, estratti dalle cave del Pireo, era almeno in parte
proveniente dal cantiere ormai interrotto dell’Olympieion pisistratide, ma il dato più
significativo consiste nella presenza di una crepidine di tre gradini a conclusione del
basamento78
.
77 E. Lippolis, M. Livadiotti, G. Rocco 2007, p. 299; B. Holtzmann 2003, pp. 83-84. 78
E. Lippolis, M. Livadiotti, G. Rocco 2007, pp. 298-299. Secondo R. Tölle-Kastenbein 1993, la piattaforma non deve essere intesa come un Prepartenone I, ma come lo stesso Hecatompedon, nel quale non sarebbe da riconoscere un edificio vero e proprio, ma uno spazio sacro scoperto, una sorta di terrazza.
Ricostruzione delle due principali teorie di ubicazione dell’Hecatompedon sull’Acropoli:
la teoria A presume un Hecatompedon creato sul sito poi occupato dal tempio pisistratide di Athena Poliàs, quindi nella zona nord dell’Acropoli.
la teoria B propende invece per un Hecatompedon localizzato sul sito del futuro Partenone, quindi nella zona sud.
La teoria B è quella oggi riconosciuta.
27
Solo dopo la vittoria di Maratona del 490 a.C. si sarebbe deciso di innalzare su quello stesso
zoccolo un tempio interamente in marmo pentelico (Prepartenone II), ancora incompiuto al
momento dell’invasione persiana del 480 a.C. che ne causò la distruzione79
.
Il tempio H sarebbe stato dunque un edificio dedicato ad Athena nella sua epiclesi di Pallàs o
Parthenos e nel suo aspetto guerriero, mentre quello geometrico e poi pisistratide, doveva
essere dedicato ad Athena nella veste pacifica di protettrice della città80
.
Fig. 13. Fonte: E. Lippolis, M. Livadiotti, G. Rocco 2007.
L’attività edilizia sull’Acropoli si protrasse per tutto il VI sec. a.C., con monumenti
riconducibili all’opera dei Pisistraditi, come il tempio di Athena Poliàs e alcuni apprestamenti
nell’area dei Propilei e del pyrgos, oltre ad altre strutture quali gli oikoi B, D ed E.
Il vasto programma costruttivo è senza dubbio ricollegabile al nuovo ruolo assunto dal
santuario di Athena Poliàs anche in relazione alla creazione delle grandi Panatenee, la cui
istituzione secondo Apollodoro (Apollod., Bibl. III, 14, 6), sarebbe dovuta ad Erittonio,
mentre Plutarco ne attribuisce la creazione a Teseo (Plut., Thes. 24, 3).
Il vero punto di svolta sull’Acropoli si colloca proprio in concomitanza con la
riorganizzazione delle grandi Panatenee del 566 a.C.81
; a livello archeologico la comparsa
79
F. Santi 2010, p. 84; E. Lippolis, M. Livadiotti, G. Rocco 2007, pp. 302-303. 80
F. Santi 2010, p. 84. 81 F. Santi 2010, p. 48.
Pianta dell’Acropoli Pisistratica secondo l’ipotesi Dinsmoor poi ripresa da Korres. Notare come la fronte occidentale dell’Hecatompedon sia allineata con quella del tempio di Athena Poliàs.
NORD
28
delle prime anfore panatenaiche in un periodo compreso tra il 570 ed il 560 a.C. costituisce
una delle conferme più evidenti alla cronologia eusebiana dell’istituzione della grande festa82
.
È proprio in questi anni che sul versante occidentale venne creata una monumentale rampa
d’accesso per la processione panatenaica, sulla sommità venne costruito il tempio di Athena
Poliàs, nuovi culti vennero istituiti e promossi (Athena Nike ed Artemis Brauronia) e culti di
antica tradizione vennero mantenuti (futuro Eretteo e Zeus Polieus)83
.
A parte queste notizie di carattere leggendario, sono pochi i dati di natura storica che le fonti
consentono di ricavare sulla fondazione della festa, che deve in ogni caso, essere distinta tra le
due festività annuali dedicate alla dea: le piccole Panatenee, forse già citate nell’Iliade84
e di
cadenza annuale e le grandi Panatenee con cadenza penteterica; quest’ultime, secondo lo
scoliasta del Panatenaico di Elio Aristide85
, istituite da Pisistrato stesso.
Quando gli Ateniesi, dopo la vittoria di Platea (479 a.C.), tornarono sull’Acropoli
saccheggiata e distrutta dai Persiani, decisero di non ricostruire nulla, ma di lasciare ben
visibili le tracce del sacrilegio compiuto dai Barbari.
Le sculture e gli ex voto, ormai inservibili, ma sacri in quanto dedicati agli dei, vennero
seppelliti ritualmente e sottratti alla vista come fossero elementi di un corredo funebre.
Con il passare degli anni nuove opere architettoniche arrivarono a sostituire quelle oltraggiate
dai barbari, ma il programma architettonico resterà fermo fino al 447 a.C. quando Pericle, con
il tesoro della lega Delio-Attica, darà il via alla ricostruzione dell’Acropoli e dei suoi templi.
Per rinforzare le difese della città venne ricostruita frettolosamente da Temistocle la cinta
muraria, utilizzando anche materiale di reimpiego post persiano e venne avviata la
riorganizzazione del Pireo con la costruzione delle Lunghe Mura, mentre con il bottino
dell’Eurimedonte (circa 466 a.C.) Cimone ricostruì i tratti rettilinei delle mura meridionali
dell’Acropoli86
.
82 H.A. Shapiro 1989, pp.18-20. La più antica anfora panatenaica, la Burgon, oggi a Londra, si data al 570-560 a.C. 83 F. Santi 2010, p. 49. 84
Omero, Il. II, vv. 550-551. 85
F. Santi 2010, p. 48. 86 G. Bejor, M. Castoldi, C. Lambrugo 2008, p. 175; E. Lippolis, M. Livadiotti, G. Rocco 2007, p. 367.
29
Cosi Diodoro (Giuramento di Platea, 11.29.3)87
: …”e dopo aver sconfitto i barbari in
battaglia, non distruggerò nessuna città che ha combattuto contro di loro, non ricostruirò
nessuno dei templi che sono stati bruciati e abbattuti, ma li lascerò come monumenti agli
uomini che verranno, in memoria dell’empietà dei barbari.”
L’ipotesi di un Hecatompedon creato sul sito del tempio di età geometrica dedicato ad Athena
Poliàs viene quindi scartata dalle moderne teorie che propendono invece per una sua
sostituzione con l’Archaios Neos pisistratico.
L’Archaios Neos era realizzato con basamento e muri in calcare ed un fastoso tetto con tegole
in marmo insulare, come in alcuni dei templi di area cicladica, ma per la prima volta sul
continente greco88
.
Il frontone orientale, meglio conservato, rappresenta una Gigantomachia: nella ricostruzione
comunemente proposta la figura di Athena, alta 2 m, giganteggia al centro del timpano,
incombendo sul gigante atterrato ai suoi piedi; la dea si slancia in avanti con fare imperioso e
tende, lungo il braccio sinistro, l’egida dal bordo coronato di orribili serpenti.
Ai lati troviamo giganti caduti ed inginocchiati.
L’altro frontone dovrebbe prevedere al centro della composizione un gruppo di due leoni in
assalto su un toro atterrato; in marmo pario, come le sculture della Gigantomachia89
, ci è
pervenuto in condizioni molto frammentarie.
La figura di Athena fu rinvenuta tra il 1863 ed il 1888,
smembrata in più frammenti, in differenti punti dell’Acropoli.
Priva di gran parte delle gambe, della spalla destra, di una
cospicua porzione del braccio sinistro e di quasi tutto il petto, fu
ricomposta dal restauratore P. Kaludis con la guida e le direttive
di H. Schrader90
.
87 J.M. Hurwit 1999, p. 138. 88 G. Bejor, M. Castoldi, C. Lambrugo 2008, p. 114-115. 89 H. Schrader 1897, p. 103. L’utilizzo del medesimo materiale, marmo insulare a grana grossa, in più punti macchiato di blu, è stato alla base dell’ipotesi di una contemporaneità di esecuzione di entrambi i gruppi e della loro attribuzione allo stesso edificio templare. 90 H. Schrader 1939, pp. 345-347.
Fig. 14. Fonte: F. Santi 2010.
30
La testa rinvenuta già nel 1863 nell’angolo sud-orientale dell’Acropoli negli scavi per la
costruzione del museo91
, presenta stilizzazioni tipiche della scultura attica arcaica: occhi
amigdaloidi e sporgenti, arcate sopraccigliari piuttosto pronunciate, zigomi alti e prominenti.
La mano sinistra della dea venne scoperta davanti alla fronte orientale del Partenone, mentre
per quanto riguarda i giganti atterriti, la maggior parte dei frammenti provengono dall’area
antistante la fronte est del Partenone, dove furono scoperti nel 188292
.
91 H. Schrader 1939, p. 346, fig. 405. La testa ha perso del tutto le tracce della policromia originaria, presente invece sugli altri frammenti della scultura: le foto dell’epoca mostrano il pezzo all’aperto sotto la luce solare, in breve tempo ciò dovette provocare il disfacimento dei pigmenti superstiti. 92 H. Schrader 1939, p. 345.
NORD
Fig. 15. Fonte: F. Santi 2010.
In azzurro le zone di rinvenimento dei cosiddetti “elementi H” dell’Hecatompedon.
In rosso le zone di scoperta dei frammenti del frontone della Gigantomachia del tempio di Athena Poliàs.
31
Capitolo 4. Perserschutt, Tyrannenschutt e Zerstörungsschutt
4.1 Definizione, localizzazione ed eventuali affinità compositive
Come si può evincere dal titolo non esiste un solo tipo di colmata, oltre alla “Colmata
Persiana” ne sono state riscontrate almeno altre due tipologie sul pianoro dell’Acropoli.
L’archeologa tedesca A. Lindenlauf, nel suo lavoro del 1997, definisce la Perserschutt come
“una spianata di macerie uniformi causate dai Persiani che sono state in seguito sfruttate
dagli Ateniesi secondo un progetto di riordino e di riutilizzo per costruzioni e terrazzamenti
sull’Acropoli negli anni successivi al 480 a.C.93
”.
Sempre nella sua opera viene poi definita un’importante distinzione: sebbene dai primi
archeologi entrambi i due grandi riempimenti, a sud del Partenone e a ridosso del muro nord
dell’Acropoli, furono erroneamente intesi come fenomeni risultanti dalla “Colmata Persiana”,
oggi sappiamo che quest’ipotesi non è più accettabile, infatti, solo il grande scarico a sud del
Partenone si è verificato in conseguenza al sacco persiano94
, mentre i materiali che
provengono dal lato nord vanno a costituire quella che, sempre secondo la Lindenlauf, può
essere intesa come Zerstörungsschutt95
.
Quest’ultima colmata, le cui dimensioni vanno dai 10 ai 15.000 m3
di materiali, è costituita da
detriti generati dagli Ateniesi stessi sul pianoro, secondo W. Kolbe persino da materiale
portato sull’Acropoli dalla città sottostante di Atene96
e, grazie alla datazione degli ultimi
reperti rinvenuti, i lavori di riorganizzazione sarebbero databili fino alla metà del V sec. a.C. o
addirittura al 435 a.C.97
La distinzione tra le due colmate non è immediata e il rinvenimento di tracce di devastazione
persiana sui pezzi, che aiuterebbero nell’identificazione, non è sempre lampante, ma
sembrerebbe che la Zerstörungsschutt si sia generata negli anni successivi al 480 a.C. in
seguito a lavori di riordino dell’Acropoli da parte degli stessi Ateniesi, che avrebbero
93 A. Lindenlauf 1997, p. 50. 94 A. Lindenlauf 1997, pp. 49, 54-55, 70. 95
A. Lindenlauf 1997, p. 70. 96
A. Lindenlauf 1997, p. 75. 97 A. Lindenlauf 1997, p. 75.
32
smantellato gli edifici più danneggiati dall’invasione persiana, provocando l’accumulo di
macerie poi riutilizzate nei vari ampliamenti o riempimenti sulla rocca98
.
La situazione è resa ancora più intricata dal rinvenimento anche nel lato sud di materiale non
mutilato o con tracce di bruciature, quindi non oltraggiato dai Persiani, il che rende ancora più
difficile l’attribuzione dei vari resti alla Perserschutt o alla Zerstörungsschutt, altrimenti detta
Auch-Perserschutt99
.
I frammenti scultorei e alcune membrature architettoniche in poros degli edifici arcaici
dell’Acropoli vennero rinvenuti quasi esclusivamente in uno strato del grande riempimento a
sud, compreso tra il muro cimoniano e il Partenone, su cui s’impostò la terrazza a sud del
tempio pericleo100
.
Lo strato, definito da F. Santi Porosschicht per la forte omogeneità dei rinvenimenti, quasi
tutti di materiali in calcare, risultava compreso tra il grande zoccolo di fondazione
dell’edificio prepartenonico ed un muro, denominato S2, che gli corre pressoché parallelo a
una distanza compresa tra gli 11 e i 13 m.
Questo ci porta quindi a poter affermare che il seppellimento delle sculture frontonali in poros
e delle membrature architettoniche dei relativi edifici avvenne dopo l’erezione del grande
podio templare, ormai saldamente fissato in età prepersiana101
.
98 A. Lindenlauf 1997, p. 75. Secondo W. Kolbe 1936, per ampliare il lato nord e quello sud dell’Acropoli furono necessari 50.000 m
3 di macerie.
99 A. Lindenlauf 1997, pp. 56-57. Già durante gli scavi di Kavvadias e Kawerau, sebbene lacunosi, non si è riusciti
a distinguere con certezza tra le due differenti colmate. 100
F. Santi 2010, p. 30. Lo stesso Santi in un passaggio successivo riprende in maniera dubitativa la questione che nel suo testo rimane spiegata in modo insufficiente. 101
F. Santi 2010, p. 30. Sia Dörpfeld nel suo articolo del 1902 che Heberdey nella sua pubblicazione del 1919 datavano il podio di fondazione dell’edificio prepartenonico, nonché il Porosschicht, in età prepersiana. Successivamente altre voci, tra cui W. Kolbe, avevano invece proposto una datazione dello zoccolo di fondazione del Prepartenone e del tempio stesso in età postpersiana. Le analisi condotte da M. Korres negli anni ’90 del secolo scorso hanno ormai definitivamente sancito la datazione prepersiana del podio di fondazione del Prepartenone. Attraverso l’uso di un endoscopio si è potuto stabilire che tutti i blocchi dello stereobate prepartenonico presentano fratture di tipo termico, di certo ricollegabili all’incendio persiano del 480 a.C. (M. Korres 1993, pp. 70-71, 73).
33
Fig. 16. Fonte: F. Santi 2010.
In un periodo di poco posteriore al rinvenimento dei pezzi G. Dickins coniò per il
Porosschicht il nome di Tyrannenschutt102
, ossia “Colmata Tirannica”, nato come
duplicazione concettuale di Perserschutt: impossibile non notare la forte omogeneità dei
pezzi, quasi prevalentemente in poros e la pressoché assenza di resti in marmo103
.
102 G. Dickins 1912, p. 9. Dickins, seguendo la datazione prepersiana del Partenone proposta da Dörpfeld, attribuiva lo smantellamento dell’Hecatompedon, l’erezione dello zoccolo del Prepartenone ed il seppellimento della sua decorazione figurata, rinvenuta nel Porosschicht, al primo regime democratico. Lo studioso quindi datava la “Colmata Tirannica” un trentennio prima della “Colmata Persiana”. 103 F. Santi 2010, p. 31.
Sezione nord-sud della terrazza meridionale del Partenone a metà della stessa (Heberdey 1919):
P: Muro Miceneo XIII sec a.C. S2: Muro Poligonale 495 a.C. K4: Muro Cimoniano 467 a.C. K5: Muro Pericleo 2: Stereobate
34
A ciò si aggiungeva l’osservazione della mancanza di tracce di bruciato che invece avrebbero
dovuto essere presenti se anche le sculture frontonali in poros, come gli agalmata marmorei
sepolti nella “Colmata Persiana”, fossero state distrutte dalla furia dei Persiani.
Tutto ciò spinse R. Heberdey ad ipotizzare addirittura che gli edifici in poros e la relativa
decorazione figurata fossero stati sistematicamente smantellati al momento della costruzione
dell’Hecatompedon o più verosimilmente alla fine del regime tirannico e che i resti in calcare,
frantumati, fossero stati sepolti in concomitanza con l’erezione delle zoccolo di fondazione
del Prepartenone104
.
La teoria di Heberdey, una fase di seppellimento dei pezzi ante 480 a.C., sembra difficilmente
sostenibile, all’interno del Porosschicht, infatti, colpisce il livello di distruzione dei pezzi e la
loro dispersione all’interno del riempimento: frammenti pertinenti allo stesso frontone e ad
uno stesso gruppo si trovano in punti differenti, talora piuttosto lontani, come il caso delle tre
teste del Barbablù105
.
Lo stesso discorso si potrebbe fare per la testa di Eracle del gruppo dell’eroe in lotta con
Nereo/Tritone rinvenuta nel pozzo sulle pendici settentrionali dell’Acropoli, la sua presenza
risulterebbe poco comprensibile se la sua rottura non fosse dovuta alla distruzione del 480
a.C.
Il pezzo è effettivamente l’unico di una certa importanza rinvenuto al di fuori della cosiddetta
“Colmata Tirannica”, per di più separato da tutti gli altri elementi scultorei del frontone del
Barbablù e per primo dal corpo dell’eroe, con cui si congiunge, scoperto a circa 20 m a sud-
ovest dell’angolo sud-orientale del Partenone106
.
La testa fu rinvenuta da O. Brooner nel 1939, ridotta in molti frammenti, a 6.60 m di
profondità in un pozzo alle pendici settentrionali dell’Acropoli, poi denominato “well E”.
Importante notare che sulla sommità del capo è presente una profonda incisione, forse opera
di un’ascia o di uno scalpello dalla punta larga.
Esclusa la possibilità che il motivo della messa fuori uso dei pozzi sia stata la mancanza di
acqua (al momento dello scavo essi presentavano infatti ancora una sufficiente provvista
104
F. Santi 2010, p. 33. 105
F. Santi 2010, p. 33. 106 F. Santi 2010, pp. 31-33.
35
idrica), Brooner ipotizzò che la chiusura dei pozzi sia avvenuta dopo l’invasione persiana e
che debba porsi in relazione ai lavori di spianamento dell’Acropoli, realizzati dopo il 480 a.C.
Fondamentale a riguardo è il fatto che alcuni dei frammenti ceramici rinvenuti nei pozzi
appartengono a vasi trovati negli scavi dell’Acropoli, elemento da cui si dedurrebbe che la
terra superflua fu gettata giù dalle mura e usata per coprire le asperità delle pendici
settentrionali. Lo studioso americano affermava dunque che il rinvenimento della testa di
Eracle confermerebbe l’equivalenza tra Tyrannenschutt e Perserschutt come il prodotto di
un’unica azione.
Pur mancando la certezza assoluta che il riempimento dei pozzi sia avvenuto esattamente
nello stesso momento di quello della zona meridionale dell’Acropoli, ciò spiegherebbe nel
modo più logico la separazione della testa di Eracle dagli altri elementi dello stesso frontone.
Fig. 17. Fonte: F. Santi 2010.
Estensione del cosiddetto Porosschicht con indicazione dei luoghi di rinvenimento dei frammenti scultorei.
36
Fig. 18. Fonte: F. Santi 2010.
Per quanto riguarda l’Hecatompedon lo smantellamento dei frontoni del tempio dovette
avvenire comunque già prima del 480 a.C.
Infatti se essi, secondo le teorie prevalenti al momento, decoravano un Urparthenon del VI
sec. a.C., messo fuori uso alla fine dello stesso secolo per l’erezione del podio prepartenonico,
dovettero rimanere in vista fino all’occupazione persiana dell’Acropoli, in prossimità del
cantiere del Prepartenone ed essere ugualmente coinvolte nella distruzione del 480 a. C.107
Il materiale costruttivo del tempio H dovette in effetti rimanere a disposizione per molto
tempo sull’Acropoli visto il reimpiego che se ne fece in strutture successive, ad esempio nel
muro cimoniano108
.
107
M. Korres 1997a, pp. 224-225. 108 F. Santi 2010, p. 97.
Pianta delle pendici settentrionali dell’Acropoli con l’indicazione dei pozzi scavati da O. Brooner. Il “pozzo E” è segnalato in rosso.
37
Fig. 19. Fonte: F. Santi 2010.
Per quanto riguarda gli oikoi, mentre una parte di essi fu sepolta nel Porosschicht, un’altra
parte fu ancora riutilizzata nelle fondazioni della Pinacoteca e dei Propilei mnesiclei.
È fuor di dubbio comunque che i frontoni in poros, prima di essere sepolti, andarono incontro
a fortissimi danneggiamenti, difficilmente non riconducibili all’invasione persiana del 480
a.C.
Dinsmoor sottolineava infatti la presenza di “unmistakable traces of fire” sul frontone
dell’hydra e ipotizzava che anche il colore rosso sul retro del frontone dell’apoteosi potesse
essere ricondotto ad un fenomeno di combustione109
.
Inoltre, per quanto concerne la pressoché totale mancanza di frammenti scultorei in marmo
nel Porosschicht, Santi suppone una distinzione del materiale durante le fasi di seppellimento
dei resti delle costruzioni distrutte e delle sculture danneggiate.
Nello strato in poros sembra ad esempio che non sia stata rinvenuta alcuna delle sime
marmoree del tempio H e degli oikoi, confermando l’idea che esse furono volontariamente
separate dagli elementi architettonici e scultorei in poros, pur essendo pertinenti alle
medesime costruzioni110
.
Sempre Santi ipotizza varie motivazioni alla base di questa scelta: la maggiore antichità dei
pezzi, il maggiore stato di frammentazione dovuto alla forte friabilità del poros, il minore
109
F. Santi 2010, p. 35. 110 F. Santi 2010, p. 35.
Porzione del muro cimoniano in cui sono reimpiegati i blocchi di architrave del tempio H.
38
pregio del calcare rispetto al marmo e forse anche l’immediato reimpiego delle lastre di fondo
dei frontoni111
.
Conclusioni
Come segnalato dalla Monaco nella sua riflessione del 2004 il dilemma relativo alla “Colmata
Persiana” resta assolutamente aperto e, piuttosto che proporre nuove sintesi di qualsiasi tipo,
sarebbe opportuno tornare ad interrogarsi sulla consistenza o meglio, prima ancora, sulla
stessa esistenza della colmata all’interno dei riempimenti dell’Acropoli.
Essenziale sarebbe una ricerca mirata alla sola “Colmata Persiana”, senza il continuo raffronto
con le varie fasi edilizie del Partenone, del Prepartenone o dei vari edifici presenti
sull’Acropoli; fondamentale quindi slegarsi dall’impostazione di fine ‘800 di Dörpfeld che
indirizzava i suoi studi, seppur altamente proficui, principalmente alla sola datazione
dell’edificio prepartenonico.
Inoltre basandoci agli studi più recenti (Lindenlauf, Korres, Hurwit e Santi) risulta
particolarmente evidente sia l’impossibilità di sostenere le ipotesi che intendono tutti i
riempimenti come colmata (teoria Dörpfeld 1892), sia quelle che escludono totalmente la
colmata dal novero dei riempimenti, quasi non considerandola reale.
Concordando totalmente con il pensiero della Monaco, considero fondamentale una nuova
analisi dei materiali rinvenuti nei vari riempimenti per la ricerca di eventuali tracce di
distruzione persiana (specialmente bruciature) che potrebbero rivelarsi indispensabili nella
catalogazione e datazione dei reperti.
I vari termini tedeschi utilizzati dagli studiosi negli anni indicano quasi certamente opere di
accumulo di periodi diversi, che hanno probabilmente prodotto la mescolanza di resti di epoca
arcaica e classica, rendendo difficile la determinazione dei vari strati che spesso riportano
materiali simili, presentando un’analisi stratigrafica particolarmente complessa.
111
F. Santi 2010, p. 35. Nei frontoni più aggettanti le sculture presentano spesso evidenti tracce di distacco dal piano di fondo che non è quasi mai conservato.
39
Proprio la mancanza di bruciature e la quasi totalità di elementi in poros ha portato alla
creazione, da parte di Dickins, del termine Tyrannenschutt, prima conosciuto come
Porosschicht, per via dell’omogenea composizione dello strato di terra nel terrazzamento a
sud del Partenone.
La mancanza di segni di distruzione persiana, presenti invece nella Perserschutt, anch’essa
localizzata principalmente nella parte meridionale del Partenone, ha portato gli studiosi a
datare circa al 510 a.C. la cosiddetta “Colmata dei Tiranni”, evento che sarebbe quindi
precedente alla “Colmata Persiana”.
La Lindenlauf cita inoltre una Auch-Perserschutt o Zerstörungsschutt, composta da materiali
databili alla metà del V sec. a.C., forse addirittura fino al 435 a.C.
La datazione, tutt’altro che sicura, porterebbe ad ipotizzare lavori di riordino dell’Acropoli da
parte degli stessi Ateniesi, con smantellamento degli edifici più danneggiati dall’invasione
persiana, dal periodo successivo al 480 a.C. sino all’età periclea, con la presenza di macerie
visibili sul pianoro per molti anni.
La sfida odierna, l’unica per giungere finalmente ad identificare, seppure con margini di
dubbio, la famosa colmata, distinguendola da presunti precedenti riempimenti
(Tyrannenschutt o Porosschicht) o successivi (Zerstörungsschutt), sta proprio in un
indispensabile ritorno ai dati e alla documentazione di scavo originaria.
Una documentazione disorganica, tutt’altro che omogenea e in parte confusa, ma non
inesistente e che se letta nella sua complessità può certamente fornire indicazioni preziose.
Il primo passo sarebbe di accertare e distinguere chiaramente la presenza delle varie colmate,
soprattutto nella terrazza sud del Partenone, per anni studiata da Dörpfeld, dove la distinzione
tra Porosschicht e Perserschutt è minima, infatti è stato possibile recuperare sia materiale
marmoreo che in poros; indizio forse di una sola colmata.
Grazie alla ricerche che ho compiuto per questa tesi, la mia ipotesi prevedrebbe una raccolta
delle macerie lasciate dal passaggio dei Persiani durante il periodo che va dall’invasione
persiana all’ascesa di Cimone e, forse grazie anche al bottino conseguito con la vittoriosa
battaglia dell’Eurimedonte, una demolizione di ciò che era rimasto, poco prima dell’epoca
periclea, per poter avviare i cantieri per la nuova Acropoli dell’epoca classica.
40
Il rinvenimento delle sole fondazioni del tempio di Athena Poliàs sembrerebbe confermare
l’ipotesi di una distruzione totale per potere ricostruire da zero.
Come ho cercato di descrivere la situazione riguardante la “Colmata Persiana” rimane a
tutt’oggi molto intricata e lontana dalla sua conclusione.
Augurandomi una soluzione del problema a breve termine, auspico che il mio elaborato abbia
portato almeno un po’ di chiarezza in un quesito ricco di lati oscuri.
41
ULTERIORI ILLUSTRAZIONI
L’Acropoli Classica.
Fig. 20. Fonte: J.M. Hurwit 1999
Il Moskophoros, la testa di Athena della Gigantomachia e il torso dell’efebo di Kritios nel 1866.
Fig. 21. Fonte: J.M. Hurwit 1999.
42
I tre frontoncini appartenenti ai vari naiskos ritrovati sul pianoro dell’Acropoli:
A. frontone dell’hydra
B. frontone dell’ulivo
C. frontone dell’apoteosi di Eracle
Fig. 22, 23, 24. Fonte: J.M. Hurwit 1999.
A
B
C
43
BIBLIOGRAFIA
ANGIOLILLO 1997: S. ANGIOLILLO, “Arte e cultura nell’Atene di Pisistrato e dei
Pisistratidi”, Bari 1997.
BEJOR, CASTOLDI, LAMBRUGO 2008: G. BEJOR, M. CASTOLDI, C. LAMBRUGO,
“Arte greca. Dal decimo al primo secolo a.C.”, Roma 2008.
BEYER 1974: I. BEYER, “Die Datierung der grossen Reliefgiebel des alten Athenatempels
der Akropolis”, AA 1977, pp. 44-84.
BOARDMAN 1985: J. BOARDMAN, “Greek Sculpture. The Archaic Period. A Handbook2”
,
Thames and Hudson 1985.
BRONEER 1933: O. BRONEER, “Excavation on the North Slope of the Acropolis in Athens,
1931-1932”, AJA 2, 1933, pp.329-417.
BUNDGAARD 1974: J.A. BUNDGAARD, “The Excavation of the Athenian Acropolis
1882-1890”, Copenhagen 1974.
DICKINS 1912: G. DICKINS, “Catalogue of the Acropolis Museum, I, Archaic Sculpture”,
Cambridge 1912.
DINSMOOR 1934: W.B. DINSMOOR, “The date of the Older Parthenon”, AJA 38, 1934.
DINSMOOR 1947: W.B. DINSMOOR, “The Hecatompedon on the Athenian Akropolis”,
AJA 51, 1934.
DÖRPFELD 1885: W. DÖRPFELD, “Der alte Athena-Tempel auf der Akropolis zu Athen”,
AM 10, 1885.
DÖRPFELD 1886: W. DÖRPFELD “Der alte Athena-Tempel auf der Akropolis zu Athen”,
AM 11, 1886.
DÖRPFELD 1887, 1: W. DÖRPFELD, “Der alte Athena-Tempel auf der Akropolis zu Athen
II”, AM 12, 1887.
DÖRPFELD 1887, 2: W. DÖRPFELD, “Der alte Athena-Tempel auf der Akropolis zu Athen
III”, AM 12, 1887.
DÖRPFELD 1890: W. DÖRPFELD, “Der alte Athena-Tempel auf der Akropolis zu Athen
IV”, AM 15, 1890.
DÖRPFELD 1897: W. DÖRPFELD, “Der alte Athena-Tempel auf der Akropolis zu Athen
V”, AM 22, 1897.
44
DÖRPFELD 1902: W. DÖRPFELD, “Die Zeit des älteren Parthenon”, AM 27, 1902.
GLOWACKI 1998: K.T. GLOWACKI, “The Acropolis of Athens before 566 b.C.”,
Philadelfia 1998, pp. 79-88.
HEBERDEY 1919: R. HEBERDEY, “Altattische Porosskulptur”, Wien 1919.
HOLTZMANN 2003: B. HOLTZMANN, “L’Acropole d’Athènes: monuments, cultes et
histoire du sanctuaire d’Athena Polias”, Paris 2003.
HURWIT 1999: J.M. HURWIT, “The Athenian Acropolis. History, Mythology and
Archaeology from the Neolithic Era to the present”, Cambridge 1999.
KARAKASI 2001: K. KARAKASI, “Archaische Koren”, München 2001, pp.130-132.
KAVVADIAS, KAWERAU 1906: P. KAVVADIAS, G. KAWERAU, “Die Ausgrabung der
Akropolis vom Jahre 1885 bis zum Jahre 1890”, Athen 1906.
KISSAS 2008: K. KISSAS, “Archaische Architektur auf der Athener Akropolis. Dachziegel-
Metopen-Geisa-Akroterbasen”, Archäologische Forschungen 24, Wiesabaden 2008.
KORRES 1993: M. KORRES, “Wilhelm Dörpfeld Forschungen zum Vorparthenon und
Parthenon”, AM 108, 1993, pp. 59-78.
KORRES 1997a: M. KORRES, “Die Athena-Tempel auf der Akropolis”, in AA.VV., W.
HOEPFNER (hrsg. von), Kult und Kultbauten auf der Akropolis, Internationales Symposion
(Berlin 1995), Berlin 1997, pp. 218-245.
LINDENLAUF 1997: A. LINDENLAUF, “Des Perserschutt der Athener Akropolis”, in “Kult
und Kultbauten auf der Akropolis”: Internationales Symposion vom.7 bis 9 Juli 1995 in
Berlin, W. HOEPFNER, Archäologisches Seminar der Freien Universität Berlin, Berlin 1997,
pp.46-115.
LIPPOLIS, LIVADIOTTI, ROCCO 2007: E. LIPPOLIS, M. LIVADIOTTI, G. ROCCO,
“Architettura greca. Storia e monumenti dal mondo della polis dalle origini al V secolo”,
Milano 2007.
MONACO 2004: M.C. MONACO, “La colmata persiana: appunti sull’esistenza e la
definizione di un fantasma”. Riflessioni su M. STESKAL, “Der Zerstörungsbefund 480/79
der Athener Akropolis. Eine Fallstudie zum Etablierten Chronologiegerüst”, Hamburg 2004,
pp. 262, 86figg., ASAtene 82, 2004, pp. 487-496.
NYLANDER 1962: C. NYLANDER, “Die sogenannten mykenischen Säulenbasen auf der
Akropolis in Athen”, in OpAth 4, 1962, pp. 31-77.
45
OSANNA 2001: M. OSANNA, “Pausania sull’Acropoli”, in MEFRA 113, 2001, pp. 321-
340.
PALAGIA, BIANCHI 1994: O. PALAGIA, R.S. BIANCHI, “Who invented the claw
chisel?”, in OJA 13, 1994, pp. 185-197.
REISCH 1896: E. REISCH, “Heraklesrelief von Lamptrae”, in AM 21, 1896.
SANTI 2010: F. SANTI, “I frontoni Arcaici dell’Acropoli di Atene”, Roma 2010.
SCHOLL 2006: A. SCHOLL, “Die Akropolisvotive aus dem 8. Bis frühen 6. Jahrhundert
v.Chr. und die Staatswerdung Athens”, Jdl 121, 2006, pp. 1-173.
SCHRADER 1939: H. SCHRADER, “Die archaischen Marmorbildwerke der Akropolis”,
Frankfurt 1939.
SHAPIRO 1989: H.A. SHAPIRO, “Art and cult under the tyrants in Athens”, Mainz am
Rhein 1989.
STEWART 1990: A. STEWART, “Greek sculpture. An exploration”, New Haven & London
1990.
TÖLLE-KASTENBEIN 1993: R. TÖLLE-KASTENBEIN, “Das Hekatompedon auf der
Athener Akropolis”, Jdl 108, 1993, pp. 43-75.
46
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
AA = Archäologischer Anzeiger
AM = Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung
AJA = American Journal of Archaeology
ASAtene = Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle Missioni italiane in Oriente
DAI = Deutsches Archäologisches Institut
Jdl = Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts
OJA = Oxford Journal of Archaeology
OpAth = Opuscula Atheniensia
47
LISTA DELLE ILLUSTRAZIONI
Fig. 1. Mappa dell’Acropoli e delle pendici meridionali 5
Fig. 2. Mappa dell’Acropoli e delle pendici meridionali 6
Fig. 3. Mappa dell’Acropoli e delle pendici meridionali 7
Fig. 4. Trabeazione dell’Archaios Neos reimpiegata nel muro nord dell’Acropoli 8
Fig. 5. Mappa dell’Acropoli e delle pendici meridionali 9
Fig. 6. Terrazza a sud del Partenone 10
Fig. 7. Mappa dell’Acropoli e delle pendici meridionali 11
Fig. 8. Il decreto Hecatompedon 19
Fig. 9. Ipotetica ricostruzione dei due frontoni dell’Hecatompedon 21
Fig. 10. Ricostruzione dell’Acropoli nel VI sec. a.C. 22
Fig. 11. Le fondazioni Dörpfeld 22
Fig. 12. Le due teorie di ubicazione dell’Hecatompedon 26
Fig. 13. Mappa dell’Acropoli con allineamento Hecatompedon ed Archaios Neos 27
Fig. 14. Scultura di Athena dal frontone della Gigantomachia 29
Fig. 15. Mappa dell’Acropoli e delle pendici meridionali 30
Fig. 16. Sezione nord-sud della terrazza meridionale del Partenone 33
Fig. 17. Estensione del Porosschicht nella terrazza a sud del Partenone 35
Fig. 18. Pianta delle pendici settentrionali dell’Acropoli con i pozzi scavati 36
Fig. 19. Architravi reimpiegati nel muro cimoniano 37
Fig. 20. L’Acropoli Classica 40
Fig. 21. Il Moskophoros, la testa di Athena e il torso dell’efebo di Kritios 40
Figg. 22, 23, 24. I tre frontoncini appartenenti ai naiskos 41
48
SITI INTERNET CONSULTATI
http://www.academia.edu/
http://www.ajaonline.org/
http://www.dainst.org/it/
http://www.jstor.org/
https://openlibrary.org/
























































![[Intro; with F. Gambetti] From Parmenides to Plato: an overview - Da Elea ad Atene: verità, linguaggio, politica in G. Casertano et al., Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6337b6d5ce400ca6980922d3/intro-with-f-gambetti-from-parmenides-to-plato-an-overview-da-elea-ad-atene.jpg)