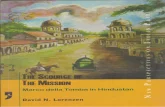Sussurri arcani dalla Tomba Monumentale M di Orthi Petra, Eleutherna Il contributo dell'indagine...
Transcript of Sussurri arcani dalla Tomba Monumentale M di Orthi Petra, Eleutherna Il contributo dell'indagine...
Sotto l'Alto Patronato di S.E. il Presidente della Repubblica Ellenica Dott. Karolos Papoulias
e di S.E. il Presidente della Reppublica Italiana On. Giorgio Napolitano
, P R,I N C I P E S SE' del Mediterraneo all'alba della Storia
MUSEUM OF CYCLADIC ART N1CHOLAS ANO DOLLY GOULANDRIS l-ou'~nA TION
• • • • • • •
Catalogo a cura di
NIKOLAOS CHRISTOS STAMPOLIDIS
con la collaborazione di MIMIKA YANNOPOULOU
Promosso e ideato da
TIANEflILTHMIO KPHTIE ~ UNIVERSITY OF CRETE ~
HELLENIC REPUBLIC Ministry of Education and Religious Affairs Culture and Sports
Con il contributo dell'Ambasciata di Grecia a Roma
Atene 2012
Fig. 1. La lastra rinvenuta al di sopra della base per incensiere, ricolma di vaghi e gioielli, ora rimossi. Si conserva in maniera straordinaria la mascella di una delle defunte dell'edificio M.
Sussurri arcani dalla Tornba A10nuntentale JJ1 di Orthi Petra, Eleutherna:
Il contributo dell 'indagine antropologica
Inginocchiandoci con reverenza, all'interno dell'edificio tombale monumentale M, ci
siamo trovati davanti ai corpi di quattro donne affidate all'abbraccio protettivo della
Madre Terra per l'ultimo viaggio nell' Aldilà, obbedendo al richiamo, in un istante privo
di respiro, di divini suoni taciuti che tramandavano il significato e lo scopo del loro
trasporto nei campi di asfodeli ...
Nel tempo, all'interno dell'edifìcio tombale M si sono accumulati strati archeologici, a
seguito di eventi che comprendevano non solo i premurosi preparativi ali 'inumazione per
la vita ultraterrena, ma anche la successiva osservanza dei riti e delle tradizioni funebri,
nonché processI tafonomici verificati si nel corso dei successivi secoli e millenni.
Inoltre, processi diacronici dei mutamenti diagenetici a carico dei resti organici e
inorganici delle quattro inumate hanno alterato il materiale antropologico, costituito,
di conseguenza, da resti scheletrici parzialmente preservati (fig. 1). La composizione
strutturale di un notevole numero di ossa conservatesi ha evidenziato superfici
alquanto fratturate e deteriorate. Nonostante ciò, è stato possibile acquisire alcuni dati
particolarmente impOitanti, indclebilmente impressi sulle ossa e sui denti delle defunte.
Fondamentali indizì riguardanti la loro complessa condizione umana sono stati ricavati
grazie a un'attenta indagine osteologica e rispecchiavano caratteristiche della variabilità
genetica e/o epigenetica, aspetti dei processi biologici di sviluppo e, in alcuni casi, perfino
dei processi di degenerazione dovuti all'invecchiamento. Prendendo in considerazione
parametri legati all'ambiente fisico, sono state inoltre identificate patologie acquisite
in vita o effetto delle conseguenze, dirette e/o indirette, di usi culturali che spazi ano
dalla dieta a questioni motorie, oppure ancora risultato di scelte o di esigenze imposte da
abitudini, strutture e modelli socio-culturali. Tutti questi dati, assieme all' analisi di tipo
archeologico, hanno costituito preziosi tasselli del singolare lavoro di ricostruzione e
decifrazione della vita condotta da queste quattro donne.
Dopo aver completato la raccolta e la documentazione del materiale antropologico e con
l'aiuto delle analisi fisico-forensi, tuttora in corso (fig. 2), è stato possibile concludere,
grazie a un processo deduttivo a carattere interdisciplinare, che tre delle quattro donne
erano state deposte l'una molto vicina all'altra, in posizione supina e distesa, disposte con
orientamento nord-sud sul pavimento dell'edificio funebre. La quarta donna, di età più
avanzata, era stata deposta a contatto con le altre, ma in posizione di maggior riguardo,
seduta su un trono, come se sorvegliasse le tre donne più giovani durante le operazioni
all' interno del contesto funerario e al tempo stesso presidiasse a imperscrutabili questioni
legate a forze invisibili. I piedi poggiavano sul pavimento dell'edificio tombale, a
contatto col busto della seconda e della terza donna, che le si trovavano più vicino; i piedi
e le cosce, invece, ricoprivano leggermente la regione del torace e del ventre della terza
donna, che si trovava più vicino a lei.
L'analisi antropologica ha consentito di stabilire che le quattro donne erano state deposte
l'una accanto all'altra, secondo un ordine ben preciso, non casuale, correlato alla loro età
biologica - dalla donna più giovane alla più anziana, seduta. Così, la donna più giovane,
che ai fini dello studio antropologico è stata convenzionalmente chiamata 'H', dell 'età
di circa 13 anni e mezzo, era posta a una distanza maggiore dalla donna più anziana.
A seguire erano, nell'ordine, la defunta 'N', dell'età di circa 16 anni, e la defunta 'Y',
dell'età di circa 28 anni, che giaceva accanto alla quarta e più anziana defunta, denominata
T', di circa 72 anni d'età.
Sulla base delle stime archeo-antropologiche effettuate in situ, e prendendo in
considerazione i dati della stratigrafia culturale in relazione alla variabilità del substrato
(a un livello sia geopedologico, sia culturale) sul quale erano stati deposti questi corpi,
ma anche considerando le relazioni particolari della disposizione anatomica, nonché
i numerosi eventi precedenti e successivi il seppellimento, capaci di influenzare
l'assestamento dei tessuti corporei prima e dopo i processi diagenetici determinati
da fattori geodinamici e tafonomici (i cui risultati visibili si rispecchiano nella natura
dell'accumulo e della sequenza degli strati archeologici e dei gruppi di sedimenti
eterogenei), attivi all'interno dell'edificio funerario M, è stato possibile concludere che le
quattro donne furono deposte nel corso di un processo contiguo nello spazio e nel tempo.
Stando a quanto esposto, sembra che le donne H e Y siano state senz'altro deposte per
prime, andando a costituire la stratigrafia laterale iniziale delle sepolture, in due fasi
successive; prima, con ogni probabilità, fu la donna H e seconda fu la donna Y. La
posizione supina e quasi completamente distesa dei loro corpi delimitò uno spazio quasi
rettangolare, che avrebbe ospitato le salme alla fine della loro vita mortale. La posizione
delle donne H e Y, con le cosce rivolte in modo da essere leggermente contrapposte, a
sinistra e a destra rispettivamente, in combinazione con le ginocchia lievemente flesse,
indirizzava le superfici plantari dei piedi destri in una convergenza contigua di flessioni
plantari, delimitando uno spazio quasi isoscele tra le gambe; qui era stato deposto sul
pavimento, tra gli altri oggetti, anche un vaso di bronzo, il cui perimetro superiore era
toccato dalle superfici dorsali delle gambe e dei piedi delle donne, laddove i piedi sinistri,
disposti simmetricamente, rispecchiavano la disposizione anatomica dei piedi destri.
Di seguito fu deposta la donna N, in posizione supina e distesa tra le donne H e Y; il
braccio destro poggiava mollemente sul braccio sinistro della donna Y, mentre il br~ccio
sinistro copriva in parte quello corrispondente, destr~, della donna H. In seguito a tale
deposizione, i busti delle tre donne più giovani aderivano l'uno all'altro, in successione,
con relazioni spaziali isometriche tra le teste; invece, le estremità inferiori della donna
N, completamente distese e leggermente flesse alle ginocchia, coprivano le gambe della
donna H. Allo stesso tempo, la parte laterale destra della gamba destra della donna N
toccava il lato sinistro del succitato vaso bronzeo.
Fig. 2. L'analisi del materiale osseo nel laboratorio di restauro del Museo Archeologico di Iraklio.
a
Fig. 3. Dallo scavo delle inumazioni nell'area orientale dell'edificio M, all'interno dello spazio rettangolare irregolare. Si distinguono il cranio e le ossa della defunta r e delle. defunte Ye N.
La donna r fu deposta per ultima, poggiata su un trono, molto probabilmente
dotato di una base costituita da un unico pezzo di legno. Le cosce, le
ginocchia flesse e il terzo superiore delle gambe che sporgevano, coprivano
la parte superiore del corpo della donna Y, segnatamente il torace e la regione
addominale superiore (dal livello acromio-sterno-clavicolare fino alla regione
epigastrica). Le superfici posteriori dei due terzi inferiori delle gambe della
donna r (dal li vello della tibia fino all' area posteriore prossimale I del tallone)
erano disposte nel seguente modo: la regione destra toccava la regione laterale
sinistra del gomito sinis,tro della donna Y e il lato destro del gomito destro
della donna N, mentre il corrispondente lato sinistro delle gambe della donna
r toccava la regione della scapola e della spalla destra della donna N. Le
superfici plantari dei piedi della donna r toccavano il terreno: la pianta destra era in
parte coperta dalla regione addominale destra della donna N, mentre la regione del tarso
e del tallone del piede sinistro era in posizione laterale rispetto alla regione delimitata
dall'estremità superiore della spalla della donna N, con le aree metatarsiche e delle
falangi distali2 dello stesso piede assicurate sotto la nuca della donna N.
Dal punto di vista antropologico, indipendentemente dalla ricchezza e dall'unicità dei
beni di corredo e dagli altri dati archeologici, se si prende in considerazione il criterio
della particolare collocazione delle quattro donne all'interno della camera funebre
dell'edificio M come componente basilare di un processo di sepoltura e di un più generale
rituale funebre indicativo, a quanto sembra, di rispetto e venerabilità, questa sepoltura può
essere definita come lo specchio concettuale di alcuni soltanto dei numerosi aspetti di un
processo arcano e particolarmente sofisticato; tale processo comprendeva lo spostamento
e il trasferimento delle peculiarità, possibilità e funzioni di questo gruppo di donne dalla
vita mortale a quella eterna.
I corpi di queste quattro donne, deposti in ordine successivo eppure differenziato nel
suo uso gerarchico della tridimensionalità fra le tre donne più giovani e la quarta, la
più anziana, offrivano una serie interconnessa di forme, come a creare una continuità,
dalla più giovane alla più anziana e viceversa, rispecchiando cosÌ una progressione,
una successione e probabilmente anche una precedenza all'interno del gruppo delle tre
donne più giovani, soggette a essere controllate o anche guidate dalla donna più anziana,
superiore quanto a gerarchia e responsabilità.
l. Nella descrizione dell'anatomia scheletrica, col termine 'prossimale' si indica la posizione anatomica che si trova più vicina al cranio.
2. Nella descrizione dell'anatomia scheletrica, col termine 'distale' si definisce la posizione anatomica che si trova più lontana dal cranio.
Come in un'improvvisa pausa prosodica di parole e frasi alate, assiomi proverbi ali di una
saggezza non convenzionale, giacevano unite tra loro in muta comunicazione, le teste
collocate con dignità e con precisione quasi assoluta lungo uno stesso profilo lineare.
La profonda dedizione, l'amicizia e il senso del dovere erano rimasti immutati, incapaci
di essere cancellati dal passare dei secoli. I dettagli di un simile spettacolo, seppur
radicati nell'ambiente fisico dell'edificio tombale M, aleggiavano nella sfera del Tempo,
con l'ambiziosa intenzione di restare animati in eterno. Per quanto le funzioni interne
di un simile animismo siano incomprensibili e sfuggenti agli occhi di un osservatore
non iniziato, i suoni emessi dalle vive impressioni e dalle relazioni simboliche di questo
gruppo di quattro donne hanno sconfitto l'assenza di parola, un dato loro imposto come
contratto fatale, ma incapace di fermare il senso della preparazione del contesto, della
deposizione e dell'affinità degli oggetti del corredo funerario.
Eppure, il simbolismo espresso e le relazioni apparenti tra queste quattro defunte, rivelati
dalla loro singolare disposizione funebre, dovevano essere avvalorati da ulteriori aspetti,
emersi dalla catalogazione dei resti scheletrici; ciò ha permesso, come suoni della
circostanziata relazione di un testimone oculare, senza tuttavia le affrettate implicazioni di
tecniche distruttive di natura archeometrica e forense su materiali insostituibili, di gettar
luce su importanti condizioni e circostanze della loro vita precedente la morte, perfino su
una serie di qratteristiche fisiologiche genetiche e congenite, elementi imprescindibili
della loro costituzione scheletrica.
La predominanza di un certo numero di evidenti caratteristiche morfologiche dentarie
di natura epigenetica, presenti sulle superfici cliniche e anatomiche dei denti di
questi individui, è culminata nell'osservazione del tratto ereditario del Carabelli3, una
manifestazione fenotipica osservata in prossimità della cuspide mesiolinguale dei molari
permanenti superiori, che qui si riscontra con una frequenza superiore rispetto a quelle
osservate in altre popolazioni europee. Tale tratto può apparire bilateralmente, più spesso
simmetricamente tra i corrispondenti denti sinistri e destri della mascella superiore, e può
presentare quattro gradi di espressione; essi vanno dalla forma a fossa, a quella a solco, a
quella a rilievo cuspidale, fino al tubercolo/escrescenza.
3. Descritta per la prima volta dal Carabelli, nel 1844. Si v. Hofman-Axthelm 1981. La classificazione delle varianti del tratto dci Carabelli, nonché di altre degenerazioni della corona dentaria, si deve a Dahlberg 1963, 149-178.
La variabilità nella manifestazione (ad es., nel caso del tubercolo/escrescenza, da un
piccolo tubercolo fino a un'escrescenza pronunciata) supporta un'origine poligenica4, che
agisce sui processi di formazione delle cuspidi dei molari superiori permanenti nel più
ampio contesto dello sviluppo oro-facciale. Come ha dimostrato un notevole numero di
studi interdisciplinari, incentrati su analisi bio-culturali, un numero determinato di isolati
popolazionistici fortemente endogami presenta il tratto del Carabelli sul primo molare
superiore, con frequenze che raggiungono addirittura 1'86% (percentuale che riflette
un'endogamia ancestrale nell'ambito di una piccola comunità)5; d'altro canto, la presenza
del tratto del Carabelli sul second? e sul terzo molare superiore è caratterizzata da una
significativa diminuzione della frequenza. Alla luce di quanto esposto, va rimarcato che
le tre donne più giovani, H, N e Y, presentano il tratto del Carabelli sui primi molari
superiori, espresso bilateralmente e simmetricamente, sotto forma di tubercoli ben
evidenti.
La presenza di tale tratto in tutte e tre le donne, osservato nella sorprendente percentuale
del 100%, rappresenta un dato unico nel contesto di questo campione popolazionistico
ed è indicativa, a quanto pare, di una probabile relazione di parentela. La donna più
anziana (r) aveva già perduto la gran parte dei molari prima della morte, ad eccezione
del terzo molare superiore sinistro, che però non è stato possibile analizzare a causa della
forte corrosione delle superfici occlusali e mesiolinguali, risultato dell'invecchiamento
che ha favorito la deformazione funzionale legata allungo processo masticatorio. Anche
i secondi e terzi molari delle tre donne più giovani presentavano il tratto del Carabelli,
bilateralmente e simmetricamente, sotto forma di tubercoli meno accentuati e di fosse;
si è riscontrata anche stavolta un'incidenza di questa caratteristica dentaria ereditaria
polimorfica pari al 100%, fatto che accresce l'unicità della loro correlazione nello stesso
contesto archeologico, dal momento che la presenza del tratto del Carabelli nei secondi
molari permanenti superiori è inusuale e nei terzi molari superiori è rara6• Inoltre, la
manifestazione bilaterale simmetrica del tratto del Carabelli, soprattutto nei primi molari
permanenti superiori, suggerisce che esso si sia manifestato durante il processo di
odontogenesi a causa di fattori soprattutto ereditarÌ e non a causa di parametri ambientali.
4. Si v. Goose - Lee 1971,64-69. 5. Si v. la bibliografia relativa: Rudan - Rudan 2000, 117-128; Lauc 2003, 65-72. 6. Hillson 1996, 91.
Pertanto, è evidente che perlomeno le tre donne più giovani, data l'inevitabile esclusione
della donna r a causa dei problemi legati alla conservazione e all'età della stessa,
condividessero in misura notevole un certo numero di caratteristiche genetiche derivate
dal poDi genico di una popolazione dalle dinamiche demografiche molto limitate a causa
di un basso 'flusso genico'7 e quindi fortemente endogama.
Le caratteristiche dentarie ereditarie qui osservate, che nel caso specifico si manifestano nel
massimo grado di espressione possibile8, testimoniano condizioni di singolare parentela
genetica perlomeno tra le tre donne più giovani, rafforzando il valore simbolico delle
complesse associazioni tombali e dei costumi funerarì praticati all'interno dell'edificio
monumentale M. Oltre a confermare una comune discendenza e una parentela genetica,
ulteriori prove emerse dall'analisi antropologica e paleopatologica delle inumate hanno
chiarito aspetti sconosciuti delle loro abitudini di vita, offrendo sostanziali indicazioni
circa i primi anni della loro vita, connessi alla loro educazione in un ambiente socio
culturale definito da specifiche caratteristiche. Sulla base di dati provenienti ancora una
volta dal contesto dentario, più precisamente dalle ipoplasie dello smalt09, è stato possibile
dimostrare che tutte e tre le donne più giovani furono soggette a stress durante i primi
anni di vita. Quest'ultimo è stato caratterizzato da momenti di interruzione e successivo
miglioramento dello sviluppo biologico, che sono rimasti impressi in maniera indelebile
sullo smalto di tutte e tre le donne più giovani, sotto forma di linee di ipoplasia dello
smalto lO. Dal inomento che è possibile calcolare l'età biologica in cui si sono verificati
tali episodi di ipoplasia, si è potuto constatare un pattern ricorrente nelle tre donne più
giovani. Dal terzo al primo quarto del sesto anno di vita (all'incirca dai 3 ai 5,25 anni),
esse affrontarono complessivamente tre episodi consecutivi di stress fisico, distanti
mediamente l'uno dall'altro appena nove mesi. Tali espisodi furono così importanti da
limitare temporaneamente aspetti dello sviluppo biologico di queste tre donne, arrestando
così il funzionamento degli ameloblasti, responsabili della produzione di smalto, e
interrompendo di conseguenza la regolare formazione di questo tessuto dentale. Ogni
volta che le tre donne si riprendevano da ciascun evento stressante, l'attività delle cellule
ameloblastiche cominciava nuovamente, segnando tuttavia in maniera indelebile il dente
con una linea ipoplasica nel punto in cui lo sviluppo si era arrestato per poi riprendere.
7. Il 'flusso genico' è un concetto relativo alle dinamiche evolutive di una popolazione; esso descrive le condizioni ehe possono influenzare, permettere o impedire la distribuzione di materiale genetico allelomorfo ed è pertanto in relazione con la varietà genetica a livello interno a un gruppo/una popolazione della stessa specie.
8. Vale a dire che eccedono la percentuale del tratto ereditario del Carabelli, nel coevo campione antico, osservato nella popolazione femminile di Eleutherna.
9. Tale fenomeno fu inizialmente denominato 'difetto ipoplasico' da Zsigmondy 1893, 709-7l7. Della vasta bibliografia relativa alla natura dell'ipoplasia dello smalto dentario si v. ad es.: Sarnat - Schour 1941, 1989-2000; Goodman - Armelagos - Rose 1980,515-528; Goodman - Rose 1990,59-110; Hillson 1992, 460-466; Witzel et alii 2008, 400-414.
10. Per questioni metodologiehe si v.: Swardstedt 1966; Reid - Dean 2000,135-139; Reid - Dean 2006, 329-346; Hubbard et alii 2009, 177-189.
Le cause dell'ipoplasia dello smalto dentario sono molteplici e sono in relazione o con
l'ambiente prenatale e le condizioni di salute della madre, oppure con l'ambiente post
natale, legato a una serie di condizioni idiopatiche, come reazioni di ipersensibilità
auto-immunitaria, traumi, fattori epidemiologici (ad es. malattie infettive infantili
incluse quelle esantematiche), condizioni socio-culturali (ad es. gli effetti del cattivo
adattamento allo svezzamento), nonché fattori ambientali che causano malnutrizione
elo fame periodica. Il caso di queste tre donne, dal punto di vista qualitativo, offriva
un'occasione unica per gettar luce sulle loro condizioni di vita attraverso le ipoplasie,
che probabilmente rispecchiano anche più in generale l'ambiente socio-culturale di
Eleutherna. Sulla base dei risultati paleopatologici, nella misura in cui lo ha consentito
lo stato di conservazione delle ossa, ma anche sulla base dell'indagine scheletrica e del
profilo generale paleopatologico di un campione popolazionistico di Eleutherna loro
coevo, si è supposto che i traumi e le insufficienze alimentari vadano esclusi dal novero
dei possibili fattori che scatenarono i parametri stressogeni dei primi anni della loro
vita, causando effetti ipoplasici sullo smalto dentario. Sebbene non si possa escludere
l'ipotesi alternativa, che cioè complicazioni relative allo svezzamento siano state un
probabile fattore di stress, forse anche della manifestazione precoce di ipoplasia, si
sta valutando la possibilità che malattie infettive dell'età infantile con febbre, quindi
fattori epidemiologici relativi a una specifica fascia d'età della popolazione, siano stati i
probabili fattori che causarono tale stress in età precoce. Tali eventi di stress, derivati da
probabili patologie infettive che si manifestarono con relativa frequenza nella seconda
metà del sottogruppo d'età denominato 'infanzia 1'11 nel contesto di Eleutherna, sembra
siano perdurati come manifestazioni endemiche-epidemiologiche potenzialmente nocive,
che inesorabilmente colpirono le tre donne più giovani quando ciascuna di esse raggiunse
l'intervallo cronologico cui si è fatto riferimento.
Le manifestazioni età-specifiche di questi eventi di arresto e ripresa dello sviluppo
biologico, rivelati dall'indagine sui denti delle tre donne più giovani, che coprono un
ampio spettro di classi d'età, hanno offerto informazioni preziose su specifici fattori
fisici, sociali e ambientali ai quali erano state esposte durante i primi anni di vita.
Il. La fascia d'età 'infanzia l' riguarda il periodo della vita compreso tra la nascita e il sesto anno di vita.
I I I
_eliWI I
Tali fattori sembra si siano mantenuti con una certa costanza nel periodo coperto dalle
età delle tre donne più giovani e pare abbiano afflitto ripetutamente, per tre volte, le tre
donne, sulle quali le conseguenze furono evidenti nella prima età infantile; tali eventi
hanno interessato in sequenza dapprima la donna Y, poi (12 anni dopo) la donna N e
infine (14,5 anni dopo la prima manifestazione nella donna Y) la donna H. Dal punto
di vista paleopatologico e paleoepidemiologico, questi episodi di stress manifestatisi in
età infantile suscitano ulteriori interrogativi che esigono risposte, dal momento che una
triplice ripetitività e un'incidenza età-specifica sono state osservate, seppure con una
minore frequenza, anche sui denti del coevo campione femminile di Eleutherna12•
Di conseguenza, si sta valutando la plausibilità delle seguenti ipotesi esplicative 13 , pur
non limitandosi solo a esse: a) che condizioni idiopatiche, legate a caratteri genetid4,
possano aver reso le tre donne più giovani più suscettibili all 'impatto di malattie infettive
dell'età infantile, rispetto alle altre donne del campione coevo; b) che queste tre donne,
accomunate dalla discendenza come dimostrato dalla singolare manifestazione dei tratti
dentari ereditari, possano aver vissuto i primi anni della loro vita in un altro luogol5, dove
le malattie infettive dell'età infantile non venivano affrontate in modo particolarmente
risolutivo; c) che durante il primo periodo di vita di queste tre donne, nel territorio di
Eleutherna, possano essere stati assenti forme di aggregazione, vuoi a causa delle distanze
tra le varie aree, vuoi a causa di misure culturali imposte al fine di evitare la diffusione
di malattie infettive dell'età infantile; infine, in aggiunta alle possibilità precedenti, d)
che nel contesto sociale di Eleutherna, perfino tra persone accomunate da una stessa
discendenza, vi fossero restrizioni dettate dalla posizione sociale, che avevano generato
norme o addirittura obblighi di stratificazione sociale e particolari contesti in cui allevare
in modo preciso una prole selezionata, con la finalità, tra tutti gli obiettivi socio-culturali,
di proteggere dall'indesiderata diffusione di malattie infettive dell'età infantile.
12. Sebbene il campione relativo alla contemporanea popolazione femminile di Eleutherna possa comprendere un nucleo di attributi qualitativi e pertanto possa non essere adatto per trame risultati statistici più ampì, è tuttavia l'unico che a questo momento offra la possibilità di una prospettiva, in questo sito, per un certo numero di circostanze bio-culturali di questo specifico lasso temporale, riguardanti minimamente le donne di Eleutherna.
13. Isolate o combinate tra loro. 14. Una tale ipotesi indicherebbe una mutabi1ità genetica minore determinata da una minore distanza
biologica. Questo argomento è ancora in corso di attento studio, tramite una serie accuratamente programmata di misurazioni archeometriehe.
15. Nonostante l'assenza di prove che conducano in questa direzione, si deve prendere in considerazione una tale possibilità, che va adeguatamente tenuta in conto confrontando i dati a disposizione ed eventuali nuovi dati.
Le 'Sacerdotesse-Aristocratiche' di Eleutherna
Sebbene ulteriori dati archeo-antropologici possano meglio chiarire le circostanze che
nelle prime fasi della vita di queste tre donne causarono gli episodi di stress, che in tutti e
tre i casi esse riuscirono a superare16, è possibile che esistessero, nell'ambito del contesto
socio-culturale, adeguati meccanismi o risorse che furono evidentemente in grado di
alleviare condizioni di stress biologico in quel periodo critico che è l'età infantile.
Per quanto riguarda la donna r, la più anziana, la conservazione delle superfici dentarie
(tenendo conto delle conseguenze dell'usura e della patogenesi relativa all 'età e a processi
degenerativi) non ha permesso di effettuare osservazioni simili, eccezion fatta per quei
pochi anelli di smalto sulla superficie della corona dentaria in prossimità delle giunture
tra cemento e smalto; tali anelli hanno stimato un'età biologica dello smalto superiore
agli iniZI del primo quarto del sesto anno di vita. In ogni caso, tali superfici dentarie non
presentavano linee ipoplasiche dello smalto, come nel caso delle tre donne più giovani
e del campione femminile coevo, caratterizzato per l'appunto dall'assenza di ipoplasie
dello smalto dopo il primo quarto del sesto anno di vita (5,25 anni). Ciò è indizio di una
crescita e di uno sviluppo privi di episodi di intenso stress, che avrebbero altrimenti
segnato la formazione dello smalto, fino alla metà circa del dodicesimo anno di vita.
L'indagine dentaria delle quattro donne sepolte nell' edificio tombale M - soprattutto delle
tre più giovani, le cui superfici dentarie erano in uno stato di conservazione migliore - ha
fornito ulteriori informazioni circa la loro dieta, la quale, a quanto pare, comprendeva
alimenti preparati con notevole cura.
Tracce di usura lievemente omogenee sui denti anteriori e posteriori, in cui si erano ben
conservati il bordo incisale nel caso dei denti anteriori e le superfici occlusali nel caso
dei denti laterali, indicano che nei cibi accuratamente preparati eràno in gran misura
assenti, sia perché erano stati eliminati, sia perché non vi erano stati inclusi casualmente
o di proposito, elementi di una durezza pari o superiore a quella dello smalto dentario 17.
16. Come è testimoniato con efficacia anche dal campione antropologico della popolazione femminile di Eleutherna risalente a questo stesso periodo.
17. Avendo come punto di riferimento la durezza 5 per lo smalto dentario nella scala Mohs e la durezza lO, la più alta, per il diamante.
Le tracce di usura l8 variavano dall'appiattimento dell'apice delle cuspidi fino a una lieve
abrasione del bordo incisale nelle donne più giovani H e N19; fanno eccezione alcuni
punti isolati, soprattutto sui denti anteriori, che di solito erano impiegati anche per altri
scopi, fungendo da 'terza mano'20 e per mordere esclusivamente materiali morbidi. Un
moderato grado di usura è stato rilevato nella donna Y, mentre un grado di usura notevole
è stato documentato sulle superfici dentarie della donna più anziana (r); le condizioni
dei denti di quest'ultima sono proporzionate all'età e alle modifiche determinate dalla
masticazione nel corso della lunga vita, modifiche tuttavia indicative del consumo di
cibi sempre accuratamente preparati. Mutamenti osservabili sulle mascelle e sui denti
furono consecutivi ad alterazioni causate dalla sinergia di diversi fattori: periodontite,
lievi depositi infragengivali di tartaro, ipercementazione della radice dentaria, processi
di riassorbimento alveolare, perdita di alcuni denti durante la vita, un ascesso apicale in
via di guarigione21, spostamento di denti combinato al mutamento dell' asse di pressione
durante la convergenza masticatoria tra mandibola superiore e inferiore22, nonché infine
le conseguenze di osteoartropatia e indurimento osseo delle aree di giunzione temporo
mandi boIari.
Come rivelato dall'indagine dentaria delle tre donne più giovani, sulla base dei
cambiamenti acquisiti che si sono evidenziati sia sulle superfici dentarie cliniche sia su
quelle anatomiche, nonché delle condizioni periodontali delle ossa alveolari, è chiaro che
gli alimenti consumati contenevano adeguate quantità di ingredienti ricchi di carboidrati,
provenienti da prodotti agricoli. Fenomeni di carie al colletto23 sono stati documentati in
percentuale notevolmente maggiore rispetto ad altre popolazioni, la cui dieta si basava
su alimenti ricchi di carboidrati24 e di glucosio, ad es. quelli derivati da cereali o dal
consumo di prodotti coltivati come la vite, o perfino ricchi di lattosio assunto dal consumo
di derivati del latte.
18. Si v. Fine - Craig 1981,335-344; Johansson et alii 1993. 125-131. 19. La donna N presentava inoltre una tendenza, allo stadio iniziale, a isole di dentina su alcune zone delle
superfici occ\usali. 20.Si v. gli esempi in Molnar 1971,175-190, e Molnar 2008.423-431. 21. Si v. Alexandersen 1967,551-595; Brook et alii 1991, 123-125; Alt et alii 1998,387-415. 22. Khcra et alii 1990, 139-147. 23. Si v. ad es.: Magitot 1875; Mande11983, 926-929; Kim 1990,48-53; Hahn 1991,147-153; Ismail 1997. 13-
23; Hillson 200 I, 249-289.
24. Questo soggetto è in corso di valutazione sulla base degli studI clinici derivati dall'analisi epidemiologica di Gustafson ct alii 1954,232-364; Srecbny 1983, 148-155; Kashket el a1ii 1994,291-296.
II' W:, Le 'Sacerdotesse-Aristocratiche' di Eleutherna
Sia i denti della mascella superiore sia quelli della mascella inferiore erano affetti da carie
in egual misura, che interessava prevalentemente i denti posteriori rispetto a quelli anteriori
e, in molti casi, superficì cervicali multiple dello stesso dente. Data la documentazione di
un elevato numero di carie, che nella maggior parte dei casi interessava il collett025 e solo
in alcuni casi anche le superfici occlusali26, è probabile che queste donne consumassero
prevalentemente alimenti ricchi di fruttosio - acquisito, si propone, soprattutto dal miele,
il cui favo con ogni probabilità era trattenuto per un tempo alquanto lungo nel cavo orale
- combinato con il possibile consumo di carboidrati cotti, che forse contenevano miele o
altre sostanze dolcificanti a base di glucosio.
Quest'ultimo, assieme al fruttosio, sarebbe stato metabolizzato dai batterì del cavo orale
per le loro funzioni, innescando l'attività infettiva27 che avrebbe favorito la proliferazione
della flora batterica e la successiva deposizione di placca dentaria calcificata28; quest'ultima
è ben distinguibile sulle superfici dentarie delle tre donne, a dispetto della loro igiene
dentaria complessivamente buona, con conseguenze nocive soprattutto a livello delle
giunzioni tra smalto e cemento. L'elevata incidenza delle carie del colletto nelle tre
donne più giovani dell'edificio tombale M supera di gran lunga quella documentata
nella contemporanea popolazione femminile di Eleuthema. Ciò suggerisce che queste
tre donne avessero più facile accesso a cibi più ricchi in zuccheri rispetto alle donne di
Eleuthema loro contemporanee. Assumendo la giovane donna H, di 13,5 anni d'età, in
rappresentanza di tutto il gruppo delle tre donne più giovani, si può considerare un altro
aspetto riguardante la dieta, relativo all'assunzione di tali alimenti ricchi di zuccheri in
una fase più precoce della vita e con una frequenza superiore rispetto al coevo campione
femminile di Eleuthema.
25. Nella donna Y si sono riscontrate carie su 13 (40,625%) dei 32 denti o su 18 (11,25%) delle 160 superfici dentarie interessate (ogni dente ha cinque superfici dentarie: 32 denti x 5 superfici = 160 superfici); inoltre, su 16 (12,5%) delle 128 superfici di congiunzione tra smalto e dentina si è riscontrata carie del colletto (si eccettuano i bordi incisali e le superfici occlusali dei 32 denti: 32 denti x 4 superfici = 128 superfici) - si escludono dal computo due superfici occlusali con carie. Nella donna N si è riscontrata carie del colletto su 6 (40,0%) dei 15 denti disponibili per le analisi o su 9 (12,0%) delle 75 superfici dentarie interessate, mentre 9 (15,0%) delle 60 superfici di congiunzione tra smalto e dentina erano state colpite da carie del colletto. Nella donna H si è riscontrata carie del colletto su 5 (17,0%) dei 29 denti disponibili per le analisi o su 7 (4,82%) delle 145 superfici dentarie interessate, mentre 7 (6,03%) delle 116 superfici di congiunzione tra smalto e cemento erano state colpite da carie del colletto. L'alto numero di superfici di congiunzione tra smalto e cemento colpite da carie potrebbe ulteriormente aumentare dopo la conclusione della ricerca, ora in corso, sulla differente diagnosi tra carie del colletto e conseguenze dell'attività post mortem di bacilli acidi, in grado di causare processi di degenerazione del tessuto della dentina, nei punti di congiunzione tra smalto e cemento, tali da somigliare ai danni provocati dalla carie del colletto.
26. Ciò si è osservato solo nel caso della donna Y, la più adulta delle tre donne più giovani. La sua età ha permesso che fosse esposta per un tempo sufficiente alle condizioni che possono aver causato due carie su superfici occlusali.
27. Come quella dello Streptococcus mutans e del Lactobacillus acidophilus, responsabili soprattutto delle malattie dentarie.
28. Swardstcdt 1966; Powell - Garnick 1978, 621-624; Dobney - Brothwell 1986, 55-82; Driessens -Verbecck 1989,7-18; Licvcrse 1999,219-232.
Le 'Sacerdotesse-Aristocratiche' di Eleuthema
Quanto alla donna più anziana (O, in merito alla presenza o meno di carie e alla caduta
di numerosi denti prima della morte29, i denti preservati mostravano superfici occlusali
e bordi incisali fortemente usurati; tale dato potrebbe aver cancellato eventuali tracce
di carie cervicali. Sia i bordi incisali, sia le superfici occlusali si presentavano inclinate
lateralmente, scoprendo la dentina terziaria all'interno di una cavità, la cui estremità
inferiore era posta più in basso rispetto alla giunzione tra smalto e cemento, laddove
originariamente sarebbe insorta la carie. Appare altamente probabile che la carie del
colletto, assieme ad altri processi di usura dentaria, abbia contribuito a tali mutamenti
della superficie della corona, indebolendone la struttura attraverso un processo di graduale
erosione fino a raggiungere la polpa dentaria. Ciò avrebbe condotto alla distruzione e
destabilizzazione della porzione di corona affetta da tale processo, con un conseguente
sfaldamento della sua superficie, perfino durante le normali condizioni di masticazione.
Un' altra documentata manifestazione dentaria riguarda una singolare caratteristica,
propria delle quattro donne dell'edificio tombale M e non del campione femminile
popolazionistico di Eleutherna loro contemporaneo: la colorazione delle superfici
dentarie. Le sfumature di colorazione delle superfici dentarie di queste donne variavano
dal giallo-rossiccio (7.5YR 6/6 della scala Munsell) e dal giallo-marroncino (lOYR 6/6
della scala Munsell) al marrone intenso (7 .5YR 5/8 della scala Munsell) e al marrone scuro
(7.5YR 3/4 della scala Munsell), mostrando un aumento dell'intensità di colorazione in
relazione all' aumentare dell' età; di conseguenza, la colorazione non può essere attribuita
esclusivamente a fattori tafonomici (ad es. decolorazione dovuta all'infiltrazione di
ossidi di ferro). Sebbene sia macroscopicamente sia a basso ingrandimento non si siano
osservati, né sulle corone dentarie né sullo smalto, sintomi di un'imperfetta amelogenesi,
viene presa in considerazione l'ipotesi di ereditarietà di questo disturbo, legata a forme
autosomiche dominanti o recessive e/o recessive legate ali 'X30.
29. Si v. Lukacs 1995. 151-156. 30. Poiché la manifestazione di tale malattia, dal momento che è di tipo genetico, può essere particolarmente
più alta tra parenti.
Le 'Sacerdotesse-Aristocratiche' di Eleutherna
In ogni caso, si sospetta che il cavo orale di queste donne sia stato esposto, in vita, a
una sostanza organica di origine vegetale con funzioni molteplici3l, tra cui anche
quella di colorante; tale sostanza sarebbe penetrata, provocando la colorazione della
corona dentaria32• L'intensità della colorazione dipendeva dalla durata, dall 'incidenza e
dagli effetti cumulativi dell 'impiego di tale sostanza, a seguito di penetrazione e/o di
reazioni chimiche a carico delle zone acellulari più sottili dello smalto e della sostanza
intercellulare della sotto stante dentina33• Tale fenomeno era molto evidente sui bordi
incisali e sulle superfici occ1usali, come mostrato dall'assottigliamento dello smalto,
nonché a livello di isole di dentina non pienamente formate (nel caso della donna N), di
isole di dentina già esposte (nel caso della donna Y) e ancor più sulle superfici occlusali
e sui bordi incisali fortemente usurati (nel caso della donna n. Le manifestazioni di
colorazione dei denti di tutte e quattro queste donne suggeriscono che esse siano state
esposte a fattori ad alto potenziale colorante, fatto che rivela l'assenza di fondamentali
differenze interne al gruppo riguardo a questo aspetto. Tali informazioni ulteriori vanno
ad aggiungersi alle manifestazioni fenotipiche derivate da fattori ereditari e all' insieme di
tutte le altre manifestazioni finora documentate, che rispecchiano le relazioni particolari e
interdipendenti tra queste quattro donne sepolte nell'edificio tombale M.
Bisogna ammettere che, sebbene i denti delle quattro donne fossero in uno stato di
conservazione migliore rispetto ai rimanenti resti scheletrici, si sono potuti ottenere dati
importanti anche dalle ossa craniche ed endocraniche, in aggiunta alle informazioni fornite
dall'indagine dentaria; si sono cosÌ ottenuti nuovi dati, relativi soprattutto a questioni
di biologia scheletrica e di plasticità delle ossa, indici mio-scheletrici che riflettono il
movimento durante la vita e lo stress da lavoro abituale, ma anche la paleopatologia.
31. Tale sostanza poteva avere diversi impieghi c non essere esclusivamente di tipo alimentare. Durante l'indagine antropologica, ora in corso, si prende in esame una serie di sostanze derivate dai fiori, dai frutti e dalle foglie di alcune piante aromatiche, incluso il Papaver somniferum.
32. Va riconosciuto (sebbene ciò non valga nel caso di questo specifico materiale dentario) che, in casi di amclogcnesi imperfetta, l'insufficiente mineralizzazione e/o la presenza di uno strato più sottile di smalto dentario e il conseguente processo di mineralizzazione precoce possono favorire una maggiore colorazione delle superfici dentarie tramite l'assunzione o la masticazione di diverse sostanze.
33. Lo strato superiore-esterno di dentina primaria, coperto dallo smalto dentario.
Le 'Sacerdotesse-Aristocratiche' di Eleutherna
1/ I Si è data grande importanza allo studio delle componenti scheletriche dell'asse I endocranico34, integrato dall'indagine dello scheletro degli arti, al fine di acquisire
informazioni relative allo sviluppo successivo i primi anni d'infanzia e, ave possibile
(per le donne Y e r), fino ai primi anni dell' età adulta35• Si è potuta in tal modo constatare
l'assenza di ostacoli o di condizioni debilitanti, tali da impedire i processi di sviluppo
corporeo e che d'altro canto avrebbero lasciato chiari segni di stress sul materiale
osseo. Tenendo conto dei fattori limitanti, imposti dalla conservazione parziale del
materiale scheletrico, è stato possibile constatare che, a dispetto della costituzione
anatomica relativamente gracile, tutte e quattro le donne svolsero, fino a quando il
sopraggiungere della morte non ne impose la sospensione, attività che richiedevano la
partecipazione coordinata di tutto il sistema mio-scheletrico, senza tuttavia osservare
mutamenti scheletrici imputabili ad attività particolarmente faticose, tra cui ad es.
- ma non solo - il sollevamento di pesi eccessivi e i conseguenti effetti traumatici.
Tali considerazioni chiariscono aspetti della vita di queste quattro donne, suggerendo
una sistematica astensione da attività fisiche impegnative36, nell'ambito delle diverse
mansioni femminili. Questa condizione trova riscontro in quanto osservato anche nel
campione coevo femminile di Eleuthema, che evidentemente apparteneva a un ceto
sociale elevato37•
Tuttavia, sembra che le due donne più anziane (Y e r) non si astenessero del tutto
da attività relativamente intense, che richiedevano un movimento continuo e preciso
della parte superiore del corpo. Tali processi hanno riguardato le articolazioni sterno
c1avicolari e delle estremità superiori, spalla e gomito, nonché l'articolazione distale
del polso, mettendo in moto i muscoli agonisti con i loro corrispondenti antagonisti, al
fine di preservare un angolo di circa 45° tra la spalla e l'omero e le braccia abdotte e in
parziale estensione, come ad es. richiede il lavoro di filatura all' arcolaio. Testimonianze
delle conseguenze di movimenti ripetuti, eseguiti regolarmente e per un lungo periodo
di tempo durante la loro vita, sono anche fornite dalla precoce comparsa di mutamenti
osteo-artropatici, evidenti sull'articolazione distale dell'avambraccio, in concomitanza
con un focolaio osteo-sclerotico a livello dell'articolazione del gomito nella donna
Y, mentre importanti mutamenti osteo-artropatici, accompagnati da aree fortemente
interessate da processi osteo-sclerotici, erano dominanti sulle articolazioni degli arti
superiori della donna più anziana (r).
34. Con particolare attenzione agli elementi dello sviluppo corporeo. 35. Dai 18 ai 20/21 anni d'età, vale a dire i primi anni della cd. 'prima età adulta' (18-25 anni). Tale termine
designa una fascia d'età, in stud'ì bio-archeologici e demografici, che non prende in considerazione modelli culturali antichi, come ad es. questioni riguardanti la fertilità, i riti di passaggio all'età da matrimonio e la procreazione.
36. Come ad es. la partecipazione forzata ad attività agricole, che solitamente procurano stress dovuto al trasporto di pesi eccessivi o a traumi.
37. Si v. Agelarakis 2010.
w ..... _-.;,4""1;..1131 Le 'Sacerdotesse-Aristocratiche' di Eleutherna
Per quanto consentito dallo stato di conservazione, l'indagine ossea della donna r ha
evidenziato un quadro di salute relativamente buono e di notevole longevità. Afflitta
dalle inevitabili conseguenze della vecchiaia, come osteoporosi e disturbi spondilo
artropatici, con frequenti manifestazioni di dolorose infiammazioni e gonfiori a carico
delle articolazioni durante gli ultimi anni di vita, la donna r presentava tuttavia un
notevole grado di sopportazione; i segni delle inserzioni muscolari a livello degli
arti inferiori, afflitti anch'essi da osteoartropatie, hanno fornito prova di movimenti
locomotori lunghi e continui, nello splendido territorio di Eleutherna.
Le relazioni tra queste quattro donne, inizialmente emerse dal complesso simbolismo
tombale, erano destinate a superare l'angusto contesto funerario, fino a riflettere
l'ambiente sociale di appartenenza in vita, illuminando aspetti della loro vita e
permettendo perfino di ricostruire la sfera del loro passato attraverso parentele
ancestrali precedenti la loro vita. È unica la storia di queste quattro donne e delle
relazioni particolari che esse avevano intrecciato prima della morte e che erano
inevitabilmente destinate a continuare anche nella esistenza ultraterrena. Le relazioni
e le importanti esperienze di vita condivise dalle quattro donne dell'edificio tombale
M hanno trovato un comune denominatore perfino nell'assenza di prove, nell'ambito
dell' indagine scheletrica, che avrebbero potuto indicare la causa della loro morte in
una costrizione, una violenza o nelle conseguenze di un trauma fisico. Sebbene l'ampio
range temporale coperto dall'età di queste quattro donne potesse suggerire, come
possibile causa di morte, una malattia infettiva, non si hanno dati archeo-antropologici
coevi a questo periodo e relativi allo stesso ambiente che possano provare un'ipotesi
simile. Tra le poche ipotesi ancora in corso d'indagine vi è una proposta, che cioè in
una circostanza temporale iscritta sulle pergamene di Clio, forse determinata da un
evento di portata storica, e in un'espressione assoluta di sacrificio volontario, in un
comportamento pregno di rispetto e obbedienza mosso da un obbligo morale e dai
dettami della virtù e della coscienza, con dedizione e fede nel compimento legale e
onesto delle azioni richieste da determinate posizioni socio-culturali e/o per pietà,
devozione e obbedendo a un giuramento di sudditanza all'occulta esistenza del divino,
una sostanza dagli effetti mortali, e forse con un precursore sonnifero, che aveva lo
scopo di chiamare Atropo ad agire, abbia permesso alle quattro donne di travalicare
insieme i limiti e di continuare in eterno, l'una in compagnia dell'altra, i propri doveri
e le proprie funzioni nei campi di asfodeli di Ade.
Bisogna ammettere che probabilmente non conosceremo mai i loro nomi, i loro pensieri
e le responsabilità di ciascuna di esse, le loro ambizioni, le loro speranze, i loro sogni.
Eppure, guardando fugacemente aspetti delle significative e complesse relazioni che
intercorrevano tra di loro nell' antico sciogliersi di questo arcano enigma e nella narrazione
che si è finora decifrata, si possono scoprire avvenimenti di eccezionale importanza. In
tal modo si è svelato un legame ancestrale, ma si sono anche avvertiti la responsabilità e
l'obbligo di indagare più a fondo, al di là dei fondamenti percepibili, nella speranza che
un' ulteriore ricerca interdisciplinare e un lungo studio basato su processi metodologici e
su un' analisi accurata possano illuminare ulteriormente l'ispirata sequenza di eventi e gli
splendidi risultati ottenuti dagli antichi abitanti di Eleuthema38 •
Pro/. Anagnostis Pan. Agelarakis
3S. Desidero esprimere la mia più viva riconoscenza al mio collega. il prof. N. Chf. Stampolidis. Direttore del Museo di Arte Cic1adica. che scava a Orthì Petra. per la fiducia di lunga data e il sostegno offcrtomi durante i venti anni della nostra collaborazione a Elcutherna. Ringrazio anche la sig.ra Argyrò MoutafìAgelaraki per le sue cure, le attenzioni e l'aiuto offerto durante gli anni di scavo a Orthì Petra.
Le 'Sacerdotesse-Aristocratiche' di Eleutherna