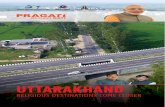«Non come si troveranno gli uomini del futuro, bensì come saranno…». Il “realismo politico”...
Transcript of «Non come si troveranno gli uomini del futuro, bensì come saranno…». Il “realismo politico”...
1
«Non come si troveranno gli uomini del futuro, bensì come saranno…».
Il "realismo politico" di Weber tra problematica antropologica e tragicità
del moderno
«Qui Weber non è più il discepolo di Nietzsche,
come neppure di Darwin, egli rappresenta qualcosa di più antico:
egli è il Socrate del dialogo con Critone,
che non fugge dalla prigione, ma risponde ai suoi giovani "liberi", cosmopoliti,
che lo vogliono "liberare": non voglio vivere che qui,
io voglio finire qui come "uno schiavo e uno del luogo"».
Eduard Baumgarten
Introduzione
In un passo precedente a quello posto in esergo a questo contributo, Eduard Baumgarten,
forse il più strenuo e acuto difensore di Weber al Congresso Tedesco di Sociologia del 1964,
affermava che la difficoltà nel fare i conti con l'eredità spirituale di Weber consisteva «non nel
fatto che Weber era figlio del suo tempo, ma che noi siamo figli delle nostre angosce per le
nostre esperienze e gli facciamo dei rimproveri che sarebbe meglio rivolgessimo contro noi
stessi»1.
Evidentemente, l'esperienza era la catastrofe spirituale della Germania sotto il Nazismo;
l'intorpidimento morale e intellettuale che rese possibile ad Adolf Hitler il dominio su una
delle nazioni più colte e progredite del mondo. Weber fu, più o meno esplicitamente, accusato
di aver preparato con la sua concezione politica l'avvento del dramma nazista. O meglio: di
aver costruito una visione politica di potenza, unita a un relativismo etico di matrice nichilista,
che non poteva fornire gli anticorpi alla deriva totalitaria che sarebbe seguita2. Ironia della
1 In O. STAMMER (a cura di), Max Weber e la sociologia oggi, Jaca Books, Milano 1967; pp. 184-185, ed. or. O.
STAMMER (Hrsg.), Max Weber un die Soziologie heute, Mohr, Tübingen 1965. 2 Una tra le più influenti interpretazioni in questa chiave fu quella di Leo Strauss, che nel capitolo del suo
Diritto naturale e storia dedicato a Weber lo elevava a «più grande sociologo del nostro secolo», per poi seppellirlo
insieme alla scienza sociale moderna - vero obiettivo polemico di Strauss. Il saggio - come nota A. SZAKOLCZAI,
Reflexive Historical Sociology, Routledge, London-New York 2000, p. 59 - alza una «cortina fumogena» sull'opera di
Weber e, costruendo la figura di un pensatore che in ogni pagina della sua opera utilizza espressioni che
contravvengono palesemente al suo postulato metodologico dell'avalutatività senza rendersene conto, sminuisce
anche i punti dell'analisi che colgono i problemi e le debolezze della prospettiva di Weber. Bastino, in questa
sede, una notazione sullo stile e una sulla sostanza dell'analisi di Strauss. Per chi abbia letto direttamente l'opera di
Weber e, secondo il metodo interpretativo dello stesso Strauss, provato a intendere il pensiero dell'autore
esattamente come egli lo intendeva, appare piuttosto ovvio che Strauss faccia con Weber ciò che imputa a Weber
di aver fatto con Calvino: identifica l'essenza dell'opera di Weber «con i suoi aspetti storicamente più fecondi di
conseguenze», che si fondavano però su un «radicale fraintendimento» - al quale Strauss stesso stava
contribuendo - di ciò che Weber considerava essenziale nel suo pensiero. Fin qui lo stile. Sulla sostanza, invece,
avanziamo, a titolo esemplificativo, questo interrogativo: «se il rifiuto dei giudizi di valore [...] impedisce di
chiamare le cose con il loro nome» e, al contrario, esprimere un giudizio di valore valido significa saper
distinguere, per esempio, tra «vera religione e impostura» - e dunque anche tra il vero e il falso profeta - forse ciò
2
sorte, la reductio ad Hitlerum, sempre negata ma, negli effetti, adombrata, avvenne senza che il
diretto accusato potesse difendersi personalmente, essendo chiamato a rispondere di un
evento storico che si sarebbe prodotto ben oltre l'arco temporale della sua esistenza3. E,
infatti, la reductio si basava sulle conseguenze logiche e storiche, identificabili dalla "saggezza"
dei posteri, delle sue posizioni politiche e della sua scienza avalutativa, tanto che poté essere
mossa per interposta persona: Carl Schmitt come legittimo discepolo di Max Weber, secondo
il giudizio autorevole di Habermas4.
Se molto vi fu di ingeneroso in queste prese di posizione, è indubbio che molto vi fu anche
di controverso nelle posizioni politiche di Weber, così come nella sua sociologia politica.
Eppure la chiamata in correità per un dramma storico antecedente alla sua morte è di certo
eccessiva. Weber era un figlio del suo tempo e della sua "Germania", e non fu capace di
trascendere completamente questo suo posizionamento storico-sociale. Fu di certo più un
nazionalista che un liberale nell'accezione anglosassone del termine. Fu un patriota e un
fautore della politica di potenza per la Germania, non certo un apologeta di un
cosmopolitismo e di un universalismo astratti. Eppure, come ricostruzioni più recenti hanno
avuto il pregio di mettere in luce, seppe esercitare, al netto di questi limiti "tedeschi" e
"ottocenteschi", un giudizio più sobrio ed equilibrato di molti dei suoi contemporanei in molte
occasioni, anche durante gli anni turbolenti e tragici della prima guerra mondiale5. Riesce
difficile pensare che, ancora vivo, non sarebbe stato strenuo oppositore della meschinità e
della volgarità dell'ideologia nazista, senza peraltro dover ripudiare le sue posizioni politiche e
teoriche, certo problematiche, ma mai totalitarie.
Molto è stato scritto, in prospettiva più o meno polemica, sul Weber politico e teorico della
politica. Non sarebbe utile in questa sede alcun esercizio compilativo o alcuna presa di
posizione in una diatriba che, almeno dal contributo di David Beetham, può essere
approcciato in maniera più equilibrata rispetto agli eccessi iniziali6. Piuttosto, ciò che vorrei qui
significa per Strauss che una vera scienza sociale dovrebbe essere capace di dimostrare "oggettivamente" che, per
esempio, Gesù fu un vero profeta, e quindi il figlio di Dio fattosi uomo per la salvezza degli uomini?
Naturalmente questo Strauss non lo pensava, così come credo non pensasse davvero che fosse necessaria una
scienza sociale empirica per «parlare di crudeltà» una volta descritte con obiettività «le azioni manifeste che si
osservano in un campo di concentramento»; azioni peraltro psicologicamente supportate da un giudizio di valore
fondato su ciò che in quel momento ebbe la forza di imporsi come una "verità" scientifica empiricamente
fondata: l'inferiorità razziale dell'Ebreo. Altra questione è quella della restaurazione di una scienza aristotelica
«fondata su una conoscenza autentica dei veri fini»; ma in questo caso la durezza di Strauss contra Weber risulta
sproporzionata rispetto alla "colpa" del sociologo tedesco. Sui punti trattati cfr. L. STRAUSS, Diritto naturale e storia,
Il Melangolo, Genova 1990, pp. 44; 68; 69; 72, 60; 49; ed. or., L. STRAUSS, Natural Right and History, The University
of Chicago Press, Chicago 1953. 3 Strauss, ancora, avanza questa tesi quando può affermare che se si accompagnano le posizioni di Weber fino
alle loro «ultime concezioni, inevitabilmente giungeremo a un punto, oltre il quale la scena è oscurata dall'ombra
di Hitler». Cfr. L. STRAUSS, op. cit., p. 50. 4 Cfr. l'intervento di Habermas al Congresso del 1964 in O. STAMMER, op. cit., pp. 99-107. 5 Cfr. il seminale contributo di D. BEETHAM, La teoria politica di Max Weber, Il Mulino, Bologna 1989, ed. or. D.
BEETHAM, Max Weber and the Theory of Modern Politics, Allen & Unwin London 1974, in particolare pp. 194-202 e
la risposta di Eduard Baumgarten ad Aron al Cogresso del 1964, in O. STAMMER, op. cit., pp. 184-189. La
formazione di una logica del giudizio responsabile è il cuore dell'interesse politico weberiano nell'interpretazione
di W. HENNIS, Il problema Max Weber, Laterza, Roma-Bari 1991, in particolare pp. 253-261, ed or. W. HENNIS, Max
Webers Fragestellung, Mohr, Tübingen 1986. 6 Altro riferimento imprescindibile è l'ormai classico contributo di W. MOMMSEN, Max Weber e la politica
tedesca, 1890-1920, Il Mulino, Bologna 1993, ed. or. W. MOMMSEN, Max Weber und die deutsche Politik, 1890-1920,
3
fare, è seguire un suggerimento che lo stesso Beetham avanza: quello di approfondire
un'articolazione spesso lasciata in ombra nell'analisi di Weber, e cioè il nesso tra la sua
"visione" della politica e la sua sociologia scientifica.
Se dunque ritorno, sommariamente, sulla canonizzazione weberiana che si cristallizzò al
Congresso tedesco di sociologia del 1964, lo faccio solo perché ciò mi permetterà di mostrare
- passando attraverso le analisi essenziali dei primi interpreti di Weber - la tesi del mio
contributo: la polemica sul Weber “politico” è parte della più generale problematica weberiana,
che la scienza odierna non ha risolto, ma che anzi in essa si rivela al massimo grado di
chiarezza. Approcciare dunque il tema del "realismo politico" weberiano nel contesto della sua
prospettiva sociologica mi permetterà di mostrare l'attualità e la profondità del "problema"
Weber; quanto, cioè, esso ci dice delle aporie della nostra scienza e della razionalità moderna
nella quale siamo ancora immersi. Solo se posto sotto questa luce si può valutare in maniera
più equilibrata il "realismo" di Weber, che è il risultato del tentativo di rispondere a una
questione decisiva che il suo tempo pareva mettere sempre più in ombra al crescere della forza
dello specialismo e del punto di vista empirico sulla realtà. Partiamo perciò dal Congresso del
1964 per mostrare i limiti del ritratto che in quell'occasione fu tratteggiato.
1. Il canone weberiano: XV Congresso Tedesco di Sociologia, 1964
Furono tre le interpretazioni di Weber che, al Congresso Tedesco di Sociologia,
canonizzarono la sua figura all'interno della storia delle scienze sociali: quella di sociologo
avalutativo delineata da Parsons, quella di apologeta della borghesia sviluppata da Marcuse e
quella di teorico della politica di potenza presentata da Aron.
Parsons impone la figura di Weber quale sociologo avalutativo che costruisce una teoria
generale delle scienze sociali come risposta ai limiti delle tre tradizioni culturali che facevano
da sfondo alla sua epoca: storicismo, marxismo e utilitarismo. Ponendo al centro della
sociologia sostanziale quella giuridica e, in particolare, il concetto di potere razionale-legale,
Parsons poté costruire la figura di un Weber evoluzionista per il quale il processo di
modernizzazione trovava compimento nel capitalismo razionale borghese. Superandole,
Weber annunciava la fine delle tre "ideologie" che si rifacevano alle correnti intellettuali del
suo tempo: conservatorismo, socialismo e liberalismo. Superandole, Weber costruì la
«sociologia scientifica» quale «erede più importante delle tre ideologie», non solo per la
superiore capacità di «capire il mondo sociale e culturale» ma anche per la possibilità che
questa aveva, su base razionale, «di partecipare alla formazione di tale mondo»7.
Si potrebbe dire che Parsons contribuì a canonizzare la figura di Weber come quella di un
sociologo "disinvolto" mentre, in realtà, fu un sociologo "tragico".
Alle stesse conclusioni nell'identificazione tematica, ma con un giudizio esattamente
opposto, arriva la lettura di Marcuse: «la razionalità formale diviene senza soluzione di
J.C.B. Mohr, Tübingen 1959. Come osserva Pombeni nell'introduzione all'edizione italiana, l'opera di Mommsen,
che pure presentò per prima la visione di Max Weber come teorico della politica di potenza nazionale, ebbe il
merito di «togliere Weber dalla galleria del museo dei fondatori della sociologia e della "scienza" democratica della
trasformazione sociale, per consegnarlo alla storia della cultura europea contemporanea». In W. MOMMSEN, op.
cit., p. 13. 7 T. PARSONS, Relazione ai valori e oggettività nelle scienze sociali, p. 84 in O. STAMMER, op. cit., pp. 55-86.
4
continuità razionalità capitalistica»8 e, per questo motivo, Weber diventa un apologeta
dell'ideologia borghese, anziché essere il sociologo scientifico che apriva la strada alla fine delle
ideologie. Weber viene chiuso nella sua auto-identificazione borghese e la sua sociologia
diventa arma nelle mani della classe di appartenenza contro le possibilità di una «razionalità
storica qualitativamente diversa»9. L'accusa di Marcuse è dunque pesante, poiché rischia di
relegare Weber nella poco nobile schiera dei servitori della classe cui appartengono. Tuttavia,
lo stesso discorso potrebbe valere all'inverso, e cioè per i professionisti della rivoluzione10.
Non è dato sapere se per il rischio di ritorsione dell'accusa, o per riconoscimento della
profondità dello spirito, in ogni caso Marcuse chiude il suo intervento instillando nell'uditorio
il dubbio che, forse, già nel concetto weberiano di razionalità fosse contenuta l'ironia che lo
sconfessa: «e questa voi la chiamate ragione?»11.
Marcuse, pur non cancellando completamente l'elemento tragico dell'interpretazione
weberiana della modernità, sembra ridurlo a constatazione ironica senza conseguenze, poiché
spiega il proprium della problematica weberiana - l'interrogazione sulla razionalità moderna - nei
termini dei condizionamenti materiali del pensatore.
La definizione aroniana di Weber come politico di potenza rivela un'argomentazione che
sfiora il cuore della problematica del sociologo tedesco e, per questo motivo, merita una
trattazione un poco più estesa. Secondo Aron, Weber è «erede di Machiavelli» e
«contemporaneo di Nietzsche»12, poiché pone al centro del fenomeno politico la lotta per la
potenza; lotta che si vuole fin da subito nazionale. Al centro del suo interesse politico sta
dunque la potenza al servizio della nazione:
«Egli aveva deciso che il valore più alto, al quale avrebbe sottomesso tutto il resto nella
politica, il dio al quale avrebbe sottomesso tutto il resto nella politica, il dio (o il demone) al
quale aveva giurato fede, era la grandezza della Germania»13.
Eppure la grandezza della Germania, la potenza della nazione tedesca, era messa in
relazione alla cultura della Germania, e da fine della politica, diventa mezzo in vista di un fine
più alto: la potenza è «condizione della forza di diffusione della cultura»14. Nell'epoca dei
nazionalismi e degli imperialismi, Weber, realisticamente, riconosceva che la potenza era
mezzo indispensabile per salvaguardare ciò che di più nobile le culture nazionali avevano
prodotto. Di più: la potenza era condizione necessaria per la diffusione della cultura, ma non
era sufficiente a sviluppare cultura. Da qui l'apprezzamento delle comunità che rinunciano alla
politica di potenza per custodire e promuovere valori e virtù di differente natura e tuttavia
culturalmente significativi15.
8 H. MARCUSE, Industrializzazione e capitalismo, p. 204, in O. STAMMER, op. cit., pp. 199-225. 9 Ivi, p. 207. 10 Reinhard Bendix, nella sua risposta all'intervento di Marcuse, avanza sottilmente la possibilità di questa
ritorsione: «Se il concetto di ragione di Weber è "borghese", quale è la posizione sociale di una "critica della
reificazione e della disumanizzazione"?». Cfr. O. STAMMER, op. cit., p. 233. 11 H. MARCUSE, op. cit., p. 224, in O. STAMMER, op. cit.. 12 R. ARON, Max Weber e la politica di potenza, p. 133, in O. STAMMER, op. cit.; pp. 129-153. 13 Ivi, p. 136 14 Ibidem. 15 In maniera appropriata D. BEETHAM, op. cit., p. 187, nota come Aron ponga l'accento sulla "diffusione"
della cultura piuttosto che sulla "qualità" della cultura, come è invece in Weber. Cfr. anche, in ivi, pp. 169-183,
5
Se dunque il nazionalismo di Weber era funzionale al fine più alto di conservare e
promuovere beni di cultura che sono l'eredità spirituale della nazione, che cosa deforma in
senso pessimistico e conflittuale lo sguardo di Weber sulla realtà? Non certo una differenza di
grado rispetto ad altri esponenti della tradizione realistica sulla politica, come in altri passi
dell'intervento Aron sembra suggerire. L'impossibilità di una tale interpretazione si percepisce
dalla continua oscillazione nello stesso intervento tra asserzioni che rivendicano la politica di
potenza come valore supremo e specificazioni che emendano la perentorietà di tali
affermazioni nel senso di una funzionalità della potenza rispetto alla diffusione della cultura
come valore supremo16. A rendere distorto in chiave pessimistica lo sguardo di Weber sulla
realtà non è la sua prospettiva di potenza sulla politica ma la sua «formula politeistica»17, che
trasforma la giusta impossibilità di decidere sulla superiorità della cultura tedesca rispetto a
quella francese18, in una eterna lotta tra ideali deificati, tra loro inconciliabili. Si chiede Aron:
«È giustificato partendo da un fatto reale - che l'idea francese e quella tedesca si
differenziano - arrivare all'idea che gli dei lotteranno tra loro fino alla fine dei tempi? Posso
solo supporre che Max Weber, posseduto dall'idea della lotta sempre e ovunque presente,
abbia tramutato una rivalità di potenza incontestabile ma anche passeggera, in una lotta tra
dei. Sotto certi aspetti le rivalità di potenza mettono in gioco anche il destino di uomini e
anime. Ma non è sempre così»19.
Ed è proprio così: per Weber la posta in gioco nella potenza della nazione era il destino
degli uomini; o meglio, delle qualità umane, espresse nei beni di cultura, che le forme politiche
nazionali, nel suo tempo, sole sembravano capaci di garantire nella loro sopravvivenza e nel
loro autonomo sviluppo. Per Weber la potenza della nazione era al sevizio delle generazioni
future, perché per esse fossero conservate le più alte possibilità umane che in varie epoche le
diverse forme dell'associazione umana avevano reso concrete possibilità storiche. La nazione
l'analisi della relazione tra il concetto di Kultur e quello di nazione in Weber, alla quale ho attinto per l'analisi
critica del contributo di Aron. 16 Cfr., per esempio, R. ARON, op. cit., p. 144, in O. STAMMER, op. cit.: «Anche se avesse saputo che la
Germania guglielmina non aveva bisogno delle colonie né per la sua espansione culturale, né per il benessere della
classe operaia, la sua convinzione non avrebbe cambiato in nulla: l'interesse per la potenza era uno scopo fine a
se stesso, e rimane vero che l'espansione di una cultura ha un certo rapporto con la potenza della nazione, di cui è
espressione». Mi pare davvero difficile sostenere la posizione di un Weber teorico della potenza come fine ultimo
della politica se si ritorna sulle parole – riportate anche da Aron - chiare e commoventi, del suo testamento
spirituale riguardanti il «tipo d'uomo» degno della politica: «L'aspirazione al potere è lo strumento con cui egli
inevitabilmente si trova a operare. L'"istinto di potenza" - come si usa dire - fa perciò in effetti parte delle sue
normali qualità. E tuttavia il peccato contro lo spirito santo della sua professione ha inizio là dove questa
ispirazione al potere diviene priva di causa e si trasforma in un oggetto di autoesaltazione puramente personale,
invece di porsi esclusivamente al servizio di una "causa". Vi sono, infatti, in ultima analisi soltanto due tipi di
peccato mortale sul terreno della politica: l'assenza di una causa e - spesso, ma non sempre, si tratta della stessa
cosa,- la mancanza di responsabilità». Cfr. M. WEBER, La scienza come professione. La politica come professione, Einaudi,
Torino 2004, pp. 101; 102-103. 17 Cfr. R. ARON, op. cit., p. 145, in O. STAMMER, op. cit.. 18 Cfr. M. WEBER, La scienza come professione, cit., p. 33: «Come si possa fare per decidere "scientificamente" tra
il valore della cultura francese e di quella tedesca, io non lo so». 19 Cfr. R. ARON, op. cit., p. 147, in O. STAMMER, op. cit..
6
era proposta di umanità per l'umanità20. Mi pare, a questo proposito, che abbia detto una
parola definitiva Hennis, con la sua ricerca sul Max Webers Fragestellung, quando dimostra che la
"nazione" era per Weber «"l'ordinamento sociale" più ampio che poteva impegnare ed
improntare la "personalità"»21. La nazione, con la sua politica di potenza, era il regime politico
che solo, agli occhi di Weber, garantiva la coltivazione e lo sviluppo delle qualità umane e degli
ideali a esse connessi. La nazione era la "polis" al di fuori della quale il cittadino non avrebbe
potuto vivere e realizzarsi come uomo22.
Che poi il suo relativismo etico trasformasse gli ideali in divinità, che tra loro si scontrano
irriducibilmente, appartiene alla storia tragica della modernità disincantata, che Weber ha
lucidamente colto, mettendo in chiaro le conseguenze possibili, estreme, di una tale
condizione, in polemica con gli spiriti irenici e disinvolti; ma non a Weber è imputabile
"l'inversione" del mito platonico della caverna e di ciò che ne consegue.
Possiamo perciò dire che la definizione di Aron è giusta per quanto riguarda ciò che Weber
condivideva con il milieu culturale e intellettuale del suo tempo. È, invece, ingiusta e fuorviante
per quanto riguarda lo specifico di Weber: ingiusta poiché lo riduce a teorico della politica di
potenza, quando invece Weber, fin dove fu capace di trascendere il suo tempo, pose la
potenza nazionale al servizio degli ideali di cultura e dello sviluppo dell'umanità. Fuorviante
perché svia dalla vera posta in gioco della sua problematica, che non è quella di aver teorizzato
il politeismo valoriale, ma di aver colto la dimensione tragica di una tale condizione e di aver
tentato di rispondervi, al fine di preservare ciò che maggiormente gli stava a cuore: il destino
spirituale dell'uomo che collega la propria personalità a valori e ideali ultimi.
Questa posta ha, dunque, più a che fare con una questione di verità che non con una di
potenza e questo elemento è chiaramente sottolineato dai primi interpreti di Weber, ai quali è
necessario tornare, per poi, sulla scorta delle loro analisi, riprendere le fila del "problema"
Weber là dove fu espresso con maggiore chiarezza: nella Prolusione di Friburgo.
2. I primi interpreti di Weber: Jaspers, Löwith, Landshut e la problematica antropologico-filosofica
in Weber
Realizzate prima della canonizzazione della sociologia weberiana23 avviata dalla lettura di
Parsons24 e prima dei quattro grandi rifiuti25 che impedirono ad altre tradizioni intellettuali di
20 Mutuo, liberamente, l'espressione da P. MANENT, Les métamorphoses de la cité. Essai sur la dynamique de
l’Occident, Flammarion, Paris 2010, p. 415. Dell'opera è in corso di pubblicazione per l'editore Rubbettino una
traduzione italiana curata da G. DE LIGIO. 21 Cfr. W. HENNIS, op. cit., p. 253, nota 65. 22 Questo è il senso della citazione di Eduard Baumgarten posta in esergo. 23 Cfr. L. SCAFF, Weber before Weberian Sociology, in «The British Journal of Sociology», n. 35, vol. 2, pp. 190-215. 24 Cfr. T. PARSONS, The Structure of Social Action, McGraw-Hill, New York 1937; trad. it. T. PARSONS, La
struttura dell'azione sociale, Il Mulino, Bologna 1962 e O. STAMMER, op. cit. 25 Cfr. W. HENNIS, op. cit.; Hennis si riferisce a L. STRAUSS, op. cit., a E. VOEGELIN, The New Science of Politics,
University of Chicago Press, Chicago 1952; a G. LUKÁCS, Die Zersto rung der Vernunft, Aufbau-Verlag, Berlin 1954,
trad. it. G. LUKÁCS, La distruzione della ragione, Einaudi, Torino 1959 e a H. MARCUSE (1967), op. cit., in O.
STAMMER, op. cit.. La critica di Voegelin delle Walgreen Foundation Lectures del 1951 fu concepita in un periodo
particolare della vita dell'autore e risente fortemente dell'influenza di Leo Strauss, che proprio due anni prima,
nelle stesse "lezioni", aveva sferrato il suo duro attacco a Weber. L'interpretazione di Voegelin non rispecchia
fedelmente l'ispirazione che egli trasse da Weber per sviluppare i suo lavori sullo "spirito" della modernità. Sul
punto cfr. l'analisi di A. SZAKOLCZAI, op. cit.. Per un resoconto più equilibrato e veritiero sul debito e la critica di
7
confrontarsi senza pregiudizi sull'opera weberiana, esse offrono la possibilità di ricostruire
un'interpretazione di Weber quanto più possibile vicina alla sua intenzione profonda, allo
"spirito" della sua opera.
Karl Jaspers, allievo e amico di Weber, il 17 luglio 1920 pronunciò all'Università di
Heidelberg un discorso commemorativo per la sua scomparsa avvenuta un mese prima.
Questo discorso, che fu successivamente pubblicato e integrato dapprima da una riflessione su
Max Weber politico, scienziato, filosofo (1932) e, a distanza di quasi trent'anni, da una
Caratterizzazione conclusiva (1960-61), è particolarmente utile per ricostruire la dimensione
personale della figura intellettuale di Weber26.
Jaspers, in polemica con Rickert, definisce fin da subito Max Weber come un filosofo. Egli
fu però un filosofo in un senso che si discosta sostanzialmente dalla concezione moderna della
filosofia come costruzione sistematica di una visione del mondo, e si avvicina maggiormente
alla concezione classica del filosofo quale uomo che vive una «esistenza filosofica»27.
Un'esistenza cioè, come ha magistralmente mostrato Pierre Hadot, che viene condotta
filosoficamente nella sua interezza, come «maniera di vivere»28. Se, dunque, «il suo filosofare va
ricercato in ciò che egli fece»29, è in primo luogo alla richiesta che il suo demone interiore gli
imponeva, l'attività scientifica, che l'attenzione va rivolta.
Non appena ci si volge all'opera, sorge il problema della sua frammentarietà, della sua
natura incompiuta. Se, tuttavia, si è disposti ad accettare la natura classicamente filosofica di
Weber, si comprenderà allora che la non sistematicità della produzione weberiana non
rappresenta un limite, ma indica anzi la sua cifra distintiva. Jaspers definisce questa
frammentarietà dell'opera come «necessaria»30 poiché scaturiva dalla tensione universale della
personale «volontà della conoscenza»31 di Weber. La sua volontà della conoscenza, instancabile
e mai paga, prendeva la forma delle ricerche specifiche poiché egli riconosceva che «l'uomo
come essere finito», limitato, può sperare di «cogliere l'interezza dell'assoluto soltanto
attraverso la separazione più chiara possibile»32 dei fili che compongono l'ordito della realtà.
Esattamente nel duplice riconoscimento dell'impossibilità di realizzazione del compito e, al
contempo, dell'inevitabilità di una simile impresa per l'uomo della conoscenza - per il vero
filosofo - risiedono la nobile tragicità di Max Weber e la sua grandezza.
In una lettera indirizzata a Hannah Arendt nel novembre del 1966, Jaspers riporta una
conversazione che ebbe con Weber riguardo alla celebre conferenza Wissenschaft als Beruf. Da
giovane allievo, Jaspers pungolò Weber sulla mancanza, nel suo intervento, di considerazioni
Voegelin nei confronti di Weber cfr. La grandezza di Max Weber, ultima lezione del corso estivo del 1964
all'Università di Monaco, tradotta in italiano in E. VOEGELIN 2005, Hitler e i tedeschi, Medusa, Milano 2005, che
riprenderò nelle conclusioni di questo contributo. 26 I testi sono stati raccolti e tradotti in inglese in K. JASPERS, (ed. J. DREIJMANIS), Karl Jaspers on Max Weber,
Paragon House, New York 1989. La caratterizzazione del 1932 è stata tradotta in italiano in K. JASPERS, Max
Weber politico, scienziato, filosofo, Morano, Napoli 1969. 27 K. JASPERS, Karl Jaspers on Max Weber, cit., p. 3. 28 Cfr. P. HADOT, Esercizi spirituali e filosofia antica. Einaudi, Torino 1988; ed. or. P. HADOT, Exercices spirituels et
philosophie antique, Etudes augustiniennes, Paris 1981 e P. HADOT, La filosofia come modo di vivere, Aragno, Torino
2008; ed. or. P. HADOT, il ie c e nie re de vivre, Albin Michel, Paris 2001. 29 K. JASPERS, Max Weber politico, scienziato, filosofo, cit., pp. 79-80. 30 K. JASPERS, Karl Jaspers on Max Weber, cit., p. 5. 31 Ivi, p. 19. 32 Ivi, p. 15.
8
sostanziali riguardo al senso dell'erudizione, sul perché ci si debba impegnare anima e corpo
per essa. Dopo un primo silenzio, seguito da una seconda richiesta di chiarimento, Weber
rispose: «Per capire quanto si può sopportare, ma è meglio non parlare di simili questioni»33.
Emerge qui un secondo elemento centrale per identificare lo «spirito» di Weber e la sua
predisposizione profonda al lavoro intellettuale. Egli non si approcciava alla realtà che studiava
come a qualcosa di esterno, ma, ancora una volta filosoficamente, sentiva agire su di sé il
materiale che studiava, in modo così profondo che «nella sua grande anima viveva il destino
del suo tempo»34. Weber sentiva l'intima affinità tra il proprio destino personale - la propria
personalità - e il fato della sua epoca; conoscenza della sua anima e del fato del suo tempo
erano inseparabili. Proprio questa sensibilità, che vede nel particolare concreto la traccia
dell'assoluto, rese di portata universale la sua sociologia: cercando di ricostruire le condizioni
dell'esistenza che la realtà prepara per chi la abita, la sua sociologia è rivolta a comprendere
l'interezza dell'esistenza umana e le possibilità che ogni tempo dischiude o preclude all'uomo; a
individuare la sua posizione nel cosmo.
L'ultimo punto che dobbiamo acquisire dalle considerazioni di Jaspers è che la sua
sociologia, volta a ricostruire, con «una oggettività senza limiti», «l'intero complicato sistema di
connessioni causali»35 della realtà, ha il suo «asse centrale nel continuo riferimento all'uomo»36.
Karl Löwith, sulle orme di Jaspers, aiuta a meglio specificare il significato della portata
universale della sociologia weberiana e questa centratura antropologica. Nel saggio del 1932,
Max Weber e Karl Marx37, l'autore afferma che i due studiosi sono accomunati da uno stesso
approccio al capitalismo come «problema fondamentale» del loro tempo, poiché in esso è in
gioco l'uomo «nella sua totale umanità», che «si rivela nel "come" dei suoi rapporti sociali ed
economici»38. Löwith individua perciò al fondo della ricerca weberiana un'ispirazione
antropologica fondamentale che, al pari della convinzione di Jaspers, rende lo studioso tedesco
un filosofo-sociologo, la cui connotazione filosofica deriva da questo afflato antropologico
che innerva l'opera intera. Se nel capitalismo come oggetto di studio della disciplina
sociologica, come problema culturale fondamentale, era in gioco il destino dell'uomo, allora
«ciò che stimolava» la volontà della conoscenza weberiana «trascendeva completamente la
scienza come tale»39. Proprio perché questa centratura antropologica rappresenta il sostrato
che muove le ricerche particolari, essa non è mai esplicitata chiaramente in nessuna di esse,
poiché al contempo le trascende.
Se Jasper mostra il perché della similarità tra Weber e i grandi spiriti della filosofia greca,
Löwith spiega perché egli si sentisse distante dalla filosofia moderna che era diventata,
conformemente al processo di specializzazione, «soltanto «logica», «gnoseologia», comunque
«filosofia come disciplina speciale»40. La portata universale della frammentaria opera weberiana
risiede perciò nell'ispirazione antropologica che ricerca il significato culturale, per l'uomo, della
33 Cfr. L. KOHLER E H. SANER (eds.), Hannah Arendt/Karl Jaspers correspondence, 1926-1969, Harcourt Brace
Jovanovich, New York 1992, p. 661. 34 K. JASPERS, Karl Jaspers on Max Weber, cit., p. 9. 35 Ivi, p. 6. 36 K. JASPERS, Max Weber politico, scienziato, filosofo, cit., p. 49. 37 Traduzione italiana in K. LÖWITH, Marx, Weber, Schmitt, Laterza, Roma-Bari 1994. 38 K. LÖWITH, Marx, Weber, Schmitt, cit., p. 3. 39 Ivi, p. 8. 40 Ivi, p. 10.
9
condizione del presente in cui vive. Se Weber percepisce che nel capitalismo è in gioco il
destino dell'uomo tutto intero, ciò significa che nell'attività scientifica - il cui oggetto è il
capitalismo - è in gioco anche il destino del soggetto che realizza l'attività scientifica - l'uomo
tutto intero e non lo specialista. Questa particolare posizione nei confronti del mondo,
classicamente filosofica, impone una «saldatura» tra la facoltà propria del soggetto conoscente
- l'intelletto - e la facoltà propria dell'uomo che vuole - la sua «coscienza morale»41. Löwith
arriva, per una via un po' differente, a giustificare l'affermazione di Jaspers che nell'anima di
Weber viveva il destino del suo tempo; e non a caso cita espressamente questo passaggio della
commemorazione del 1920.
Mi pare sia proprio il riconoscimento dell'ispirazione antropologico-filosofica di Weber,
presente anche in Jaspers, che permette a Löwith di individuare una serie di elementi decisivi
dell'opera di Weber che saranno poi messi in ombra dalla canonizzazione del Weber scienziato
sociale: il senso dell'indagine storica come spiegazione del «modo in cui noi oggi siamo così
come siamo diventati»42; il comune sentire tra Weber e Nietzsche sul valore della conoscenza
della realtà «in quanto problema»43; il senso profondo dell'individualismo weberiano come effetto
del «disincanto» di ogni «oggettività»44; la razionalizzazione moderna come «fenomeno
specificatamente problematico»45; infine l'autonomizzazione dell'economico come effetto dello
svuotamento «del contenuto religioso del suo ethos»46.
Anche Siegfried Landshut, nel suo importante saggio del 1929, Critica della sociologia47, mette
in rilievo l'ispirazione antropologica e universale di Weber, mostrando una consonanza
davvero significativa tra i primi interpreti del suo pensiero. Pur inscrivendo tutta l'opera nel
quadro della sociologia come disciplina scientifica, anche Landshut precisa questo riferimento
in un modo che si avvicina molto alla connotazione filosofica di Jaspers e di Löwith. Egli
afferma che la sociologia weberiana non è diretta verso la costruzione sistematica e formale di
una classificazione del «materiale fattuale» da una posizione esterna, ma muove dall'esperienza
fondamentale della realtà come questione aperta e «dal proprio coinvolgimento nella sua
problematicità»48. Anche in questo caso, il movente fondamentale della volontà della
conoscenza weberiana è individuato nell'esperienza della partecipazione alla realtà del proprio
tempo da parte del soggetto conoscente, scienziato e uomo tutto intero. Questa esperienza di
partecipazione alla realtà è contraddistinta - e questo è l'elemento decisivo - da una natura
problematica, cioè da una costitutiva «opacità»49 del significato culturale del tempo che l'uomo
si trova ad abitare.
La scienza di Weber è perciò una sociologia storico-comparativa che cerca di ricostruire le
concrete connessioni di «motivazioni e significati» dai quali «dipende la possibilità della
41 Ibidem. 42 Ivi, p. 14. 43 Ivi, p. 16. 44 Ivi, p. 26. 45 Ivi, p. 27. 46 Ivi, pp. 37-38. 47 Il saggio è stato tradotto in italiano in S. LANDSHUT, (a cura di E. FIORLETTA), Sulle tracce del politico, Pensa
Multimedia, Lecce 2009, pp. 153-295; ed. or. S. LANDSHUT, Kritik der Soziologie, Duncker & Humblot, Mu nchen
und Leipzig 1929. 48 S. LANDSHUT, op. cit., p. 177. 49 Ivi, p. 157.
10
formazione»50 dei fenomeni del presente. Poiché le ricerche particolari muovono
dall'esperienza della partecipazione alla realtà, che è costitutivamente problematica nel suo
significato culturale per gli uomini che la abitano, Landshut può identificare la finalità della
sociologia di Weber nella volontà di «comprendere la specifica connessione delle motivazioni
che determinò il destino del suo tempo»51.
3. Il "problema" Weber
Sulla scorta dei contributi di Jaspers, Löwith e Landshut è possibile fare luce sulla
specificità del realismo weberiano. Esso si sviluppa in risposta alla questione antropologico-
filosofica che, sin dagli esordi, Weber vedeva emergere dalla particolare configurazione del
tempo che si trovava ad abitare, e che andava a scontrarsi con la direzione che le scienze del
suo tempo avevano preso. Vorrei allora mostrare la genesi del realismo weberiano come
risposta a questa problematica messa in luce dai primi interpreti di Weber52.
Essa emerge - anzi esplode -, per la prima volta solennemente, nella Prolusione di Friburgo
del 1895, quando Weber, chiamato a presentare la sua prospettiva accademica, prese posizione
contro una diffusa concezione della politica economica che impediva di interrogarsi sul
destino spirituale dell'umanità del tempo53. L'affermazione "scandalosa" è quella che titola il
mio intervento:
«Non come si troveranno gli uomini del futuro, bensì come saranno è la questione che ci
spinge a pensare al di là del vincolo della nostra generazione e che in verità sta anche alla
base di ogni lavoro di politica economica. Noi non vorremmo alimentare il benessere
degli uomini, quanto quelle qualità alle quali associamo la sensazione che creino la
grandezza umana e la nobiltà della nostra natura»54.
Il contrasto tra il verbo «trovarsi» (sich befinden) e il verbo «essere» (sein) mostra la particolare
inclinazione conoscitiva di Weber: era il destino spirituale dell'uomo, e non quello materiale,
l'interesse ultimo - inattuale - della scienza sociale weberiana. Come ha giustamente
sottolineato Hennis, tutta la produzione di Weber di quegli anni relativa alla condizione dei
lavoratori agricoli a est dell'Elba, nel possente passaggio «dal patriarcalismo al capitalismo»55,
era intonata su Nietzsche e sulla questione dell'ultimo uomo che ha inventato la felicità. Per
Weber sono le qualità umane le caratteristiche in riferimento alle quali deve essere saggiato il
50 Ivi, p. 161. 51 Ivi, p. 204, nota 90. 52 In questa prospettiva si inscrivono tre importanti contributi che hanno riproposto il "problema" Weber
attraverso una rilettura da nuovo della sua opera e della sua biografia. Cfr. W. HENNIS, op. cit.; L. SCAFF, Fleeing the
Iron Cage: Culture, Politics, and Modernity in the Thought of Max Weber, University of California Press, Berkley 1989 e
A. SZAKOLCZAI, Max Weber and Michel Foucault: Parallel Life-work, Routledge, London-New York 1998. 53 Cfr. D. BEETHAM, op. cit., p. 31: «Una delle caratteristiche del metodo weberiano era quella di trasformare in
questioni politiche argomenti che per altri erano esclusivamente di natura sociale». 54 M. WEBER, Scritti politici, Donzelli, Roma 1998, p. 16. 55 Cfr. M. RIESEBRODT, From Patriarchalism to Capitalism: The Theoretical Context of Max Weber's Agrarian Studies
(1892–93), in «Economy and Society», 15 (4), pp. 476-502.
11
portato di mutamento dei processi economico-sociali. Esse non hanno evidentemente a che
fare con «la questione della forchetta e del coltello»56:
«Vogliamo, per quel che è in nostro potere, conformare la condizione esteriore non in
modo tale che gli uomini si sentano a proprio agio, ma in modo tale che sotto la
pressione dell'inevitabile lotta per l'esistenza si conservi ciò che di meglio vi è in loro»57.
È certo difficile pensare che, nel modellare queste conclusioni «secche» e «brutali», Weber non
avesse preso spunto dall'apertura della seconda considerazione inattuale, Sull'utilità e il danno
della storia per la vita, dove il contrasto è appunto tra l'umanità dell'uomo e la felicità dell'animale
che «salta intorno, mangia, riposa, digerisce, torna a saltare»58. Ancor più evidente risulta la
diretta ispirazione nietzscheana se si pensa che il carattere specifico dell'ultimo uomo è quello
di aver «inventato la felicità»: «Una vogliuzza per il giorno e una vogliuzza per la notte; salva
restando la salute»59. Riferimento all'ultimo uomo che, non a caso, ritornerà nell'ultima pagina
de L'Etica protestante, lavoro che chiude la prima fase della ricerca weberiana relativa al tema del
destino spirituale dell'umanità sotto il capitalismo meccanizzato60.
Il tema è quello di Marx, affrontato però attraverso la prospettiva di Nietzsche. Il problema
era appunto che, nelle scienze sociali del suo tempo, e nella politica economica che si trovava a
insegnare, interessarsi del destino spirituale, degli effetti sulle qualità umane (Qualität der
Menschen) degli ordinamenti sociali suonava inattuale61. Questo è il problema di fondo in cui
rimarrà intrappolato, anche psichicamente, tutto il primo Weber: come rimanere
scientificamente rigoroso ma non irrilevante rispetto a tale questione ultima (opzione
positivista); come porre tale questione ultima senza risolverla nel normativismo materialista
(opzione marxista).
56 M. WEBER, Dalla terra alla fabbrica. Scritti sui lavoratori agricoli e lo Stato nazionale (1892-1897), Laterza, Roma-
Bari 2005, p. 118. 57 Ivi, p. 117. 58 F. NIETZSCHE, Sull'utilità e il danno della storia per la vita, Adelphi, Milano 200718, p. 6. 59 F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 200728, p. 12. 60 Cfr. M. WEBER, Sociologia della religione, I vol., Edizioni di Comunità, Torino 2002, pp. 185-186. Per una
trattazione del “problema” Weber relativamente al tema del capitalismo mi permetto di rimandare a C. SILLA, Per
una genealogia weberiana del capitalismo di consumo. Il caso del marketing negli Stati Uniti (1890-1930), in «Studi di
Sociologia», 2, 2013, pp. 141–162. Ho provato a sviluppare tema e metodo di Weber in C. SILLA, Marketing e
desiderio. Una genealogia del capitalismo di consumo, Carocci, Roma 2013. 61 Cfr. W. HENNIS, op. cit., pp. 248; 249: «Chi può negare che la civiltà europea ha potuto assumere la sua
caratteristica forma intimamente pacifica soltanto grazie a quell'arte di "espungere", neutralizzare, depoliticizzare.
Ma tutto questo costituiva per Weber un problema!»; era per lui problematico poiché le «esigenze del presente»
non erano ciò che gli stava sommamente a cuore. Quanto Weber trovasse problematica l'apparenza dell'evidenza
del punto di vista liberare sulla diffusione del benessere, lo esplicita in una lettera del 1897 diretta a Sombart: «Il
suo "ideale" puramente tecnologico, malgrado tutte le riserve, non è tuttavia un ideale se Lei non intende questo
concetto nel senso ampio in cui si dice per es. che anche un cesso ben costruito è un "cesso ideale" [...]. Oggi lei è
approdato al vecchio ideale liberale del 'massimo benessere per il maggior numero possibile', coltivando
l'ottimistica illusione di avere con ciò cancellato l'eteronomia dell'ideale. Mi rifiuto di credere che questa sia la sua
ultima parola». Cfr. ivi, p. 237.
12
4. Il realismo come scienza di realtà e l'avalutatività come risposta alla tragicità del moderno
La risposta a questo dilemma troverà risoluzione prima nella «scienza di realtà» del saggio
L'«Oggettività» conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale (1904) e, più compiutamente, nel
saggio Il senso della «avalutatività» delle scienze sociologiche ed economiche (1917).
Nel primo saggio metodologico la questione è posta nei termini del superamento della
visione dell'economia politica come «"scienza etica" su base empirica»; che cioè fondava
giudizi di valore oggettivamente validi facendoli derivare da una «specifica "concezione
economica del mondo"»62. Si scambiava «l'apparenza dell'evidenza» - cioè la generale
concordia nell'identificare il fine ultimo della politica economica e sociale nel miglioramento
del benessere materiale degli uomini - con la verità. Ecco perché Weber si era sentito inattuale,
poiché il valore che dirigeva la sua volontà della conoscenza era "oggettivamente" estromesso
dai problemi supremi della scienza cui partecipava: il suo valore era la nobiltà (spirituale)
dell'uomo. Il punto è decisivo e merita questa lunga citazione:
«[...] quando riflettiamo in maniera specifica sui problemi pratici della politica economica
e sociale (nel senso corrente del termine), risulta chiaro che vi sono numerose, anzi
innumerevoli questioni di carattere pratico, per la cui discussione si muove, in generale
accordo, da certi scopi assunti come di per sé evidenti - si pensi ad esempio ai crediti in
caso di bisogno, ai compiti concreti dell'igiene sociale, all'assistenza dei poveri, [...] a
gran parte della legislazione protettiva dei lavoratori - e che di questi scopi si discute,
almeno in apparenza, solo in riferimento ai mezzi adatti per conseguirli. Ma anche se si
scambiasse qui l'apparenza dell'evidenza con la verità - ciò che la scienza non potrebbe
mai fare impunemente - [...] dovremmo tuttavia osservare che anche questa apparenza di
evidenza dei criteri regolativi di valore svanisce non appena passiamo dai problemi
concreti dei servizi di polizia e di assistenza alle questioni della politica economica e
sociale. [...] Di certo c'è, in ogni circostanza, soltanto una cosa, che quanto più
"generale" è il problema del quale si tratta, vale a dire quanto maggiore è la portata del
suo significato culturale, tanto meno esso è suscettibile di avere una risposta
univocamente determinata in base al materiale del sapere empirico, e di conseguenza
tanto maggiore rilievo hanno gli assiomi ultimi, altamente personali, della fede e delle
idee di valore"63.
Questo è il punto decisivo dell'operazione della scienza empirica moderna, che scambia
l'apparenza dell'evidenza con la verità.
L'opzione metodologica che consente di non cadere in tale errore è quella che articola in
maniera feconda significatività personale e oggettività scientifica nella trattazione dei temi della
politica economica e sociale. La domanda è: come si possono trattare scientificamente i giudizi
di valore? Weber individua tre possibili considerazioni scientifiche dei giudizi di valore.
Innanzitutto, essi posso essere analizzati dal punto di vista dell'appropriatezza dei mezzi
rispetto allo scopo; poi è possibile individuare le conseguenze che deriverebbero dall'utilizzo
dei mezzi appropriati e dal raggiungimento dello scopo prefisso; infine, è possibile far
emergere e chiarire logicamente le idee che stanno a fondamento dei giudizi di valore stessi e
degli scopi ad essi inerenti. Questa terza possibilità di trattazione oggettiva dei giudizi di valore
62 M. WEBER, Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali, Edizioni di Comunità, Torino 2001, p. 151. 63 Ivi, pp. 154-155.
13
si congiunge alla significatività personale della trattazione scientifica: attraverso questa
operazione di chiarificazione la scienza fornisce, all'«uomo che agisce volontariamente», il
materiale per l'auto-riflessione «su quegli assiomi ultimi che stanno a base del contenuto del
suo volere»64.
Se i primi due sono obiettivi di legittima pertinenza della scienza empirica, questo terzo non
lo è, «almeno parzialmente»; esso ricade, infatti, nell'ambito della «filosofia sociale». Facciamo
però attenzione a due ulteriori specificazioni che qualificano il ragionamento weberiano sul
punto: per prima cosa l'autore precisa che tale suddivisione del sapere è attribuita alla
"consuetudine" in uso nella divisione del lavoro scientifico del suo tempo; inoltre, così decisivi
sono stati idee ed ideali nello «sviluppo della vita sociale», che non ci si può sottrarre dal
compito di trattare scientificamente i giudizi di valore e neppure di «"valutarli" criticamente»,
pur se questo compito ricade, «almeno parzialmente»65, fuori dalla scienza empirica.
Il punto é chiarito definitivamente nel secondo saggio metodologico, laddove, almeno nella
prima versione, Weber si richiama esplicitamente alla Prolusione di più di vent'anni precedente,
e in cui riconnette esplicitamente significatività e oggettività, chiarendo la relazione tra
Wertfreiheit e Wertbeziehung:
«Soltanto una cosa è fuor di dubbio: che ogni ordinamento, quale che sia, delle relazioni
sociali deve in ultima analisi, [se si vuole valutarlo,] essere sempre esaminato in
riferimento al tipo umano a cui esso, attraverso una selezione (di motivi) esterna o
interna, offre le migliori possibilità per diventare predominante. Altrimenti l'indagine
empirica non è realmente esaustiva, e neppure c'è la base di fatto necessaria per una
valutazione, sia essa consapevolmente soggettiva o pretenda invece una validità
oggettiva. Proprio questo voleva esprimere a suo tempo la mia prolusione accademica, con la quale non
posso d'altra parte più identificarmi in molti punti importanti»66.
La valutazione degli ideali che definiscono il tipo d'uomo predominante nel proprio tempo è
questione fondamentale e, al contempo, non può essere demandata all'oggettività scientifica,
pena l'errore di scambiare l'apparenza dell'evidenza con la verità. Non è attraverso la scienza
empirica che si può svelare la verità degli assiomi ultimi che ci muovono; a questa è
demandato il compito, pur fondamentale, di chiarire il loro significato, fornendo il materiale
per la scelta, sempre e irriducibilmente personale. Potremmo dire che Weber vuole salvare le
cose ultime più importanti - la ricerca della verità di quei valori ultimi che ci muovono -,
portandole fuori dalla scienza empirica moderna fin dentro la responsabilità della persona67.
Molto esplicito fu, in questo senso, nel suo intervento alla discussione del Verein für
Sozialpolitik sul tema della "produttività dell'economia" nel 1909:
«Il motivo per cui in ogni occasione mi scaglio in modo tanto aspro, con una certa
64 Ivi, p. 153. 65 Ivi, p. 153. Nel saggio Roscher e Knies e i problemi logici dell'economia politica di indirizzo storico, ancora più
indicativamente, la consueta divisione del lavoro scientifico è riferita a cause «spesso "accidentali»"». Cfr. ivi, p.
12. 66 Ivi, p. 574. 67 Così Weber in un altro punto del saggio: «[Questa posizione] l[a] si può sostenere, per esempio, non già
perché si desideri che tutti gli uomini diventino il più possibile, nel loro senso intimo, degli "specialisti"; ma,
proprio al contrario, perché si desidera vedere le decisioni di vita ultime e più personali, che un uomo deve
prendere da sé, non confuse con una formazione specialistica» Cfr. Ivi, p. 547.
14
pedanteria da parte mia, contro la commistione del dover essere con l'essere, non consiste
nel fatto che io sottovaluti le questioni relative al dover essere, ma è, tutt'al contrario, che
non posso sopportare quando problemi di importanza tale da smuovere il mondo, problemi
della più grande portata ideale, in certo senso i problemi supremi che possono animare il
petto di un uomo, vengono trasformati qui in una questione di "produttività" tecnico-
economica e fatti oggetto di discussione di una disciplina specifica qual è l'economia
politica»68.
Ecco: questo era il problema di Weber, sottrarre alle «fredde mani cadaveriche»69 del
razionalismo scientifico la decisione sulle questioni ultime relative al senso dell'esistenza e ai
beni da conservare e promuovere nella vita comune. Se tali questioni vengono lasciate alla
scienza specialistica, questa le dissolve poiché non può fare altro che abbassarle a quel livello
empirico che è il solo al quale può accedere oggettivamente e, così facendo, trasforma
l’apparenza dell’evidenza empirica in verità. L'intento di Weber era dunque di salvare l'uomo
che «ha mangiato dall'albero della conoscenza»70 dalla possibilità che un giorno il mondo si
sarebbe popolato di padroni dell'oggettività scientifica (per i quali esiste solo ciò che si può
rilevare empiricamente) titolari della parola ultima di saggezza sul mondo.
5. Conclusione: la grandezza di Max Weber
Non si può comprendere appieno la questione di Weber senza comprendere la natura di
costruzione sociale che egli vedeva dietro alla razionalità moderna. Mi pare lo abbia detto con
grande chiarezza Löwith: la razionalità moderna produce una disgiunzione tra l'uomo come
parte della realtà e la realtà stessa71. L'uomo moderno staccandosi dalla realtà, si innalza a
signore della realtà e, in questo modo, «costruisce» il significato della realtà, lo pone con un
atto di signoria. Ecco perché si può pensare "la realtà come costruzione sociale".
Per questo Eric Voegelin, uno dei più fedeli eredi spirituali di Weber, può al contempo dire
che la ricerca della verità, nella modernità più che mai, «non può essere condotta senza
diagnosticare i modi dell'esistere nella non-verità» e che il compito più urgente del nostro
tempo sia quello di «ristabilire la realtà»72 nella sua interezza. Per questo afferma ancora, «non è
possibile un ritorno a Weber, nemmeno al di là di Max Weber»73, poiché Weber aveva già
compiuto l'esito logico della scienza moderna, e l'aveva virilmente assunto sulle sue spalle,
provando a costruire una scienza sociale empirica che, sottraendolo a se stessa, salvasse ciò
che di più importante vi è nell'uomo. Non a caso Jaspers disse che, se nel secolo era esistito un
vero filosofo, quello era soltanto Max Weber74. Weber era filosofo poiché visse un'esistenza
filosofica, assumendo su di sé - secondo una rigorosa corrispondenza tra pensiero e vita -
68 Cfr. ivi, p. 444. 69 Cfr. M. WEBER, Sociologia della religione, II vol., Edizioni di Comunità, Torino 2002, p. 340. 70 M. WEBER, Saggi sul metodo, cit., p. 156. 71 Cfr. K. Löwith, op.cit., pp. 23-24, nota 23. 72 La prima affermazione è in E. VOEGELIN, Ordine storia, I vol., Vita e Pensiero, Milano 2009, p. 10, ed. or. E.
VOEGELIN, Order and History: Israel and Revelation, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1956. La seconda
è in E. VOEGELIN, Hitler e i tedeschi, Edizioni Medusa, Milano 2005, p. 242, ed. or. E. VOEGELIN, Hitler and the
Germans, University of Missouri Press, Columbia 1999. 73 Ibidem. 74 Cfr. K. JASPERS, Karl Jaspers on Max Weber, cit., p. 3.
15
l'esito nichilistico della scienza moderna, per salvare la possibilità della verità rimettendola alla
responsabilità dell'uomo che ha trovato e obbedisce «al demone che tiene i fili della sua vita»75.
Avendo compreso il potenziale tirannico della scienza empirica moderna - della sua
"oggettività" - provò a delimitarne precisamente possibilità e scopo, assumendo su di sé il peso
insopportabile della vocazione verso una professione incapace di rispondere alle questioni
veramente importanti per l'uomo. Volendo mostrarci, con il suo esempio, quale potesse essere
l'unica postura possibile (solida, sobria e intellettualmente onesta) dentro il paradosso della
razionalità moderna, Weber ci ha sopravvalutati. Noi abbiamo risolto il paradosso abbassando
quelle questioni ultime al livello al quale la scienza empirica è in grado di rispondervi. Così
facendo non solo non vi abbiamo risposto, ma fatichiamo a riconoscere l'esistenza di quel
livello più alto che è il solo al quale si possano porre quelle domande ultime senza dissolverle.
Abbiamo, appunto, perso la realtà nella sua interezza. Si potrebbe dire che abbiamo
trasformando l'esperienza in "esperimento" e, attraverso l'illusione del controllo, ci siamo
preclusi ogni accesso a quel livello della realtà non empiricamente rilevabile, eppure veramente
umano. Parafrasando Schmitt: nella scienza importa l'inconfutabilità, non la verità. Eppure
all'uomo importa la verità, non l'inconfutabilità76.
Certo non tenterò alcuna soluzione rispetto al problema capitale di questa irrazionalità della
razionalità moderna, che dice tutto sui mezzi ma nulla può dire sui fini, se non abbassandoli a
ciò che si può dimostrare empiricamente. Non dirò ovviamente nulla neppure
sull'affermazione di Voegelin relativa alla necessità di restaurare la realtà (perduta nella sua
interezza). Ciò che però mi pare si possa dire è che dalla problematica weberiana emerga quasi
necessariamente un compito che mi pare sia rimasto disatteso nei diversi canoni disciplinari
che questa grande figura ha ispirato: il compito di riconsiderare un'articolazione virtuosa tra
scienza empirica che si occupa dei mezzi, delle causazioni adeguate, e filosofia che si interroga
sui fini, sui motivi e le ragioni dell'agire. Direi che, se per Weber così come per il nostro tempo
non sembra possibile restaurare la soluzione - classica, aristotelica - della filosofia politica
come scienza politica, è certo che una prospettiva davvero realista sulla politica e sulla realtà
non possa fare a meno della guida della filosofia, oltre che della strumentazione della scienza
empirica. Così come ogni scienza empirica non può fare a meno dell'interrogazione filosofica
a patto di non essere disposta a una perdita, questa volta disinvolta e non tragica, della realtà.
E allora davvero l'uomo di scienza, avendo risolto il "problema" Weber, sarebbe null'altro che
il signorotto soddisfatto delle sue impensate certezze e delle sue piccole vogliuzze; delle sue
apparenze di evidenza:
«Allora certo per gli «ultimi uomini» di questo sviluppo culturale potrebbe diventare
verità il principio: «specialisti senza spirito, gaudenti senza cuore – questo nulla si
immagina di essere salito ad un grado non mai prima raggiunto di umanità»77.
Così pure, nella sua critica al «mero "politico della potenza"», Weber aveva messo in guardia
rispetto ai rischi umani di una tale disgiunzione tra "agire" e "senso", tra fine e mezzo, in
politica:
75 Cfr. M. WEBER, La scienza come professione, op. cit., p. 44. 76 Cfr. La visibilità della Chiesa. Una riflessione scolastica, p. 73: «Infatti qui importa la verità, non l'inconfutabilità»,
in C. SCHMITT, Cattolicesimo romano e forma politica, Giuffré, Milano 1986, pp. 71-85. 77 Cfr. M. WEBER, Sociologia della religione, I vol., cit., pp. 185-186.
16
«Dell'improvviso crollo interiore di alcuni tipici rappresentanti di questo principio abbiamo
potuto constatare quale intima debolezza e impotenza si nasconda dietro questi gesti
boriosi, ma del tutto vuoti. Esso è il prodotto di un'indifferenza assai misera e superficiale di
fronte al senso dell'agire umano, la quale non ha alcun tipo di rapporto con la coscienza del
tragico a cui è intrecciato in verità ogni agire, e in particolare l'agire politico»78.
Il rifiuto di Weber dell'indifferenza di fronte al senso dell'agire umano può, in conclusione,
permetterci di provare a dubitare del suo presunto nichilismo, rispetto a quanto molti, invece,
hanno fatto. La seguente domanda non sembra irragionevole: potrebbe forse essere che il
riferimento al "demone" che tira i fili della propria vita della fine di La scienza come professione sia
più vicino all’ironia socratica, anziché, come pare a un primo sguardo, alla tragicità
nietzscheana? Posto certamente che si sia colto, come Weber non stanca di suggerire, cosa
significhi adempiere al proprio compito quotidiano nell'attesa, pur senza speranza, di una
risposta sull'arrivo del mattino da parte della sentinella in Edom.
Lasciamo la ricerca dell'oggettività alla "razionalità" scientifica e la ricerca della verità alla
"ragione" e alla "fede" dell'uomo. Facciamolo preservando le forme del "comune", che sole
possono dare sostanza alla realizzazione delle più alte qualità umane e degli ideali ad esse
connessi, senza lasciarci tentare da un cosmopolitismo astratto che appiana ogni differenza. E
allora forse davvero potremmo immaginare Max Weber affermare: «Non voglio e non posso
vivere che qui; qui voglio adempiere il mio compito quotidiano, come si addice a una
personalità matura che conduce responsabilmente la sua vita in riferimento a ideali ultimi,
nell'attesa che passi la notte e il mattino arrivi, anche per noi».
78 Cfr. M. WEBER, La scienza come professione, cit., p. 103.