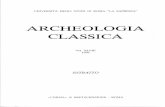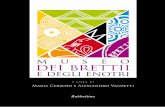La tomba di un aristicratico naukleros dall'Agro Veientano. Il kantharos con scene di navigazione da...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La tomba di un aristicratico naukleros dall'Agro Veientano. Il kantharos con scene di navigazione da...
nuova serie
Rivista del Dipartimento di Scienze dell’antichità
Sezione di Archeologia classica, etrusco-italica, cristiana e medioevale
Fondatore: giulio q. giglioli
Direzione Scientifica
maria paola baglione, gilda bartoloni, luciana drago, enzo lippolis, laura michetti, gloria olcese,
domenico palombi, maria grazia picozzi, franca taglietti
Direttore responsabile: gilda bartoloni
Redazione:franca taglietti, fabrizio santi
Vol. LXIV - n.s. II, 32013
«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER - ROMA
ISBN ISBN CARTACEO 978-88-913-0479-7ISBN DIGITALE 978-88-913-0475-9
ISSN 0391-8165
© COPYRIGHT 2013 - SAPIENZA UNIVERSITà DI ROMAAut. del Trib. di Roma n. 104 del 4 aprile 2011
Volume stampato con contributo della Sapienza Università di Roma
Archeologia classica : rivista dell’Istituto di archeologia dell’Università di Roma. - Vol. 1 (1949)- . - Roma : Istituto di archeologia, 1949- . - Ill. ; 24 cm. - Annuale. - Il complemento del titolo varia. - Dal 1972: Roma: «L’ERMA» di Bretschneider. ISSN 0391-8165 (1989)
CDD 20. 930.l’05
Comitato Scientifico
pierre gros, sybille haynes, tonio hölscher, mette moltesen, stephan verger
Il Periodico adotta un sistema di Peer-Review
p. 51
» 371» 223
» 295
» 349
» 263
» 7
» 169
» 133
» 483» 719» 609
INDICE DEL VOLUME LXIV
articoli
arizza m., de cristofaro a., piergrossi a., rossi d., La tomba di un ari-stocratico naukleros dall’agro veientano. Il kantharos con scena di naviga-zione di via A. d’Avack ...................................................................................
baldassarri p., Alla ricerca del tempio perduto: indagini archeologiche a Palazzo Valentini e il templum divi Traiani et divae Plotinae ........................
dionisio a., Caratteri dei culti femminili a Corfinio ...........................................domingo J.Á., mar r., pensabene p., El complejo arquitectónico del templo
del Divo Claudio en el monte Celio de Roma.................................................gregori g.l., Il ‘sepolcreto’ di militari lungo la via Flaminia. Nuove stele dal
V-VI miglio .....................................................................................................marcattili f., Templum Castorum et Minervae (Chron. 354, p. 146 M). Il tem-
pio di Minerva ad Assisi ed il culto romano dei Dioscuri ...............................ortalli J., Strutture pubbliche e luoghi della politica alle origini della città. Un
‘Campo Marzio’ nella Felsina villanoviana? ..................................................pacilio g., montanaro a.c., La ‘Tomba dei capitelli ionici’ di Tiati. San
Paolo di Civitate (FG) .....................................................................................palombi d., Receptaculum omnium purgamentorum urbis (liv. 1, 56, 2).
Cloaca Massima e storia urbana .....................................................................
NOTE E DISCUSSIONI
ambrosini l., Una nuova kylix del pittore di Meidias da Cerveteri nella tecnica a figure rosse e a fondo bianco ........................................................................
carafa p., bruno d., Il Palatino messo a punto ................................................corda i., Salvadanai fittili di età romana e sacra privata: riflessioni preliminari ......
indice del volume lxiv
p. 657» 521
» 591
» 677» 583
» 557» 637
» 545
» 800
» 793» 787
» 807
costantini a., Il reimpiego delle anfore tardo antiche. Considerazioni sulle sepolture ad enchytrismòs in Toscana .............................................................
giletti f., L’Acropoli di Taranto: un contributo preliminare sulle nuove ricerche ....leotta m.c., cancellieri m., Ceramiche a ‘tiratura limitata’: due esemplari
da Privernum ...................................................................................................lorenzatti s., De Benghazi à Versailles: histoire et réception d’une statue entre
XVIIe et XXe siècles ........................................................................................marengo s.m., taborelli l., A proposito dei Peticii e il commercio orientale ....pensabene p., gallocchio e., Alcuni interrogativi sul complesso augusteo
palatino ............................................................................................................tortorella s., Archi di Costantino a Roma ......................................................vallarino g., Instrumentum publicum e democrazia a Taranto: rilettura di
un’iscrizione vascolare ....................................................................................
RECENSIONI E SEGNALAZIONI
anguissola a., ‘Difficillima Imitatio’. Immagine e lessico delle copie tra Grecia e Roma (M.E. micheli) .....................................................................................
remolà vallverdù J.a., acero pérez J., (a cura di), La gestión de los residuos urbanos en Hispania. Xavier Dupré Raventos (1956-2006) In memoriam (D. manacorda) ...............................................................................................
vismara c., (a cura di), Uchi Maius 3. I Frantoi. Miscellanea (a. leone) .......
Pubblicazioni ricevute ............................................................................................
ArchCl, LXIV, 2013, pp. 51-131
LA TOMBA DI UN ARISTOCRATICO NAUKLEROS DALL’AGRO VEIENTANO
IL KANTHAROS CON SCENA DI NAVIGAZIONE DI VIA A. D’AVACK
Il kantharos d’impasto con scena di navigazione rinvenuto in una sepoltura dall’agro veientano (Roma, via Alfredo d’Avack) rappresenta un documento di grande rilevanza, sia per il significato iconografico della scena incisa, sia per le informazioni storico-socia-li che la lettura della sua decorazione e l’analisi complessiva del suo contesto rivelano sulla città di Veio in età orientalizzante. Il presente contributo, prendendo le mosse dalla breve presentazione di tutto il complesso sepolcrale indagato1, ha l’intento di fornire una lettura dettagliata del reperto e degli altri elementi del corredo di provenienza.
La necropoLi di via a. d’avack
Presso la moderna via A. d’Avack, traversa della Via Giustiniana (Fig. 1), è stato sco-perto, tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008, un nucleo di tombe di età orientalizzante ed arcaica, individuato in occasione delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione di un piano di edificazione privata2. L’area del sepolcreto gravita, attualmente come in età antica, lungo il percorso della Via Veientana3, circa 4 km a sud-est dal pianoro che ospitava Veio. Le tombe dovevano essere collegate all’asse viario principale mediante un percorso secondario, di cui però non è stata rinvenuta traccia forse a causa delle attività agricole
1 L’edizione definitiva dello scavo di via Alfredo d’Avack, in corso di elaborazione da parte degli scriventi, sarà inserita in una più ampia pubblicazione relativa ad alcune necropoli orientalizzanti ed arcaiche rurali indagate dalla SSBAR negli ultimi quindici anni nei territori compresi tra gli ex XVIII e XX Municipii di Roma.
2 Gli scavi sono stati finanziati dalla Bellavista Immobiliare ed eseguiti dagli autori del presente contributo (coordinatori Marco Arizza e Alessio De Cristofaro) con la direzione scientifica della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (Funzionario Responsabile per il XX Municipio – Daniela Rossi). Carla Carducci e Laura De Marco hanno seguito lo scavo delle Tombe 1 e 2. I rilievi sono stati eseguiti dalla Pragma S.r.l.; i restauri sono a cura di Giuseppe Mantella; si deve ad Andrea Venier il recupero dei letti in tufo e il restauro dei metalli. Una prima notizia del rinvenimento è stata data in: arizza et Al. 2009, pp. 250-259. La necropoli nel suo insieme è stata presentata preliminarmente ad un convegno presso la British School at Rome, i cui atti sono in corso di stampa.
3 Sulla Via Veientana: Ward-perkins 1955, pp. 44-58; Fentress et Al. 1983, pp. 58-62 e Messineo 1983, pp. 136-146; da ultimo Mari 2004, p. 72 con bibl. precedente.
52 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
moderne che hanno cancellato le evidenze stratigrafiche più superficiali. Le indagini esten-sive, condotte su circa 10 ettari di terreno, hanno parzialmente consentito di ricostruire le dinamiche insediative dell’area, dalla protostoria fino all’età arcaica.
All’età orientalizzante sono riferibili sette tombe di cui sei del tipo a camera ipogea con dromos di accesso (Tombe 1-5, 9) e una a nicchia (Tomba 7), ricavata lungo il corri-doio della Tomba 2; di età arcaica è invece la Tomba 8, del tipo cosiddetto ‘a vestibolo’ o ‘a tramite’4 (Fig. 2). Le sepolture sono dislocate alla base delle pareti di un rilievo colli-nare: sette sul versante meridionale, una su quello opposto a nord.
L’analisi dei materiali dei corredi consente di individuare la seguente scansione cro-nologica: all’Orientalizzante medio sono riconducibili le Tombe 1 e 3A5; al recente le Tombe 4, 2 e 3B; genericamente all’età orientalizzante si possono riferire le Tombe 5, 7 e 9 le quali, poiché vittime di spoliazioni moderne o di danneggiamenti antichi, non han-no restituito elementi diagnostici utili ad una datazione più puntuale.
4 drago 1997; paLMieri 2009.5 Sulla suddivisione in Tomba 3A e 3B vedi infra alle considerazioni finali.
Fig. 1. agro veientano (RM). Immagine con il posizionamento della necropoli di via A. d’Avack (da Google map).
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 53
È possibile ipotizzare che al medesimo sistema di occupazione del territorio identi-ficato dalle tombe di via d’Avack vadano riferite anche le due tombe a camera scoperte nel 2003 lungo la stessa via6 e quelle indagate da Enrico Stefani nel 1935 nella tenuta Inviolatella, sulle pendici occidentali di una delle collinette che digradano verso la via Veientana, a sud di via d’Avack7.
6 giannini 2009.7 steFani 1935a.
Fig. 2. Pianta della necropoli (M. Sabatini).
54 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
iL contesto: La toMba 3
Disposta tra le Tombe 2 e 4, la Tomba 3 presenta un corridoio a cielo aperto lun-go m 4,40, con le pareti digradanti verso l’accesso esterno, che introduce alla camera di forma quadrangolare8; il passaggio al vano di deposizione era sigillato mediante almeno tre blocchi parallelepipedi di tufo sovrapposti (Fig. 3). I ripetuti interventi agricoli hanno comportato il progressivo assottigliamento dello strato di tufo che separava il vano dal piano di calpestio esterno, fino a provocare il crollo della volta all’interno della camera. I blocchi, crollando, hanno mantenuto quasi completamente la loro compattezza, frattu-randosi in poche grandi porzioni. Questo scenario ha fortunatamente tratto in inganno gli scavatori clandestini che si sono arrestati sul livello più alto dei crolli della volta, confon-dendolo probabilmente con il fondo della camera; al contempo però il violento impatto ha
8 La camera misura m 3,10 × 2,80 con pareti verticali; della copertura si conserva solo l’imposta.
Fig. 3. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Ingresso della tomba 3 (foto autori).
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 55
causato un forte danneggiamento dei materiali del corredo che, in alcuni casi, è stato tanto grave da non consentirne neanche il restauro. Il corredo, numericamente assai cospicuo, conta minimo 81 esemplari ceramici oltre ad elementi in metallo e a resti di ambra. Lungo il margine orientale della camera era presente un letto funebre in tufo (Fig. 4) composto da tre poggioli scolpiti e un piano di deposizione. I due poggioli esterni sono modanati,
Fig. 4. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Il letto litico della tomba 3 (foto autori).
56 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
mentre il centrale è scanalato a zampa di leone; il piano deposizionale, in due parti, riporta una lavorazione sulla faccia superiore conformata a cuscino9.
Si è scelto di presentare il corredo privilegiando l’aspetto funzionale poiché questo meglio evidenzia la volontà di selezionare oggetti il cui significato concorre a definire sul piano sociale la figura ed i costumi del defunto. In questo processo di costruzione dell’immagine funeraria, larga parte è riservata alla sfera del rituale del banchetto10 e alla sequenza delle azioni che lo compongono11: è in questo modo, infatti, che lo status sociale e le vicende biografiche del defunto trovano una loro canonizzazione per essere tramandate ai discendenti come memoria familiare. All’interno delle categorie funzionali si è operata la distinzione per forme e classi e si sono istituiti confronti, senza pretesa di completezza, con i contesti funerari veienti editi e con alcuni significativi corredi dalle principali necropoli dell’Etruria meridionale e del Latium Vetus.
Anfore
Dedicata al trasporto e alla conservazione del vino, bevanda prestigiosa dei mag-giorenti etruschi consumata durante banchetti e cerimonie, la presenza dell'anfora nelle tombe evidenzia la capacità economica ed il conseguente rango del suo possessore. L’u-nico esemplare presente è in impasto con tracce di ingobbio chiaro; il corpo è ovoide con base piana, anse a bastoncello che si impostano dalla spalla alla base del collo distinto e concavo, ed orlo piatto esternamente (Fig. 5, a). Il tipo è databile tra la fine del VII e la prima metà del VI sec. a.C.12.
9 Un letto simile, formato da due lastroni di tufo rossiccio sostenuti da tre parallelepipedi, è stato ritrovato anche nella vicina tomba della tenuta Inviolatella sopra ricordata (steFani 1935a) e nel vano II del sepolcro A del tumulo di Vaccareccia (630-620 a.C.) con cuscino arcuato (id. 1935b, pp. 333-226). Poggioli modanati molto simili sono presenti in una kline da Cerveteri, tomba 6 della Banditaccia, del tipo Ia della classificazione di Steingräber (steingräber 1979, p. 333, n. 684, taf. XXXVI, 2), datata alla seconda metà del VII sec. a.C. Da ultimo, sui letti in area falisca vedi de Lucia broLLi, taboLLi 2012.
10 Per una analisi approfondita delle forme ceramiche dedicate alla pratica potoria e della loro ricorrenza nei corredi dei centri etrusco-meridionali vedi bartoLoni, acconcia, ten kortenaar 2012, con bibl. pre-cedente.
11 «Abluzione/purificazione, distribuzione di cibo e bevande, mescita di vino e acqua, distribuzione in coppe, etc.» (deLpino 2000, p. 193).
12 Inv. 566303. L’esemplare è avvicinabile ai tipi 1/2 di Py = Gras EM A / B (gras 1985, pp. 328-336, fig. 46b), datati fra il 600 ed il 570 a.C. (rizzo 1990, p. 24), anche se generalmente le anfore afferenti a questi tipi presentano il collo meno sviluppato ed il ventre meno rastremato, come in quelle vulcenti dalla tomba in proprietà Contorni e dalla t. 65 della necropoli dell’Osteria (rizzo 1990, p. 104, XIII, 3, fig. 199; p. 131, XIX, 1, fig. 270). Il confronto più stringente è con i sette esemplari rinvenuti nella vicina necropoli di Volusia, t. 1 (carbonara et Al. 1996, pp. 20-22, nn. 1-6, fine VII-inizi VI sec. a.C.). Le affinità con gli esemplari di Volusia, soprattutto per la forma della pancia e lo sviluppo del collo, potrebbero confermare una produzione di ambito locale (ibid., p. 22).
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 57
Olle
Sono presenti tre di olle, in impasto rosso, atte a contenere liquidi e probabilmente impiegate per miscelare vino ed acqua13. Le prime due, di minori dimensioni, sono globu-lari con labbro a tesa obliquo decorato da incisioni concentriche, costolatura orizzontale a rilievo presso l’attacco della spalla e fondo piano profilato14 (Fig. 5, c). Entrambe sono pri-ve di anse, caratteristica molto frequente negli esemplari provenienti dal Lazio e da Veio15. L’ultima, anch’essa priva di anse e di dimensioni maggiori, è di forma ovoide con ventre rastremato e presenta una decorazione a scanalature verticali che partono dal listello sulla spalla e terminano presso la metà inferiore della pancia16 (Fig. 5, b). L’assenza della decora-zione a stampigli sulla spalla, che troverà ampia diffusione a partire dalla seconda metà del VII sec. a.C.17, potrebbe suggerire una datazione alta per gli esemplari qui esaminati.
Tripod-bowl
Il tripod-bowl (Fig. 5, d), con i piedi impostati direttamente sull’orlo a garantire una maggiore stabilità, è una forma documentata fin dal Bronzo antico in Oriente, che trova
13 Sul legame tra il nome etrusco delle olle e il consumo del vino: coLonna 1973-1974, pp. 145-146.14 Inv. 566265, 576094. A Veio: Riserva del Bagno, t. V (buraneLLi 1982, pp. 95-96, n. 6, fig. 3); Picazzano,
t. XX (paLM 1952, p. 58, n. 1, pl. VII, senza costola orizzontale); Casalaccio, t. VIII (vighi 1935, p. 59, n. 6, tav. II/3); tumulo Vaccareccia, sepolcro A - vano I (steFani 1935b, p. 337, n. 31, fig. 11 b, con serie di puntini impressi sulla spalla, datato 630-620 a.C. in de santis 2003, p. 87); Volusia, t. 4 (carbonara et Al. 1996, pp. 47-48, n. 5, ultimo quarto VII-prima metà VI sec. a.C.); Pantano di Grano, t. 3 (de santis 1997, p. 135, n. 1, fig. 26/1, secondo quarto VII sec. a.C.) e Poggioverde, t. 28 (piergrossi 2003-2004, con serie di decorazioni circolari impresse sulla spalla). Appartiene al gruppo 140 C 3 b della classificazione ten Kortenaar (ten kortenaar 2011, p. 70, tav. 8).
15 A. Piergrossi in acconcia, piergrossi, ten kortenaar 2004, p. 123. Esemplari simili a: Castel di Decima, t. IV (bartoLoni, cataLdi dini, zevi 1975, p. 341, fig. 132/25, secondo quarto VII sec. a.C.); Ficana, t. 14 (cataLdi dini 1981, p. 138, fig. 83i, 630-600 a.C.); Osteria dell’Osa (bietti sestieri 1992, tipo 92f, p. 321, tav. 28, IV fase laziale). Le olle inornate senza anse sembrano precedere quelle decorate a strigliature come testimonierebbe l’olla con costolatura sulla spalla dall’insediamento di Cures, datata stratigra-ficamente agli inizi dell’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C. (coLazingari, FuLgenzi 1996, p. 173, fig. 19/5).
16 Inv. 566290. A Veio: Vaccareccia, t. VI (paLM 1952, p. 63, n. 2, pl. XV/2, 725-700 a.C.) e sporadico (papi 1988, p. 110, n. 37); Monte Michele, t. D e t. 5 (cristoFani 1969, p. 34, n. 19, tav. XV/2, 630 a.C.; boitani 1983, p. 546, tav. C/b, con decorazione impressa, secondo quarto VII sec. a.C.); Volusia, t. 4 (carbonara et Al. 1996, p. 48, n. 6, ultimo quarto VII-prima metà VI sec. a.C.). Esemplari molto vicini provengono dalla t. XXXIII de La Rustica, datata intorno al 630 a.C. (Roma 1976, p. 161, cat. 49/5, tav. XXVIII/A); dalla t. CVIII di Castel di Deci-ma, terzo quarto del VII sec. a.C. (Roma 1976, p. 286, cat. 90/25-26, tav. LXXI) e dalla tomba a cassone sotto il cd. ‘heroon’ di Enea da Pratica di Mare del secondo quarto del VII sec. a.C. (P. Sommella in Roma 1976, p. 309, cat. 102/23, tav. LXXX). In area falisca, dalla necropoli di Narce-Monte Cerreto proviene un esemplare avvicinabile datato ai decenni centrali del VII sec. a.C. (bagLione, de Lucia broLLi 1998, p. 153, fig. 15).
17 bartoLoni 1980, passim.
58 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
posto nella pratica del banchetto per polverizzare spezie ed erbe da aggiungere al vino per dolcificarlo o aromatizzarlo “alla moda siriana”18. Il confronto più stringente per l’e-semplare della T. 3, forma frequente in ambito veiente, è con quelli dal tumulo Chigi e dal tumulo CXXVI di Cerveteri19, sia per le misure20, sia per la presenza delle due sca-nalature sull’orlo obliquo e della solcatura profonda sotto l’orlo. Il tipo di impasto rosato potrebbe denunciare una provenienza nord-siriana; le dimensioni maggiori, rispetto ai
18 Inv. 566274. Per il censimento delle presenze e la disamina di questi reperti in ambito etrusco vedi botto 2000 e, da ultima, de santis 2003, pp. 93-94. Vedi anche bartoLoni 2007, p. 152.
19 bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, p. 41, fig. 8/b; botto 2000, p. 72, C4, fig. 1. 5, con bibliografia precedente.
20 Diam. cm 21, h. cm 7,6. Gli altri esemplari da Veio, fatta eccezione per quello dal sepolcro A del tumu-lo di Vaccareccia (ultimo quarto VII sec. a.C.), e per alcuni provenienti da Monte Aguzzo, presentano un dia-metro (14-17 cm) ed un’altezza (5-7 cm) inferiori rispetto al nostro.
Fig. 5. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Corredo dalla tomba 3 (inv. a. 566303, b. 566290, c. 566265, d. 566274; foto autori).
a b
cd
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 59
prototipi orientali, sembrerebbero invece confermare una manifattura locale21. La data-zione del contesto ceretano copre un arco di tempo tra la fine del VII, datazione preferi-bile per il tripode-mortaio, e la metà del VI sec. a.C.
Oinochoai
I cinque esemplari di oinochoai, vaso deputato alla distribuzione del vino nelle cop-pe, sono tutti in bucchero (Fig. 6, a); uno è conservato nella metà superiore ed è possi-bile riconoscerne la bocca trilobata, l’ansa a doppio bastoncello e la decorazione sulla spalla con ventaglietti puntinati chiusi rivolti a destra22. Tutti gli altri hanno ansa a nastro e, eccezion fatta per uno decorato semplicemente con linee incise orizzontali e paralle-le sulla pancia, riportano ventaglietti puntinati chiusi rivolti a destra sulla spalla e rag-gi incisi che partono dal piede23. Questi tipi di oinochoai sono molto diffusi in ambito
21 bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, p. 41, nota 163.22 Inv. 566285. Alla luce della parzialità di conservazione non si è in grado di stabilire confronti. 23 Inv. 566262, 566281, 566264, 566268. Tipo Rasmussen 3a, pl. 8, n. 31, terzo quarto VII-primo quarto
Fig. 6. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Corredo dalla tomba 3 (inv. a. 566268, b. 566214, c. 566239; foto autori).
a b c
60 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
etrusco meridionale in un arco cronologico piuttosto ampio: dalla metà del VII al primo quarto del VI sec. a.C.
Olpai
Come le successive olpai-attingitoi, le olpai, atte a versare liquidi (l’acqua da misce-lare al vino o per nettare le mani prima di compiere rituali di libagione o partecipare al banchetto), sono presenti con due esemplari: uno in bucchero e uno in ceramica etrusco-corinzia. Il primo, con ansa a nastro, presenta una decorazione con ventaglietti puntinati chiusi e rivolti a destra, sormontanti gruppi di linee parallele lungo il corpo del vaso24 (Fig. 6, b). Questa forma, in bucchero, trova la massima diffusione nell’ultimo quarto del VII sec. a.C. con pochi esempi nel primo del VI sec. a.C.
Il secondo invece, del noto tipo “a squame”, presenta quattro file di archetti nella parte superiore del corpo, subito sotto il collarino che separa il collo dalla pancia; su quest’ultima vi sono bande orizzontali dipinte che sormontano una serie di raggi che partono dal piede25 (Fig. 6, c). Per questo tipo di olpai a squame, già Cristofani e Zevi
VI sec. a.C. A Veio: Monte Aguzzo (Tumulo Chigi: bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, p. 43; i con-fronti posti con i materiali provenienti dal Tumulo Chigi sono stabiliti, nella maggior parte dei casi, sulla base delle sole descrizioni riportate in articoli preliminari in attesa dell’edizione definitiva del contesto è in corso di stampa: vedi bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, p. 28, nota 46); tumulo Vaccareccia, camera lungo il dromos sepolcro A (steFani 1935b, p. 350, nn. 1-2, fig. 21/l, datata al terzo quarto del VII sec. a.C. in de santis 2003, p. 87) e sporadico (papi 1988, p. 103 n. 17); Monte Oliviero (steFani 1928, p. 103 m, fig. 12/m); Casalaccio, t. V (vighi 1935, pp. 53-54, n. 11, fig. 5); Picazzano, tt. X, XV, XVI, XIX, XVII, (paLM 1952, p. 54, n. 6, pl. I; p. 55, nn. 19-20, pl. II; p. 55, n. 11, pl. III; p. 54, nn. 3-4, pl. IV; p. 56, n. 5, pl. VI); Monte Michele, t. F (cristoFani 1969, p. 42, n. 1, fig. 20, tav. XXI, 610-590 a.C.); Pozzuolo (Marchetti 2004, p. 23, tav. 3); Macchia della Comunità, tomba a camera (adriani 1930, p. 54, tav. I/m); Volusia, t. 4 (carbonara et Al. 1996, pp. 53-57, nn. 18-24, ultimo quarto VII a.C.). Attestazioni di questo tipo a Caere: Monte Abatone, tt. 45, 90, fine terzo quarto VII-primo quarto VI sec. a.C. (Milano 1986a, p. 32, n. 20, fig. p. 32 solo con solcature orizzontali; p. 68, n. 39, fig. p. 70, con striature verticali sulla pancia); Banditaccia, zona della Tegola Dipinta, tumulo VII, t. 1 (rizzo 1990, pp. 83, 84, nn. 32-34 con striature verticali sulla pan-cia, ultimo trentennio VII sec. a.C.); Tarquinia (da diversi contesti conservati al Museo Nazionale Tarquiniese: LocateLLi 2004, p. 77, gruppo 5); Vulci, Osteria, proprietà Contorni (rizzo 1990, p. 109, nn. 28-29, fig. 207, 600-570 a.C.) e t. 81 (rizzo 1990, p. 116, nn. 59-60, ultimo quarto VII-primo quarto VI sec. a.C.).
24 Inv. 566214. Tipo Rasmussen 1, pl. 21, n. 87, metà VII sec. a.C. (tipo 9e in hirschLand, raMage 1970, fig. 22, n. 3). Poco presente a Veio: Casalaccio, t. VI (vighi 1935, p. 57, n. 12); Pozzuolo, t. 2 (Marchetti 2004, n. 9, p. 20, fig. 7). Il tipo è attestato a Caere: Banditaccia, Tumulo I a Nord del Tumulo del Colonnello (rizzo 1990, p. 67, nn. 16-17, fig. 88 con raggi incisi alla base, fine del VII-inizi VI sec. a.C.) e a Tarquinia: Monterozzi, t. Cultrera XXV (LocateLLi 2004, p. 80, gruppo 19.3, tav. 5/10, orientalizzante recente).
25 Inv. 566239. A Veio: Monte Aguzzo (Tumulo Chigi: bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, p. 36); Vaccareccia, tumulo A, vano II (steFani 1935b, pp. 342-343, n. 30, fig. 12/f, ripreso in de santis 2003, p. 93, n. 114, 630-620 a.C.); Tomba Campana (cristoFani, zevi 1965, pp. 31-33, n. 29, ultimo quarto VII-
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 61
hanno correttamente ipotizzato una produzione veiente da fissare all’ultimo quarto del VII sec. a.C.26.
Olpai-attingitoi
Impiegate come attingitoi/versatoi, sono documentate in nove esemplari tra cui uno in impasto bruno, uno in ceramica depurata e gli altri in bucchero. Dell’esemplare in impasto bruno, non integralmente ricomponibile, è possibile leggere comunque la deco-razione: alla base del collo una serie di ventagli puntinati verticali aperti e, subito sopra, ventagli puntinati chiusi rivolti a sinistra; dai confronti indicati la cronologia oscilla dal secondo quarto del VII a tutto l’Orientalizzante recente27.
Tra i buccheri i due più antichi presentano una decorazione con striature verticali incise sulla pancia28 (Fig. 7, a), databili tra il secondo e il terzo quarto del VII sec. a.C.; gli altri, con pancia liscia, hanno linee orizzontali incise sul collo29, in due casi accom-
inizio VI sec. a.C.); Macchia della Comunità, tt. 2, 33, 35 e 44 (cristoFani, zevi 1965, p. 31 e nota 108, ultimo quarto VII a.C.); Quaranta Rubbie (adriani 1930, p. 58, fig. 10, tav. II, otto esemplari ripresi in rizzo 1990, p. 47, nn. 13-19, ultimo quarto VII sec. a.C.). Il tipo è attestato a Tarquinia, Caere e Vulci (un censimen-to critico dei rinvenimenti in cristoFani, zevi 1965, p. 33, note 116-118).
26 cristoFani, zevi 1965, pp. 31-33.27 Inv. 566283. Ci si limita a riportare gli esempi di olpette in impasto rinvenute a Veio: Riserva del Bagno,
t. V (buraneLLi 1982, p. 97, nn. 9-10, fig. 2, priva di decorazione); Monte Michele, t. 5 (boitani 1983, p. 546, tav. C/e, con ricca decorazione incisa, secondo quarto VII sec. a.C.); Volusia, t. 4 (carbonara et Al. 1996, n. 11, pp. 50-51, con linee parallele incise sul collo sormontate da motivo a zig zag, ultimo quarto VII sec. a.C.); Poggioverde, t. 3 (piergrossi 2003-2004, 640 a.C.); Pantan di Grano, t. 1 (de santis 1997, p. 120, n. 13, fig. 13, con striature sulla pancia e motivi a zig zag e molla incisi sul collo, secondo quarto VII sec. a.C.).
28 Inv. 566207, 566249. Entrambe del tipo 1a di Rasmussen, pl. 22, n. 96, secondo-terzo quarto VII sec. a.C. (tipo 8b in hirschLand, raMage 1970, fig. 21, nn. 2-3); il collo della prima non è decorato, mentre quello dell’altra ha tre incisioni orizzontali sormontate da una serie di ventaglietti puntinati chiusi rivolti a destra. A Veio: Monte Aguzzo (Tumulo Chigi: bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, p. 43); Volusia, t. 10 (carbonara et Al. 1996, p. 100, n. 11, orientalizzante recente), Picazzano, t. XVI (paLM 1952, p. 56, n. 9 con le sole incisioni orizzontali sul collo); Monte Michele, t. D (cristoFani 1969, p. 32, n. 8, fig. 12, tav. XVI/3, sul collo serie di ventaglietti puntinati semiaperti verticali, 630 a.C.). Il tipo è attestato anche a Caere: Monte Abatone, tt. 79, 90, secondo-terzo quarto VII sec. a.C. (Milano 1986a, pp. 46-47, n. 14 e; pp. 71-72, n. 47); Banditaccia, Tumulo della Speranza, t. 1 (rizzo 1990, p. 59, n. 55, fine VII-inizi VI sec. a.C.); zona della Tegola Dipinta, Tumulo VII, t. 1, (rizzo 1990, p. 83, nn. 28 e 29, ultimo trentennio VII sec. a.C.); Tarquinia, tumulo Poggio Gallinaro (LocateLLi 2004, p. 50, tabella 21.1, tav. 1/2); Vulci, Polledrara, tomba costruita (sgubini Moretti 1994, p. 21 e nota 70, ripreso in beLeLLi Marchesini 2004, pp. 104, 139, n. 137, seconda metà VII sec. a.C.).
29 Inv. 566269, 566278, 566282. Tipo Rasmussen 1b, pl. 23, n. 100, ultimo quarto VII-metà VI sec. a.C. (tipo 8c, in hirschLand, raMage 1970, fig. 21, n. 1). A Veio: Monte Michele, t. E (cristoFani 1969, p. 39, nn. 5-6, fig. 18, tav. XXX/3-4); Picazzano, tt. XI, XV, XVII, XX (paLM 1952, p. 54, n. 1, pl. I; p. 55, n. 15, pl. II; p. 57, n. 5, pl. IV; p. 59, n. 9, pl. IV). Il tipo è attestato anche a Caere: Monte Abatone, tt. 32,
62 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
pagnate da una serie di ventagli puntinati30, e si collocano genericamente tra la seconda metà del VII e la prima metà del VI sec. a.C. Per quanto concerne quello in ceramica
79, 81, 90, ultimo quarto VII-terzo quarto VI sec. a.C. (Milano 1986a, p. 24, nn. 19-20, fig. p. 23; pp. 46-47, n. 13; pp. 49-50, n. 6; pp. 72-73, nn. 48-49), Tarquinia: Monterozzi, t. 6118 (LocateLLi 2004, p. 80, gruppo 22, tav. 4, n. 13, terzo quarto VII-primo quarto VI sec. a.C.); Vulci: Ponte della Badia, Osteria, Polledrara, fine VII-inizi VI sec. a.C. (beLeLLi Marchesini 2004, pp. 104 e 121-143, tav. 7, nn. 1, 3), Poggio Buco (peLLegrini 1989, p. 87, n. 276).
30 Inv. 566266, 566267. Tipo Rasmussen 1a, pl. 23, n. 97, secondo-terzo quarto VII sec. a.C. A Veio: Monte Michele, t. E (cristoFani 1969, p. 39, n. 4, fig. 18, Tav. XXX/2, 610-590 a.C.); Picazzano, tt. XI, XV, XVI, (paLM 1952, p. 54, n. 1, pl. I; p. 55, n. 16, pl. II; p. 56, n. 10, pl. III).
Fig. 7. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Corredo dalla tomba 3 (inv. a. 566207, b. 566289, c. 566275, d. 566210; foto autori).
a c
db
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 63
etrusco-geometrica non si conserva alcuna decorazione31 e si attesta non oltre la fase ini-ziale dell’Orientalizzante recente (Fig. 7, b).
Anforette
Sembra ormai accertato che l’anforetta, specialmente nella versione di piccole e medie dimensioni, venisse utilizzata come vaso potorio, una traduzione indigena delle coppe bian-sate d’argilla depurata di tradizione ellenica32. Nella tomba 153 di Castel di Decima erano presenti circa 50 esemplari di queste anforette nella zona riservata al servizio da banchetto33. Quando, con l’avanzare della produzione, queste anfore crescono di altezza, fino a diventare il prototipo delle anfore nicosteniche, si può ipotizzare una variazione funzionale al conte-nimento di liquidi. Alcuni hanno supposto che l’anforetta contenesse il vino puro destinato alle pratiche sacrificali34; altri l’acqua lustrale da utilizzarsi per il lavaggio preliminare alla partecipazione al banchetto o, in ambito funerario, al lavaggio del corpo del defunto35.
Nella Tomba 3 di via d’Avack vi sono otto anforette, tre in bucchero e cinque in impasto bruno. Tra le cinque anfore36 a doppia spirale in impasto, fossile-guida dell’O-rientalizzante in area medio-tirrenica, tre37, assimilabili tra loro, presentano labbro sva-sato, ampio collo concavo, corpo globulare espanso schiacciato in alto, al di sotto di una carena appena accennata, fondo piano profilato e ricca decorazione incisa. Oltre al con-sueto partito decorativo della doppia spirale a più giri e le fasce di linee a formare la W sotto le anse, sono arricchite da altri elementi geometrici e motivi zoomorfi: alla base del collo si svolge una serie di zig-zag sopra una doppia linea e, in due casi, un motivo a mol-la, mentre nel campo di risulta sopra la spirale, sulla spalla, trova spazio un volatile cam-pito o a linee o a punti, rivolto a destra e zampe a terminazione trifida (Fig. 7, c).
Queste anfore appartengono alla produzione intermedia riconosciuta per questa foggia che, da una dimensione piuttosto piccola e una forma più schiacciata, passa ad
31 Inv. 566289. Nella classificazione di Sara Neri riconducibile al tipo Bb1a (neri 2010, pp. 120-121, tav. 22/7). A Veio: Monte Aguzzo (Tumulo Chigi: bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, p. 34); Vacca-reccia, t. X (paLM 1952, p. 66, n. 21, pl. XXI, 700-675 a.C.); Volusia, t. 5 (carbonara et Al. 1996, n. 5, pp. 75-76, con collo meno sviluppato, or. rec.); Poggioverde, t. 13 (de cristoFaro 2006, pp. 537-538, II.II.26, scheda di A.L. Corsini; foto in de cristoFaro, piergrossi 2012, tav. 18/1, 650-630 a.C.). Questo tipo di attingitoi in ceramica depurata dipinta è attestato a Caere (ad es. Monte Abatone, t. 352: Milano 1980, p. 227, n. 86; Laghetto I, t. 65: Milano 1980, p. 258, n. 13) e con un esemplare a Tarquinia (canciani 1974, p. 52, n. 7, tav. 38, seconda metà VII sec. a.C.).
32 toreLLi 2000, p. 96; da ultimo bartoLoni, acconcia, ten kortenaar 2012, pp. 261-266.33 bartoLoni 2007 con bibl. precedente.34 toreLLi 2000, p. 93.35 Da ultima batino 1998, p. 26.36 L’esemplare inv. 566250, in frammenti, risulta di difficile inquadramento tipologico.37 Inv. 566275, 566305, 576091.
64 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
esemplari di dimensioni maggiori intorno ai 20 cm di altezza, con maggiore sviluppo del collo, anche se sostanzialmente la larghezza è di poco inferiore all’altezza del vaso38. È proprio in questo tipo che troviamo le decorazioni più ricche ed esuberanti, che tendo-no a riempire l’intera superficie del corpo e che caratterizzano questi esemplari come di particolare pregio. L’anfora inv. 566275 trova il confronto più puntuale per forma, sche-ma decorativo e superficie bruna ben lucidata, nell’anfora con iscrizione studiata da G. Colonna, datata al 675-650 a.C. e assegnata a produzione ceretana39. L’airone campito a puntini è identico, tanto da poter supporre la stessa mano, nel qual caso l’attribuzio-ne all’area cerite ipotizzata da G. Colonna, potrebbe estendersi al nostro vaso. L’airone campito a linee sinuose del pezzo inv. 576091 si ritrova molto simile in due anforette inedite dalla necropoli veiente di Macchia della Comunità in contesti datati alla metà del VII sec. a.C.40. Ugualmente databile tra il primo quarto e la metà avanzata del VII sec. a.C. è l’ultima anforetta41, di dimensioni inferiori42, con collo ancora più allungato, cor-po globulare meno espanso e leggermente rastremato verso il piede profilato, che presen-ta un airone non campito sopra la spirale.
Tra quelle in bucchero si distingue la più antica, con striature incise verticali sulla pancia, ventaglietti verticali semichiusi alla base del collo e linee verticali sui margini delle anse43 (Fig. 7, d); questo tipo di anforette è stato prodotto a Veio dal secondo quarto del VII a.C. Il secondo esemplare presenta due spirali sul corpo inquadrate da un motivo a W e striature verticali sulle anse a nastro44; la cronologia sembra fissarsi nel terzo quarto del VII sec. a.C.
38 Il tipo B nella classificazione di G. Colonna, che si sviluppa a partire dal primo quarto fino ed oltre la metà del VII sec. a.C. (coLonna 1970, p. 642). Nella tipologia di A.J. Beijer è avvicinabile ai tipi IIb e IIc, con medesima datazione (beijer 1978, pp. 10, 13, pl. 7/4, 8/1-4). Dal territorio veiente: Pantano di Grano, t. 2 (de santis 1997, p. 133, n. 3, fig. 21, secondo quarto VII sec. a.C.). Altri confronti per la forma da Cerveteri: Banditaccia, t. 2 (ricci 1955, c. 225, n. 35); Monte Abatone, tt. 89, 352 (Milano 1980, p. 190, n. 1; p. 219, n. 1) e nel Lazio, da Decima, t. 152 (G. Bartoloni in bartoLoni, cataLdi dini, zevi 1975, pp. 305, 308-309, nn. 6-8, figg. 89, 92-93, primo quarto VII sec. a.C.), da Acqua Acetosa-Laurentina, t. 133 (bedini 2006, p. 476, II.966, scheda di A. Cassotta, secondo quarto VII sec. a.C.); da Osteria dell’Osa, t. 227 (A. De Santis in bietti sestieri 1992, p. 851, n. 4, fig. 3c.91, fase IVB).
39 coLonna 1970.40 gaLante 2001-2002.41 Inv. 566261. Vicina al tipo Ic Beijer (beijer 1978, p. 11, pl. 4/1). Per la forma vedi di nuovo Decima, t.
152 (G. Bartoloni in bartoLoni, cataLdi dini, zevi 1975, p. 309, n. 9, fig. 92, primo quarto VII sec. a.C.); Osteria dell’Osa, t. 601 (A. De Santis in bietti sestieri 1992, p. 851, n. 5, fig. 3c.71, fase IVA2).
42 H. 13 cm circa.43 Inv. 566210. Tipo Rasmussen 1a, pl. 1, n. 3, secondo-ultimo quarto VII sec. a.C. (Ramage 1d, fig. 12,
n. 4). A Veio: Monte Aguzzo (Tumulo Chigi: bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, pp. 42-43); Monte Michele, tt. C, D e 5 (cristoFani 1969, p. 28, n. 9, fig. 7, tav. IX/2, 660-630 a.C.; p. 29, n. 2, fig. 11, tav. XIII/2 con decorazione differente, 630 a.C.; boitani 1983, p. 555, tav. CII/a, secondo quarto VII sec. a.C.); Pozzuolo, t. 1 (Marchetti 2004, p. 18, nn. 28, 30, fig. 2/2). Attestazioni di questo tipo sono anche a Caere, Camera degli Alari (hirschLand raMage 1970, p. 39, fig. 12/4, 640-620 a.C.).
44 Inv. 566279. Tipo Rasmussen 1b, pl. 2, n. 5, 650-620 a.C. (tipo 1b in hirschLand, raMage 1970,
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 65
L’ultima tra quelle in bucchero è riconducibile allo stesso tipo della precedente con le sole incisioni a W sulla pancia45, ma profilo più ovoide e le anse rigide, quasi metal-liche. La datazione di questa evoluzione del tipo è collocabile nell’ultimo quarto del VII sec. a.C.
Calici
Forma potoria per eccellenza è il calice46: undici in tutto gli esemplari di cui nove in bucchero e due in impasto bruno. Gli esemplari in impasto bruno presentano vasca troncoconica carenata decorata con linee incise e alto piede a tromba e sono databili tra il secondo e il terzo quarto del VII sec. a.C.47. Gli esemplari in bucchero (Fig. 8, a) sono tutti riconducibili allo stesso tipo48: piede a tromba abbastanza sviluppato (tranne in due
fig. 12, n. 5). A Veio: Pozzuolo (citate in Marchetti 2004, t. 1, n. 33; t. 6, n. 6; t. 7, n. 14, p. 18 nota 12); Casalaccio, tt. V, VI (vighi 1935 p. 54, n. 12, tav. II/2; p. 57, n. 10, fig. 6, con in più “fiorellino” inciso sopra le spirali); Picazzano, tt. X, XV, XVII, XVIII, XX (paLM 1952, p. 54, n. 5, pl. I; p. 55, n. 17, pl. II; p. 57, nn. 7-8, pl. IV; p. 58, n. 6, pl. VI; p. 59, nn. 7-8, pl. VII con decorazione differente); Macchia della Comunità, t. III (adriani 1930, n. 2, p. 50, notevolmente più piccola); Quaranta Rubbie, tomba a camera (adriani 1930, p. 57, fig. 8, ripresa in rizzo 1990, p. 47, n. 22, grande quasi il doppio e con in più ventagli incisi verticali sul collo, ultimo trentennio VII sec. a.C.); tumulo Vaccareccia, sepolcro A - vano II (steFani 1935b, p. 343, n. 8, fig. 13/f; de santis 2003, p. 89, n. 104; paLM 1952, t. XIX, p. 71, n. 12, pl. XXVIII, 630-620 a.C.). Il tipo è presente anche a Caere, Tomba Giulimondi (cascianeLLi 2003, p. 52, n. 18, fig. 18, seconda metà VII sec. a.C.); Camera degli Alari (hirschLand raMage 1970, p. 40, fig. 12/5, 640-620 a.C.), Tarquinia, Monterozzi, t. Cultrera XXV (LocateLLi 2004, p. 77, gruppo 2.2, tav. 3/5, seconda metà VII sec. a.C.).
45 Inv. 566215. Tipo Rasmussen 1b, pl. 2, n. 6, 650-620 a.C. A Veio: Pozzuolo, t. 9 (Marchetti 2004, p. 18, n. 25, fig. 3). La stessa evoluzione del tipo è riscontrabile a Tarquinia (LocateLLi 2004, p. 55, gruppo 2.5-6, tav. 3/6 con striature al posto delle incisioni a W), Vulci: Osteria, tomba dei Soffitti Intagliati (beLeLLi Marchesini 2004, p. 98, nota 69 con bibl. precedente, tav. 7/11 con decorazione più ricca).
46 Contra vd. toreLLi 2000, p. 99, nota 37.47 Inv. 566288, 566245. Veio: Monte Michele, t. C (cristoFani 1969, p. 26, n. 5, fig. 8, tav. X/3, 660-630
a.C.); Picazzano, t. XVIII (paLM 1952, p. 57, n. 2, tav. VI); Pantano di Grano, tt. 1, 3 (de santis 1997, p. 124, n. 21, fig. 14; p. 138, n. 12, fig. 27, secondo quarto VII sec. a.C.). Caere, Laghetto I, tt. 79, 139 (cavagnaro vano-ni 1996, p. 106, n. 4, tav. 22; p. 107, n. 6, tav. 24); Pratica di Mare, t. sotto il cd. ‘heroon’ (Roma 1976, p. 308, cat. 102/15, tav. LXXX, 675-650 a.C.); Marino, Riserva del Truglio, t. II (gieroW 1964, p. 148, nn. 3-5, fig. 86).
48 Inv. 566203, 566205, 566206, 566219, 566263, 566271, 566276. Tipo Rasmussen 2d (tipo 4c in hir-schLand, raMage 1970, fig. 18, n. 4), ultimo quarto VII-prima metà VI sec. a.C. A Veio: Monte Aguzzo (Tumulo Chigi: bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, p. 44); Picazzano, tt. IV, XI (paLM 1952, p. 53, n. 1, pl. I; p. 54, n. 3, pl. I); tumulo Vaccareccia, sepolcro A – vano I (steFani 1935b, p. 339, nn. 44-47, fig. 13/a, b, d, e, 630-620 a.C.); Casalaccio, tt. IV, V, VII (vighi 1935, p. 52, n. 14, tav. II/1; p. 54, n. 14, tav. II/2; p. 58, n. 3, fig. 7); Pozzuolo, tt. 1, 7 (citate in Marchetti 2004, p. 22, nn. 20-21; p. 22, n. 22); Volusia, tt. 1, 4 (carbonara et Al. 1996, pp. 35-36, nn. 44-47; pp. 62-63, nn. 43-45, fine VII-inizi VI sec a.C.). Il tipo è anche attestato a Caere: Monte Abatone, tt. 32, 45, 79, 81, 90 (Milano 1986a, pp. 23-24, nn. 21-25; pp. 31-32, nn. 30-34; pp. 46-47, n. 17; pp. 49-50, nn. 7-9; pp. 72-73, nn. 52-55, ultimo quarto VII-prima metà VI sec.
66 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
casi; vedi Fig. 8, b49), collarino nella metà superiore dello stelo, decorazione a punta di diamante a marcare la carena e tre linee incise sulla parete della vasca; in due casi sono
a.C.); Banditaccia, Tumulo I a nord del Tumulo del Colonnello (rizzo 1990, p. 67, nn. 12-13, scorcio VII-ini-zio VI sec. a.C.); Tarquinia: cd. ‘tomba egizia’ (LocateLLi 2004, p. 82, gruppo 35.32, tav. 4/1, ultimo quarto VII-inizi VI sec. a.C.); Pian della Civita (LocateLLi 2004, p. 82, gruppo 35.3, 4, 8, tavv. 4/2-3, 14/5-6), ultimo quarto VII-inizi VI sec. a.C.; Vulci: Osteria, t. 81 (rizzo 1990, p. 115, nn. 36-42, ultimo quarto VII-inizi VI sec. a.C.); t. 46 Bongiovì (rizzo 1990, p. 97 nn. 27-32), Proprietà Contorni (rizzo 1990, p. 108, nn. 20-23, ultimo quarto VII-inizi VI sec. a.C.).
49 Inv. 566204, 576085. L’unico confronto da Veio appartenente al tipo Rasmussen 2d, ma con basso piede a tromba e ventaglietti puntinati chiusi viene da Pozzuolo, t. 1 (Marchetti 2004, p. 22, n. 22, fig. 6). Sono noti inoltre esempi a Tarquinia: Monterozzi, t. 6118 (LocateLLi 2004, p. 83, gruppo 37.1, tav. 4/4, terzo quarto VII-primo quarto VI sec. a.C.) e Vulci: Osteria, proprietà Radicetti (rizzo 1990, p. 146, nn. 4-5, prima metà VI sec. a.C.).
Fig. 8. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Corredo dalla tomba 3 (inv. a. 566219, b. 566204, c. 566293, d. 566260, e. 566218; foto autori).
c
a b
ed
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 67
presenti anche ventaglietti chiusi rivolti a destra e in uno verticali aperti. Il range cro-nologico di riferimento per questi esemplari è compreso tra l’ultimo quarto del VII e il primo del VI sec. a.C.
Kantharoi
Sempre nell’ambito dei vasi potori, il kantharos è presente con nove esemplari (sette in bucchero e due in impasto bruno). Degli esemplari in impasto uno presenta vasca emi-sferica profonda e anse sormontanti50 (Fig. 8, c). La forma non trova confronti puntuali in ambito veiente, mentre è avvicinabile ad uno in bucchero dalla stessa Tomba 3 (Fig. 8, d), differente per forma e decorazione dagli altri esemplari: dimensionalmente più pic-colo, con piede ad anello, anse a nastro impostate su labbro e spalla, profonda vasca troncoconica a profilo arrotondato; decorato con gruppi di linee incise sulla vasca e una fila di ventaglietti orizzontali chiusi rivolti a destra sulla spalla e verticali sull’ansa51. Ampiamente attestato a Veio, è collocabile tra la fine del terzo e l’ultimo quarto del VII sec. a.C. È possibile quindi ipotizzare una sperimentazione di una bottega locale che, producendo vasi in entrambe le classi, realizzava la forma anche in impasto bruno52. Il secondo kantharos in impasto è l’oggetto principale del presente contributo e quindi si rinvia oltre per l’analisi di dettaglio53.
Gli altri kantharoi in bucchero appartengono allo stesso tipo54 assai standardizzato
50 Inv. 566293.51 Inv. 566260. Tipo Rasmussen 2, pl. 30, n. 158 (con anse a nastro), fine terzo quarto-ultimo quarto VII
sec. a.C. Tumulo Vaccareccia, sepolcro A – vano II (steFani 1935b, p. 343, nn. 10-11, fig. 16/f,g; de santis 2003, p. 90, n. 107, con ventagli anche sull’orlo, 630-620 a.C.); Picazzano, t. IV (paLM 1952, p. 53, n. 3, pl. I, con anse a bastoncello); Monte Michele, t. D (cristoFani 1969, p. 37, nn. 28-29, fig. 15, tav. XVI/1, il primo con striature verticali sulla vasca e ventagli semichiusi aperti verticali sull’orlo, il secondo privo di decorazio-ne; 630 a.C.); Macchia della Comunità, t. 44 (citato in de santis 2003, p. 90); Volusia, t. 8 (carbonara et Al. 1996, p. 88, n. 12, con le sole linee incise sulla vasca e anse a bastoncello, fine VII-inizi VI sec. a.C.). Il tipo è documentato anche a Tarquinia: Monterozzi, Cultrera (rasMussen 1979, p. 18, n. 10, fig. 160, ripreso in LocateLLi 2004, p. 58, nota 50 e p. 84, gruppo 42.1, tav. 6/3).
52 Il tema è in corso di approfondimento da parte dei due autori. 53 Inv. 576093.54 Inv. 566202, 566212, 566218, 566221, 566223. Tipo Rasmussen 3e, pl. 32, n. 169, ultimo quarto VII-
terzo quarto VI sec. a.C. (tipo 5c-d in hirschLand, raMage 1970, fig. 19, nn. 4, 6). Monte Aguzzo (Tumulo Chigi: bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, p. 43); Picazzano, tt. XIII, XIX, XX (paLM 1952, p. 54, n. 5, pl. II; p. 58, nn. 8-11, pl. VI; p. 59, nn. 17-23, pl. VIII); Vaccareccia, t. a camera lungo il dromos (steFani 1935b, p. 351, n. 9, fig. 21/e, datata alla fine del VII sec. a.C. in de santis 2003, p. 87); Monte Michele, tt. E, F (cristoFani 1969, p. 40, nn. 8-9, fig. 18, tav. XVIII/3-4; p. 44, n. 5, fig. 21, tav. XXI/2; 610-590 a.C.); Casalaccio, t. IV (vighi 1935, p. 52, n. 13, tav. II/1); Oliveto Grande, t. I (ingLieri 1930, p. 70, presenti 15 esemplari); Pozzuolo, tt. 6, 7, 8, 9 (citati in Marchetti 2004, p. 26, nn. 26a-b; p. 26, nn. 16-17; p. 26, nn. 19-20; p. 26, nn. 1-2, 30-36, 49); Volusia, tt. 1, 4 (carbonara et Al. 1996, pp. 29-34, nn. 25-42; pp. 59-61,
68 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
e ampiamente attestato nei corredi dell’Etruria meridionale: anse a nastro sormontanti dall’orlo alla carena e basso piede a tromba, linee parallele incise sul labbro e decorazio-ne a punta di diamante sulla carena, in un caso sormontata da ventagli puntinati verticali aperti55 (Fig. 8, e). Alla luce della grande diffusione di questo tipo di vaso, il range cro-nologico risulta abbastanza ampio e si estende dall’ultimo quarto del VII alla metà del VI sec. a.C.
Kyathoi
Le tazze/kyathoi sono vasi multifunzionali con cui si attingeva e si versava o da cui si poteva bere direttamente. Le redazioni miniaturistiche potevano avere un significato simbolico, ma anche servire per aggiungere al vino le spezie triturate o il miele o il for-maggio. Nella Tomba 3 sono documentati sei esemplari tra cui quattro in bucchero (dei quali uno miniaturistico) e due, sempre miniaturistici, in impasto bruno. Tra quelli in bucchero, i primi due hanno ansa bifora, piede ad anello distinto e decorazione a pun-ta di diamante sulla carena; sono presenti sulla parete ventagli puntinati chiusi rivolti a destra e verticali sull’ansa a nastro56 (Fig. 9, a); un terzo esemplare, simile nella forma ai precedenti, presenta ventaglietti verticali chiusi sopra la carena57. I tipi sembrano potersi ricondurre nell’ambito della seconda metà del VII sec. a.C.
nn. 32-41, or. rec.). Il tipo è documentato anche a Caere: Monte Abatone, tt. 32, 45 (Milano 1986a, pp. 21-22, nn. 6-9; pp. 28-30, nn. 5-6 e 16-17, terzo-ultimo quarto VII sec. a.C.); Tarquinia: Monterozzi, t. 6118 (Loca-teLLi 2004, p. 85, gruppo 46.3, tav. 4/10, terzo quarto VII-primo quarto VI sec. a.C.); Vulci, Osteria, proprietà Contorni (rizzo 1990, p. 108, nn. 14-19, fine VII sec. a.C.), Osteria, proprietà Radicetti (rizzo 1990, p. 146, nn. 2-3, prima metà VI a.C.), Osteria, proprietà Simoni (rizzo 1990, p. 157, nn. 10-11, 600-570 a.C.), Poggio Buco, tt. VII, VIII (bartoLoni 1972, p. 91, n. 56, fig. 42, tav. LI a; p. 120, nn. 51-54, fig. 57, tav. LXII g-i, LXXIV h, ultimo quarto VII-inizi VI sec. a.C.; sporadico, p. 176, nn. 52-57, fig. 86, tav. CIX a-f; sporadico, p. 206, n. 24, fig. 103, tav. CXLII b; peLLegrini 1989, p. 90, nn. 284-289); Agro falisco: Vignanello, loc. Mole-sino, tomba infantile (aMbrosini 2004, p. 231 nota 51, fig. 5a).
55 Inv. 566284.56 Inv. 566209, 566277. Il tipo è Rasmussen 1d, pl. 34, n. 184, seconda metà VII sec. a.C. (tipo 6d in
hirschLand, raMage 1970, fig. 11, n. 1); a Veio: Monte Michele, t. D (cristoFani 1969, p. 34, n. 16, fig. 13/16, tav. XV/3, con ventagli orientati diversamente e senza decorazione a punta di diamante sulla carena, 630 a.C.), Casalaccio, t. 5 (vighi 1935, p. 54, n. 15, tav. II/2), tumulo Vaccareccia, sepolcro A - vano II (steFani 1935b, p. 344, nn. 12-16bis, fig. 16/a-e, h, 630-620 a.C.); sporadico (papi 1988, p. 106, n. 26), Volusia, t. 4 (carbonara et Al. 1996, p. 61, n. 42, ultimo quarto VII sec. a.C.). Il tipo è stato ripreso in de santis 2003, p. 90, n. 108. Da segnalare una rara redazione in impasto bruno a Volusia, t. 8 (carbonara et Al. 1996, p. 85, n. 4, fine VII-inizi VI sec. a.C.). Il tipo è attestato anche a Caere: Banditaccia, t. 608 (hirschLand raMa-ge 1970, p. 39, n. 82, fig. 11/1, terzo quarto VII sec. a.C.), Bufolareccia, t. 999 (rizzo 1990, p. 76, n. 25, 580-550 a.C.); Monte Abatone, t. 90 (Milano 1986a, pp. 72-73, n. 51, seconda metà VII sec. a.C.) e a Vulci, Osteria, proprietà Contorni (rizzo 1990, p. 108, n. 25, fig. 207, fine VII sec. a.C.).
57 Inv. 576087.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 69
Due tra i miniaturistici, databili dalla seconda metà del VII al VI secolo a.C., han-no ansa bifora e piede ad anello distinto (Fig. 9, b); quello in bucchero presenta ansa a nastro, la decorazione a punta di diamante e, sulla parete, una serie di ventagli puntinati verticali alternati aperti e chiusi58. Per quanto concerne l’ultimo miniaturistico in impa-sto bruno, presenta ansa bifora crestata, piede ad anello distinto59, con una incisione a
58 Inv. 566251 (impasto); 566270 (bucchero) riconducibile al tipo 1e di Rasmussen, pl. 35, nn. 190 e 191; insolita la decorazione puntinata. A Veio: Picazzano, t. XVII (paLM 1952, p. 57, n. 17, pl. IV); Vaccareccia, sporadico (papi 1988, p. 106, n. 27). Per l’esemplare in impasto vi sono confronti da Veio: Casalaccio, t. IV (vighi 1935, p. 51, n. 3, tav. II/1); Monte San Michele, recupero (carbonara et Al. 1996, p. 120, n. 4, fig. 233); Poggioverde, t. 2 (piergrossi 2003-2004, 640-630 a.C.); in area laziale a Tor de’ Cenci, t. 4, prima metà del VII sec. a.C. (bedini 1988-1989, p. 253, n. 23, figg. 32, 34) e a Pratica di Mare, t. sotto il cd. ‘heroon’, 675-650 a.C. (Roma 1976, p. 309, cat. 102/22, tav. LXXX).
59 Inv. 566241. A Veio: Pantano di Grano, t. 2 (de santis 1997, p. 133, n. 5, fig. 21, secondo quarto VII
Fig. 9. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Corredo dalla tomba 3 (inv. a. 566277, b. 566251, c. 566241, d. 566217, e. 576095, f. 566216; foto autori).
ab c
d
ef
70 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
X nel fondo interno della vasca ed appare dalla prima metà del VII sec. a.C. fino a tutto l’Orientalizzante recente (Fig. 9, c).
Coppe
Ancora nell’ambito delle forme potorie rientrano le coppe, presenti nella Tomba 3 in nove esemplari, sette in bucchero e due in ceramica etrusco-geometrica. Tra i primi sono riconoscibili due gruppi: quattro esemplari dello stesso tipo60 con orlo a tesa obliquo, pie-de ad anello e anse a bastoncello orizzontali impostate sulla spalla; la decorazione prevede gruppi di linee parallele incise sulla vasca e, tranne in un caso, una serie di ventaglietti chiusi rivolti a destra (Fig. 9, d). Le altre tre invece sono riconducibili ad un altro tipo61, simile al precedente ma con vasca meno profonda e anse sempre orizzontali (in un caso a sezione qua-drangolare). La decorazione è in tutto simile al gruppo precedente. La diffusione di questi tipi è collocabile cronologicamente in un range che va dal terzo all’ultimo quarto del VII a.C.
Per quanto concerne le due in ceramica etrusco-geometrica, la forma di entrambe è riconducibile allo stesso tipo62 con labbro a tesa, vasca mediamente profonda, anse
sec. a.C.), Poggioverde, t. 14 (piergrossi 2003-2004, ultimo quarto VII sec. a.C.). Presenti anche a Caere, Banditaccia, tumulo I a n del tumulo del Colonnello (rizzo 1990, p. 67, n. 18, fig. 89, fine VII-inizio VI sec. a.C.); a Vulci, Cuccumella, t. Philadelphia 66 (haLL dohan 1942, p. 86, n. 15, pl. XLV) ed in area falisca (Narce, tt. 16F, 105F: haLL dohan 1942, p. 49, n. 8, pl. XXIV; p. 50, nn. 18-19, pl. XXV).
60 Inv. 566208, 566217, 566222, 566280. Tipo Rasmussen 1c, pl. 37 n. 208, terzo quarto VII-primo quarto VI sec. a.C. (tipo 7b in hirschLand, raMage 1970, fig. 10, n. 1). Tumulo Vaccareccia, sepolcro A - vano II (steFa-ni 1935b, p. 344, n. 19, fig. 17/b, ripreso in de santis 2003, p. 91, n. 111; nn. 18, 21, fig. 17/f, d, con anse incise e senza ventaglietti; nn. 20, 23, 25, fig. 17/c, a, h, senza ventaglietti; p. 351, n. 13, fig. 21/m; 630-620 a.C.), sporadico (papi 1988, p. 105, n. 24, senza ventaglietti, p. 106, n. 25); Picazzano, tt. X, XVI, XVII, XIX (paLM 1952, p. 54, n. 3, pl. I; p. 56, n. 5, pl. III; p. 57, n. 18, pl. IV; p. 58, n. 12, pl. VI); Casalaccio, tt. IV, V (vighi 1935, p. 51, nn. 10-12, tav. II/1, di cui una con incisione a zig zag al posto dei ventaglietti; p. 54, n. 16, tav. II/2); Pozzuolo, tt. 7, 9 (citati in Marchetti 2004, p. 22, nn. 19-20; nn. 40-42, fig. 8, senza ventaglietti); Monte Michele, forse tt. D o E, F (cristoFani 1969, p. 48, n. 2, fig. 2, senza linee incise e con ventaglietti semiaperti; p. 42, n. 4, fig. 20, tav. XXI/5, 610-590 a.C.; sporadici, p. 50, n. 5, fig. 25, tav. XXV/4, senza ventaglietti). Questo tipo è attestato anche a Caere: Monte Abatone, tt. 608, 79, 90 (hirschLand raMage 1970, p. 39, fig. 10/1, terzo quarto VII sec. a.C.; Milano 1986a, p. 46, n. 8; pp. 66-69, nn. 24-29, 34-35), Tarquinia: Monterozzi, t. 6118 (LocateLLi 2004, p. 86, gruppo 60.1-2, tav. 6/2, terzo quarto VII-primo quarto VI sec. a.C.); Vulci: Osteria, tomba dei Soffitti Intagliati (beLeLLi Marchesini 2004, p. 115, nota 160 con bibl. precedente, ultimo quarto VII sec. a.C.).
61 Inv. 566220, 566248, 566287. Tipo Rasmussen 1b, pl. 37, n. 207, ultimo quarto VII sec. a.C. (tipo 7b in hirschLand, raMage 1970, fig. 10, n. 2). A Veio: Picazzano, t. XXI (paLM 1952, p. 60, n. 7, pl. IX) e Poz-zuolo, t. 1 (Marchetti 2004, p. 22, n. 40, fig. 11). Questo tipo è attestato anche a Caere: Monte Abatone, t. 608 (hirschLand raMage 1970, p. 39, fig. 10/2, terzo quarto VII sec. a.C.), Tarquinia: Monterozzi, Cultrera, t. XXV (LocateLLi 2004, p. 86, gruppo 59.1, tav. 6/1, ultimo quarto VII sec. a.C.).
62 Inv. 566242, 576095. Nella classificazione di Sara Neri riconducibili al tipo Bc1a (neri 2010, pp. 152-155, tav. 28).
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 71
a bastoncello impostate obliquamente sulla spalla e piede ad anello. La prima ha una decorazione in colore marrone rossastro consistente in gruppi di fasce orizzontali sulla vasca e colore pieno sull’orlo con fascia risparmiata sulla spalla decorata con una banda ondulata dello stesso colore (Fig. 9, e). La seconda invece ha una decorazione in colore arancio vivo conservata solo in poche zone così da non consentire una lettura d’insieme del motivo. Entrambe trovano riscontri in ambito veiente63 tanto da aver fatto supporre la presenza di una officina locale64. La produzione si concentra nell’ambito dell’ultimo quarto del VII sec. a.C.
Kotylai
Rimanendo nelle forme dedicate all’atto del bere65, le kotylai sono presenti con tre esemplari tutti in bucchero (Fig. 9, f). Nonostante una fosse in frammenti non ricostrui-bile, si è comunque in grado di stabilire che appartengono tutte allo stesso tipo66: con la misura dell’altezza quasi pari al diametro dell’orlo, anse a bastoncello orizzontali e piede ad anello. La decorazione varia tra i tre esemplari: uno presenta gruppi di linee incise parallele orizzontali su orlo e vasca; il secondo due serie di linee incise orizzontali su orlo e subito sotto le anse, che inquadrano un gruppo di ventaglietti puntinati chiusi oriz-zontali e raggi che partono dal piede; l’ultimo, frammentario, presenta sotto le anse una fitta serie di ventaglietti chiusi e verticali che sormontano linee incise orizzontali paralle-le, oltre ai raggi che partono dal piede. La datazione per questi reperti si concentra tra la fine del terzo e l’ultimo quarto del VII sec. a.C.
63 Vaccareccia, sporadico (papi 1988, pp. 120-121, nn. 14-15, con differente decorazione sulla spalla), Macchia della Comunità, t. VII (adriani 1930, p. 54, n. 7), Casalaccio, t. V (vighi 1935, p. 54, n. 20, fig. 5, con differente decorazione sulla spalla); Volusia, t. 4 (carbonara et Al. 1996, p. 69, n. 56; t. 5, p. 76, n. 6, entrambe senza decorazione nella fascia risparmiata sulla spalla, ultimo quarto VII sec. a.C.). Tipo attestato anche a Caere: Monte Abatone, t. 352 (Milano 1980, p. 227, n. 83-85); Tarquinia (canciani 1974, p. 45, n. 7, 9, tav. 33/7, 9, fine VII sec. a.C.) e Vulci, t. 22 (haLL dohan 1942, p. 89, n. 9, tav. XLVII).
64 neri 2010, p. 155. 65 Giovanni Colonna connette questo recipiente al consumo di cibi dalla consistenza semiliquida: zuppe e
minestre (coLonna 1990, pp. 30-32).66 Inv. 566216, 566213, 566286. Tipo Rasmussen c, pl. 26, terzo-ultimo quarto VII sec. a.C. (tipo 2c in
hirschLand, raMage 1970, fig. 12, n. 1-2). Monte Michele, t. D (cristoFani 1969, p. 34, n. 17, fig. 13, con incisioni limitate all’orlo e ventaglietti, 630 a.C.); Pozzuolo, t. 2 (Marchetti 2004, p. 21, n. 10, fig. 5, con vasca decorata, sotto i ventaglietti verticali aperti, da striature verticali); tumulo Vaccareccia, sepolcro A - vano II (steFani 1935b, p. 344, n. 17, fig. 13/c, ripreso in de santis 2003, p. 91, n. 109, 630-620 a.C.). Il tipo è presente anche a Caere: Camera degli Alari (hirschLand raMage 1970, p. 40, fig. 12/1-2, 640-620 a.C.); Tarquinia: Pian della Civita (LocateLLi 2004, p. 81, gruppo 30.1-3, tav. 5/7, ultimo quarto VII sec. a.C.) e Vulci: Osteria, t. 15 Bongiovì (beLeLLi Marchesini 2004, p. 104, nota 107).
72 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
Piatti
Il piatto è una forma di ascendenza orientale, tradizionalmente collegata all’introduzio-ne dell’uso rituale del consumo della carne, utilizzato come vassoio per la presentazione a tavola. All’interno della tomba ne sono stati recuperati tre: due in impasto rosso e uno del ben noto tipo ad aironi67. I primi due sono riferibili alla stessa tipologia68: vasca poco pro-fonda carenata, labbro a tesa quasi orizzontale, fori di sospensione nei pressi della carena e piede ad anello; uno ha l’orlo piatto esternamente e il fondo ombelicato69; l’altro l’orlo arrotondato e leggermente assottigliato e presenta la vasca interna decorata con due scana-lature concentriche70 (Fig. 10, a-b). La forma con basso piede ad anello e vasca schiacciata incontra maggiore fortuna a Veio e in area falisca fin dall’inizio del VII secolo a.C., mentre nel Lazio è maggiormente diffuso il piatto su piede con vasca profonda71.
Per quanto concerne il piatto ad aironi, assai diffuso a Veio72 e Cerveteri73, esso pre-senta labbro a tesa con orlo arrotondato, vasca troncoconica e fondo piano. La decora-
67 MarteLLi 1987a, pp. 16-17 e p. 256, scheda 28.3.68 Inv. 566272, 566273. Nella classificazione di Silvia ten Kortenaar riconducibili al gruppo 290 C (ten
kortenaar 2011, pp. 148-154, tavv. 41-43).69 ten kortenaar 2011, tipo 290 C a 1, pp. 148-149, tav. 41; questa variante sembra presentare le pri-
me attestazioni tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII sec. a.C., come testimoniato dai confronti di Caere: Mon-te Abatone, tt. 76, 89 (Milano 1986a, pp. 33-41, n. 44; pp. 53-63, n. 28) e di area falisca: Narce, Monte Cerreto, t. 103 (BagLione, de Lucia broLLi 1998, pp. 161-166, fig. 21, Orientalizzante antico); Monte Li Santi, tomba 2 di Philadelphia (haLL dohan 1942, p. 53, n. 19, tav. XXVII). Anche a Veio è presente a Casale del Fosso, tt. 804, 868 nella fase IIIA locale (720-680) e 861 (secondo quarto del VII sec. a.C.) (ten kortenaar 2011, pp. 218-219, 221-222), per proseguire fino all’Orientalizzante recente a Macchia della Comunità, tt. 12, 42 (inediti: ten kortenaar 2011, p. 149).
70 ten kortenaar 2011, tipo 290 C c 2, p. 152, tav. 43, datato all’Orientalizzante medio. È attestato a Veio: tumulo Vaccareccia, sepolcro A - vano I (steFani 1935b, p. 45, n. 43, fig. 11a, 630-620 a.C.); Picazzano, tt. XVI, XVII (paLM 1952, p. 56, n. 2, pl. III; p. 56, n. 2, pl. IV) e nel territorio: Pantano di Grano, t. 1 (de santis 1997, p. 120, n. 1, fig. 12, secondo quarto VII sec. a.C.); Poggioverde, tt. 8, 13 (piergrossi 2003-2004; Piergrossi in de cristoFaro, piergrossi 2012, pp. 128-129, tav 18/4, tombe databili nel terzo quarto del VII sec. a.C.). Presenti anche in area falisca a Narce: Cavone di Monte Li Santi, t. 3 e t. 64B di Philadelphia (bagLione, de Lucia broLLi 1998, p. 134, fig. 7.5, Orientalizzante recente; haLL dohan 1942, p. 53, n. 19, tav. XXVII; p. 73, n. 3, pl. XXXVIII).
71 Piergrossi in acconcia, piergrossi, ten kortenaar 2004, p. 124.72 Inv. 566252. Nella classificazione di Sara Neri riconducibile al tipo Bb1a (neri 2010, pp. 171-174, tav. 31).
A Veio: Grotta Gramiccia, t. 2 (boitani et Al. 2008, pp. 23-24, 680-660 a.C.); Monte Michele, forse t. B (cristo-Fani 1969, p. 48, nn. 12-13, tav. XXIV/1, 700-675 a.C.); Vaccareccia, sporadico (papi 1988, p. 101, n. 12); Macchia della Comunità, tt. 26, 33, 34, 35, 64 (inediti, citati in neri 2010, p. 171); Pozzuolo, tt. 2, 4, 10 (inediti, citati in neri 2010, p. 171); Riserva del Bagno, t. V (buraneLLi 1982, p. 94, n. 2, fig. 2); Pantano di Grano, tt. 1, 2 (de santis 1997, p. 124, n. 29, fig. 15; p. 133, n. 13, fig. 22, secondo quarto VII sec. a.C.); Passo della Sibilla, t. A (raddatz 1983, p. 210, n. 9, fig. 4/1); Volusia, t. 4 (carbonara et Al. 1996, p. 62 n. 72, figg. 133-133a, ultimo quarto VII sec. a.C.); Poggioreale, t. 4 (inedito, citato in arizza, de cristoFaro, santoLini giordani 2001, p. 442).
73 Per la bibliografia sui confronti a Caere: neri 2010, pp. 171-174.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 73
zione dipinta in colore marrone rossiccio sul fondo esterno prevede fasce concentriche e quattro aironi gradienti e nel tondo centrale una teoria di raggi racchiusi in una banda piena; presenti due fori da sospensione all’attaccatura del labbro (Fig. 10, c). La produ-zione di questo tipo inizia tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII sec. a.C. e perdura fino alla fine del terzo quarto del VII sec. a.C.
Coppette su piede
Di incerta funzione sono invece i cinque esemplari di coppette su piede: uno in impa-sto rosso, uno in bucchero grigio, due in ceramica depurata e uno etrusco-corinzio.
Fig. 10. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Corredo dalla tomba 3 (inv. a. 566272, b. 566273, c. 566252; foto autori).
c
ba
74 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
L’esemplare in impasto rosso presenta labbro a tesa quasi orizzontale decorata da una fila di triangoli con il vertice verso l’interno, campiti da trattini obliqui paralleli, orlo arrotondato, vasca emisferica e alto piede a tromba (Fig. 11, a). L’inquadramento crono-logico, alla luce dei pochi confronti, è fissabile nella prima metà del VII sec. a.C. 74.
Quello in bucchero grigio ha l’orlo assottigliato, il labbro rientrante, la vasca poco profonda troncoconica e il piede a tromba; presenta un collarino sullo stelo (Fig. 11,
74 Inv. 566291. A Veio: Casalaccio, t. II (vighi 1935, p. 45, n. 5, tav. I /2, con decorazione simile). In impasto bruno con incisioni riempite di colore rosso: Volusia, t. 10 (carbonara et Al. 1996, p. 97, n. 6, figg. 185-186a, con decorazione zoomorfa, or. rec.); Monte San Michele (carbonara et Al. 1996, p. 123, n. 11, figg. 241-241a). È presente anche un esemplare simile proveniente da una tomba prossima al contesto in esame e parzialmente pubblicata (giannini 2009, p. 249, n. 4, figg. 137-138, con decorazione simile ma meno arti-colata). A Cerveteri: Banditaccia, t. B25 (sartori 2002, p. 16, B25.8-9, tav. VIII, figg. 11a-b, 12a-b, datata al primo-secondo quarto del VII sec. a.C. su base epigrafica).
Fig. 11. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Corredo dalla tomba 3 (inv. a. 566291, b. 566211, c. 566244, d. 566292; foto autori).
a b
dc
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 75
b). La forma non trova confronti in bucchero in ambito veiente75; l’inquadramento cronologico si colloca quindi genericamente tra gli anni finali del VII e la metà del VI sec. a.C.
Per quanto concerne invece i due in ceramica depurata, la forma è più nota76: labbro a tesa rientrante, orlo arrotondato ingrossato, vasca a calotta e piede a tromba; la deco-razione è costituita da incisioni concentriche sulla tesa e parallele sulla vasca e sul piede (Fig. 11, c); in merito alla cronologia, questi esemplari sembrano da ricondurre nelle fasi finali dell’Orientalizzante recente.
Più nota a Veio è invece la coppetta in ceramica etrusco-corinzia77: labbro a tesa orizzontale, bassa vasca globulare, alto piede a tromba con collarino sullo stelo; la deco-razione, in colore rosso e marrone scuro, sul piede e sul labbro, prevede una fascia a spirale lungo lo stelo e sulla faccia interna della vasca; sono presenti due forellini da sospensione sul labbro, prossimi all’orlo (Fig. 11, d). Anche per questo esemplare la datazione sembra potersi fissare tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. a.C.
Alla luce della forma con orlo a tesa orizzontale o, nel caso delle acrome e del buc-chero, addirittura rientrante, queste coppette non sembrerebbero prestarsi ad un uso poto-rio. Si propone quindi una lettura come piccoli contenitori per piccoli frutti (nocciole, fichi, etc.) o per modeste porzioni di carne o salse da impiegare sempre per il consumo delle carni.
75 Inv. 566211. Si può sommariamente ricondurre al Gruppo 27 di Rasmussen, pl. 42, n. 275, ma con marcate differenze: l’esemplare in esame è quasi il doppio in altezza, con piede ben più sviluppato decorato da un collarino. A Veio invece è presente in ceramica depurata a Picazzano, t. XIII (paLM 1952, p. 54, n. 7, pl. II, con piede molto più basso); Casalaccio, t. VII (vighi 1935, p. 58, nn. 5-6, fig. 7, senza collarino). Dalla cd. ‘casa torre’ con cisterna di Piazza d’Armi proviene un esemplare simile in ceramica figulina con vasca legger-mente più globulare, datato alla metà del VI sec. a.C. (Formello 2003, p. 103, n. 133). Qualche confronto, con alcune differenze, da Poggio Buco, t. VII (bartoLoni 1972, pp. 94-96, nn. 76-78, tav. LV/d-f, ultimo quarto VII-inizi VI sec. a.C.; peLLegrini 1989, pp. 96-97, nn- 315-317, tavv. LXVII-LXVIII, senza collarino e con piede meno sviluppato oltre che assai più piccole in altezza). Un confronto più stringente per la forma, ma in ceramica etrusco-corinzia, è sempre da Poggio Buco, t. VII (bartoLoni 1972, p. 83, n. 33, tav. XLVI/b, con piede meno slanciato).
76 Inv. 566243, 566244. Tumulo Vaccareccia, sepolcro A - vano I (steFani 1935b, p. 338, n. 38, fig. 12/h, 630-620 a.C. in de santis 2003); sporadico (papi 1988, p. 123 n. 23); Volusia, t. 8 (carbonara et Al. 1996, p. 89, n. 14, figg. 167-167a, con decorazione leggermente differente, fine VII-inizi VI sec. a.C.). Un esemplare molto simile a Poggio Buco (bartoLoni 1972, sporadico B, p. 170, n. 32, fig. 84, tav. CXVI/a).
77 Inv. 566292. A Veio: Monte Aguzzo (Tumulo Chigi: bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, p. 38); Volusia, t. 4 (carbonara et Al. 1996, pp. 70-71, nn. 57-60, figg. 128-130a, con fasce parallele invece che a spirale, ultimo quarto VII sec. a.C.); Monte Vascurella (steFani 1922, p. 218, n. 40, fig. 3/c). Il tipo è diffuso a Caere: Monte Abatone, t. 45 (Milano 1986a, pp. 28-29, n. 11, or. medio-prima metà VI sec. a.C.) e, soprattutto, a Poggio Buco t. VII (bartoLoni 1972, p. 83, nn. 34-35, fig. 38, tav. XLVI/c-d, ultimo quarto VII-inizi VI sec. a.C.). Per la bibliografia sugli altri confronti: Mangani 1986, p. 29, tav. 37, n. 1.
76 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
Askoi
Questa forma, atta a contenere liquidi, poteva essere impiegata per la mensa (olii, salse particolari, etc.) o per la toletta personale78. Nella Tomba 3 è presente un esemplare del tipo ad anello orizzontale, con orlo trilobato, alto collo cilindrico, corpo a sezione circolare e ansa a nastro dal labbro al corpo; la decorazione, di colore rossiccio, consiste in linee orizzontali e tremule parallele sul collo, reticella e serpentello sull’ansa, denti di lupo sul corpo che sormontano una fascia di colore pieno (Fig. 12, a).
La forma dell’askos è poco ricorrente79; la produzione sembra iniziare già nell’O-rientalizzante medio e il tipo di decorazione ci consente di considerarlo etrusco-geome-trico e collocarlo attorno alla metà del VII sec. a.C.
Aryballoi
Contenevano olii e profumi per la cura del corpo gli aryballoi che nella Tomba 3 sono presenti in quattro esemplari: il primo in argilla colore giallo-verdastra con lab-bro a tesa, collo cilindrico, spalla schiacciata, corpo ovoide, fondo piano; la decorazione, dipinta in colore marrone scuro, consiste in linee concentriche sulla tesa e parallele sulla spalla oltre a bande più spesse sul corpo (Fig. 12, b). L’esemplare sembrerebbe potersi ricondurre alla serie protocorinzia dei conical con decorazione a bande80 o ad una sua imitazione locale, inquadrabile cronologicamente nella seconda parte del secondo quarto del VII sec. a.C.81.
78 bedini 1987, p. 164.79 Inv. 566240. Anche Sara Neri nella sua classificazione, alla luce della limitatezza delle attestazioni,
suddivide gli askoi tra quelli con corpo ad anello orizzontale e verticale; in particolare quindi il nostro esem-plare rientra nel Tipo 1 (neri 2010, pp. 33-35, tav. 2). Confronti a Veio: Monte Michele, t. 5 (boitani 1982, p. 102, tav. XXXVI/2; ripreso in boitani 1983, p. 544, tav. XCVI/b e in boitani 2001, pp. 117-118, n. I.G.8.23, secondo quarto VII sec. a.C.); da considerare anche un askos ad anello orizzontale con fregio dei cani correnti sul corpo, recuperato negli scavi ottocenteschi di Veio (bernabò brea 1942, III Cb, tav. 1, figg. 2-3, ripreso in beLLeLLi 2007, pp. 301-303, fig. 41; deLpino 1985, pp. 93-106, fig. 58). Tipo attestato anche a Caere: Monte Abatone, t. 4 (rizzo 2007, p. 30, n. 28, fig. 37; scheda con inquadramento della forma ed esausti-va bibliografia), Tarquinia (canciani 1974, p. 36, nn. 7-8, tav. 27/7-8, terzo venticinquennio VII sec. a.C.), Poggio Buco, t. VII (bartoLoni 1972, p. 84, n. 41, tav. XLVI/e-f, ultimo quarto VII secolo a.C.), Narce, t. 8 (pasqui 1894, col. 529, n. 31, ripreso in beLLeLLi 2007, p. 302, figg. 37-39). Esemplari anche dalle necropoli di Castel di Decima, tt. 5, 81 (guaitoLi, picarreta, soMMeLLa 1974, p. 112, n. 17, fig. 15; F. Zevi in Roma 1976, p. 289, primi anni del VII sec. a.C.) e Acqua Acetosa Laurentina, t. 133 (bedini 1987, pp. 163-164, n. 45, terzo quarto VII sec. a.C.).
80 neeFt 1987, Stream F, List LXI, pp. 121-124, 236. Nella classificazione di Sara Neri rientra nel tipo 2a (neri 2010, p. 25, tav. 1).
81 Inv. 566237. Confronti a Veio: Monte Michele (cristoFani 1969, sporadici, p. 50, n. 9, fig. 25, tav. XXV n. 5; boitani 1982, p. 100, ripreso in boitani 1983, pp. 541-542, fig. 3, con cirri sulla spalla); Casa-
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 77
Fig. 12. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Corredo dalla tomba 3 (inv. a. 566240, b. 566237, c. 566246, d. 576088, e. 566247, f. 566238; foto autori).
a d
b
e
c
f
78 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
Il secondo aryballos ha sempre tesa orizzontale ma collo meno sviluppato, corpo ovoide con spalla maggiormente marcata, fondo piano e ansa a nastro dal labbro alla base del collo; la decorazione, marrone rossastra, prevede una linea ondulata racchiusa tra due linee concentriche sulla tesa, linee parallele sul collo, sulla spalla e sull’ansa e due bande parallele sul corpo; nella fascia risparmiata tra spalla e collo è presente una serie di motivi a rosetta con corpo circolare pieno e corona circolare a puntini ravvicinati (Fig. 12, c). Il motivo della rosetta con corona puntinata è ben noto nella ceramica proto-corinzia, soprattutto nella serie conical in cui il nostro aryballos rientrerebbe82; si avan-zano dei dubbi sulla possibilità che il pezzo fosse stato importato piuttosto che prodotto localmente83; genericamente quindi si propone una datazione simile al precedente.
Per quanto concerne gli altri due aryballoi, sembra evidente la loro produzione etru-sco-corinzia; il primo è piriforme con labbro a tesa orizzontale, orlo arrotondato, collo cilindrico, ansa a nastro dal labbro alla base del collo, spalla sfuggente e piccolo piede a bottone. La decorazione, di colore marrone rossastra, consiste in petali sulla spalla e sulla tesa; sul corpo, sotto una doppia serie orizzontale di puntini, una fascia di quattro ordini sovrapposti di squame con punto centrale e disegno inciso; la fascia sormonta due linee parallele orizzontali ravvicinate e un campo con un motivo a silhouette forse ricon-ducibile al tema dei cani correnti (purtroppo la pittura è assai evanide e non consente la lettura completa del motivo); sopra il piede una seconda serie di petali; l’ansa invece riporta linee parallele orizzontali (Fig. 12, e). La forma e il tipo del pezzo sono noti in Etruria84 ma la compresenza del motivo dei running dogs85 e delle squame non trova confronti, almeno a Veio; la collocazione cronologica sembra porsi nell’ambito dell’O-rientalizzante recente.
L’ultimo degli aryballoi presenta una forma particolare: tesa orizzontale, collo cilin-drico, ansa a nastro dal labbro al collo, spalla carenata profilata, corpo troncoconico, largo piede piano. La decorazione, dipinta di colore marrone scuro, consiste in tratti-
laccio, t. III (vighi 1935, p. 49, n. 29, tav. I/3); Volusia, t. 4 (carbonara et Al. 1996, pp. 64-65, n. 48, figg. 119-119a, ultimo quarto VII sec. a.C.). Vedi anche Caere: tomba Giulimondi (cascianeLLi 2003, pp. 40-41, n. 5, fig. 5, datato alla prima metà del VII sec. a.C.); Monte Abatone, t. 90 (Milano 1986a, p. 80, nn. 94-96) e Tarquinia: Macchia della Turchina, t. 65,1 (Milano 1986b, p. 225, n. 640, fig. 220).
82 Inv. 566246. Vd. nota 80.83 Un’analisi delle argille potrebbe dirimere la questione, altrimenti di difficile soluzione.84 Inv. 566247. A Veio: Picazzano, t. XX, XXI (paLM 1952, p. 60, n. 32, pl. VIII; pp. 60-61, n. 13, pl.
IX; p. 61, n. 14, pl. IX; tutti solo con squame e senza motivo decorativo sottostante; p. 60, n. 11, pl. IX, ripreso in beLLeLLi 2007, p. 300, figg. 26-27 con cani correnti sulla spalla); Vaccareccia, sporadico (papi 1988, p. 102, n. 15, senza squame); Volusia, t. 10 (carbonara et Al. 1996, pp. 103-104, n. 19 solo con squame, or. rec.). Presenti anche a Caere: Monte Abatone, t. 90 (Milano 1986a, p. 79, n. 87; note sul tipo a p. 111, n. 5, note 22-25); Vulci: Osteria, t. 81 (rizzo 1990, p. 111, XIV, 3, fig. 215, ultimo quarto VII-primo quarto VI sec. a.C.); Poggio Buco (bartoLoni 1972, sporadici A, p. 160, n. 12, fig. 78, tav. CV/e; peLLegrini 1989, p. 112, n. 356, tav. LXXVIII).
85 Sul motivo dei running dogs beLLeLLi 1997, pp. 7-54 con bibliografia precedente.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 79
ni paralleli sulla tesa, petali sulla spalla che sormontano bande orizzontali; sulla carena trattini paralleli e sul corpo larga fascia piena che sormonta due linee parallele; serie di petali sopra il piede mentre l’ansa è decorata con linee parallele (Fig. 12, f). L’aryballos, dalla rara forma caratterizzata da un profilo marcatamente sagomato, a scaletta, è presen-te nel repertorio etrusco-corinzio, seppure poco attestato86.
Alabastra
Uno solo l’esemplare del contenitore per unguenti profumati (Fig. 12, d), di una forma definita “con fondo piatto” o forma Ricci 121 della classe dei running dogs87. Purtroppo si conserva solamente la parte inferiore del vaso: corpo troncoconico e fondo piatto. La deco-razione dipinta in colore marrone scuro rossastro è costituita da colore pieno per la parte superiore visibile del vaso e da due registri risparmiati e sovrapposti, separati da una spessa linea orizzontale: nel superiore una teoria di cani correnti, dipinti a silhouette e rivolti a destra, mentre in quello inferiore trattini orizzontali ravvicinati. Il tipo di vaso e la decora-zione indicano con chiarezza la sua appartenenza alla classe etrusco-corinzia con una data-zione che oscilla tra la fine del VII e la prima metà del VI sec. a.C.88.
Materiali metallici
Tra i numerosi frammenti in ferro alcuni sono riferibili ad armi, altri ad utensili lega-ti al consumo della carne nell’ambito del banchetto o a strumenti di lavoro. Di incerta attribuzione è l’elemento lacunoso di filo bronzeo conformato a doppia spirale89 (Fig. 13, a), che potrebbe appartenere ad un gancio ad occhi90.
86 Inv. 566238. A Veio l’unico confronto che si può porre è con un esemplare da Monte Oliviero (steFani 1928, p. 102 h, fig. 8), anche se con marcate differenze. Il confronto più stringente è con un esemplare dalla t. 7 di Lucrezia Romana (Roma 2006, p. 371, II.667, scheda di M.H. Marchetti); altri confronti a Vulci: Osteria, t. 81 (rizzo 1990, p. 113, XIV, 17, fig. 227), Poggio Buco, t. VII (bartoLoni 1972, 82, nn. 26-27, fig. 37, tav. XLIV/e-d, ultimo quarto VII-primo quarto VI sec. a.C.). Un tentativo di inquadramento tipologico è in coen 1991, p. 118.
87 Inv. 576088. Per una sintesi sugli alabastra forma Ricci 121 con cani correnti: beLLeLLi 2007, pp. 293-324 con bibliografia precedente.
88 Sono noti, provenienti da Veio e conservati presso il museo di Hannover, quattro esemplari assai simili al nostro (gercke 1996, pp. 112-113, nn. 35-38, con decorazione differente nel registro inferiore). Secondo Bellelli i quattro esemplari di Hannover andrebbero attribuiti allo stesso decoratore di due esemplari tarquiniesi che denomina Pittore di Tarquinia (beLLeLLi 1997, p. 42). Si segnala la presenza di un esemplare dal Tumulo Chigi (bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012, p. 39, fig. 7/b) con diversa scansione decorativa.
89 Inv. 576089.90 Cfr. Narce, t. 24 M (haLL dohan 1942, p. 33, n. 20, pl. XVII).
80 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
Un’immanicatura a cannone con foro passante91 (Fig. 13, c) per il fissaggio dell’asta lignea, di cui restano tracce, appartiene verosimilmente ad una lancia, attributo principe di cittadinanza piena e di maturità, oltre che di abilità alla guerra92.
Alcuni frammenti potrebbero appartenere ad un coltello a profilo continuo93 (Fig. 13, d), mentre è certa la presenza di un coltello in ferro a lama serpeggiante94 (Fig. 13, e) ricomposto da due frammenti, di circa 15 cm di lunghezza, utilizzato per la macellazione ed il taglio delle carni anche in funzione rituale e sacrificale. Il tipo è largamente diffuso nell’Italia centro-meridionale tirrenica, fin dal Bronzo Finale, realizzato in bronzo. Le notevoli dimensioni, la lama larga verso la base ad andamento serpeggiante con dorso e
91 Inv. 566312, 566313.92 Sul significato simbolico dell’hasta vedi scarano ussani 1996.93 Inv. 566314a. Il tipo non è identificabile a causa del pessimo stato di conservazione.94 Inv. 566314b.
Fig. 13. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Materiali metallici e fuseruola dal-la tomba 3 (inv. a. 576089, b. 566253, c. 566312, d. 566314a, e. 566314b, f. 566316, g. 566317, h. 566315; foto autori).
a b
f
g
h
c
d
e
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 81
taglio quasi paralleli fanno discendere questo esemplare dal tipo Caracupa95, diffuso dal-l’VIII sec. a.C. nel Lazio e in Campania.
Alcuni frammenti di verga di ferro a sezione quadrangolare96 sono pertinenti a spie-di (Fig. 13, f): largamente attestati in ambiente tirrenico a partire dalla seconda metà dell’VIII sec. a.C., dove, al pari di altri elementi connessi con l’ideologia del banchetto e la preparazione del pasto funebre, stanno ad esprimere lo status sociale del defunto. Sembrano potersi riconoscere anche alcuni frammenti di alari97 (Fig. 13, g), molto corro-si ed ossidati, con terminazione arcuata che trovano confronto con analoghi esemplari da Veio, Caere e Vulci98. In entrambi i casi si tratta di tipi molto generici, caratterizzati da un’ampia diffusione su scala geografica e, allo stesso tempo, attestati in un range crono-logico altrettanto ampio.
Legata ad attività agricole è la roncola in ferro99 (Fig. 13, h), presente anche nella t. 5 della stessa necropoli con due esemplari, strumento di specifico impiego per la potatura nell’arboricoltura e, in particolare, nella viticoltura100. Questo strumento era usato, inoltre, per lo sfruttamento di risorse boschive e della macchia: tagliare e pulire rami e canne di dimensione media o piccola, appuntire pali, eliminare la corteccia. Poteva quindi trovare impiego anche per ricavare la materia prima per barche e lo strumentario necessario alla pesca (nasse e reti con relativi galleggianti in sughero) e per le torce resinate per la pesca
95 bianco peroni 1976, pp. 40-41, taf. 18-19; vedi anche A. Bedini in bedini, cordano 1975, pp. 383-384; bartoLoni 1989, pp. 44-45. Un esemplare molto simile in ferro proviene dall’area ceretana (rico-gnizioni Arco del Mignone), in angioni 1990, p. 263, figg. 339, 341/3. Da rilevare la presenza di un esempla-re in ferro in uno strato di riempimento nel santuario orientale di Gabii con materiali coerentemente databili fra VIII e VII sec. a.C. (zuchtriegeL 2012, pp. 243-244, fig. 2/5).
96 Inv. 566316. Altri esemplari provengono da contesti sepolcrali veienti appartenenti a figure principe-sche del Villanoviano finale e dell’Orientalizzante antico: Quattro Fontanili, t. Z 15 A (Quattro Fontanili 1965, p. 177, fig. 87, tre spiedi in ferro); Casal del Fosso, t. 1038 (buraneLLi 1979, p. 2, fig. 2.4-5, due spiedi in bronzo); Monte Michele, t. 3 (boitani 1983, p. 546, tav. 99b, ferro).
97 Inv. 566317.98 Gli alari risultano quasi sempre compresenti agli spiedi. Si trovano a Veio nei corredi citati alla nota
96: Quattro Fontanili, t. Z 15 A (Quattro Fontanili 1965, p. 178, y fig. 87, un alare in ferro); Casal del Fosso, tt. 1038, 1073 (buraneLLi 1979, p. 2, fig. 4, un alare in ferro; p. 1, fig. 8.2, frr. alari in ferro); Monte Michele, t. 3 (boitani 1983, p. 546, tav. 99a). A titolo esemplificativo vedi il set per la cottura delle carni dalla tomba degli Alari di Cerveteri, datato all’ultimo quarto del VII sec. a.C. (ricci 1955, c. 329 e ss.; scheda di G. Bar-bieri in Viterbo 1987, p. 160, n. 39). A Vulci, Osteria, t. 167 (A.M. Moretti Sgubini in Roma 2001, pp. 207-215, III.B.3.28, datata tra l’ultimo trentennio del VII ed il primo quarto del VI sec. a.C.). Per una disamina dei ritro-vamenti di alari e spiedi in area centro-meridionale da ultimi kohLer, naso 1991.
99 Inv. 566315.100 deLpino 1989, 1997, 2007 analizza la presenza di pennati dal Bronzo finale alla prima età del Ferro
in relazione con lo sviluppo di attività agricole specializzate. Un differente uso dello strumento è raffigurato su una hydria ceretana, utilizzato come arma da un eroe che affronta un mostro marino (heMeLrijk 1984, pp. 45-46, pl. 13, 17, 103-105, 133, 138, 154; fig. 61). Si ringrazia Laura Ambrosini per la segnalazione.
82 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
notturna101. Non subendo particolari variazioni morfologiche, gli attrezzi agricoli risul-tano particolarmente difficili da collocare cronologicamente con precisione in assenza di dati contestuali circoscritti102. Un esemplare molto simile al nostro è conservato presso il Museo Archeologico di Firenze, provenienza sconosciuta, e viene datato all’età ellenisti-ca103.
È da riconoscere un attrezzo agricolo anche in un pezzo di ferro di forma rettango-lare104, scheggiato ma molto pesante, forse appartenente ad una scure o un’ascia/pic-cone che poteva servire a carpentieri per squadrare e lisciare tronchi, tra l’altro, anche nell’ambito delle costruzioni navali.
Fuseruole
Appartenente alla sfera femminile è invece la fuseruola (Fig. 13, b) troncoconica in bucchero105 e, forse, il frammento di perla106 in ambra a botticella scanalata. Le fuse-ruole, come tutti gli strumenti legati alla filatura e tessitura, si trovano in contesti fune-rari a connotare l’attività principale della donna, e spesso in contesti abitativi. Realizzate abitualmente in impasto fin dall’epoca protostorica, le fuseruole in bucchero sono meno diffuse107.
Marco arizza, aLessandra piergrossi
101 Vedi il ritrovamento all’interno della capanna di VII sec. a.C. a Punta Chiarito (Ischia) (giaLaneLLa 1994, p. 193, B86, fig. 31.3; aLecu 2004, p. 134).
102 Sepolture con strumenti da lavoro appartenenti a guerrieri eminenti sono diffuse fin dall’età del Ferro (per una disamina delle presenze, soprattutto in Italia meridionale, cfr. iaia 2006, ed in particolare per le roncole p. 194, fig. 4/15-16; vedi anche Calatia, t. 194, ultimo quarto dell’VIII sec. a.C., in LaForgia 2003, p. 139, cat. 74, fig. 111). Per l’ambito etrusco un esemplare dalle ricognizioni dell’Arco del Mignone in angioni 1990, p. 263, fig. 341/2. Per una parziale rassegna di attrezzi e strumenti agricoli in area etrusca vd. il “Ripostiglio del Genio Militare” da Talamonaccio (scheda di G. Colonna in Viterbo 1987, p. 144-145, n. 6).
103 In Firenze 1985, pp. 147-148, 6.17 e Viterbo 1987, p. 144, n. 4.104 Inv. 576090.105 Inv. 566253.106 Inv. 576097.107 Per alcuni confronti vedi: Veio, deposito votivo Campetti (vagnetti 1971, p. 153, nn. 2-3, tavv.
LXXVI ed E); San Giovenale, necropoli di Porzarago, t. 13 (berggren, berggren 1972, p. 84, n. 52, tav. LVI); Orvieto, Crocefisso del Tufo, t. 53 (bizzarri 1966, p. 99, nn. 1099-1122, fig. 43); Roma, Velia, pozzo I (A. Magagnini in Roma 1990, p. 107, n. 20, fig. 4.7.20); dall’area sud-ovest del Palatino, struttura ipogea sotto il tempio della Vittoria (M.F. Rossi in pensabene, FaLzone 2001, p. 269, tav. 87.412, fine VII-VI sec. a.C.); Gabii, tempio di Giunone Regina (gran ayMerich 1982, pp. 350-351, fig. 2.2).
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 83
iL kAnthAros e La sua decorazione (Figg. 14-15)
Il kantharos, purtroppo frammentario e solo parzialmente ricostruibile108, si presenta di colore cuoio brunito, lucidato109 e a vasca carenata, con larghezza che prevale sull’altez-za110. Il piede è ad anello, la vasca bassa con profilo quasi rettilineo ornata all’esterno con baccellature radiali a profilo arrotondato desinenti verso la carena con uno spigolo decorato a punte di diamante. Il bacino è alto con pareti a profilo solo leggermente convesso, deco-rate esternamente con tecnica ad incisione. Il bordo è indistinto a margine arrotondato. Sul-la carena si impostano, in punti diametralmente opposti, due anse laterali a doppio baston-cello e sezione circolare irregolare che, sormontando la vasca, a due terzi della loro altezza, si fondono in un unico elemento decorato con costolature orizzontali desinenti in protomi d’ariete. Le terminazioni a testa d’ariete delle anse si saldano sull’orlo della vasca. I due elementi zoomorfi presentano musi ben descritti resi con una costolatura centrale a spigolo vivo, due cerchietti per gli occhi ed un breve taglio orizzontale per la bocca. Le corna degli animali, a forte effetto plastico, sono assai revolute con costolature definite. L’interno del vaso è decorato sul fondo con una serie di cerchi concentrici costolati contornati da una raggiera di solcature (Fig. 16). Le pareti, purtroppo non complete, presentano esternamen-te su entrambi i lati una complessa scena di navigazione, la cui lettura, come si dirà, non sempre risulta perspicua in tutti i suoi particolari. La decorazione occupa quasi interamente le due pareti; è realizzata mediante incisione a crudo con strumento a punta stondata di discreta larghezza e poi riempita di cinabro111.
Per comodità descrittiva ed in modo del tutto convenzionale, i due lati del vaso sono stati distinti con le lettere A e B. Sul lato A (Figg. 17-18) è presente una nave tondeggian-te dalla chiglia seminascosta sotto il pelo d’acqua, con estremità di prua e poppa molto revolute e decorate fino alla punta con una serie di solcature parallele. Il ponte superiore è occupato da due figure umane collocate agli estremi della nave. A prua, è un guerriero stante rivolto verso sinistra, barbato, dotato di elmo, recante due lance sulla spalla sinistra e, parzialmente leggibile, uno scudo rotondo sempre tenuto sul lato sinistro; nei pressi del fianco sinistro del guerriero è anche un altro oggetto verosimilmente identificabile con una piccola scala a pioli. A poppa, invece, è un’altra figura caratterizzata sempre con barba a punta, ma priva di elmo e di armatura, che si presenta seduta con le gambe allungate e
108 Inv. 576093. Il pezzo, rinvenuto disseminato disordinatamente nel riempimento della tomba, è stato ricomposto da una quarantina circa di frammenti e solo in parte reintegrato, in particolare laddove le necessità statiche per la valorizzazione del fittile lo richiedevano.
109 La superficie ceramica presentava, prima del consolidamento e restauro, una patina fragile e piuttosto degradata dall’attacco acido del terreno che ne ha alterato in qualche parte la lucidatura.
110 Il diametro della vasca misura cm 15, l’altezza al bordo è di cm 11 mentre al sommo delle anse è di cm 15,5. Lo spessore delle pareti varia tra cm 0,3 e 0,4.
111 La determinazione della qualità del colore utilizzato è stata ottenuta mediante analisi di laboratorio XRF (X.ray fluorescence spectroscopy), condotte su un campione di pigmento prelevato al momento dello scavo.
84 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
Figg. 14-15. agro veientano (RM), necropoli di via A. d’Avack. Il kantharos con scena di navigazione (foto autori) e rilievo del vaso (D. Rossi).
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 85
sostenendo con la mano destra una lunga scala con undici pioli che affonda verso la fian-cata del natante. Attorno alla figura si dispongono riempitivi di vario tipo: alla sua destra, una girandola ed una foglia vagamente cuoriforme pendente da un lungo stelo ricurvo; alla sua sinistra, un motivo a petalo situato nei pressi della testa e tre elementi dall’aspetto irregolarmente amigdaloide, forse foglioline stilizzate. L’imbarcazione presenta un albero maestro centrale ed una vela rettangolare decorata con incisioni a reticolo e semiraccol-ta sul pennone trasversale. Il cordame laterale non sembra fissare la vela ad un cassero, proseguendo invece direttamente fin sulla chiglia. Sia il cordame verso poppa che l’albero
Fig. 16. Veduta del fondo decorato e delle anse a protome d’ariete del kantharos (foto SBAR).
86 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
centrale presentano una serie di incisioni a festone. Sempre sul ponte, nella zona centrale, all’interno dei due triangoli che si formano tra l’albero maestro centrale ed il cordame late-rale sono rappresentati due volatili, identificabili con gli animali convenzionalmente defi-niti in letteratura come aironi, rivolti di profilo verso destra. L’esemplare di sinistra mostra
Figg. 17-18. Lato A del kantharos (foto SBAR) e rilievo della scena lato A (D. Rossi).
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 87
un pennacchio sulla sommità del capo. Lo scafo della nave, nella fascia centrale, è rappre-sentato sezionato e bipartito in due registri che si sovrappongono orizzontalmente, consen-tendo così all’osservatore la visione frontale del contenuto dell’interno dello scafo e delle panchine di levaggio. I due registri di questa sezione risultano a loro volta quadripartiti da tre divisori composti ciascuno da tre solcature verticali parallele, indicanti lo scheletro del natante. In ognuno dei quattro riquadri del registro inferiore è un cavallo di profilo112 rivolto verso sinistra davanti al muso del quale si trova una mangiatoia a forma di ferro di cavallo. Il registro superiore mostra invece, sempre in uno schema quadripartito113, diverse figurazioni: a partire da sinistra, nel primo riquadro un uomo barbato seduto verso pop-pa con le gambe allungate ed un remo nelle mani, identificabile come vogatore; nel terzo riquadro una figura umana raffigurata stante e vestita con un abito quadrettato, caratteriz-zato da losanghe romboidali sul torso e le spalle; nell’ultimo spazio verso prua è campito un airone stilizzato reso di profilo e rivolto verso destra. Verso poppa, poi, oltre l’ultimo equino del registro inferiore, si intravedono una gamba quasi distesa ed un braccio che sor-regge il remo governale, da attribuirsi alla rappresentazione in gran parte perduta del timo-niere, che possiamo però supporre di dimensioni analoghe alla soprastante figura attestata sul ponte. Il governale si presenta con una forma a foglia di lauro piuttosto allungata. Sotto la chiglia, verso poppa, è raffigurato con evidenza un lungo e aguzzo sperone tagliamare, mentre, sempre in questo punto, la murata è decorata con tre cerchietti e, nuovamente, due motivi a girandola. Infine, raffigurato apparentemente all’esterno della chiglia verso prua, è un oggetto di difficile definizione e, conseguentemente, identificazione. Si presenta ton-deggiante con una sorta di collo verticale sovrastato da una linea orizzontale convessa; al suo interno è un motivo a ferro di cavallo rivolto verso l’alto, entro i cui rebbi è un circolet-to. Lateralmente al profilo, a destra e sinistra del punto di massima espansione, sembrano rappresentate due sorta di prese ad orecchio, mentre sul fondo spicca una desinenza confi-gurata a losanga o a punta di freccia.
Il lato B del kantharos è conservato in modo decisamente più lacunoso (Figg. 19-20). Da quanto rimane, tuttavia, è possibile affermare che la scena qui raffigurata fosse molto simile a quella del lato A, differendo in sostanza solo per alcuni piccoli dettagli. Il natante inciso è analogo al precedente anche se, purtroppo, conservato solo per la metà compresa tra l’albero maestro e la poppa. Quest’ultima è sempre revoluta con i costoloni messi bene in evidenza. A differenza della nave del lato A, qui sul ponte sembra possibile riconoscere l’esistenza di un cassero reso con due solcature orizzontali parallele al di sopra delle quali si trovano due raffigurazioni di aironi stilizzati di profilo verso destra114, mentre al di sotto di queste è, a sinistra, un riempitivo in forma di conchiglia, a destra, un oggetto non identifica-
112 Il secondo da sinistra per chi guarda è ricostruibile solo in modo ipotetico, poiché in questo punto il vaso presenta una piccola lacuna.
113 Qui il secondo riquadro è perduto completamente.114 Quello a sinistra ben conservato e caratterizzato da un ciuffo di piume sul capo, quello a destro leggi-
bile solo parzialmente.
88 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
Figg. 19-20. Lato B del kantharos (foto SBAR) e rilievo della scena lato B (D. Rossi).
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 89
bile a causa delle lacune del fittile. La vela, sempre rettangolare e caratterizzata da losanghe romboidali, è parzialmente alzata sul pennone orizzontale mentre il cordame è segnato come se fosse fissato fino alla chiglia. Su di esso si notano motivi ondulati, in questo caso resi più spigolosi, con linee a zig-zag, sul cordame di prua ed invece rappresentati con andamento più dolce, a festone, sul cordame di poppa. A poppa, un personaggio barbato seduto sostiene con la mano destra quello che potremmo identificare come il remo-timone o, in alternativa, con la porzione superiore di una scala a pioli analoga a quella registrata sul lato A, ma in questo caso seminascosta all’osservatore dal corpo della nave. Parallelo a questo primo per-sonaggio, subito più in basso e nella stessa posizione a poppa, è un altro personaggio barbato e seduto, stavolta identificabile con sicurezza come timoniere grazie al lungo remo di gover-nale saldamente assicurato nella sua mano destra. Anche la porzione centrale di questo scafo è sezionata in due registri orizzontali sovrapposti, a loro volta suddivisi in quattro riquadri occupati da soggetti raffigurati in dimensioni minori rispetto a quelli sul ponte. Dei riquadri inferiori pertinenti l’interno del natante si conservano solo due equini di profilo rivolti ver-so sinistra e posti di fronte ad una mangiatoia sagomata a forma di ferro di cavallo. Nei tre riquadri superiori superstiti, invece, sono collocati tre rematori seduti di piccole dimensioni, rivolti di profilo verso poppa. Un remo affusolato ma privo di collegamento con la panchina di levaggio è inoltre presente sul fianco della nave allungato verticalmente fin oltre la chiglia. Ancora sotto la chiglia, a poppa, si legge un motivo di incerta definizione, che potremmo interpretare come lo sperone tagliamare già visto sul lato A, inserito però questa volta entro una serie di linee irregolarmente sinuose evocanti presumibilmente le onde marine.
La forma
La genesi e l’evoluzione generale della forma del kantharos sono state largamente dibat-tute da vari autori115, i quali, per quanto attiene all’ambito etrusco, hanno da tempo evidenzia-to la centralità funzionale ed ideologica di questo contenitore nella cerimonia del banchetto.
Per quanto concerne l’esemplare in esame, l’analisi morfologica, pur evidenzian-do alcuni aspetti di unicità relativi al pezzo, permette di delineare i tratti salienti di una famiglia tipologica le cui attestazioni sembrano addensarsi sostanzialmente tra Veio ed alcuni centri del Latium vetus. Le caratteristiche più evidenti e costanti di questi kantha-roi sono costituite da una vasca larga e bassa su piede ad anello, una parete alta e quasi rettilinea, poco svasata, ed anse alte a bastoncello biforcato e sormontanti il labbro. Kan-tharoi in impasto con queste caratteristiche riconducono il vaso ad un tipo che sembra comparire a partire dall’Orientalizzante antico116.
115 Fondamentale: gras 1984; batino 1998, pp. 28-29; Mura soMMeLLa 2005, p. 237 e nota 46 (con bibl. prec.); bieLLa 2007, pp. 115-120.
116 Per il Latium vetus: cfr. Formazione 1980, p. 130, tipo 17 b, 2-3: la forma è simile, le pareti si presenta-no più svasate decorate in genere con meandro e le anse presentano costolature; l’inquadramento cronologico qui
90 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
Confronti utili provengono dalle necropoli urbane di Veio117 e dal suo territorio118, così come da Roma119, Osteria dell’Osa120, Nomentum121, Acqua Acetosa Laurentina122, Castel di Decima123, Lavinium124, Satricum125.
Allo stato attuale delle conoscenze, non siamo in grado di stabilire con certezza qua-le centro possa essere ritenuto responsabile delle prima formulazione di questo genere
proposto è il periodo laziale IV A (730/20- 640/30); gras 1984, p. 326, descrive il tipo che compare nel Lazio nel periodo IV A alla fine dell’VIII secolo e che secondo lo studioso si differenzia moltissimo dagli esemplari vulcenti annunciando l’avvento del classico kantharos di bucchero. Si vedano inoltre caraFa 1995, p. 59, tipo 128 e parise badoni 2000, p. 98, tav. XLII, 3 (dalla t. V della necropoli veiente di Riserva del Bagno, su cui vedi nota successi-va), che corrisponde alla tipologia formale più simile e che presenta anse intrecciate e decorazione a meandro.
117 Riserva del Bagno, tomba V (buraneLLi 1982, p. 96, fig. 3/11), con un esemplare che si presenta morfologicamente simile al nostro, con anse a bastoncello intrecciato e decorazione a meandro inciso; tomba delle Anatre (Medoro 2003, p. 78, fig. 93, 680-660 a.C.): in questo caso l’esemplare presenta forti analogie con quello in esame, in particolare per quanto riguarda le anse che, costolate, si ricongiungono alla sommità dove mostrano una cuspide riproducente in forma stilizzata la testa d’ariete con ricciolo inciso evocativo delle corna; anche l’interno del fondo vasca presenta i cerchi concentrici ed i raggi. Casalaccio: tt. I, III (vighi 1935, p. 42, n. 4, tav. I/1; p. 48, n. 17, tav.I/3).
118 Pantano di Grano sulla via Aurelia: dalla tomba 1 proviene un esemplare che viene definito tazza biansata e che, rispetto a quello in esame, presenta dimensioni minori, vasca più bassa ma uguali anse che, da doppio baston-cello, convergono in un unico manico costolato terminante con protome di ariete; il fondo della coppa è anche qui baccellato ed all’interno mostra le medesime solcature; la decorazione, incisa a crudo e riempita di rosso, è a palmet-te fenicie, zig-zag e punti impressi tra linee parallele (de santis 1997, pp. 112, 120, n. 17, fig. 14, secondo quarto VII sec. a.C.); l’autrice evidenzia come di solito, all’interno del corredo di appartenenza, simili tazze si qualifichino come recipienti di prestigio. Passo della Sibilla, t. a (raddatz 1983, p. 209, n. 1, pp. 212-213, Abb. 2/1a-b, secondo quarto VII sec. a.C.), Poggioverde, t. 4 (piergrossi 2003-2004, secondo quarto VII sec. a.C.).
119 Cfr. ad esempio l’esemplare dalla tomba AA del sepolcreto presso il Tempio di Antonino e Faustina, identico nelle anse, ma privo di baccellature sulla vasca (gjerstad 1966, p. 111, n. 6, fig. 39).
120 Simile nella tettonica generale, è ad es. l’esemplare dalla t. 601, n. 9 (bietti sestieri 1992, tipo 100f, p. 335, tav. 30) con vasca profonda e diritta, anse a doppio bastoncello intrecciato e stesso decoro sul fondo interno della vasca. Particolarmente vicini al nostro esemplare per la conformazione delle anse con pro-tomi d’ariete e il decoro zoomorfo ad incisione della vasca inusuale per questa classe di kantharoi appaiono gli esemplari provenienti dalle tombe 54 e 224, databili rispettivamente all’orientalizzante medio e recente (bietti sestieri 1992, tipo 100i, p. 336, tav. 30).
121 Loc. Quartacci, t. 6 (tognineLLi 2008, pp. 57-59, fig. 8/1), conservato al Museo Pigorini, con anse a doppio bastoncello intrecciato, datato alla seconda metà del VII secolo.
122 T. 70 (bedini 1992, cat. 105).123 T. 7 (M. Cataldi Dini in bartoLoni, cataLdi dini, zevi 1975, p. 328, n. 15, figg. 111, 114, prima
metà VII sec. a.C.). 124 T. a cassone sotto il cd. ‘heroon di Enea’ (P. Sommella in Roma 1976, p. 308, cat. 102/13-14, tav.
LXXX, secondo quarto del VII sec. a.C.). Nell’esemplare le anse a bastoncello doppie si attorcigliano verso l’alto ed i decori incisi sono riempiti di colore rosso.
125 T. II a camera entro tumulo (G. Colonna in Roma 1976, p. 339, cat. 111/15-17, tav. XCII, dal secondo al terzo quarto del VII secolo). In questo caso gli esemplari appaiono quasi sempre di dimensioni minori rispet-to a quello da via d’Avack e caratterizzati da vasca a parete meno rettilinea e spessori maggiori.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 91
di kantharos. Alla luce della documentazione raccolta, infatti, alla vecchia proposta di localizzare a Roma la prima elaborazione del modello126, potrebbe essere tranquillamen-te contrapposta l’ipotesi di un suo spostamento a Veio127, da dove si sarebbe poi diffuso nelle contermini aree gravitanti sul Tevere.
Kantharoi in impasto con anse plastiche e decorazioni incise, come noto, sono carat-teristici anche di alcuni corredi aristocratici delle necropoli orientalizzanti di area fali-sca e capenate. È però interessante rilevare come questi esemplari, pur concettualmente analoghi al fittile in esame, mostrino caratteri morfologici del tutto diversi ed originali rispetto a quelli veienti-laziali, caratteri che in ciascun centro assumono fisionomia parti-colare e che sembrano nel tempo seguire una loro specifica evoluzione formale128.
Da rilevare è che un tipo di kantharos, in parte analogo a quello in esame, ma più semplificato nella dinamica tettonica, ovvero con anse singole e privo di rilievi plastici, risulta attestata anche in alcuni contesti orientalizzanti ceretani129.
Più interessante invece, in questa sede, risulta approfondire l’origine ed il significato di alcuni dei particolari morfologici più rilevanti del nostro fittile. La conformazione del fondo interno del kantharos, ad anelli concentrici e solcature radiali, e le baccellature sull’esterno della vasca dipendono chiaramente da vasi potori realizzati in materiali pre-ziosi, ed in particolare dalle ben note patere baccellate in bronzo di produzione orientale, conosciute anche a Veio in esemplari di produzione assira e locale130. In questo senso, di notevole interesse sono anche le patere baccellate in impasto rosso e bruno131 che Veio ha restituito, evidenti redazioni economiche delle più importanti versioni in metallo prezioso. Esse documentano infatti la piena ed intenzionale assimilazione di questa for-ma nel repertorio morfologico delle officine ceramiche veienti, venendo così a costituire un’indispensabile premessa per la specifica conformazione baccellata del genere di kan-tharos cui il nostro esemplare afferisce132. È probabile che a condizionare questo innesto morfologico possa essere stata la consapevolezza della specifica destinazione funzionale delle patere baccellate nell’ambito del cerimoniale legato al banchetto, ovvero quella di essere vasi potori di prestigio destinati ad esaltare il rango principesco del possessore:
126 Cfr. in proposito coLonna 1988, p. 305, ipotesi ripresa in de Lucia broLLi, benedettini 2000, p. 31.127 Spostamento che sarebbe giustificato dal cospicuo numero di attestazioni del tipo registrate a Veio,
dalla loro cronologia alta (gli esemplari più antichi risalgono già al 680 a.C. ca: Tomba delle Anatre) e dal livello qualitativo di alcuni esemplari, come quello qui in esame.
128 Per l’area capenate, puntuali osservazioni in proposito sono in benedettini 1996, pp. 30-33 e in Mura soMMeLLa 2004-2005, p. 237-239; per l’area falisca, sempre benedettini 1996, p. 32, nota n. 110. Di recente bieLLa 2007, pp. 115-120.
129 Vedi ad es. Laghetto, t. 76 (Milano 1986a, p. 36, nn. 11-12, fig. a p. 35).130 Cfr. sciacca 2008, pp. 6-9; più in generale, sulle patere baccellate è ora fondamentale id. 2005.131 Opportunamente raccolte e commentate in sciacca 2008, in part. pp. 8-9.132 Una filiazione in questo senso è già suggerita, seppure in forma più ipotetica, in sciacca 2005, p.
218, nota 104, che giustamente estende il discorso relativo alle influenze esercitate dai keimelia orientali anche ad altre forme di impasto, quali ad esempio le tazze monoansate.
92 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
funzione che, fatte le debite differenze, anche il nostro kantharos è chiamato ad assolve-re nell’ambito del corredo funerario di cui è parte.
Relativamente alla conformazione delle anse ed alla loro terminazione in teste d’arie-te, invece, tutt’altre sembrano essere le origini. Le protomi d’ariete, considerate sovente tipiche di kantharoi e coppe carenate su alto piede di produzione falisca e capenate133, sembrano discendere invece in questo caso da soluzioni morfologiche già da tempo patri-monio del repertorio formale delle botteghe veienti dell’impasto. Puntuali, in questo sen-so, appaiono i richiami alle anse sormontanti con terminazioni zoomorfe del Villanoviano avanzato e dell’Orientalizzante antico veiente, note da numerose e ben documentate sco-delle e tazze monoansate134 e, dal secondo decennio del VII sec. a.C., ben documenta-te anche sui kantharoi del tipo in esame135. La conformazione plastica delle anse, così tipicamente indigena, potrebbe allora aver costituito un esplicito richiamo simbolico ad un’antica tradizione di immagini aristocratiche per noi oggi non completamente perspi-cua, ma che per l’osservatore antico doveva invece rappresentare un chiaro messaggio. L’impressione, in sintesi, è che il fittile rappresenti una caratteristica elaborazione delle officine locali degli impasti, in cui si mescolano elementi formali della tradizione autocto-na con incisive suggestioni desunte da materiali allogeni di prestigio.
Per quanto concerne la tecnica decorativa, l’uso di incidere a crudo e riempire di colore rosso le ceramiche ad impasto è noto a Veio sin dal Villanoviano136. Come noto, in età orientalizzante si tratta poi di una tecnica decorativa ampiamente adottata nella produzione dei cosiddetti ‘impasti sottili’ di area medio-tirrenica137.
Per quanto attiene alla famiglia di kantharoi qui considerati, molti esemplari pre-sentano partiti decorativi vegetali desunti dal patrimonio iconografico dell’arte orientale (palmette, fiori di loto, archetti), mentre altri sono distinti da motivi geometrici ripresi da quello di ambito ellenico (meandro).
133 Roma 1979, p. 76, in cui si afferma che «i kantharoi con anse a testa d’ariete sono tipici della produ-zione falisca...»; li considera tipici anche de Lucia broLLi, benedettini 2000, p. 30; parise badoni 2000, p. 99, tav. XLIII, 6, da Narce, Contrada Morgi. Per Capena: Mura soMMeLLa 2004-2005, p. 230-232 e nota 34, fig. 8,11, fig. 11, t. LXXXI A, con un esemplare in cui gli arieti presentano decori a circoletti sulle corna; qui, inoltre, si dice che un altro esemplare analogo proveniva dalla t. 14 “Santarelli” identificata come femmi-nile per la presenza di fuso e fuseruola. Falerii: de Lucia broLLi 1991, dalla t. 34 della Penna, p. 31, fig. 8 e, sempre dalla stessa località, in cozza, pasqui 1981, p. 183, dalla t. 23; a Castel S. Elia in steFani 1930, p. 528, fig. 9.
134 Cfr. ad es. Vaccareccia, t. 6 (paLM 1952, p. 63, tav. XV/8); Quattro Fontanili, t. Y alfa (Quattro Fon-tanili 1970, p. 257, fig. 44/2); t. K 7-8 (Quattro Fontanili 1972, p. 366, fig. 110/4); guidi 1993, tipo 24, p. 24-26, fig. 13/3-5. Per l’età orientalizzante antica cfr. la tazza carenata su alto piede finestrato dalla tomba dei Leoni Ruggenti (boitani 2010, fig. 17).
135 Al momento l’attestazione più antica è costituita dall’esemplare dalla Tomba della Anatre (cfr. supra, nota 117).
136 Da ultimo: drago troccoLi 2009, p. 331.137 Ad oggi l’unico quadro generale sull’argomento è la breve sintesi in de Lucia broLLi, benedettini
2000.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 93
Relativamente agli aspetti cronologici, la gran parte dei kantharoi simili esaminati può essere datata tra il secondo ed il terzo quarto del VII secolo a.C. La particolare com-plessità tecnica e la raffinatezza esecutiva dell’esemplare in esame inducono però a col-locarlo nel novero degli impasti sottili veienti più antichi, tutti databili nella prima metà del secolo138, così che una sua collocazione alla metà circa del VII secolo a.C. appare al momento come la datazione più probabile.
Analisi iconografica
L’identificazione e la lettura iconografica di buona parte degli elementi della rap-presentazione, per entrambi i lati del kantharos, non presentano eccessiva difficoltà in quanto, da un punto di vista tematico, essa si inserisce in un ormai corposo gruppo di figurazioni a soggetto marinaresco che caratterizza diverse opere d’arte etrusca di età orientalizzante139. Qui di seguito si analizzano i dettagli iconografici delle raffigurazioni al fine di comparare gli elementi che le accomunano ai monumenti noti e, soprattutto, di evidenziare quelli che le rendono documenti con caratteristiche di originalità.
Lo scafo appartiene a quel tipo di imbarcazione etrusca ben identificata da diver-si autori come un ibrido tra la nave mercantile pesante ed arrotondata e quella snella e veloce a vocazione militare140. La linea è tondeggiante, la prua e la poppa sono forte-mente ricurvi e sono raffigurate percorse da solcature parallele che sembrano identifica-bili quali rappresentazioni stilizzate dei costoloni lignei di rinforzo al guscio del natante. Da segnalare è che tale armatura, nella realtà, doveva risultare invisibile dall’esterno e percepibile solo a quanti frequentassero il suo interno141. Si tratta però di una conven-zione grafica utilizzata altre volte nelle raffigurazioni navali su monumenti etruschi di
138 Cfr., ad esempio, gli impasti da: t. dei Leoni Ruggenti (boitani 2010, 690-680 a.C.), t. 5 di Monte Michele (boitani 1985, secondo quarto VII sec. a.C.); Pantano di Grano, t. 1 (de santis 1997, pp. 116-128, secondo quarto VII sec. a.C.). Inoltre si vedano le considerazioni espresse infra a proposito di alcuni importanti impasti provenienti dalla t. 1 della necropoli in esame.
139 Seppure al tema non siano ancora state dedicate ricerche definitive, una prima raccolta di monumenti è già in pagLieri 1960; fondamentali osservazioni storiche e archeologiche sul tema in cristoFani 1983 (in particolare per il periodo orientalizzante le pp. 11-31) e cristoFani 1984; una lista puntuale e aggiornata di attestazioni è in MarteLLi 2008a, p. 137, nota 58, a cui è necessario aggiungere il successivo bieLLa 2010. Stimolanti considerazioni storico-antiquarie sul tema della talassocrazia alto-arcaica sono in cherici 2006, in particolare pp. 439-449.
140 In proposito, si veda già cristoFani 1983, pp. 45-47; inoltre: bonino 1989, p. 1525; höckMann 2000; pettena 2002, p. 92 e, da ultimo, MandoLesi, casteLLo 2009, p. 15.
141 Può essere interessante segnalare come anche nei modellini fittili di barche di età villanoviana venisse di solito messa in evidenza l’armatura dello scafo: cfr. da ultimo MandoLesi, casteLLo 2009, in particolare pp. 9-13.
94 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
età orientalizzante142, legata forse all’assimilazione di modelli iconografici di matrice orientale che queste per molti aspetti sembrano tradire143. Nella realtà, le nostre navi dovrebbero essere annoverate nel genere cosiddetto ‘cucito’, di antica origine e di cui già Omero tratta in occasione dell’assedio a Troia144, o in alternativa nel tipo convenzio-nalmente definito come misto, in cui la tecnica cucita è presente assieme all’impiego di mortase e tenoni145.
Lo sperone tagliamare reso come una punta aguzza è spesso presente a prua nel-le rappresentazioni coeve146: è stato supposto che potesse trattarsi di un apprestamento
142 Si veda, ad esempio, una nave graffita su di un’olla tarquiniese in impasto rosso (inv. RC 7486) di pro-venienza ignota che presenta anch’essa la prua solcata da linee parallele mentre tutto lo scafo è segnato da una griglia che potrebbe suggerire il fasciame ligneo (Milano 1986b, pp. 231-232, fig. 235 a e b); si vedano inoltre: le navi raffigurate su due anfore del Gruppo degli Anforoni Squamati oggi al Louvre (sziLagyi 1992, p. 136, nn. 81-82, tav. XLVII a-b e c-d) e su un dinos dello stesso Gruppo al Museo Archeologico di Cerveteri (cri-stoFani 1984, p. 5, fig. 2); la nave costolata rappresentata sull’anfora ceretana oggi conservata a Milano ed attribuita al Pittore della Sirena-Assurattasche (MarteLLi 1987c, passim, figg. 17-20). Anche nell’imbarcazio-ne miniaturizzata sull’oinochoe di Tragliatella l’ossatura della scafo è posta graficamente in evidenza (gigLio-Li 1929 e MarteLLi 1987a, n. 49, pp. 271-271, figg. a p. 102).
143 Manca ad oggi uno studio iconografico sistematico sulle raffigurazioni di navi etrusche; alcune inte-ressanti osservazioni sui presumibili modelli orientali sono però già in pagLieri 1960, pp. 221-223; effet-tivamente, sia la forma di alcuni scafi, panciuti e tondeggianti con le estremità revolute e sagomate, sia la resa grafica del sistema velico documentata per la gran parte delle navi etrusche orientalizzanti, trovano ad esempio importanti punti di contatto con alcune raffigurazioni di navi commerciali, più o meno coeve, dipinte su ceramiche cipriote (basch 1987, pp. 261-262, figg. 564-567; più in generale sulle imbarcazioni ciprio-te: Westerberg 1983), così come l’uso di marcare lo scafo con solcature, di cui si è in precedenza parlato, mostra suggestive assonanze con le raffigurazioni di navi nilotiche in giunchi e fibre vegetali, note certamente in questa epoca in area medio-tirrenica grazie alla mediazione di coppe in metallo prezioso di probabile produ-zione fenicia (ad esempio canciani, von hase 1979, p. 38, cat. n. 19, tav. 16). Purtroppo, allo stato attuale è difficile giudicare in quale grado le raffigurazioni etrusche mirassero a riprodurre l’aspetto delle navi realmente utilizzate o quanto dipendessero dall’assimilazione di tradizioni iconografiche esotiche. La mancanza di relitti etruschi databili prima della fine del VII-inizi del VI secolo a.C., infatti, impedisce qualsiasi verifica in questo senso: il relitto più antico resta al momento quello del Giglio, ritenuto da Cristofani greco-orientale (cristo-Fani 1992-1993), ma più opportunamente ricondotto da Colonna ad ambito etrusco (coLonna 2006, in part. pp. 10-12). Il fatto, però, non è di poco conto, poiché l’eventuale dipendenza iconografica da fonti orienta-li delle navi etrusche orientalizzanti, oltre che da dinamiche artistiche, potrebbe effettivamente rispecchiare il reale aspetto dei natanti, e dunque l’assimilazione di forme e tecnologie dell’ingegneria nautica orientale mediata tramite l’immigrazione di artigiani specializzati, sulla scorta di quanto ormai ben documentato per altri ambiti della cultura materiale tirrenica di quest’epoca, quali ad esempio l’architettura e la metallotecnica (su possibili influenze levantine sulla tecnologia navale etrusca già in età villanoviana si vedano gli accenni in MandoLesi, casteLLo 2009, pp. 16-17).
144 hoM., Il., II, 135.145 MandoLesi, casteLLo 2009, p. 21 (con bibl. prec.). Roma 2009, in part. pp. 56-59, con accurata
sintesi di entrambe le tecniche.146 A puro titolo esemplificativo: oinochoe del Pittore delle Palme oggi in Missouri: MarteLLi 1987a,
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 95
finalizzato a potenziare le dotazioni difensive del natante147, ma è evidente che, a pre-scindere dalla effettiva possibilità di attribuire sempre ai tagliamare anche la funzione di rostro148, la presenza di simili dispositivi deve in primo luogo aver assolto alla funzione di facilitare la navigazione149. Nelle navi in esame, lo sperone compare solo a poppa: anomalia non inedita e forse imputabile ad un errore o ad una volontaria abbreviazione del ceramografo150.
L’attestazione di un albero maestro centrale con vela rettangolare ed indicazioni som-marie di sartie e scotte si registra costantemente sulle principali raffigurazioni etrusche di natanti su ceramiche, bronzi e avori di età orientalizzante e arcaica151. Frequente è anche la rappresentazione delle stesse vele raccolte con un motivo a festone152; inconsueta è invece la presenza di linee, a festone e a zig-zag, sul cordame laterale, che non trova al momento riscontri puntuali153. Esse potrebbero però raffigurare altri brani della velatura raccolti ed assicurati alle sartie, così come sembrano suggerire i lessemi grafici utilizzati per raffigura-re la vela raccolta già citati. Dato il particolare genere di trasporto delle nostre navi potrem-mo, quindi, ipotizzare una sorta di tendone sul ponte a protezione di merci e uomini154.
cat. 24 (F. Canciani), p. 253, fig. a p. 79; cratere di Aristonothos: schWeitzer 1955, MarteLLi 1987a, cat. n. 40 (M. Martelli), pp. 263-265, figg. a p. 93; oinochoe in impasto bruno sottile da Casalaccio (Veio): vighi 1932; pisside white on red da Cerveteri oggi al Louvre MNB1780-D150: MarteLLi 1987a, cat. n 44 (M. Mar-telli), pp. 267-268, figg. a p. 95, Micozzi 1994, C13, p. 245, tavv. XI-XII, con commento delle scene figura-te alle pp. 108-110; ma, per la lettura di questo monumento, parzialmente ridipinto da restauri ottocenteschi, restano fondamentali le osservazioni in gauLtier, geppert 2000.
147 Frequentemente ricordata dagli studiosi è la notizia pliniana relativa al fatto che sarebbe stato un etru-sco il primo a dotare una nave di uno sperone offensivo: pL., N.H., VII, 57 e VIII, 209. Interpretazione come rostro ad esempio in cristoFani 1983, p. 29. Sulla possibile doppia funzione del rostro si vedano, ad esempio, bonino 1989, p. 1523 e MandoLesi, casteLLo 2009, p. 17.
148 Contrari a questa ipotesi sono ad esempio per le navi di ambito fenicio-cipriota Westerberg 1983, pp. 64-65, nota n. 17 e per quelle di ambito sardo depaLMas 2000, p. 204.
149 Cfr. MandoLesi, casteLLo 2009, in particolare pp. 16-17.150 Lo stesso fenomeno si registra sull’imbarcazione pubblicata in bieLLa 2010.151 Ai monumenti già citati supra nota 146, si possono aggiungere: un piatto dalla necropoli di Acqua
Acetosa Laurentina: MarteLLi 1987a, cat. n. 39 (M. Martelli), fig. a p. 92; la nave raffigurata sulla prima pisside della Pania (cristoFani 1971). Il vascello sbalzato e cesellato su pannello in lamina bronzea oggi a Copenaghen, verosimilmente pertinente in origine alla decorazione di un carro (cfr. MarteLLi 2005, fig. 3, p. 126, con ipotesi che si tratti di un riferimento ai traffici fluviali del proprietario del carro).
152 Ad esempio: oinochoe da Veio-Casalaccio (Veio); prima pisside della Pania; pisside white on red MNB 1780, D 150 al Louvre.
153 L’unico confronto di cui recentemente si è venuti a conoscenza solo da testimonianza orale potrebbe essere la nave dipinta su di un frammento ceramico ancora inedito rinvenuto a Veio nella Tomba dei Leoni Ruggenti. La notizia si deve a Francesca Boitani, editrice del contesto, che qui cordialmente ringraziamo. Ulte-riori informazioni su questo ritrovamento infra.
154 L’esistenza di tendoni sembrerebbe documentata sulla nave di sinistra della pisside MNB 1780, D 150 al Louvre.
96 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
La presenza di un cassero, attestata solo sul natante del lato B, pur non essen-do carattere comune a tutte le raffigurazioni orientalizzanti di navi in ambito etrusco, è comunque già presente ad esempio sulla già citata oinochoe da Veio-Casalaccio e sulle navi raffigurate su due pissidi white-on-red dalla tomba 1 della necropoli di S. Paolo a Cerveteri155.
La presenza delle scalette a poppa e a prua, conosciuta in Etruria da raffigurazioni di V secolo a.C.156, non sembra invece documentata nei monumenti di epoca orientalizzan-te, per cui la rappresentazione in esame si attesterebbe al momento come la più antica in cui compare questo dettaglio. Di grande interesse è la posizione in cui le scale vengono raffigurate, ovvero in mano a personaggi e disposte trasversalmente allo scafo, come a suggerire l’imminenza di uno sbarco o di una partenza: imminenza che parrebbe confer-mata dalla stessa posizione raccolta della velatura.
Il remo-timone delle imbarcazioni è accuratamente segnalato sin dall’Orientalizzan-te antico157: lo strumento assume di solito la forma di una pertica più o meno lunga desi-nente con una pala di forma rettangolare o trapezoidale. Appare però singolare come nel caso in esame la pala sia caratterizzata da un profilo a foglia lanceolata, al momento sostanzialmente priva di riscontri nei coevi documenti etruschi.
Le linee orizzontali ed ondulate raffigurate assieme al rostro di poppa della nave sul lato B possono essere agevolmente interpretate come onde marine, a suggerire simboli-camente l’elemento in cui le navi sono immaginate158.
La figura del timoniere a poppa compare dipinta in forme estremamente schematiz-zate già su un’olla da Bisenzio159, per poi ritrovarsi in monumenti successivi secondo sostanzialmente tre schemi iconografici: in piedi160, accosciata161 o seduta con le gambe distese davanti, come accade nel fittile in esame. Per quanto concerne la presenza del guerriero armato sul ponte, punto di riferimento iconografico imprescindibile è ovvia-
155 In questi casi, però, i casseri sono sempre due per imbarcazione, posizionati rispettivamente a poppa e a prua: per questi monumenti si veda vighi 1932 e rizzo 2005, p. 288, tav. IIIb.
156 In particolare, si veda la celebre raffigurazione di nave dalla Tomba omonima di Tarquinia, in cui a poppa è ben visibile una lunga scala a pioli: per la prima edizione della tomba cfr. Moretti 1961, cui vanno aggiunte almeno le fondamentali osservazioni in coLonna 2003 e la dettagliata analisi tecnica in cherici 2006, pp. 449-456.
157 Già nell’oinochoe del Pittore della Palme citata supra alla nota 146; sulle raffigurazioni dei timoni si vedano le osservazioni in cristoFani 1984, p. 5 e MandoLesi, casteLLo 2008 p. 20, nota 6.
158 Per l’oinochoe del Pittore delle Palme Canciani ipotizzò che le linee ondulate al di sotto delle navi potessero evocare le onde marine; onde marine sono raffigurate anche nella pisside Louvre MNB 1780, D 150. Da respingere è pertanto quanto espresso in pizzirani 2005, pp. 255-256, dove si afferma che in età orien-talizzante mancherebbe nelle raffigurazioni su monumenti etruschi «…la dimensione propriamente fisica del mare».
159 deLpino 1977, p. 477 n. 93, pl. XVIa.160 Cratere di Aristonothos.161 Come ad esempio nella prima pisside della Pania o nella pisside white on red MNB 1780, D 150 al
Louvre.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 97
mente il celebre cratere di Aristonothos ai Musei Capitolini162, da cui dipendono anche raffigurazioni successive163. È interessante evidenziare, però, come nel caso in ogget-to l’armato sia uno solo e non una schiera, ad indicare presumibilmente in modo com-pendiario la sua funzione di scorta armata alle navi da trasporto e non quella di gruppo impegnato in battaglia.
Di grande interesse, invece, risulta la resa dell’interno dello scafo, al momento un unicum nei monumenti noti di ambito etrusco. Se, infatti, in alcune raffigurazioni l’uso della veduta di prospetto consente di visualizzare i rematori della nave, assisi sul ponte di levaggio ma con la testa ben visibile oltre la linea di murata164, qui la sezione illustra nel dettaglio una situazione tutta interna al natante affatto inedita rispetto a quanto finora conosciuto. Il ceramografo, infatti, ribalta su un unico piano frontale sia le panche di levaggio dei rematori che il fondo del natante, ponendo in alto i rematori, ovvero ciò che effettivamente nella realtà dell’imbarcazione doveva avere una posizione soprelevata rispetto al carico trasportato più in basso nello scafo, nel caso specifico cavalli. Ne con-segue che la rappresentazione dei rematori non solo è completa, ma anche integralmente disposta al di sotto del ponte di coperta, fatto che non trova per ora confronti utili nella documentazione.
Importante ai fini della comprensione della scena è anche la piccola figura vestita di un abito a scacchi raffigurata all’interno della nave A. Una lacuna nel lato B impedisce di accertare se essa fosse replicata anche qui: ciò che resta visibile, però, sembrereb-be appartenere alla figura di un altro vogatore. L’abito indossato dalla figura rientra in un tipo di vestiario aristocratico etrusco classico per l’età orientalizzante165. A giudicare dalla caratterizzazione del mento, a punta aguzza, sembrerebbe trattarsi di un personag-gio maschile. La presenza di questa figura all’interno dell’imbarcazione e la circostanza che, non armata, essa vesta abiti di rappresentanza cerimoniale, inducono ad identificare in questa figura un passeggero di rango della nave, forse lo stesso naukleros.
Del tutto eccezionale risulta essere la presenza dei cavalli all’interno dello scafo166. Iconograficamente, i cavalli affrontati in coppia alla mangiatoia sono un ben noto motivo di origine attica, presto assimilato dalle altre fabbriche elleniche del tardo geometrico e
162 Per i riferimenti fondamentali cfr. supra nota 146; si tratta come noto di un monumento più volte citato in lavori di carattere specialistico e manualistico, la cui bibliografia è in continua crescita. In questa sede, ci si limita a segnalare solo alcuni interventi di carattere iconologico successivi al lavoro della Martelli: Meni-chetti 1994, pp. 50-54, dougherty 2003 e, in termini riassuntivi, bagnasco gianni 2007.
163 MarteLLi 1987a, p. 267, a proposito della pisside white on red MNB 1780, D 150 al Louvre.164 Testimonianze nuovamente offerte dal cratere di Aristonothos e dalla pisside MNB 1780, D 150 al
Louvre.165 In proposito cfr. bonFante 1975 e MarteLLi 1984, in part. p. 9. 166 Mancano in ambito etrusco raffigurazioni che associno cavalli ad imbarcazioni. Anche in ambito greco
il motivo è piuttosto raro: tra le occorrenze, si vedano ad esempio due fibule in bronzo dalla Beozia, oggi a Berlino, in cui il cavallo appare in un caso, disposto come carico sull’imbarcazione, nell’altro posto in stretta contiguità con questa (basch 1987, pp. 190-194).
98 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
precocemente assunto dalla ceramografia etrusca della fine dell’VIII secolo a.C.167. Nel nostro fittile, lo schema appare semplificato, con l’eliminazione del sostegno sul quale solitamente la vasca contenente l’acqua o il cibo è posta e con la raffigurazione di un solo equino. Il riadattamento dell’originario schema, come si dirà, appare funzionale al senso generale della narrazione.
I piccoli uccelli usati come riempitivi, del genere convenzionalmente definito in letteratura come aironi168, appartengono ad un tipo caratterizzato da corpo breve, petto gonfio e becco a forbice ben documentato sulle produzioni incise etrusco-meridionali in impasto ed in bucchero169. Altri riempitivi, di vario genere, sono presenti soprattutto sulla nave del lato A. Anche in questi casi si tratta di tipiche elaborazioni locali, non di rado molto libere, di motivi le cui origini si collocano in definitiva nell’ambito del patri-monio iconografico di matrice ellenica, ma la cui assimilazione negli impasti incisi è stata mediata in buona parte dalla ceramica dipinta sud-etrusca di età tardo-geometrica ed orientalizzante, seppure i documenti al momento disponibili non sempre permettano di seguire questo processo di trasmissione e rielaborazione in tutti i suoi passaggi. Già noti nella ceramografia etrusco-geometrica sono i motivi a cerchietto170, qui riprodotti più volte sulla chiglia del natante A.
Più raro nei monumenti etruschi di età orientalizzante, invece, appare essere il moti-vo a girandola, documenta per ben tre volte sempre sull’imbarcazione A: esso sembre-rebbe costituire una particolare versione locale elaborata dal noto motivo a girandola attestato nella ceramica protocorinzia, soprattutto quale episema di scudi oplitici171, ed in questa seconda versione attestato anche nella ceramografia etrusca della seconda metà del VII secolo a.C.172. Può essere interessante rilevare come un motivo a girandola a rilievo compaia anche sul fondo di un importante kyathos in bucchero da Cerveteri, data-to nell’orientalizzante medio avanzato e nelle cui complesse decorazioni si ravvisano
167 Cfr. roMbos 1988, pp. 261-266; Micozzi 1994, pp. 79-80 e, da ultimo, si vedano le puntuali osser-vazioni in MarteLLi 2008b, in part. pp. 5-6 e p. 9 (con ampi riferimenti e bibliografia).
168 Su questo soggetto nella pittura vascolare etrusca di età orientalizzante restano ancora fondamentali le considerazioni in MarteLLi 1987a, pp. 16-17 e pp. 255-256, cat. nn. 26-28.3, e in Wikander 1988, pp. 80-89; inoltre, si veda l’ampia disamina estesa anche agli impasti in Micozzi 1994, pp. 72-78 e, di recente, in termini riassuntivi e solo per quanto concerne la ceramica di tradizione geometrica di età orientalizzante, neri 2010, pp. 195-199.
169 Cfr. ad esempio per Veio raddatz 1983, pp. 214-216, fig. 8; in generale, importanti osservazioni in Micozzi 1994, pp. 76-77.
170 Riempitivo precocemente assunto nel repertorio delle botteghe etrusco-meridionali, presumibilmente con la mediazione della ceramografia tardo-geometrica di matrice euboico-cicladica: si veda, ad esempio, un askos da Bisenzio, datato all’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C. (MarteLLi 1987a, cat. 17, p. 250).
171 cerchiai 1990, p. 89, nota n. 37 con elenco di attestazioni.172 Si veda ad esempio lo scudo del terzo oplita da sinistra della nave destra della pisside MNB 1780, D
150 al Louvre o quello dei due opliti sul lato A dell’olpe etrusco-corinzia a rotelle del Pittore di Garovaglio al Museo di Villa Giulia inv. 74952 (MarteLLi 1987a, cat. n. 50, pp. 272-273, fig. a p. 103, scheda di M. Martel-li).
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 99
non pochi elementi di ascendenza protocorinzia173. Inconsueto sembra anche essere il motivo costituito da uno stelo ricurvo e desinente con una fogliolina cuoriforme attestato in prossimità della figura con scala situata a poppa della nave A: seppure privo di precisi riscontri in ambito etrusco, esso può essere però accostato ad esempio ad un riempitivo a stelo con foglia elissoidale presente su un’anfora di provenienza veiente attribuita alla Bottega del Pittore delle Gru174.
È interessante rilevare come la nave del lato B non presenti sostanzialmente riem-pitivi, fatta eccezione per una sorta di piccola conchiglia incisa sotto il cassero a sinistra sulla cui funzione originaria non siamo però in grado di giudicare, essendo essa priva di utili confronti.
Resta infine da analizzare l’oggetto raffigurato sulla prua della nave A175. Per esso non si dispone al momento di alcun convincente riscontro iconografico nell’ambito del patrimonio figurativo dell’arte etrusca176. Qualche aiuto alla sua comprensione, però, può venire dal confronto con alcuni oggetti reali noti da tempo nella documentazione archeologica.
L’ipotesi più probabile è che si tratti di un grande vaso biansato, chiuso da un coper-chio conformato come una scodella rovesciata, dotato di una sorta di puntale, forse rap-presentante il piede, e decorato sul corpo da un motivo a ferro di cavallo con bugna cen-trale. A supporto di questa lettura possono essere citati come confronti alcuni contenitori più o meno coevi di ambito etrusco molto simili sia sul piano morfologico che decorati-vo177 (Fig. 21, a): rispetto a questi esempi, l’unico particolare differente sarebbe costi-tuito dalla conformazione del piede, che nei vasi reali citati di solito manca o ha aspet-
173 Cfr. cristoFani, rizzo 1993, pp. 1-7, in part. fig. 12.174 Cfr. Michetti 2009, p. 609, fig. 3. In ogni caso, si tratta evidentemente di un genere di riempitivi
che testimoniano la ricezione e la rielaborazione di motivi ceramografici ellenici: particolarmente suggestivo in questo senso parrebbe l’accostamento con un originale riempitivo del Pittore della Scacchiera, conformato come uno stelo ricurvo alla cui estremità si colloca una infiorescenza elaborata (rocco 2008, p. 113, fig. 15/39; per il Pittore e la sua bottega pp. 109-116). Sulle proiezioni del Pittore della Scacchiera e della sua cer-chia in Italia importanti considerazioni in giuLiano 2009.
175 Va rilevato come, a causa della perdita di una parte del kantharos, non sappiamo se tale oggetto com-parisse solo qui o fosse anche replicato sul lato B del fittile.
176 Per completezza di informazione, segnaliamo come tra le ipotesi di identificazione prese in esame nel corso della ricerca e poi scartate alcune meritino comunque di essere ricordate: a) un’àncora appesa alla murata esterna dello scafo: ipotesi scartata sia per la totale mancanza di possibili riscontri iconografici, sia per l’assen-za di testimonianze archeologiche che documentino per il periodo in esame àncore con simili forme; b) stemma gentilizio: ipotesi indimostrabile a causa della totale mancanza di confronti e per l’incertezza esegetica che, anche in ambito ellenico, grava sull’interpretazione degli episemata su scudi oplitici ampiamente documentati nelle coeve raffigurazioni (su questo tema: vaerst 1980).
177 Si vedano, a puro titolo esemplificativo, le olle con costolature a ferro di cavallo da Caere (ad es. ric-ci 1955, tav. A o rizzo 2007, cat. 8, pp. 24-25, fig. 58, esemplare dotato anche di protomi di leone plastiche) e da Vulci (ad es. Bologna 2000, foto a p. 314), in cui però le costolature hanno andamento rovesciato rispetto a quelle del vaso in esame.
100 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
to diverso e che invece nel caso in esame è contraddistinto come una sorta di punta di freccia rovesciata. In questa prospettiva di lettura, poi, un particolare interesse sembrano avere anche una coppia di anfore medio-orientalizzanti in argilla depurata rinvenute in una tomba facente parte della medesima necropoli della sepoltura in esame178 (Fig. 21, b). Queste, infatti, presentano, dipinte in vernice rossa sulla spalla, una decorazione com-posta dalla ripetizione seriale dello stesso motivo decorativo a ferro di cavallo inciso sul kantharos, così da provare ulteriormente l’effettiva esistenza di contenitori fittili dotati di una simile decorazione, peraltro nella stessa comunità di appartenenza di cui doveva far parte anche il defunto titolare del kantharos. Accettando questa lettura, se ne deve concludere che il vaso, al pari dei cavalli, va immaginato come carico di vino e disposto all’interno del natante. Il tema del trasporto di contenitori di derrate alimentari su imbar-cazioni non è nuovo nella coeva arte etrusca179: nei documenti noti, però, i vasi vengono in modo più convenzionale raffigurati sul ponte e non, come in questo caso, all’interno dello scafo.
178 Tomba preliminarmente edita in giannini 2009, dove però le due anfore, all’epoca ancora in corso di restauro, vengono solo sommariamente citate. Ad Emanuele Giannini, editore del contesto, e a Marina Piranomonte, funzionario responsabile del Museo di Malborghetto sulla via Flaminia dove attualmente i pezzi sono conservati, va il nostro ringraziamento per averci consentito ed agevolato l’esame autoptico delle due importanti anfore.
179 Si veda ad esempio la nave effigiata sulla prima pisside della Pania ed il carico dell’imbarcazione sul vaso di provenienza falisca edito in bieLLa 2010.
Fig. 21. a) roMa, Museo di Villa Giulia. Olla da Vulci (tomba del Carro di bronzo, 680-670 a.C.) con costolature a ferro di cavallo (da Bologna 2000, p. 314); b) vaso in argilla depurata dipinto con motivo a ferro di cavallo dalla tomba di via d’Avack (scavo Giannini).
a b
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 101
L’analisi iconografica condotta fin qui consente allora di tentare una lettura comples-siva delle scene raffigurate sul vaso. Le navi, pur molto simili nella struttura generale, differiscono per alcuni fondamentali particolari che dimostrano come esse siano certa-mente due: quella raffigurata sul lato A, per la maggior cura e ricchezza della decora-zione e per la presenza al suo interno del personaggio in costume aristocratico, va pro-babilmente identificata come la nave principale. L’iterazione di un identico soggetto su entrambi i lati del kantharos induce a ritenere le due imbarcazioni strettamente connes-se a livello narrativo: si tratta verosimilmente della rappresentazione di una spedizione marina composta da più imbarcazioni. Le navi potevano muoversi a propulsione mista, grazie alla spinta dei venti e alla trazione dei vogatori. Il tonnellaggio, le dimensio-ni immaginabili grazie alla natura del suo particolare carico180 ed il complesso sistema velico dimostrano in modo inequivocabile che si tratta di natanti destinati alla naviga-zione marittima. Alcuni particolari sembrano suggerire che le navi siano prossime all’at-tracco o alla partenza: le vele sono raccolte, mentre le scale di poppa sono in procinto di essere calate o levate. Sul convoglio vigila attento un uomo armato, pronto ad inter-venire, assieme al resto della ciurma, nel caso di attacco alle imbarcazioni. Nello scafo, minuziosamente indicato in buon ordine, è il prezioso carico portato dalle navi: cavalli e vino, sui quali, nella nave A, sembra sovraintendere un personaggio di rango, forse lo stesso naukleros.
L’insieme delle raffigurazioni, dunque, sembra immortalare in forme abbreviate ed ideali un’attività realmente svolta in vita dal defunto: l’andar per mare, con una piccola flotta di imbarcazioni di sua proprietà in grado di coprire anche distanze notevoli. La particolare natura del carico navale indica come si tratti di una spedizione a carattere commerciale su lunga distanza, come sembrerebbe provare, oltre che il tipo di natante impiegato, anche l’insistenza iconografica con cui il ceramografo pone i cavalli davanti
180 Infatti, anche ipotizzando la presenza di soli 4 cavalli per nave, ovvero quelli effettivamente effigiati, dislocati longitudinalmente lungo l’asse del natante e ciascuno occupante un suo spazio fisicamente delimitato, si deve dedurre che ciascuna imbarcazione dovesse essere lunga almeno tra i 15 e i 25 m ca., dimensioni per-fettamente conformi, per l’epoca in esame, ai natanti in uso per la navigazione marittima anche di lungo raggio (cfr. aviLia 2002, p. 77, che ad esempio ricostruisce in 30 m circa la lunghezza media di una pentecontera atti-ca di età tardo-geometrica). Relativamente alle modalità di carico dell’imbarcazione, è possibile formulare in via ipotetica almeno tre diverse soluzioni (Fig. 22): l’ipotesi c, a nostro parere, è però difficile da sostenere, in quanto il carico potente di equini in una sorta di stiva del natante, con i ponti di levaggio dei rematori sopra ed un ponte scoperto, avrebbero richiesto una profondità di scafo tale da non consentire la necessaria stabilità alla navigazione. Di contro, le due ipotesi a e b sarebbero entrambe percorribili con più facilità, immaginando una sorta di coesistenza tra gli elementi di carico e quelli costituiti dal personale umano mediante una dislocazione a quote diverse, tale da non creare intralci pericolosi per i movimenti nel corso della navigazione ed al contem-po essere compatibile con l’altezza media degli scafi dell’epoca. Naturalmente si deve immaginare che i cavalli abbiano richiesto una sorta di imbragatura per non destabilizzare la navigazione, così come dovevano essere previste grandi scorte di fieno e giare d’acqua per consentire la stessa sopravvivenza degli animali durante il viaggio. Anche tutto questo doveva trovare posto all’interno del carico, probabilmente a lato o al di sotto del tavolato per i cavalli.
102 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
alla mangiatoia, quasi a sottolineare le esigenze vitali necessarie agli animali per soste-nere il viaggio181. Nessun elemento iconografico depone a favore di una lettura in chiave bellica o mitica della scena, né si ravvisano simboli che esplicitamente possano alludere
181 Necessità che non si sarebbe presentata se si fosse trattato di un trasporto su più breve tragitto per via fluviale.
Fig. 22. Ipotesi ricostruttive delle modalità di carico del natante rappresentato sul kantharos (D. Rossi).
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 103
a concezioni escatologiche182. In ogni modo, sul grande potenziale informativo di questo documento torneremo nei paragrafi conclusivi, dopo aver prima affrontato il complesso problema relativo al suo inquadramento storico-artistico.
aLessio de cristoFaro, danieLa rossi
Analisi stilistica
L’esame dei caratteri stilistici delle scene raffigurate sul kantharos mostra la com-presenza di motivi eterogenei per origine e derivazione. Prima di affrontarli nel dettaglio, però, è indispensabile chiarire preliminarmente la cornice entro la quale è necessario inquadrare un simile monumento.
Il fittile, come già evidenziato, per quanto concerne il materiale, la forma e la tec-nica decorativa è certamente un prodotto di officina veiente. La stessa considerazione vale per la realizzazione ad incisione delle complesse scene figurate, in cui, sia l’impie-go di caratteristici motivi iconografici etruschi quali ad esempio gli aironi od il tipo di imbarcazione, sia soprattutto il ductus dell’incisione, a volta incerto ed approssimativo nella definizione anatomica delle figure, rivelano la mano di un ceramografo locale. Del bagaglio formale di questo ceramografo, però, seppure assimilate in forme non sempre adeguatamente giunte a maturazione, sembrano far parte non poche delle più importanti acquisizioni linguistiche della coeva ceramografia pittorica.
Nell’ambito delle produzioni ad impasto veienti e, più in generale, etrusco-meridio-nali183, la raffigurazione in esame rappresenta un unicum: in queste produzioni, infatti, prevalgono di solito decorazioni a carattere vegetale e zoomorfo, che solo raramente pre-sentano figure umane o semi-umane184 e ancor più raramente scene con intenti narrati-vi185. Mai, in ogni caso, scene narrative di una complessità analoga a quelle in esame, per cui invece sembra naturale rivolgersi ai coevi documenti pittorici su ceramica.
La produzione degli impasti incisi a Veio vanta un’antica e solida tradizione186, che per l’età orientalizzante antica e media si sostanzia in una serie di esemplari di
182 Prospettiva di lettura adottata ad esempio in toreLLi 1987, p. 14 e coLonna 2003.183 Per queste produzioni manca ancora ad oggi uno studio complessivo: in termini generali si vedano
caMporeaLe 1991 pp. 1-68 e de Lucia broLLi, benedettini 2000. Per gli impasti con decorazione ad incavo si veda ora bieLLa 2007; per quelli da area falisca e capenate annotazioni preliminari in bieLLa 2008.
184 Cfr. ad esempio l’oinochoe da Veio oggi a Würzburg (jucker 1981); un’anforetta a spirali con cen-tauro inciso sul collo nella collezione C.A. di Ginevra (caMporeaLe 1991, cat. n. 37, tav. XXI a-d); il vaso con centauro da Narce (cozza, pasqui 1981, c. 290, fig 146 e potter 1976, p. 263 fig. 94).
185 Con narrazioni strutturalmente molto semplici: ad esempio, oltre alle già citate raffigurazioni mari-naresche da Veio (vighi 1932) e Falerii (bieLLa 2010), si veda la scena di caccia ad un mostro dall’aspetto leonino incisa su un’olla in impasto da Orvieto (caMporeaLe 1984, pp. 62-63, tav. X a-b).
186 Da ultima drago troccoLi 2009, con nuovi dati ed importanti osservazioni.
104 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
notevole qualità ancora poco noti187. La stessa necropoli qui in esame, oltre al kan-tharos, ha fornito documenti che testimoniano in modo chiaro l’esistenza di maestran-ze capaci e sollecite nell’assimilare spunti e motivi del patrimonio figurativo dell’arte orientale e di quella ellenica, sia a livello morfologico che dei partiti decorativi188. Quelle stesse maestranze che, all’incirca dall’Orientalizzante medio, risultano impe-gnate anche nella produzione dei più antichi e ricchi buccheri incisi veienti189. È que-sto il tessuto connettivo entro cui si colloca il nostro kantharos, che, se come detto spicca per la complessa tematica narrativa affrontata, ha invece qui ben salde le sue radici artigianali.
L’analisi stilistica permette anzitutto di guadagnare un solido ancoraggio crono-logico per la realizzazione della raffigurazione. La caratterizzazione delle figure uma-ne con testa ovoide, occhio a cerchietto o comunque di prospetto, naso/labbra/mento protruse o a punta, braccia allungate e piegate nettamente ad angolo, busti triangolari visti frontalmente, sono tutti stilemi che trovano i loro ascendenti più convincenti in opere della ceramografia ellenica, soprattutto attica190 e corinzia191, ed etrusca, ovvero ceretana192, dell’orientalizzante antico avanzato e medio (Fig. 23). Sono queste delle
187 Di grande utilità, in questo senso, sarebbe un riesame globale degli impasti incisi di età orientalizzante provenienti dalle necropoli urbane e rurali. Le notevoli capacità delle botteghe veienti si possono ad esempio apprezzare dagli esemplari di bella qualità dalla piccola necropoli di Pantano di Grano analizzati in de santis 1997, o da quelli, finora solo parzialmente editi, dalla necropoli di Poggioverde sulla via Trionfale (de cri-stoFaro, piergrossi 2012); più corsivi quelli editi in raddatz 1983, nn. 1-5, pp. 209-210.
188 La tomba I, in particolare, databile nella prima parte dell’Orientalizzante medio, ha restituito impasti incisi importanti: una grande brocca a tre colli, purtroppo conservata solo parzialmente, con ricca decorazione fitomorfa in cui ai classici partiti di derivazione fenicio-cipriota si abbinano serpentelli di chiara ascendenza protocorinzia; il pezzo trova peraltro uno strettissimo confronto in un esemplare adespota in collezione privata svizzera (Collezione C.A. Ginevra: Ginevra 1993, cat. 97, pp. 190-191), per il quale era stata proposta un’o-rigine falisca e che invece il ritrovamento in esame suggerisce ora di attribuire più verosimilmente a Veio. A questa si possono aggiungere due belle kotylai, una con decorazione fitomorfa, l’altra decorata sulla vasca con un cavallo alato, il quale sembra dipendere iconograficamente e stilisticamente da elaborazioni zoomorfe carat-teristiche del Pittore delle Gru, testimoniando così le influenze della coeva ceramica dipinta sugli impasti (per il Pittore delle gru e la sua bottega si veda infra).
189 Lo studio dei buccheri con figurazioni incise veienti è sostanzialmente fermo a bonaMici 1974, pp. 139-156; su tutta la classe del bucchero veiente, da ultimo, in termini riassuntivi e con un approccio limitato alla sola tipologia vascolare: Marchetti 2004.
190 A puro titolo esemplificativo: cfr. rocco 2008, p. 45, tav. 6,3 (Gruppo dell’Hypocraterion di Argo); pp. 67-68, tav. 10,3 (Pittore di Passas e bottega); p. 117, tav. 18,1 (Gruppo del Louterion di Tebe); pp. 110-111, tav. 16,1 (Pittore della Scacchiera).
191 Cfr. ad esempio benson 1989, p. 26, pl. 7, fig. 4a-c (Evelyn Painter, EPC); pp. 43-44, pl. 15, figg. 2-3 (Pittore di Aiace, MPC IA); p. 50, pl. 18, figg. 1a-b e 2a-b (Gruppo Nola, MPC IB). Ma si vedano anche i satiri raffigurati sulla grande kotyle dagli scavi Gàbrici a Cuma, databile alla metà circa del VII secolo a.C. (Mer-Mati 2012, pp. 213-214, tav. XXV).
192 Rappresentative in questo senso sono le figure umane del Pittore dell’eptacordo (MarteLLi 1988 e
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 105
vere e proprie cifre stilistiche che, quasi come un fossile guida, caratterizzano buona parte delle figurazioni antropomorfe di questo periodo. Decisamente diversa, invece, in particolare per quanto concerne l’ambito etrusco-meridionale, sarà la caratterizza-zione delle figure umane a partire all’incirca dall’inizio dell’orientalizzante recente, con l’avvio delle produzioni etrusco-corinize. Ben esemplificativa in questo senso può essere ad esempio l’oinochoe di Tragliatella (Fig. 24, a), in cui le piccole figure umane hanno solo il naso prominente, occhi a mandorla, busti più semicilindrici che triango-lari, arti che in modo più armonico e morbido si flettono e raccordano al tronco: un insieme di stilemi per così dire più evoluti sulla via della resa organica dell’anatomia umana193, rispetto a quella più rigida e stilizzata documentata sul nostro kantharos.
ead. 2001) o quella del marinaio raffigurato sul piatto con scena marinaresca da Acqua Acetosa Laurentina (MarteLLi 1987a, cat. 39, p. 263, fig. a p. 92 (M. Martelli).
193 In questo senso, possono altresì valere come termini ante quem per la datazione della raffigurazione in esame le figure umane effigiate su due olpai del Pittore di Garovaglio (attivo attorno al 630-600 a.C.: olpe a Villa Giulia (Fig. 24, b): riferimenti supra nota 172; olpe a Philadelphia: sziLágyi 1967, pp. 549, 551, n. 35,
Fig. 23. a) Particolare di un cratere del Pittore della Scacchiera (da rocco 2008, tav. 16, 1); b) Particolare di un aryballos del Pittore di Aiace (da benson 1989, pl. 15, fig. 2); c) Aryballoi del Gruppo di Nola (da benson 1989, pl. 18, fig. 1); d) Particolare di un’an-fora del Pittore dell’Eptacordo (da MarteLLi 1987a, fig. a p. 92).
a b
c d
106 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
tav. 113, 3-4), in cui la resa dei guerrieri mostra una più organica scansione dei vari distretti anatomici, o le figure sulla pisside white on red attribuita al Pittore della Nascita di Menerva al Louvre, in cui l’impianto delle teste, l’articolazione dei volti e la costruzione anatomica palesa soluzioni più evolute in senso naturalistico (MarteLLi 1987a, cat. 43, pp. 266-267, figg. a p. 95, 630-620 a.C., M. Martelli).
Fig. 24. a) particolare dell’oinochoe di Tragliatella (da MarteLLi 1987a, fig. a p. 102); b) particolare da un’olpe del Pittore di Garovaglio (da MarteLLi 1987a, fig. a p. 95).
a
b
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 107
La figura di oplita armato sulla tolda e, più in generale, lo stesso complesso impianto della scena, trovano poi un punto di riferimento ineludibile nella più volte richiamata raffigurazione del lato B del cratere di Aristonothos, un genere di prece-dente, seppure indiretto, senza il quale una scena come quella in esame, in un ambito tipicamente indigeno quale quello degli impasti sottili incisi, non sarebbe altrimenti neppure immaginabile. Anche a livello del soggetto, infatti, un’opera come il cratere di Aristonothos mostra come l’apporto ellenico, all’incirca dall’orientalizzante medio, sia stato in grado di sostanziare ed articolare in modo estremamente complesso sul piano linguistico e semantico un tema, quale quello della vita di mare, già da alcuni decenni presente nell’arte etrusca in forme ancora molto semplici, rinnovandolo profondamen-te. Fino alla metà circa del VII secolo a.C., infatti, le raffigurazioni a tema marinaresco etrusche presentano solo singole imbarcazioni impegnate in semplici scene di naviga-zione o di pesca194, con figure numericamente ridotte al minimo. Successivamente, invece, alcune scene si arricchiscono notevolmente sul piano narrativo, sia in chiave mitologica che in quella ispirata da eventi o azioni della vita reale, con la partecipazio-ne di un maggior numero di figure e la costruzione di scene dall’impianto e dai mec-canismi di lettura più complessi195. Lo stesso tema qui rappresentato, una spedizione commerciale capeggiata dall’aristocratico/naukleros, è in parte già affrontato sul lato B del citato cratere, seppure qui nell’ambito di uno scontro navale che ha tutti i carat-teri di una tipica azione di pirateria alto-arcaica.
Anche le soluzioni prospettiche adottate per la resa dello spazio, ovvero il ribal-tamento su piano frontale impiegato per la definizione dell’interno del natante o gli scorci usati per le figure dei timonieri o dell’armato sulla tolda, hanno chiaramente le loro radici ideali in schemi di derivazione ellenica196 progressivamente assimilati e quindi mediati dalla ceramografia etrusca, segnatamente ceretana, a partire dall’inizio dell’Orientalizzante197.
194 Oinochoai del Pittore delle Palme, olla da Bisenzio, oinochoe da Veio-Casalaccio.195 Anfora del Pittore della Sirena-Assurattasche, pisside MNB 1780, D 150 al Louvre.196 Come noto, il ribaltamento su un unico piano frontale di elementi della raffigurazione nella realtà
disposti su piani diversi dell’asse di fuga prospettico trova la sua consapevole formulazione già nell’arte tardo geometrica attica: a puro titolo esemplificativo, si vedano le numerose scene funerarie di prothesis dipinte su anfore (ad es. Atene NM 804, ahLberg 1971a, fig. 2 a-b) o crateri (ad es. Parigi, Louvre A 517, ahLberg 1971a, fig. 4 a e c), di battaglie (ad es. uno skyphos da Eleusi in ahLberg 1971b, pp. 34-36, fig. 43) e, per restare alla sfera marinaresca, in scene di naufragio (buchner, ridgWay 1993, p. 696, tavv. CCIV-CCV) o raffigurazioni di navi ben equipaggiate (poMey 1997, p. 136).
197 Un uso consapevole dello scorcio è ad esempio nella raffigurazione di guerriero con carro da guerra ed auriga sull’anfora in una collezione privata statunitense attribuita al Pittore dell’eptacordo (MarteLLi 2001, p. 3, figg. 4-5); per il ribaltamento prospettico frontale, si veda invece la rappresentazione del labirinto sull’oino-choe di Tragliatella, più tarda però del kantharos in esame.
108 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
Sempre ad una datazione da collocare entro l’orientalizzante medio, inoltre, riman-dano il genere di riempitivi198 e lo stesso modo di disporre questi entro la scena199, che appariranno ben diversi, sia per tipo che per schemi, sulle di poco successive ceramiche della prima produzione etrusco-corinzia databili a partire all’incirca dal 630 a.C.200.
Infine, spunti di particolare interesse per la definizione della personalità del nostro ceramografo vengono dal modulo miniaturistico adottato nelle raffigurazioni, sostanzial-mente inedito nella coeva ceramografia etrusco-meridionale201 ed invece distintivo nelle ceramiche protocorinzie, dove, come noto, specie tra la fase media e recente, il miniatu-rismo costituisce la cifra migliore delle produzioni più importanti202. L’insieme di queste considerazioni induce a datare il kantharos attorno al 650 a.C., datazione peraltro confor-me con quanto, indipendentemente, è stato possibile desumere dall’analisi morfologica del fittile e dallo studio complessivo del corredo di cui esso è parte.
I dati raccolti, al contempo, mostrano la personalità di un ceramografo il cui baga-glio formale pone alcuni ulteriori e non meno importanti interrogativi. In primo luogo, se ceramista e ceramografo coincidano, oppure se è necessario postulare l’esistenza di due distinti artigiani. Il fatto che, come si è evidenziato, il linguaggio figurativo del kantha-ros mostri chiaramente di dipendere dalle esperienze della coeva ceramografia pittorica e non sembri avere legami con la tradizione degli impasti, potrebbe suggerire la presen-za di un ceramografo per così dire prestato all’impasto in occasione di una specifica ed eccezionale richiesta su committenza, quale certamente è il fittile in esame. Un possi-bile caso di bilinguismo203 per un ceramografo aduso alla pittura può essere suffragato da alcune considerazioni: le più antiche tombe dipinte etrusco-meridionali, infatti, opera certamente delle medesime personalità protagoniste della coeva stagione ceramografica, mostrano un disegno preparatorio ad incisione che testimonia la capacità incisoria degli artigiani quale consapevole strumento del proprio lavoro204. Inoltre, si consideri come
198 Si vedano soprattutto i motivi a cerchietto, girandola e a fogliolina con stelo ricurvo precedentemente analizzati rispettivamente alle note 170-171.
199 I riempitivi sulla nave A, infatti, si distribuiscono con un gusto per l’horror vacui del tutto originale, che sembra echeggiare la felice esuberanza e la libertà compositiva della migliore ceramografia protoattica.
200 Su questa produzione di vedano almeno: MarteLLi 1987a, in part. pp. 23-24 e cat. nn. 46-57, pp. 269-275 per le prime produzioni ceretane e veienti e, più in generale, sziLagyi 1992.
201 Nell’ambito della ceramografia etrusco-meridionale di età orientalizzante prevalgono nettamente i moduli monumentali, soprattutto nei grandi vasi con decorazioni antropomorfe e zoomorfe di ambito ceretano e veiente.
202 Sulla produzione protocorinzia osservazioni fondamentali in payne 1931, pp. 7-15 e 92-98; benson 1989, passim.
203 Accertata ormai da tempo è l’attività di singoli ceramisti in più classi: in proposito cfr. le giuste osser-vazioni di metodo in MarteLLi 1987b, in part. p. 7.
204 Sull’ipotesi che in quest’epoca i pittori delle tombe fossero artigiani specializzati anche nella decora-zione domestica, ma distinti dai ceramografi: coLonna 1994, in part. 571; ipotesi tuttavia difficilmente dimo-strabile, come indicato da MarteLLi 2008b, p. 14, la quale, più plausibilmente, ribadisce con dovizia di argo-menti come pittori di ceramiche e di tombe/case orientalizzanti dovessero coincidere. Per l’uso dell’incisione
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 109
nello stesso torno di tempo dovevano essere ben noti in Etruria meridionale i migliori prodotti delle fabbriche protocorinzie, dove pittura ed incisione si fondono in inscindibi-le unità. L’ipotesi dunque che il kantharos sia stato decorato da un pittore/ceramografo è più che plausibile.
Difficile, invece, allo stato attuale delle conoscenze, è definire con sicurezza se, oltre ad incidere il fittile, il ceramografo possa anche averlo plasticato: tuttavia, le particolarità assolutamente originali rilevate nel kantharos, il quale pur appartenendo ad un famiglia tipologica di cui si è cercato di ricostruire il profilo mostra una qualità esecutiva eccezio-nale, unitamente all’assoluta unicità della sua decorazione figurata, tenderebbero a favo-rire l’ipotesi dell’artigiano unico.
Altrettanto difficile è collocare la figura di questo artigiano nel quadro delle produ-zioni ceramografiche veienti dell’Orientalizzante medio. Queste, infatti, sono conosciute ancora in modo troppo parziale per consentire giudizi definitivi. La documentazione si riduce in sostanza ad un piccolo nucleo di ceramiche dipinte ascritte alla Bottega del Pittore delle gru205, verosimilmente prodotte a Veio206, e ad un importante frammento di anfora con decorazione a probabile carattere mitologico recentemente edito207, anch’es-
preparatoria alla pittura si veda la presentazione preliminare dell’importante scoperta veiente costituita dalla Tomba dei Leoni Ruggenti: boitani 2010, in part. p. 31. Da ultimo, una sostanziale identità tra ceramografi e pittori di affreschi è ribadita anche per l’ambito ellenico in età orientalizzante da nieMeier et Al. 2012 e hurWit 2012.
205 Opportunamente raccolte in neri 2010, pp. 244-247.206 Per il Pittore delle gru e la sua bottega quali figure peculiari della ceramografia ceretana restano fon-
damentali MarteLLi 1987b e ead. 2001; di recente, riprendendo una vecchia ipotesi del Dik (dik 1980) ed esaminando alcuni nuovi vasi attribuibili al Pittore e alla sua cerchia, è stato nuovamente ipotizzato un suo trasferimento operativo a Veio, successivo cronologicamente all’attività svolta in ambito cerite: boitani et Al. 2008, pp. 25-26 e neri 2010, p. 245. Restano tuttavia poco chiari i motivi per i quali dietro il ritrovamento di pezzi attribuibili ad una precisa personalità al di fuori del territorio in cui questi è considerato attivo debba necessariamente immaginarsi un suo trasferimento fisico, e non più semplicemente l’esito di un commercio, specie laddove, come nel caso di Cerveteri e Veio, la cultura materiale mostra chiaramente in tutti i suoi settori una fitta e consolidata trama di rapporti e scambi. Diverso il caso dei pezzi ricondotti genericamente alla Botte-ga, posto che con questa etichetta si intenda classificare in modo non troppo rigido un gruppo di artigiani nelle cui opere si ravvisano stilemi e soluzioni mutuate per via diretta o indiretta dal Maestro, e non l’opera di disce-poli a questi più strettamente legati sul piano socio-economico: nel primo caso, infatti, è verosimile ritenere che i pezzi di rinvenimento veiente e narcense possano essere stati effettivamente prodotti a Veio; nel secondo, bisognerebbe immaginare quantomeno un intenzionale distacco di un allievo dalla Bottega del Maestro con conseguente suo trasferimento da Cerveteri a Veio. In ogni modo, i documenti più di recente valorizzati (boi-tani et Al. 2008, Michetti 2009), suggerirebbero un più attento riesame dell’intero dossier Bottega, poiché anche all’’interno di questa emergono chiaramente alcune differenze iconografiche e stilistiche che potrebbero dar luogo ad una ricostruzione del quadro più complessa di quella finora prospettata (differenze in parte regi-strate già in neri 2010, pp. 244-245, che distingue i prodotti della Bottega di rinvenimento veiente-narcense da quelli ceriti).
207 Si tratterebbe di un’anfora raffigurante la lotta di Eracle e l’Idra di Lerna: van kaMpen 2012b.
110 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
so presumibilmente prodotto a Veio e dal quale sembra trasparire una complessa perso-nalità alla cui formazione hanno concorso, tra i vari apporti, anche evidenti stilemi di matrice protocorinzia208. In questa fase, comunque, le botteghe veienti risultano decisa-mente subordinate a quelle localizzate a Caere, epicentro indiscusso del rinnovamento formale e tematico della ceramografia orientalizzante medio-tirrenica209.
Lo stesso ceramografo del kantharos in esame, come si è cercato di evidenziare, dispiega un patrimonio formale ed una capacità narrativa che sarebbero impensabili sen-za i presupposti delle precedenti e coeve esperienze ceretane, seppure venato da partico-larità che là, almeno ad oggi, non sembrano documentate, quali ad esempio la dimesti-chezza a comporre scene complesse utilizzando moduli miniaturistici o l’applicazione di queste su una forma potoria quale il kantharos210. In conclusione, quale ipotesi di lavoro, è possibile proporre di identificare nel nostro ceramografo un artigiano veiente alla cui formazione hanno contribuito sia la conoscenza di temi e forme delle vicine e più aggior-nate botteghe di Cerveteri, sia l’innesto di altri apporti ellenici, verosimilmente protoco-rinzi, forse autonomamente assimilati a Veio alla metà circa del VII secolo a.C.211.
aLessio de cristoFaro
208 Le osservazioni dell’editrice, che rileva alcune somiglianze tra l’anfora con Idra e le opere del Pittore delle gru e della sua cerchia, sono da integrare con alcuni confronti che sembrano più specificatamente avvici-nare il pezzo a produzioni protocorinzie, segnatamente a quelle di ambito coloniale del gruppo Cuma (su questa produzione da ultimo: MerMati 2012). In particolare, sono da segnalare: a) l’uso di segnare con puntini allineati esterni il corpo a silhouette del serpente (ad esempio ibid., tav. XXXVI, n. 4, Gruppo del Serpente, pp. 181-182); b) la forma degli occhi e della lingua biforcuta a forbice; c) lo stesso schema dispositivo del mostro policefalo e serpentiforme, le cui spire si sviluppano in modo lineare e nastriforme in modi analoghi a quelli attestati su alcuni decori fitomorfi protocorinzi e ben diverso, ad esempio, da quello testimoniato per il drago serpentiforme effigiato sulla ben nota anfora del Pittore di Amsterdam (MarteLLi 1987c). Peraltro, la stessa scelta del soggetto, Eracle e l’Idra, rimanderebbe in qualche modo ad ambito corinzio, dove quest’episodio della saga erculea doveva essere particolarmente sentito, in ragione della vicinanza tra la città e la palude di Lerna (broMMer 1953, p. 54).
209 MarteLLi 1984; ead. 1987a; ead.1987b; ead. 1987c; Micozzi 1994; MarteLLi 2001.210 La ceramografia più impegnata sul piano narrativo, infatti, qui predilige soprattutto anfore e grandi conte-
nitori atti a contenere liquidi che morfologicamente mescolano forme indigene con forme di derivazione ellenica. 211 Assimilazione che potrebbe essere avvenuta anche tramite la presenza di artigiani ellenici immigrati diret-
tamente a Veio, come già documentato per l’Orientalizzante antico con la figura del Pittore di Narce, sulla cui origo attica ha opportunamente insistito MarteLLi 2008b. D’altra parte, una forte presenza commerciale corinzia a Veio nei decenni a cavallo della metà del VII secolo a.C. è indiziata sia da quell’oggetto straordinario che è l’Olpe Chigi (Mugione 2012, con bibl. prec.), sia dall’importazione di altri pezzi notevoli (si vedano ad esempio le tre olpai del corredo della tomba delle Quaranta Rubbie, rizzo 1990, cat. nn. 4-6, pp. 44-45) e produzioni più correnti (che meriterebbero di essere nuovamente conteggiate e sistematizzate: una prima raccolta in dehL 1984, pp. 274-276), sia, infine, dall’attività dei primi ceramografi etrusco-corinzi stanziati a Veio, quali ad esempio il Pittore Castellani, dietro il cui lavoro va presumibilmente postulato un trasferimento di maestranze da Corinto (per la localizzazione a Veio e la personalità del Pittore Castellani si pronuncia MarteLLi 1987a, p. 269; diversamente sziLagyi 1992, pp. 77-79, che ipotizza, senza argomenti convincenti, una sua attività a Vulci).
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 111
concLusioni
La lettura del corredo della Tomba 3 consente di mettere in evidenza due aspetti. Il primo concerne l’estensione dell’arco cronologico descritto dall’insieme dei mate-riali: dalle forme più antiche, la cui produzione comincia al più tardi all’inizio del secondo quarto del VII sec. a.C.212, fino agli esemplari la cui realizzazione perdura, in alcuni casi, entro la prima metà del VI sec. a.C.213. Il secondo aspetto riguarda invece la compresenza di elementi che sono usualmente riferiti alla sfera maschile214 assieme ad oggetti, quali la fuseruola, che generalmente diagnosticano il genere fem-minile del defunto.
Questi due fattori, assieme all’elevato numero di reperti recuperati all’interno della camera, hanno indotto a considerare la presenza di due sepolture distinte e cronologica-mente differenziate di cui, per motivi legati allo stato di conservazione della tomba, non si sono conservate tracce stratigrafiche.
Dal momento che la suddivisione dei numerosi materiali tra le due deposizioni è basata unicamente su criteri di classificazione, non è stato possibile assegnare con certezza alcuni tra gli 81 elementi del corredo appartenenti a tipi con un range tanto ampio da abbracciare entrambe le cronologie. Il corredo della Tomba 3A, il più antico (650-640 a.C.)215, risulta di minore consistenza numerica e appartenente ad un adul-to di sesso maschile, con vasellame per il pasto (piatti)216, per il consumo del vino (olle, anforette, calici e kantharoi, tra cui quello oggetto della presente ricerca)217 e per la cura del corpo (aryballoi e askos)218; a questa sepoltura sono forse da riferire anche il letto funebre, la lancia, i coltelli, la roncola, gli alari e gli spiedi219. La lunga durata dei tipi delle armi e delle suppellettili legate al servizio da carne non permette di escludere l’appartenenza di questi alla sepoltura più recente. Inoltre alari, spiedi e coltelli non hanno una attribuzione di genere univoca e possono alludere o alla sfera
212 Ad es. due anforette in bucchero (inv. 566210, 566279) e tutte quelle in impasto (inv. 566305, 566275, 566250, 566261, 576091), due olpai-attingitoi in bucchero (inv. 566249, 566207) e i calici in impasto (inv. 566288, 566245).
213 Ad es. le coppette su piede in impasto chiaro (inv. 566243, 566244), l’anfora (inv. 566303) e la tripod-bowl (inv. 566274).
214 Ad es. alcuni dei metalli quali la lancia (inv. 566312) o il coltello (inv. 566314).215 Questa datazione è suggerita dalle considerazioni precedentemente sviluppate nella descrizione ed
analisi dei singoli reperti. Ad ancorare alla metà circa del secolo la sepoltura sono soprattutto i due aryballoi etrusco-geometrici, il piatto ad aironi e i tipi delle olle in impasto rosso e delle anforette a spirali, che combina-ti con le classi fini, non possono scendere di molto oltre questo orizzonte cronologico.
216 Inv. 566272, 566273, 566252.217 Inv. 566265, 566290, 576094, 566250, 566261, 566275, 566305, 576091, 566210, 566245, 566288,
566293, 576093.218 Inv. 566237, 566246, 566240.219 Inv. 566312, 566313, 566314a, 566314b, 566315, 566316, 566317.
112 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
femminile della preparazione alimentare e del rito220, o alla sfera maschile legata a personaggi connotati come guerrieri221. Tuttavia, nell’ambito della comunità aristo-cratica veiente la documentazione archeologica sin dal villanoviano finale, sembra testimoniare che l’abbinamento alari, spiedi e coltello sia una caratteristica tipica del mondo maschile222, circostanza che dunque spinge a preferire una attribuzione alla sepoltura maschile più antica.
Alla Tomba 3B (630-600 a.C.)223 invece, della donna, moglie o figlia, si può riferire un set da banchetto ben più ricco e articolato: l’anfora per trasportare il vino224, la tri-pod-bowl225 per aromatizzarlo, i vasi per attingerlo e versarlo (olpai-attingitoi, kyathoi, oinochoai e olpai)226, per consumarlo (anforette, kantharoi, kotylai, calici e coppe)227 oltre ai contenitori di olii profumati228 e alla fuseruola229.
Tra le due deposizioni la distanza cronologica è indicata non solo dalle tipologie del materiale, ma anche dalla composizione stessa dei corredi: quest’ultima, nel caso del-la Tomba 3A, sottintende una ideologia funeraria che esalta il singolo, isolandolo con i segni del suo prestigio personale legati alla pratica del banchetto inteso come mangiare insieme, e gli strumenti che connotano il suo ruolo eminente nell’ambito della comunità (grafico 1). Il corredo della Tomba 3B, con la moltiplicazione dei vasi potori230 quasi esclusivamente realizzati in bucchero, sottolinea la priorità del “bere insieme” e la par-tecipazione al banchetto su larga scala (grafico 2), come elemento fondante della vita
220 pitzaLis 2011, pp. 242-243221 kohLer, naso 1991, p. 46.222 Vd. nota precedente.223 Nonostante alcuni dei reperti qui documentati continuino ad essere realizzati anche oltre la fine del VII
secolo a.C., si ritiene questa datazione più adeguata soprattutto in relazione alla presenza di alcuni tipi di cera-mica etrusco-corinzia la cui produzione è solidamente ancorata entro e non oltre l’ultimo quarto del VII secolo a.C. (vedi, ad. es., l’olpe a squame inv. 566239, commento in rizzo 1990, p. 47, nn. 13-19; l’aryballos inv. 566247, di forma desunta da modelli del protocorinzio tardo ed adottata anche in alcuni esemplari a figurazio-ne zoomorfa realizzati dal Pittore Castellani, vedi MarteLLi 1987a, p. 269, cat. 46/1-3, fig. a pag. 98). Anche tra i buccheri si segnalano, ad es., le kotylai inv. 566216, 566213, 566286 univocamente datate tra il terzo e l’ultimo quarto del VII sec. a.C.
224 Inv. 566303.225 Inv. 566274.226 Inv. 566207, 566249 566266, 566267, 566269, 566278, 566282, 566209, 566277, 566284, 576087,
566285, 566262, 566281, 566264, 566268, 566214, 566239.227 Inv. 566215, 566279, 566202, 566212, 566218, 566221, 566223, 566213, 566286, 566204, 576085,
566203, 566205, 566206, 566219, 566263, 566271, 566276, 566216, 566208, 566217, 566220, 566222, 566248, 566280, 566287, 566242, 576095.
228 Inv. 576088, 566238, 566247.229 Inv. 566253. Non è escluso che la fuseruola rappresenti un ‘ricordo’ o un oggetto dedicato dalla con-
sorte del defunto e che, quindi anche il secondo corredo appartenga ad una figura maschile legata da rapporti di stretta parentela con il defunto più anziano.
230 Il servizio poteva essere utilizzato da circa 10 commensali.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 113
socio-culturale, momento dalla valenza cerimoniale in cui viene riaffermata la volontà di aggregazione del gruppo aristocratico e la forza dei vincoli che lo sostengono di fronte agli altri componenti della società231.
Tutti gli elementi certamente presenti nella Tomba 3A concorrono a definire la posi-zione sociale e le attività del proprietario. La lancia allude al consueto ruolo ricoperto nella società di appartenenza, quello di guerriero, forse non a caso accortamente segnala-to anche sulla raffigurazione del lato A del kantharos. La roncola e la scure, occorrenze assai rare nelle tombe di questo periodo232, segnalano invece l’attività agricola stanziale, esemplificata presumibilmente dalle più complesse ed evolute colture arboricole della vite o dell’olivo ed al contempo esaltano l’abilità manuale del titolare, capace di espli-carsi nei lavori di carpenteria utili alle attività economiche e di rappresentanza del grup-po gentilizio. A Veio, Casal del Fosso233 spiedi ed alari sono associati a uno scalpello ed altri strumenti di metallo, esattamente come qui ritroviamo il coltello, la roncola e la scure, lasciando supporre per il defunto capacità nelle attività artigianali, intese come nobili doveri per personaggi di rango, basti pensare alla figura di Odisseo234: guerrieri
231 Tra la vasta bibliografia dedicata alla pratica del banchetto in Etruria si ricorda, fra gli altri: cristo-Fani 1987; deLpino 2000; toreLLi 2000; zaccaria ruggiu 2003, pp. 141-223; bartoLoni 2007; barto-Loni, acconcia, ten kortenaar 2012. Una analisi dettagliata basata sui contesti ceretani sulla trasforma-zione della pratica del banchetto fra VII e VI sec. a.C. in batino 1998, pp. 33-35.
232 iaia 2006, p. 194.233 Vd. note 96 e 98.234 Il richiamo a passi dell’epica omerica ed esiodea è espresso già in buraneLLi 1979, p. 8 e iaia 2006,
pp. 194-197. Come racconta Odisseo: «…recisi la chioma all’ulivo dalle foglie sottili / sgrossai dalla base il suo tronco, lo piallai con il bronzo, / bene e con arte, e lo feci diritto col filo, / e ottenuto un piede di letto tra-
graFico 1. Corredo della Tomba 3A. graFico 2. Corredo della Tomba 3B.
114 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
che hanno funzioni di guida sia in ambito militare che politico-sociale; che presiedono al banchetto rituale che oltre al consumo collettivo del vino prevedeva quello comune del-la carne, e al sacrificio; che non disdegnano di occuparsi di lavori manuali di qualità o, quantomeno di coordinare e gestire il lavoro.
Su tutta questa ricca panoplia, domina idealmente il kantharos, vaso centrale del corredo destinato nel corso dell’ideale banchetto ad essere tenuto dal suo legittimo pro-prietario e quindi ad essere da lui passato agli altri commensali235, i quali, leggendone le figurazioni ne avrebbero ricordato e celebrato le gesta. Il vaso racconta infatti le più significative attività sociali ed il rango del suo proprietario. Vengono così evidenziate le basi economiche su cui poggia la condizione aristocratica del defunto: la produzio-ne di vino, prodotto agricolo quanto mai prezioso e ricercato in quest’epoca, possibile evidentemente grazie allo stabile possesso di ampie e privilegiate porzioni di territorio rurale236; l’allevamento di cavalli, attività aristocratica per eccellenza e massimamente connotante il rango in sede di autorappresentazione funeraria237, che al contempo pre-suppone un’ampia disponibilità di terre e di risorse. A queste si viene ad aggiungere l’andar per mare, mediante il possesso di una piccola flotta attrezzata per la difesa e, all’occasione, anche per l’offesa, con la cosiddetta ‘guerra corsara’, secondo i modi di quella prexis di matrice aristocratica che connota il commercio mediterraneo nell’alto arcaismo238. Andar per mare che, per i grandi pericoli e le difficoltà comportate239, per il proprietario del vaso doveva significare, oltre che benessere, grande prestigio sociale e possibilità di intessere relazioni gentilizie anche di natura internazionale. Emerge in questo modo la figura di un aristocratico/naukleros che, se già nota per altri centri tirre-nici gravitanti sul mare, appare decisamente inedita in ambito veiente, così da suggerire una revisione dell’intero dossier di documenti relativi al rapporto di Veio col mare in età orientalizzante.
forai tutto col trapano. / Iniziando da questo piallai la lettiera finché la finii, / rabescandola d’oro e d’argento e d’avorio» (hoM., Od. XXIII, vv. 195-200, traduzione di G.A. Privitera).
235 Le considerevoli dimensioni del nostro fittile, grande ma non fuori misura umana, suggeriscono una capienza di liquido sufficiente ad essere sorseggiato da più commensali; le misure, come si è detto nella media superiori a quelle di esemplari analoghi, rimandano alla dimensione eroica di un méga potérion, le cui implica-zioni culturali per il mondo greco sono state magistralmente lumeggiate in Musti 2001, pp. 26-30.
236 Su questo tema, negli ultimi anni particolarmente ed utilmente indagato con approcci multidisciplina-ri, cfr. da ultimo ziFFerero 2012 e ciacci, rendini, ziFFerero 2012 (con bibl. prec.).
237 Sul tema del cavallo ed i suoi diversi usi e significati in ambito etrusco si vedano almeno azzaroLi 1972, in part. pp. 293-306, jannot 1986, gaMbari, tecchiati 2004, caMporeaLe 2005, chierici 2006, MarteLLi 2008b, p. 9 (con riferimenti alla fortuna del tema nell’ambito della ceramografia etrusco-geometri-ca). Sui carri: Viterbo 1997.
238 Lo studio fondamentale resta MeLe 1979; per l’ambito etrusco, non si può prescindere da cristoFani 1983, pp. 11-31, e gras 1985; di recente, spunti per la fase del commercio etrusco di età orientalizzante sono anche in molti dei contributi editi in atti orvieto 2006.
239 Su questo argomento alcuni spunti in cerchiai 2002.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 115
La ricognizione di una serie di elementi, infatti, induce a vedere nella Veio di età orientalizzante un centro impegnato nei traffici marittimi240. Se, infatti, è stato da tempo riconosciuto il controllo che Veio esercitò sul basso corso del Tevere241, principale via di comunicazione ed autentica spina dorsale del sistema insediativo dell’Italia centrale242, più trascurato è stato invece il possibile ruolo che la città, mediante un affaccio tirrenico, poté avere nel quadro dei commerci internazionali di quest’epoca. Pure, il costante afflusso di merci straniere in città sin dal Villanoviano evoluto mette chiaramente sull’avviso circa l’esistenza di queste attività243, che forse è troppo riduttivo vedere sempre e solo come il frutto dell’accoglimento passivo da parte veiente, mediante gli approdi tiberini, di beni di prestigio importati da più dinamici imprenditori levantini ed ellenici.
Indizi di natura archeologica permettono di articolare il quadro di questi scambi in modo più complesso. La tomba in esame, infatti, non è la sola ad aver restituito reperti chiaramente connotanti le attività marinare degli aristocratici veienti: indizi simili vengo-no anche da almeno altri quattro contesti necropolari. Dal tumulo di Monte Oliviero244, due modellini tridimensionali di barca in bucchero sono stati letti come segno del coin-volgimento del titolare nei traffici fluviali245. Ma la lettura non è affatto scontata, poiché modellini analoghi in altri centri etruschi tirrenici sono stati interpretati come testimo-nianze di navi adatte anche alla navigazione marittima246. La divisione tra imbarcazioni adatte al mare o ai fiumi, poi, appare quanto mai modernizzante e poco opportuna se applicata alla realtà antica, specie per un orizzonte così risalente. Sappiamo infatti che, ancora in età augustea, teste Dionigi di Alicarnasso, il Tevere poteva tranquillamente essere risalito e navigato dai medesimi natanti che solcavano il Mediterraneo247. La stes-
240 Le pagine che seguono anticipano alcuni dei risultati di una più ampia ricerca storico-topografica in corso di svolgimento da parte di Alessio De Cristofaro sul territorio posto tra Veio e la riva destra del basso corso del Tevere.
241 Egemonia durata dal Villanoviano iniziale fino almeno all’Orientalizzante medio: cfr. coLonna 1981, bartoLoni 1986, pp. 105-106.
242 Cfr. in generale il classico Le gaLL 1953 e quiLici gigLi 1986a.243 Per Veio come terminale medio-tirrenico preferenziale di arrivo di ceramiche e mercanzie elleniche
nella fase precoloniale (Veio IIA) di recente bartoLoni 2009, in part. p. 106 (con bibl. prec.); una puntuale disamina degli orientalia documentati nelle necropoli veienti di VIII e VII secolo a.C. è ora in sciacca 2008 (con bibl. prec.); spunti interessanti sul tema anche in drago troccoLi 2009, pp. 342-352; manca invece un puntuale riscontro delle ceramiche elleniche importate a Veio in età orientalizzante.
244 Cfr. steFani 1928, pp. 101-102, c-d, fig. 7.245 Cfr. quiLici gigLi 1986b, in part. pp. 84-85.246 Cfr. per Tarquinia MandoLesi, casteLLo 2009; per Cerveteri, rizzo 2007, p. 21, 247 Questo è lo scenario descritto da Dionigi d’Alicarnasso (dion. haL. III, 44): «Le navi a remi dunque,
per quanto grandi, e quelle da carico con stazza sino a tremila misure, risalgono attraverso la foce e vengono condotte fino a Roma, sospinte da remi e da funi. Le più grandi invece, trattenute all’ancora, vengono scaricate e le merci vengono a loro volta caricate su barche fluviali». (Trad. F. cantareLLi, Dionisio di Alicarnasso. Storia di Roma arcaica (Le antichità romane), Milano 1984.).
116 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
sa conservazione nei Navalia in Campo Marzio di una nave da guerra arcaica248, forse una pentecontoros, dimostra poi in modo definitivo come, in quest’epoca, anche imbar-cazioni di notevole tonnellaggio potessero risalire il fiume almeno fino a Roma.
Abbiamo poi la già citata raffigurazione incisa su un’oinochoe dalla necropoli di Picazzano249. Il fatto che in questo caso la nave sia immaginata come immersa nel mare aperto lo dicono chiaramente almeno due elementi: il tipo di barca rappresentato, dotato di doppio cassero e complesso sistema velico di propulsione, dunque tipicamente marittimo, ed il particolare del grande pesce, sia che si voglia leggere in quest’immagine un episodio di pesca miracolosa250 o quello di un attacco alla nave da parte di una pericolosa creatura del mare251: difficilmente pesci simili possono infatti essere considerati tipici della fauna ittica fluviale. Segue, ancora, un’altra testimonianza, rappresentata su un aryballos in buc-chero iscritto dalla necropoli rurale di Volusia252: l’iscrizione, purtroppo, non è completa-mente perspicua, ma di grande interesse appare su questo piccolo oggetto l’abbinamento di un’imbarcazione stilizzata con la sagoma di un cavallo o di bovide. Infine, un ultimo docu-mento è offerto dalla raffigurazione di nave su un’anfora dipinta, sempre da Veio, ancora in corso di studio da parte di Francesca Boitani, le cui caratteristiche iconografiche sembrano chiaramente fare riferimento ad un natante destinato alla navigazione marittima253.
L’insistenza iconografica in sede funeraria sul tema della navigazione, che con ben 5 occorrenze pone Veio su un piano analogo, se non a Cerveteri, certo a Tarquinia e a Vulci254, dimostra, come giustamente supposto nei casi di queste metropoli, un diffuso e consolidato interessamento di aristocratici veienti nei traffici marittimi. Si tratta ora di capire se, in età orientalizzante, esistessero a Veio infrastrutture funzionali al sup-porto di questi traffici. L’assetto del basso e medio corso del Tevere, col suo sistema di scali ed approdi rivieraschi è noto almeno nelle sue linee generali255. Non molto,
248 La cosiddetta ‘nave di Enea’, nota grazie ad un passo di Procopio e conservata come un fossile fino ad età bizantina: gianFrotta 1991 e coareLLi 1997, in part. pp. 347-348.
249 vighi 1932.250 Così già il primo editore, che considera il natante destinato alla navigazione marittima: vighi 1932, in
part. pp. 369-370.251 In questo senso ad esempio cerchiai 2002 e pizzirani 2005, p. 256, entrambi convinti che la scena
si ambienti sul mare.252 carbonara et Al. p. 24, n. 11, figg. 19-20a.253 A Francesca Boitani, la cui prima presentazione di questa raffigurazione risale alla conferenza da lei
tenuta assieme a Sara Neri e Folco Biagi al XVII Convegno Internazionale di Archeologia Classica svoltosi a Roma nel 2008 (comunicazione poi edita in boitani et Al. 2008, che però non fa menzione della nave: ma la notizia orale è già recepita in bieLLa 2010, p. 151, nota 22), dobbiamo cortesemente alcune informazioni trasmesseci oralmente: si tratterebbe di un natante dotato di casseri e sistema velico articolato, certamente fun-zionale alla navigazione marittima.
254 Stando alla lista di raffigurazioni di navi in MarteLLi 2008a, p. 137, nota 58, Tarquinia conta 4 occorrenze, Vulci 3 e Cerveteri ben 9; a queste vanno però aggiunte le navicelle plastiche: per Tarquinia si veda MandoLesi, casteLLo 2009; per Cerveteri, rizzo 2007, cat. 57, pp. 39-40, fig. 74.
255 In proposito, il miglior quadro topografico è quello offerto in quiLici gigLi 1986b.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 117
però, si sa circa gli approdi presenti sulla facciata veiente del Tevere, la ripa Veienta-na delle più tarde fonti romane256. A nord, un punto importante era rappresentato dal luogo in cui il fosso della Valchetta, l’antico Cremera, si getta nel Tevere, col traghetto per Fidene257. Scendendo verso Roma, un approdo doveva esistere nei pressi dell’ager Vaticanus, là dove Filippo Coarelli ha segnalato l’esistenza di un antichissimo traghet-to tiberino258 e nelle vicinanze del quale, secondo una tradizione ben valorizzata anni fa da Carmine Ampolo, doveva forse esistere un santuario rurale etrusco259. A questo approdo, ne faceva probabilmente seguito un altro all’altezza dell’Isola Tiberina, gros-somodo pendant sulla riva destra dello scalo del Foro Boario, il più antico porto tibe-rino romano260. Procedendo verso la foce, un altro attracco attrezzato esisteva gros-somodo all’altezza di Ficana, nel punto in cui il Rio Galeria si immette nel Tevere, a complemento sulla riva destra, dello scalo esistente sulla sinistra conosciuto col nome di Puilia Saxa261. Ma, ovviamente, è soprattutto nei pressi della foce del fiume che è necessario localizzare il primo e fondamentale punto di supporto alla navigazione marittima. L’importanza ed il controllo della foce del fiume da parte romana è testi-moniata in modo esemplare dalle ben note vicende relative alla fondazione di Ostia262.
È possibile però supporre che Veio, anteriormente alla fondazione ostiense tardo orientalizzante, che probabilmente segna il definitivo passaggio del controllo del fiume a Roma263, disponesse di un analogo apprestamento sulla riva destra? Dal punto di vista archeologico, sappiamo ancora troppo poco sull’area posta immediatamente a nord dell’e-stuario tiberino. Certo è che qui avevano sede le celebri Saline, risorsa di primaria impor-tanza per l’economia della regione e di tutta l’Italia centrale, a lungo contesa tra Veio e Roma fino alla definitiva sconfitta della prima ad opera di F. Camillo nel 396 a.C. È qui che, come già acutamente suggerito da Fausto Zevi264, andrebbe cercato il primitivo por-to veiente, da immaginarsi strettamente connesso con la situazione lagunare caratteristica
256 Sulla ripa Veientana restano fondamentali le osservazioni in aMpoLo 1987, pp. 75-80, in part. alla p. 77 per le diverse denominazioni antiche del territorio posto alla destra del Tevere; sul Gianicolo ed i Monti Vaticani cfr. Liverani 1996; sul tema si veda anche Liverani 1999, pp. 13-21(incentrato soprattutto sull’area dell’ager Vaticanus); per l’occupazione di questo territorio in età orientalizzante e arcaica da parte di Veio, importanti considerazioni in de santis 1997, pp. 101-108.
257 Cfr. quiLici, quiLici gigLi 1986, pp. 362-363.258 Cfr. coareLLi 1997, pp. 17, 77 e 130 (vada Tarenti). 259 Cfr. aMpoLo 1987, pp. 77-79 (con acuta analisi delle fonti). 260 coareLLi 1988b, passim.261 Porto tiberino della stessa Ficana: cfr. zevi 2000, p. 234 (con bibl. prec.); per l’approdo nei pressi del
punto il cui il Rio Galeria si immette nel Tevere e per la strada terrestre che da qui partiva conducendo, lungo tutta la valle solcata dal fiume, nel territorio veiente: quiLici gigLi 1986b, pp. 86-89.
262 zevi 2000 e id. 2002.263 Fondazione da porsi nell’età convenzionalmente definita di Anco Marcio: cfr. coareLLi 1988a, pp.
136-143 (con ipotesi che la Ostia più antica fosse localizzata sulla riva destra della foce tiberina), zevi 2000 e id. 2002 (con convincente ricollocazione della prima Ostia sulla riva sinistra).
264 Cfr. zevi 2000, p. 234, nota 30.
118 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
degli impianti estrattivi del prezioso minerale e da localizzare all’incirca tra la foce tiberina e quella, a nord, del fiume Arrone. Testimonianze sicure di occupazione etrusca di quest’area al momento non sono note, se si fa eccezione per un bronzetto nuragico senza contesto valo-rizzato anni fa da Giovanni Colonna e proveniente da Porto265: che l’area fosse però sotto il controllo di Veio almeno sin dalla fine dell’VIII secolo a.C. sembra provato dal fitto tessuto insediativo documentato lungo tutto il sistema collinare posto a nord della piana portuense, la cui cultura materiale è indubbiamente diretta espressione della città etrusca266.
È probabile però che questi approdi, per l’epoca in esame, fossero per la gran par-te costituiti da apprestamenti che difficilmente lasciano tracce nella documentazione archeologica e che dunque risulta difficile rinvenire. L’impressione è che anche essi, più che essere gestiti centralmente da una solida autorità cittadina, come accadrà per i più tardi porti-santuari emporici tirrenici, fossero in mano, come del resto la gran parte delle risorse, ai gruppi gentilizi, che attraverso di essi potevano così controllare un gan-glio fondamentale del sistema economico tirrenico di età orientalizzante. Non sarà forse un caso che nei pressi dell’affaccio tiberino si rinvengano ormai sempre più, sia sul fronte etrusco che su quello latino, tracce di quel sistema di occupazione del territorio rurale delle città che è stato a ragione considerato specchio delle dinamiche di possesso e controllo delle risorse da parte delle gentes267. Come è significativo che, negli antichi luoghi di approdo ove poi sorsero più strutturati santuari subordinati al potere politico centrale della città, restino in alcune fortunate circostanze le tracce fossilizzate di un primitivo controllo gentilizio, come insegna il caso ben noto del culto dell’Ara Maxi-
265 Cfr. coLonna 1981, pp. 171-172, che però considera il bronzetto quale testimonianza di un emporio portuale arcaico di Roma situato a nord della foce tiberina, e non veiente, come invece appare più naturale ritenere.
266 Sul sistema insediativo dislocato lungo le dorsali collinari innervate sul Rio Galeria e sul fiume Arrone cfr. de santis 1997, pp. 101-108, e daMiani, pacciareLLi 2006, pp. 539-556; a queste due ricerche, va almeno aggiunta la notizia ancora inedita del rinvenimento, in località Castel Malnome/Monti di Ponte Galeria, di una nuova piccola necropoli rurale databile all’età orientalizzante; la necropoli, di cultura materiale veiente, viene così a porsi, tra quelle fino ad ora documentate, come la più vicina alla Piana Portuense, dimostrando ad abundantiam il controllo esercitato su quest’area dalla città etrusca: ma su questo ed altri nuovi rinvenimenti nell’area gravitante sul basso corso del Rio Galeria si veda il quadro topografico presentato in cianFrigLia, de cristoFaro c.d.s. Va poi segnalato come, negli ultimi due decenni circa, la stessa Piana Portuense sia stata investita da un sistematico piano di indagini archeologiche preventive connesse con il massiccio sviluppo urba-nistico che ha interessato l’area: tali indagini hanno fruttato una copiosissima messe di nuovi dati, fino ad oggi in gran parte ancora inediti o solo preliminarmente presentati (MoreLLi, oLcese, zevi 2004 con bibl. prec.), il cui esame approfondito sarà però fondamentale per definire meglio alcuni complessi problemi topografici (via Campana, Saline, sistema insediativo rurale nella fascia di pianura costiera) di età arcaica e repubblicana, allo stato attuale ancora non completamente perspicui.
267 Cfr. per il territorio veiente de santis 1997; de cristoFaro, santoLini giordani 2005; introdu-zione di G. Colonna, in coLonna, Maras 2006; da ultimo vistoLi 2010, pp. 143-154; per il territorio dispo-sto lungo la riva sinistra del Tevere: zevi 2000, pp. 234-235.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 119
ma al Foro Boario268. Una traccia del primitivo controllo delle Saline da parte genti-lizia, inoltre, può forse essere documentato grazie ad una preziosa notizia di Livio269: questi tramanda come il neonato governo repubblicano della città, sotto la pressione dell’incombente esercito di Porsenna chiamato a restaurare il potere dei Tarquini e per ingraziarsi il favore della plebe, decidesse di avocare allo stato il monopolio del com-mercio del sale, fino ad allora rimasto in mano ai privati e lievitato a prezzi non più tollerabili: è presumibile che all’origine della gestione di questa fondamentale risorsa in senso privatistico vi fosse dunque il dominio esercitato sulle saline da gruppi gentilizi, tenacemente legati allo sfruttamento ed al possesso di risorse di primaria importanza economica270.
In ogni modo, la presunta prossimità tra porto e Saline indica chiaramente come pro-prio il sale dovesse avere un ruolo centrale nei traffici arcaici veienti271. Sale che, assie-me ai cavalli, se l’esegesi da noi qui proposta ha una sua plausibilità, a carne conservata sotto sale, a derrate alimentari prodotte dall’ubertoso ager veientanus272, a pellami e for-se a schiavi, dovevano costituire il grosso dei beni esportati da Veio per via marittima, in un commercio su itinerari lunghi ma molto segmentati, in cui le merci potevano cam-biare di mano più volte ed in cui la nave che partiva, sapeva di dover far ritorno con un carico altrettanto pieno di beni avidamente richiesti.
Marco arizza, aLessio de cristoFaro aLessandra piergrossi, danieLa rossi
BIBLIOGRAFIA
acconcia, piergrossi, ten kortenaar 2004: v. acconcia, a. piergrossi, s. ten kortenaar, «Lo sviluppo e la circolazione della ceramica di impasto rosso in Etruria meridionale e nel Lazio», in e. de sena, h. dessaLes (a cura di), Metodi e approcci archeologici: l’industria e il commer-cio nell’Italia antica, (BAR International Series 1262), Oxford 2004, pp. 120-132.
adriani 1930: a. adriani, «Veio. Macchia della Comunità», in NSc VIII, 1930, pp. 46-56.ahLberg 1971a: G. ahLberg, Prothesis and Ekphora in Greek Geometric Art, Göteborg 1971.ahLberg 1971b: G. ahLberg, Fighting in Land and Sea in Greek Geometric Art, Stockholm
1971.aLecu 2004: D. aLecu, «L’insediamento greco arcaico di Punta Chiarito (Isola d’Ischia) - Una
nuova interpretazione», in SemRom 7/I, 2004, pp. 117-150.aMbrosini 2004: L. aMbrosini, «Il bucchero nell’agro falisco. Un’analisi preliminare», in
naso 2004, pp. 225-257.
268 Cfr. coareLLi 1988b. Da ultimo, toreLLi 2006, in part. pp. 575-577.269 Cfr. Liv. II, 9, 6.270 Una prospettiva analoga in caMporeaLe 1997, p. 199.271 Cfr. caMporeaLe 1997.272 Cfr. Liv. V, 24, 6. In proposito, si veda di recente anche drago troccoLi 2009, p. 342.
120 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
aMpoLo 1987: C. aMpoLo, «Roma arcaica tra Latini ed Etruschi: aspetti politici e istituzionali», in M. cristoFani (a cura di), Etruria e Lazio arcaico, Atti dell’Incontro di studio (10-11 novembre 1986), Roma 1987, pp. 75-93.
angioni 1990: s. angioni, «Schede dei materiali», in a. MaFFei, F. nastasi (a cura di), Caere e il suo territorio da Agylla a Centumcellae, Roma 1990, pp. 240-275.
arizza et Al. 2009: M. arizza, c. carducci, a. de cristoFaro, L. de Marco, d. rossi, «Via A. d’Avack. Necropoli etrusca (Municipio XX)», in BCom CX, 2009, pp. 250-259.
arizza, de cristoFaro, santoLini giordani 2001: M. arizza, a. de cristoFaro, r. san-toLini, «Località Poggioverde, Borgata Ottavia. Necropoli etrusca e strutture di età romana» in F. FiLippi (a cura di), Archeologa e Giubileo. Gli interventi a Roma e nel Lazio nel Piano per il Grande Giubileo del 2000, Napoli 2001, pp. 442-446.
aviLia 2002: F. aviLia, Atlante delle navi greche e romane, Roma 2002.azzaroLi 1972: A. azzaroLi, «Il cavallo domestico in Italia dall’età del Bronzo agli Etruschi»,
in StEtr XL, pp. 273-306.bagLione, de Lucia broLLi 1998: M.p. bagLione, M.a. de Lucia broLLi, «Documenti ine-
diti nell’Archivio storico del Museo di Villa Giulia. Contributi all’archeologia di Narce», in ArchCl L, 1998, pp. 117–179.
bagnasco gianni 2007: G. bagnasco gianni, «Aristonothos. Il vaso», in Aristonothos. Scritti per il Mediterraneo antico, 1, 2007, pp. V-XV [http://riviste.unimi.it/index.php/aristonothos/article/view/570/762].
bartoLoni 1972: g. bartoLoni, Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972.
bartoLoni 1980: g. bartoLoni, «Il corredo della 115 dell’Osteria dell’Osa», in ArchLaz III, 1980, pp. 43-50.
bartoLoni 1986: G. bartoLoni, «I Latini e il Tevere», in quiLici gigLi 1986a, pp. 98-110.bartoLoni 1989: g. bartoLoni, «Marriage, Sale and Gift. A proposito di alcuni corredi femmi-
nili delle necropoli populoniesi della prima età del ferro», in A. raLLo (a cura di), Le donne in Etruria, Roma 1989, pp. 35-54.
bartoLoni 1997: g. bartoLoni (a cura di), Le necropoli arcaiche di Veio: giornata di studio in memoria di Massimo Pallottino, Roma 1997.
bartoLoni 2007: G. bartoLoni, «Il consumo del vino nell’Italia centrale tirrenica», in ciacci, rendini, ziFFerero, Archeologia della vite e del vino in Etruria, Atti del Convegno Interna-zionale di Studi (Scansano 2005), Siena 2007, pp. 147-154.
bartoLoni 2009: G. bartoLoni, «I primi abitanti di Roma e di Veio», in AnnFaina XXVI, 2009, pp. 93-117.
bartoLoni, cataLdi dini, zevi 1975: G. bartoLoni, M. cataLdi dini, F. zevi, «Castel di Decima (Roma)-La necropoli arcaica», in NSc 1975, pp. 233-368.
bartoLoni, acconcia, ten kortenaar 2012: G. bartoLoni, v. acconcia, s. ten korte-naar, «Viticoltura e consumo del vino in Etruria: la cultura materiale tra la fine dell’età del Ferro e l’Orientalizzante antico», in ciacci, rendini, ziFFerero 2012, pp. 201-276.
bartoLoni, Michetti, van kaMpen 2012: G. bartoLoni, L.M. Michetti, i. van kaMpen, «Monte Aguzzo di Veio, il Tumulo Chigi», in Mugione 2012, pp. 19-46.
basch 1987: L. basch, Le musée imaginaire de la marine antique, Athènes, 1987.batino 1998: S. batino, «Contributo alla costruzione di una ideologia funeraria etrusca arcaica: i cor-
redi ceretani tra l’Orientalizzante recente e l’età arcaica», in Ostraka, anno V, 1, 1998, pp. 7-38.bedini 1987: a. bedini, «Askos a ciambella orizzontale», in Viterbo 1987, Roma 1987, p. 164.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 121
bedini 1988-1989: a. bedini, «Tor de’ Cenci (Roma) – Tombe protostoriche», in NSc XLII-XLIII, 1988-1989, pp. 221-279.
bedini 1992: a. bedini, «L’insediamento della Laurentina-Acqua Acetosa», in a. La regina (a cura di), Roma. 1000 anni di civiltà, catalogo della mostra di Montreal, Verona 1992, pp. 62-63.
bedini 2006: a. bedini, «Laurentina Acqua Acetosa», in Roma 2006, pp. 534-539.bedini, cordano 1975: A. bedini, F. cordano, «Castel di Decima. La necropoli arcaica», in
NSc 1975, pp. 369-408.beijer 1978: A. beijer, «Proposta per una suddivisione delle anfore a spirali», in MNIR XL,
1978, pp. 7-21.beLeLLi Marchesini 2004: b. beLeLLi Marchesini, «Appunti sul bucchero vulcente», in
naso 2004, pp. 91-147.beLLeLLi 1997: v. beLLeLLi, «Dal Museo di Tarquinia: decoratori etruschi di “Running Dogs”»,
in MiscEtrItal II, 1997, pp. 7-54.beLLeLLi 2007: v. beLLeLLi, «Influenze straniere e ispirazione locale: gli alabastra etrusco-corin-
zi di forma Ricci 121», in g.M. deLLa Fina (a cura di), Etruschi, Greci, Fenici e Cartaginesi nel Mediterraneo centrale, AnnFaina XIV, 2007, pp. 293-324.
benedettini 1996: M.G. benedettini, «I materiali Falisci e Capenati del Museo delle Antichi-tà Etrusche e Italiche dell’Università “La Sapienza” di Roma», in ArchCl XLVIII, 1996, pp. 1-71.
benson 1989: J.L. benson, Earlier Corinthian workshops: a study of Corinthian geometric and Protocorinthian stylistic groups, Amsterdam 1989.
berggren, berggren 1972: E. berggren, K. berggren, San Giovenale, vol. I, fasc. 5. The necropoleis of Porzarago, Grotte Tufarina and Montevangone, Stockholm 1972.
bernabò brea 1942: L. bernabò brea, C.V.A. Genova, I, Roma 1942.bianco peroni 1976: V. bianco peroni, I coltelli nell’Italia continentale, Prähistorische Bron-
zefunde VII, 2, München 1976.bieLLa 2007: M.C. bieLLa, Impasti orientalizzanti con decorazione ad incavo nell’Italia centrale
tirrenica, Roma 2007.bieLLa 2008: M.C. bieLLa, «Impasti orientalizzanti con decorazione incisa di aree falisca e cape-
nate: un primo bilancio», in Atti del Congresso Internazionale di Archeologia Classica (Roma 2008), Bollettino di Archeologia On Line, 2008, pp. 32-41.
bieLLa 2010: M.c. bieLLa, «Su di un vaso falisco di età orientalizzante con scena di navigazio-ne», in RM 116, 2010, pp. 141-158.
bietti sestieri 1992: a.M. bietti sestieri (a cura di), La necropoli laziale di Osteria dell’Osa, Roma 1992.
bizzarri 1966: N. bizzarri, La necropoli di Crocifisso del Tufo in Orvieto, Orvieto 1966.boitani 1982: F. boitani, «Veio. Nuovi rinvenimenti nella necropoli di Monte Michele», in
ArchTus I, 1983, pp. 95-103.boitani 1983: F. boitani, «Veio: la tomba principesca della necropoli di Monte Michele», in
StEtr LI, 1983, pp. 533-556.boitani 2001: F. boitani, «La tomba principesca n. 5 di Monte Michele», in Roma 2001, pp.
113-118.boitani et Al. 2008: F. boitani, s. neri, F. biagi, «Riflessi della ceramica geometrica nella più
antica pittura funeraria veiente», Atti del Congresso Internazionale di Archeologia Classica (Roma 2008), in Bollettino di Archeologia On Line, 2008, pp. 20-27.
122 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
boitani 2010: F. boitani, Veio, «La tomba dei Leoni Ruggenti: dati preliminari», in Daidalos 10, 2010, pp. 23-47.
Bologna 2000: aa.vv. (a cura di), Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa, catalogo della mostra di Bologna, Venezia 2000.
bonaMici 1974: M. bonaMici, I buccheri con decorazioni graffite, Firenze 1974.bonFante 1975. L. bonFante, Etruscan Dress, Baltimore-London 1975.bonFante 1989: L. bonFante, «Aggiornamento. Il costume etrusco», in Atti del Secondo Con-
gresso Internazionale Etrusco (Firenze 1985), Roma 1989, pp. 1373-1393.bonino 1989: M.bonino, «Imbarcazioni arcaiche in Italia: il problema delle navi usate dagli
Etruschi», in Atti del Secondo Congresso Internazionale Etrusco (Firenze 1985), III, Roma, 1989, pp. 1517-1536.
botto 2000: M. botto, «Tripodi siriani e tripodi fenici dal Latium Vetus e dall’Etruria meridio-nale», in P. bartoLoni, L. caMpaneLLa (a cura di), La ceramica fenicia di Sardegna: dati, problematiche, confronti, Atti del Primo Convegno Internazionale Sulcitano Sant’Antioco (1997), Roma, 2000, pp. 63-98.
broMMer 1953: F. broMMer, Herakles. Die zwölf Taten des Helden in antiker Kunst und Litera-tur, Münster-Köln 1953.
bruni 2009: S. bruni (a cura di), Etruria e Italia preromana. Studi in onore di Giovannangelo Camporeale, Pisa 2009.
buchner, ridgWay 1993: G. buchner, D. ridgWay (a cura di), Pithekoussai 1. La necropoli: tombe 1-723 scavate dal 1952 al 1961, MonAnt 55, 1993.
buraneLLi 1979: F. buraneLLi, «Utensili per la lavorazione del legno in due tombe villanovia-ne», in ArchCl XXXI, pp. 1-9.
buraneLLi 1982: F. buraneLLi, «Un’iscrizione etrusca arcaica dalla tomba V di Riserva del Bagno a Veio», in StEtr L, 1982, pp. 91–102.
caMporeaLe 1984: G. caMporeaLe, La caccia in Etruria, Roma 1984.caMporeaLe 1991: G. caMporeaLe, La collezione C.A. Impasti e buccheri, Roma 1991.caMporeaLe 1997: g. caMporeaLe, «Il sale i primordi di Veio», in bartoLoni 1997, pp. 197-199.caMporeaLe 2005: G. caMporeaLe, «Cavalli e cavalieri nell’Etruria dell’VIII secolo a.C.
Dall’Agro Falisco all’Agro Picentino», in RendPontAc LCXXVII, 2004-2005, pp. 381-411.canciani 1974: F. canciani, C.V.A. Tarquinia, III, Roma 1974.canciani, von hase 1979: F. canciani, F.-W. von hase, La tomba Bernardini di Palestrina,
Roma 1979.caraFa 1995: p. caraFa, Officine ceramiche di età regia. Produzione di ceramica in impasto a
Roma dalla fine dell’VIII alla fine del VI secolo a.C., Roma 1995.carbonara et Al. 1996: a. carbonara, g. Messineo, a. peLLegrino (a cura di), La necro-
poli etrusca di Volusia, Roma 1996.cascianeLLi 2003: M. cascianeLLi, La Tomba Giulimondi di Cerveteri, Città del Vaticano
2003.cataLdi dini 1981: M. cataLdi dini, «La necropoli di Ficana», in aa.vv., Ficana. Una pietra
miliare sulla strada per Roma, Roma 1981, pp. 131-140.cavagnaro vanoni 1996: L. cavagnaro vanoni, Materiali di Antichità Varia, V. Concessio-
ni alla Fondazione Lerici, Roma 1996.cerchiai 1990: L. cerchiai, Le officine etrusco-corinzie di Pontecagnano, Napoli 1990.cerchiai 2002: L. cerchiai, «Il piatto della tomba 65 di Acqua Acetosa Laurentina e i pericoli
del mare», in Ostraka 11, 1, 2002, pp. 29-36.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 123
cherici 2006: A. cherici, «Talassocrazia: aspetti tecnici, economici, politici, con un brevissimo cenno a Novilara, Nesazio e ai Feaci», in deLLa Fina 2006, pp. 439-482.
ciacci, rendini, ziFFerero 2012: a. ciacci, p. rendini, a. ziFFerero (a cura di), Archeolo-gia della vite e del vino in Etruria. Dalle tecniche dell’indagine archeologica alle prospettive della biologia molecolare, Firenze 2012.
cianFrigLia, de cristoFaro cds.: L. cianFrigLia, A. de cristoFaro (a cura di), Il deposito ceramico medio-repubblicano di Castel Malnome (Ponte Galeria-Roma), Roma, c.d.s.
coareLLi 1988a: F. coareLLi, «I santuari, il fiume, gli empori», in A. MoMigLiano, A. schia-vone (a cura di), Storia di Roma, vol. I, pp. 127-151.
coareLLi 1988b: F. coareLLi, Il Foro Boario, Roma 1988.coareLLi 1997: F. coareLLi, Il Campo Marzio. Dalle origini alla fine della repubblica, Roma
1997.coen 1991: a. coen, Complessi tombali di Cerveteri con urne cinerarie tardo-orientalizzanti,
Firenze 1991. coLazingari, FuLgenzi 1996: o. coLazingari, M.t. FuLgenzi, «VIII sec. a.C.», in aa.vv.,
Identità e civiltà dei Sabini, Atti del XVIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Rieti-Magliano Sabina 1993), Firenze 1996, pp. 165-177.
coLonna 1970: G. coLonna, «Una nuova iscrizione etrusca del VII secolo e appunti sull’epi-grafia ceretana dell’epoca», in MEFRA 82, 1970, pp. 637-672.
coLonna 1973-1974: g. coLonna, «Nomi etruschi di vasi», in ArchCl XXV-XXVI, 1973-1974, pp. 132-150.
coLonna 1981: G. coLonna, «Quali Etruschi a Roma», in Gli Etruschi e Roma. Incontro di stu-dio in onore di Massimo Pallottino (Roma 1979), Roma 1981, pp. 159-172.
coLonna 1988: G. coLonna, «La produzione artigianale», in A. MoMigLiano, A. schiavone (a cura di), Storia di Roma, vol. I, pp. 291-316.
coLonna 1990: G. coLonna, «Vasi per bere e per mangiare», in Prospettiva 53-54, 1990, pp. 30-32.
coLonna 1994: G. coLonna, Etrusca Arte, in EAA, II suppl., II, 1994.coLonna 2003: G. coLonna, «Considerazioni sulla Tomba tarquiniese della Nave», in A.
Minetti (a cura di), Pittura etrusca: problemi e prospettive, Atti del convegno (Sarteano 26 ottobre 2001 - Chiusi 27 ottobre 2001), Siena 2003, pp. 63-77.
coLonna 2006: G. coLonna, «Il commercio etrusco arcaico vent’anni dopo (e la sua estensione fino a Tartesso)», in deLLa Fina 2006, pp. 9-28.
coLonna, Maras 2006: G. coLonna, D. Maras, Corpus Inscriptionum Etruscarum. II, 1, 5 (Tituli 6325-6723), et addit. vol. II, 2, 1 (Tituli 8881-8927) (Inscriptiones Veiis et in agro veien-tano, nepesino sutrinoque repertae, additis illis in agro capenate et falisco inventis, quae in fas-ciculo CIE II, 2, 1 desunt, nec non illis perpaucis in finitimis sabinis repertis), Roma 2006.
cozza, pasqui 1981: a. cozza, a. pasqui: Carta Archeologica d’Italia (1881-1879), Materiali per l’Agro falisco, Firenze 1981.
cristoFani 1969: M. cristoFani, Le tombe da Monte Michele nel Museo Archeologico di Firen-ze, Firenze 1969.
cristoFani 1971: M. cristoFani, «Per una nuova lettura della pisside della Pania», in StEtr XXXIX, 1971, pp. 63-89.
cristoFani 1983: M. cristoFani, Gli Etruschi del mare, Milano 1983. cristoFani 1984: M. cristoFani, «Nuovi spunti sul tema della talassocrazia etrusca», in Xenia
8, pp. 3-20.
124 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
cristoFani 1987: M. cristoFani, «Il banchetto in Etruria», in Viterbo 1987, pp. 123-132.cristoFani 1992-93: M. cristoFani, «Un naukleros greco-orientale nel Tirreno. Per un’interpre-
tazione del relitto del Giglio», in AIASA LXX-LXXI, 1992-93 (ed. 1998), pp. 205-232.cristoFani, rizzo 1993: M. cristoFani, M.A. rizzo, «Un kyathos ed altri vasi iscritti dalle
tombe orientalizzanti di San Paolo a Cerveteri», in BdA 78, 1993, pp. 1-10. cristoFani, zevi 1965: M. cristoFani, F. zevi, «La tomba Campana di Veio. Il corredo», in
ArchCl Xvii, 1965, pp. 1-35.daMiani, pacciareLLi 2006: i. daMiani, M. pacciareLLi, «L’insediamento di Acquafredda e
l’occupazione rurale del territorio tra Roma, Caere e Veio dal primo Ferro all’età arcaica», in A. carandini (a cura di), La fattoria e la villa dell’Auditorium nel quartiere Flaminio di Roma, Roma 2006, pp. 551-556.
de cristoFaro, santoLini giordani 2005: a. de cristoFaro, r. santoLini giordani, «Roma, località Poggioverde: una necropoli etrusca sulla via Trionfale», in Dinamiche di svi-luppo delle città nell’Etruria meridionale: Veio, Caere, Tarquinia, Vulci. Atti del XXIII Conve-gno di Studi Etruschi e Italici (Roma, Veio, Cerveteri/Pyrgi, Tarquinia, Tuscania, Vulci, Viter-bo 1-6 ottobre 2001), Pisa-Roma 2005, pp. 163-172.
de cristoFaro 2006: a. de cristoFaro, «Via Trionfale, località Poggioverde (Municipio XIX), Necropoli etrusca», in Roma 2006, pp. 534-539.
de cristoFaro, piergrossi 2012: A. de cristoFaro, A. piergrossi, «Tra Veio e Roma: alcu-ni contesti dalla Via Trionfale, Loc. Poggioverde», in I. van kaMpen (a cura di), Il nuovo museo dell’Agro Veientano a Palazzo Chigi di Formello, Roma 2012, pp. 125-130.
de santis 1997: a. de santis, «Alcune considerazioni sul territorio veiente in età orientalizzan-te e arcaica», in G. bartoLoni 1997, pp. 101-143.
de santis 2003: a. de santis, «Necropoli di Vaccareccia, il tumulo», in Formello 2003, pp. 84-99.dehL 1984: c. dehL, Die korintische Keramik des 8. und friihen 7. jhr v. Chr., in Italien. Untersu-
chungen zu ihrer Chronologie und Ausbreitung, Berlin 1984.deLLa Fina 2006: g.M. deLLa Fina (a cura di), Gli Etruschi e il Mediterraneo. Commerci e
politica, Atti del XIII Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etru-ria, AnnFaina XIII, Roma 2006.
deLpino 1977: F. deLpino, «La prima età del Ferro a Bisenzio: Aspetti della cultura Villanoviana nell’Etruria meridionale interna», in MemAccLinc 8, 21, pp. 453-493.
deLpino 1985: F. deLpino, Cronache veientane. Storia delle ricerche archeologiche a Veio I. Dal XIV alla metà del XIX secolo, Roma 1985.
deLpino 1989: F. deLpino, «L’ellenizzazione in Etruria prima della colonizzazione euboica: sui rapporti tra Grecia ed Etruria fra IX e VIII sec. a.C.», in Atti del Secondo Congresso Interna-zionale Etrusco (Firenze 1985), Roma 1989, pp. 105-116.
deLpino 1997: F. deLpino, «L’ellenizzazione in Etruria prima della colonizzazione euboica: ancora sui crateri, vino, vite e pennati nell’Italia centrale protostorica», in bartoLoni 1997, pp. 185-194.
deLpino 2000: F. deLpino, «Il principe e la cerimonia del banchetto», in Bologna 2000, pp. 191-195.deLpino 2007: F. deLpino, «Viticoltura, produzione e consumo del vino nell’Etruria protostori-
ca», in A. ciacci, P. rendini, A. ziFFerero (a cura di), Archeologia della vite e del vino in Etruria, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Scansano 2005), Siena 2007, pp. 133-146.
de Lucia broLLi 1991: M.a. de Lucia broLLi, Civita Castellana. Il Museo Archeologico dell’Agro Falisco, Roma 1991.
de Lucia broLLi, benedettini 2000: M.A. de Lucia broLLi, M.G. benedettini, «Le pro-
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 125
duzioni degli impasti orientalizzanti in area medio tirrenica», in parise badone 2000, pp. 27-34.
de Lucia broLLi, taboLLi 2012: M.a. de Lucia broLLi, j. taboLLi, «Dimore litiche per i defunti di Narce: custodie. Sarcofagi e letti funebri tra vecchi e nuovi scavi», in Mode e Modelli. Fortuna e insuccesso nella circolazione di cose e idee, Officina Etruscologia 7, pp. 9-76.
depaLMas 2000: A. depaLMas, «Imbarcazioni, rotte e traffici nella Sardegna di età nuragica», in N. negroni catacchio (a cura di), L’Etruria tra Italia, Europa e Mondo Mediterraneo. Ricerche e Scavi, Atti del IV incontro di studi di Preistoria e Protostoria in Etruria (Marciano, Montalto di Castro, Valentano 1997), Milano 2000, pp. 201-213.
dik 1980: R. dik, «Un’anfora orientalizzante etrusca nel Museo Allard Pearson», in BABesch 56, 1981, pp. 45-74.
dougherty 2003: C. dougherty, «The Aristonothos krater. Competing stories of conflict and collaboration», in C. dougherty, L. kurke (eds.), The cultures within ancient Greek cul-ture. Contact, conflict, collaboration, Cambridge 2003, pp. 35-56.
drago 1997: L. drago, «Le tombe 419 e 426 del sepolcreto di Grotta Gramiccia a Veio. Con-tributo alla conoscenza di strutture tombali e ideologia funeraria a Veio tra il VI ed il V seco-lo a.C.», in AA.VV., Etrusca et Italica. Scritti in ricordo di Massimo Pallottino, Roma-Pisa 1997, pp. 239-280.
drago troccoLi 2009: L. drago troccoLi, «Veio tra Villanoviano e tardo arcaismo. Appunti sulla necropoli di Casale del Fosso», in bruni 2009, pp. 327-370.
Fentress et Al. 1983: e. Fentress, s. judson, t. bLagg, M. de vos, d. taMi, p. arthur, d.F. WiLLiaMs, «Excavations at Fosso della Crescenza, 1962», in BSR LI, 1983, pp. 58-101.
Firenze 1985: M. cristoFani (a cura di), Civiltà degli Etruschi, catalogo della mostra di Firenze, Milano 1985.
Formazione 1980: La formazione della città nel Lazio, Atti del seminario (Roma 24-26 giugno 1977), in DdA II, 1-2, 1980.
Formello 2003: i. van kaMpen (a cura di), Dalla Capanna alla casa: i primi abitanti di Veio, catalogo della mostra di Formello, Formello 2003.
gaLante 2001-2002: G. gaLante, La necropoli di Macchia della Comunità, tesi di laurea, Uni-versità di Roma La Sapienza, a.a. 2001-2002.
gauLtier, geppert 2000: F. gauLtier, K. geppert, «Zwei Pasticci und ihre Folgen. Die Bild-motive der Caeretaner Pyxiden D 150 und D 151 im Louvre», in F. prayon, W. röLLig, Der Orient Der Orient und Etrurien. Zum Phänomen des Orientalisierens im westlichen Mittel-meerraum, 10.-6. Jh. v.Chr. Akten des Kolloquiums (Tübingen 1997), Pisa 2000 (Biblioteca di Studi Etruschi 35), pp. 211-218.
gaMbari, tecchiati 2004: F.M. gaMbari, U. tecchiati, «Il cane e il cavallo come indica-tori di status nella preistoria e nella protostoria», in P. gLeirshcer (a cura di), Guerrieri principi ed eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Alto Medioevo, Trento 2004, pp. 231-241.
gercke 1996: W.b. gercke, Etruskische Kunst im Kestner-Museum Hannover, Hannover 1996.giaLaneLLa 1994: C. giaLaneLLa, «Pithecusa: gli insediamenti di Punta Chiarito. Relazione
preliminare», in B. d’agostino, D. ridgWay, (a cura di), APOIKIA. I più antichi insedia-menti greci in Occidente: funzioni e modi dell’organizzazione politica e sociale. Scritti in onore di Giorgio Buchner, Napoli 1994, pp. 169-204.
gianFrotta 1991: P. gianFrotta, «Navi mitologiche a Roma», in Quarta Rassegna di archeo-logia subacquea, Messina 1991, pp. 85-91.
126 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
giannini 2009: e. giannini, «Via A. d’Avack. Centro Ecologico Antonina. Tomba di età orienta-lizzante (Municipio XX)», in BullCom CX, 2009, pp. 243-250.
gieroW 1964, p.g. gieroW, The Iron Age culture of Latium II. The Alban Hills, Lund 1964.gigLioLi 1929: G.Q. gigLioLi, «L’oinochoe di Tragliatella», in StEtr III, 1929, pp. 111-159.Ginevra 1993: L’arte dei popoli italici dal 3000 al 300 a.C., catalogo della mostra di Ginevra,
Napoli 1993.giuLiano 2009: A. giuLiano, «Protoattici in Occidente», in B. adeMbri (a cura di),
aειμνηστoσ. Miscellanea di studi per Mauro Cristofani, Firenze 2005, pp. 64-72.gjerstad 1966: e. gjerstad, Early Rome IV, 1-2. Synthesis of Archeological Evidence, Lund 1966.gran ayMerich 1982: J. gran ayMerich, «Bucchero», in M. aLMagro gorbea, El santua-
rio de Juno en Gabii, Roma 1982, pp. 333-354.gras 1984: M. gras, «Canthare, socíété étrusque et le mond grec», in Opus III, 2, 1984, pp. 325-331.gras 1985: M. gras, Trafics tyrrhéniens archaïques, Rome 1985, (Bibliothèque des Ecoles fran-
çaises d’Athènes et de Rome, 258).guaitoLi, picarreta, soMMeLLa 1974: M. guaitoLi, F. picarreta, P. soMMeLLa, «Con-
tributi per una recente carta archeologica del territorio di Castel di Decima», in QuadITA VI, 1974, pp. 43-130.
guidi 1993: a. guidi, La necropoli veiente dei Quattro Fontanili, Firenze 1993.haLL dohan 1942: e. haLL dohan, Italic tomb-groups in the University Museum, Pennsylva-
nia 1942.heMeLrijk 1984: J.M. heMeLrijk, Caeretan Hydriae, Mainz 1984.hirschLand raMage 1970: n. hirschLand raMage, «Studies in Early Etruscan Bucchero»,
in BSR XXXVIII, 1952, pp. 1-61.höckMann 2000: O. höckMann, «Schiffahrt der Etrusker», in F. prayon, W. röLLig, Der
Orient Der Orient und Etrurien. Zum Phänomen des Orientalisierens im westlichen Mittel-meerraum, 10. - 6. Jh. v.Chr. Akten des Kolloquiums (Tübingen 12-13 Juni 1997), Pisa 2000, (Biblioteca di Studi Etruschi 35), pp. 77-87.
hurWit 2012: J. hurWit, «Boularchos, the Chigi Painter, and the interdependence of free-pain-ting and vase-painting in the Seventh Century», in Mugione 2012, pp. 103-110
iaia 2006: C. iaia, «Strumenti da lavoro nelle sepolture dell’età del Ferro italiana», in Studi di protostoria in onore di Renato Peroni, Firenze 2006, pp. 190-201.
ingLieri 1930: r.u. ingLieri, «Tombe a camera in tenuta Oliveto Grande», in NSc VIII, 1930, pp. 69-71.
jannot 1986: J.R. jannot, «Les cavaliers étrusques», in RM XCIII, pp. 109-133.jucker 1981: H. jucker «Die Impasto-Kanne des Mamarce in Würzburg», in NumClass 10,
1981, pp. 31-51.kohLer, naso 1991: c. kohLer, a. naso, «Appunti sulla funzione di alari e spiedi nelle socie-
tà arcaiche dell’Italia centro-meridionale», in F. herring, r.d. Whitehouse, j.b. WiLkins (eds.), Papers of fourth Conference of Italian Archaeology, 1-2, Part 2, London 1991, pp. 41-63.
LaForgia 2003: E. LaForgia, Il museo archeologico di Calatia, Napoli 2003.Le gaLL 1953: J. Le gaLL, Le Tibre fleuve de Rome dans l’Antiquitè, Paris 1953.Liverani 1996: P. Liverani, «Ianiculum. Da Antipolis al Mons Ianiculensis», in E.M. steinby
(a cura di), Ianiculum-Gianicolo. Storia, topografia, monumenti, leggende dall’antichità al Rinascimento, Roma 1996, pp. 3-12.
Liverani 1999: P. Liverani, La topografia antica del Vaticano, Roma 1999.LocateLLi 2004: d. LocateLLi, «Tarquinia», in naso 2004, pp. 49-89.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 127
MandoLesi, casteLLo 2009: a. MandoLesi, c. casteLLo, «Modellini di navi tirrenico-villa-noviane da Tarquinia», in Mediterranea 6, 2009, pp. 9-28.
Mangani 1986: e. Mangani, C.V.A. Grosseto, II, Roma 1986.Marchetti 2004: M.h. Marchetti, «La produzione del bucchero a Veio: alcune considerazio-
ni», in naso 2004, pp. 17-27.Mari 2004: Z. Mari, s.v. Cassia via, in LTUR Suburbium, 2004, pp. 65-75.MarteLLi 1984: M. MarteLLi, «Prima di Aristonothos», in Prospettiva 38, 1984, pp. 2-15.MarteLLi 1987a: M. MarteLLi, La ceramica degli Etruschi, Novara 1987.MarteLLi 1987b: M. MarteLLi, «Per il Pittore delle gru», in Prospettiva 48, 1987, pp. 2-11.MarteLLi 1987c: M. MarteLLi, «Del Pittore di Amsterdam e di un episodio del nostos odissaico.
Ricerche di ceramografia etrusca orientalizzante», in Prospettiva 50, 1987, pp. 4-14.MarteLLi 1988: M. MarteLLi, «Un’anfora orientalizzante ceretana a Würburg ovvero il Pittore
dell’eptacordo», in AA, 1988, pp. 285-296. MarteLLi 1989: M. MarteLLi, «La ceramica greca in Etruria: problemi e prospettive di ricerca»,
in Atti del II Congresso Internazionale Etrusco (Firenze 1985), II, Roma 1989, pp. 796-804.MarteLLi 2001: M. MarteLLi, «Nuove proposte per i Pittori dell’eptacordo e delle gru», in Pro-
spettiva 101, 2001, pp. 2-18.MarteLLi 2005: M. MarteLLi, «Rivisitazione delle lamine di rivestimento di carri nella Ny
Carlsberg Glyptotek di Copenaghen», in Prospettiva 117-118, 2005, pp. 122-130.MarteLLi 2008a: M. MarteLLi, «Il fasto delle metropoli dell’Etruria meridionale. Importazioni,
imitazioni e arte suntuaria», in toreLLi 2008, pp. 121-139.MarteLLi 2008b: M. MarteLLi, «Variazioni sul tema etrusco-geometrico», in Prospettiva 132,
2008, pp. 2-30.Medoro 2003: a. Medoro, «Necropoli di Riserva del Bagno, Tomba delle Anatre», in Formello
2003, pp. 73-80.MeLe 1979: a. MeLe, Il commercio greco arcaico: prexis ed emporie, Napoli 1979.Menichetti 1994: M. Menichetti, Archeologia del potere. Re, immagini e miti a Roma e in
Etruria in età arcaica, Milano 1994.MerMati 2012: F. MerMati, Cuma. Le ceramiche arcache: la produzione pithecusana-cumana
tra la metà dell’VIII e l’inizio del VII sec. a.C., Pozzuoli 2012.Messineo 1983: G. Messineo, «Contributi alla ricostruzione della rete viaria antica nel settore
nord del suburbio di Roma», in ArchLaz V, 1983, pp. 136-146.Michetti 2009: L.M. Michetti, «Note su un anfora orientalizzante dal tumulo di Monte Aguzzo
a Veio», in bruni 2009, pp. 607-617.Micozzi 1994: M. Micozzi, “White-on-red”. Una produzione vascolare dell’orientalizzante etru-
sco, Pisa 1994.Milano 1980: AA.VV., Gli Etruschi e Cerveteri, catalogo della mostra di Milano, Milano 1980.Milano 1986a: B. bosio, a. pugnetti (a cura di), Etruschi di Cerveteri, catalogo della mostra di
Milano, Milano 1986.Milano 1986b: M. bonghi jovino (a cura di), Etruschi di Tarquinia, catalogo della mostra di
Milano, Milano 1986.MoreLLi, oLcese, zevi 2004: C. MoreLLi, G. oLcese, F. zevi, «Scoperte recenti nelle saline
portuensi (Campus Salinarum Romanarum) e un progetto di ricerca sulla ceramica repubbli-cana di area ostiense in età repubblicana», in A. gaLLina zevi, R. turchetti (a cura di), Méditerranée occidentale antique: les échanges (ANSER III), Catanzaro 2004, pp. 43-55.
Moretti 1961: M. Moretti, La Tomba della Nave, Milano 1961.
128 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
Mugione 2012: E. Mugione (a cura di), L’Olpe Chigi. Storia di un agalma, Salerno 2012.Mura soMMeLLa 2004-2005: a. Mura soMMeLLa, «Aspetti dell’Orientalizzante antico a
Capena. La tomba di un principe guerriero», in RendPontAcc LXXVII, pp. 219-287.Musti 2001: D. Musti, Il simposio, Roma-Bari 2001.naso 2004: a. naso (a cura di), Appunti sul bucchero. Atti delle giornate di studio, Firenze 2004.neeFt 1987: c.W. neeFt, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi, Amsterdam 1987.neri 2010: s. neri, Il tornio e il pennello. Ceramica depurata di tradizione geometrica di epoca
orientalizzante in Etruria meridionale, Roma 2010.nieMeier et Al. 2012: W.D. nieMeier, B. nieMeier, A. brysbaert, «The Olpe Chigi and
the new evidenc for early archaic Greek wall-painting from the oracle sanctuary of Apollo at Abai», in Mugione 2012, pp. 79-86.
pagLieri 1960: s. pagLieri, «Origine e diffusione delle navi etrusco-italiche», in StEtr 28, 1960, pp. 209.
paLM 1952: j. paLM, «Veiian tomb groups in the Museo Preistorico, Rome», in OpArch 7, 1952, pp. 50-86.
paLMieri 2009: A. paLMieri, «Le tombe laziali di VI e V sec. a.C. Considerazioni da una pro-spettiva etrusca», in L. drago (a cura di), Il Lazio dai Colli Albani ai Monti Lepini tra prei-storia ed età moderna, Roma 2009, pp. 371-396.
papi 1988: r. papi, «Materiali sporadici dalla necropoli della Vaccareccia di Veio», in QuadChieti 4, 1988, pp. 87-144.
parise badoni 2000: F. parise badoni (a cura di), Ceramiche d’impasto dell’età orientalizzan-te in Italia, Roma 2000.
pasqui 1894: A. pasqui, Delle tombe di Narce e dei loro corredi, MonAnt IV, 1894.payne 1931: H. payne, Necrocorinthia: a study of Corinthian art in the archaic period, Oxford
1931.peLLegrini 1989: e. peLLegrini, La necropoli di Poggio Buco. Nuovi dati per lo studio di un
centro dell’Etruria interna nei periodi orientalizzante ed arcaico, Firenze 1989.pensabene, FaLzone 2001: P. pensabene, s. FaLzone (a cura di), Scavi del Palatino I: l’area
sud-occidentale del Palatino tra l’età protostorica e il IV secolo a.C., scavi e materiali della struttura ipogea sotto la cella del Tempio della Vittoria, Studi Miscellanei 31, Roma 2001.
pettena 2002: g. pettena, Gli Etruschi e il mare, Torino, 2002.piergrossi 2003-2004: A. piergrossi, Un sito veiente di frontiera: Casale Poggioverde sulla
Via Trionfale, tesi di specializzazione, Università di Roma La Sapienza, A.A. 2003-2004.pitzaLis 2011: F. pitzaLis, La volontà meno apparente. Donne e società nell’Italia centrale tir-
renica tra VIII e VII sec. a.C., Roma 2011.pizzirani 2005: C. pizzirani, «Da Odisseo alle Nereidi. Riflessioni sull’iconografia etrusca del
mare attraverso i secoli», in Ocnus 13, 2005, pp. 251-270.poMey 1997: P. poMey, «Navigazione e navi all’epoca della colonizzazione greca», in G.
pugLiese carrateLLi (a cura di), I Greci in Occidente, catalogo della mostra di Venezia, Milano 1996, pp. 133-1540.
potter 1976: t. potter, A Faliscan Town in South Etruria: excavations at Narce 1966-71, Lon-don 1976.
Quattro Fontanili 1965: AA.VV., «Veio (Isola Farnese) – Continuazione degli scavi nella necropo-li villanoviana di Quattro Fontanili», in NSc 1965, pp. 49-236.
Quattro Fontanili 1970: AA.VV., «Veio (Isola Farnese) - Continuazione degli scavi nella necropoli villanoviana in località “Quattro Fontanili”», in NSc 1970, pp. 178-329.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 129
Quattro Fontanili 1972: AA.VV., «Veio (Isola Farnese) - Continuazione degli scavi nella necropoli villanoviana in località “Quattro Fontanili”», in NSc 1972, pp. 195-384.
quiLici, quiLici gigLi 1986: L. quiLici, S. quiLici gigLi, Fidenae, Roma 1986.quiLici gigLi 1986a: S. quiLici gigLi (a cura di), Il Tevere e le altre vie d’acqua del Lazio anti-
co, in QuadAEI 12, 1986.quiLici gigLi 1986b: S. quiLici gigLi, «Scali e traghetti sul Tevere in epoca arcaica», in quiLi-
ci gigLi 1986a, pp. 71-89.raddatz 1983: k. raddatz, «Ein Grabfund aus Veji im Südlichen Etrurien», in JbZmusMainz
XXX, 1983, pp. 207-231. rasMussen 1979: t.b. rasMussen, Bucchero pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979.ricci 1955: G. ricci, «Necropoli della Banditaccia – zona A del recinto», in MonAnt 1955, coll.
201-1048.rizzo 1990: M.a. rizzo, Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcaico, Roma 1990.rizzo 2005: M.a. rizzo, «Le tombe orientalizzanti di San Paolo a Cerveteri», in Dinamiche di
sviluppo della città dell’Etruria meridionale a Veio, Caere, Tarquinia, Vulci. Atti del XXIII convegno di studi etruschi ed italici (Roma, Veio, Cerveteri/Pyrgi, Tarquinia, Tuscania, Vulci, Viterbo, 1 - 6 ottobre 2001), Pisa-Roma 2005, pp. 283-300.
rizzo 2007: M.a. rizzo, «Una kotyle del Pittore di Bellerofonte di Egina ed altre importazioni greche ed orientali dalla tomba 4 di Monte Abatone a Cerveteri», in BdA 140, 2007, pp. 1-56.
rocco 2008: G. rocco, La ceramografia protoattica: pittori e botteghe (710-630 a.C.), Leidorf 2008. Roma 1976: AA.VV., Civiltà del Lazio Primitivo, catalogo della mostra di Roma, 1976.Roma 1990: M. cristoFani (a cura di), La grande Roma dei Tarquini, catalogo della mostra di
Roma, Roma 1991.Roma 2001: A.M. sgubini Moretti (a cura di), Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confron-
to, catalogo della mostra di Roma, Roma 2001.Roma 2006: M.a. toMei (a cura di), Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici
1980/2006, catalogo della mostra di Roma, Roma 2006.Roma 2009: F. enei (a cura di), Etruschi e Fenici sul mare. Da Pyrgi a Cartagine, catalogo della
mostra di Roma, Roma 2009. roMbos 1988: Th. roMbos, The Iconography of Attic Late Geometric II Pottery, Jonsered 1988. sartori 2002: a. sartori, Caere. Nuovi documenti dalla necropoli della Banditaccia. Tombe B 25,
B 26, B 36, B 69, Milano 2002 (Notizie dal chiostro del monastero maggiore. Supplementi, 21).scarano ussani 1996: V. scarano ussani, «Il significato simbolico dell’hasta nel III periodo
della cultura laziale», in Ostraka 5, 2, 1996, pp. 321-332.schWeitzer 1955: b. schWeitzer, «Zum Krater des Aristonothos», in RM 62, 1955, pp. 78-106.sciacca 2005: F. sciacca, Patere baccellate in bronzo. Oriente, Grecia, Italia in età orientaliz-
zante, Roma 2005.sciacca 2008: F. sciacca, «Veio. La metallotecnica orientalizzante e i rapporti con l’Oriente»,
in Atti del Congresso Internazionale di Archeologia Classica (Roma 2008), in Bollettino di Archeologia On Line, 2008, pp. 5-19.
sgubini Moretti 1994: a.M. sgubini Moretti, «Ricerche archeologiche a Vulci: 1985-1990», in M. MarteLLi (a cura di), Tyrrhenoi Philotechnoi, Atti della Giornata di Studio (Viterbo 1990), Roma 1994, pp. 9-50.
steFani 1922: e. steFani, «Scoperta di antichi sepolcri nel territorio del comune di Formello», in NSc XIX, 1922, pp. 215-219.
130 M. arizza - a. de cristoFaro - a. piergrossi - d. rossi
steFani 1928: e. steFani, «Veio. Scoperta di antichi sepolcri nella tenuta di Monte Oliviero, presso Prima Porta», in NSc IV, 1928, pp. 95-105.
steFani 1930: E. steFani, «Castel S. Elia», in NSc VI, pp. 583-586.steFani 1935a: e. steFani, «Scoperte archeologiche nella tenuta “Inviolatella”», in NSc XI,
1935, pp. 174-181.steFani 1935b: e. steFani, «Veio. Esplorazione del tumulo Vaccareccia», in NSc XI, 1935, pp.
329-361.steingräber 1979: s. steingräber, Etruskische Möbel, Roma 1979.sziLágyi 1967: G.J. sziLágyi, «Etrusko-korinthische polychrome Vasen», in WissZRostock 16,
1967, pp. 543-553.sziLagyi 1992: G.J. sziLágyi, Ceramica etrusco-corinzia figurata, 1. 630-580 a.C., Firenze
1992.ten kortenaar 2011: s. ten kortenaar, Il colore e la materia. Tra tradizione e innovazione
nella produzione dell’impasto rosso nell’Italia medio-tirrenica, Roma 2011.tognineLLi 2008: P. tognineLLi: «Crustumerium: i contatti sul fronte settentrionale. Nuovi dati
dalla necropoli di Nomentum», in in Atti del Congresso Internazionale di Archeologia Classi-ca (Roma 2008), in Bollettino di Archeologia On Line, 2008, pp. 51-69.
toreLLi 1987: M. toreLLi, La società etrusca. L’età arcaica, l’età classica, Roma 1987.toreLLi 2000: M. toreLLi, «Primi appunti per un’antropologia del vino degli Etruschi», in
D. toMasi, C. creMonesi (a cura di), L’avventura del vino nel bacino del Mediterraneo. Itinerari storici ed archeologia prima e dopo Roma, Atti Simposio Internazionale (Conegliano Veneto 1998), Treviso 2000, pp. 91-100.
toreLLi 2006: M. toreLLi, «Ara Maxima Herculis: storia di un monumento», in MEFRA 118, 2, 2006, pp. 573-620.
toreLLi 2008: M. toreLLi (a cura di), Etruschi. Le antiche metropoli del Lazio, catalogo della mostra di Roma, Roma 2008.
vaerst 1980: A. vaerst, Griechische Schildzeichen vom 8. bis zum ausgehenden 6. Jh., Diss. Universität Salzburg 1980.
vagnetti 1971: L. vagnetti, Il deposito votivo di Campetti a Veio. Materiali degli scavi 1937-1938, Firenze 1971.
van kaMpen 2012a: i. van kaMpen (a cura di), Il nuovo Museo dell’Agro Veientano a Palazzo Chigi di Formello, Roma 2012.
van kaMpen 2012b: I. van kaMpen, «Idra a Formello: una nuova immagine eseguita con tornio e pennello», in van kaMpen 2012a, pp. 85-89.
vighi 1932: r. vighi, «La più antica rappresentazione di nave etrusco-italica su un vaso della necropoli veiente», in RendAccLinc 8, 1932, pp. 367-375.
vighi 1935: r. vighi, «Veio. Scavi nella necropoli, degli alunni dell’anno 1927-28 del Corso di Topografia dell’Italia Antica della R. Università di Roma», in NSc XI, 1935, pp. 40-68.
vistoLi 2010: F. vistoLi, «Roma (Via Cassia, loc. Acquatraversa). Insediamento etrusco sulla Collina INA», in NSc 2008-2009 (2010), pp. 143-184.
Viterbo 1987: AA.VV., L’alimentazione nel mondo antico. Gli Etruschi, catalogo della mostra di Viterbo, Roma 1987.
Viterbo 1997: A. eMiLiozzi (a cura di), Carri da guerra e principi etruschi, catalogo della mostra di Viterbo, Viterbo 1997.
Ward-perkins 1955: j.b. Ward-perkins, «Notes on Southern Etruria and the Ager Veienta-nus», in BSR XXIII, 1955, pp. 44-72.
La toMba di un aristocratico nAukleros daLL’agro veientano 131
Westerberg 1983: K. Westerberg, Cypriote ships from the Bronze age to 500 B.C., Studies in Mediterranean archaeology 22, Gothenburg 1983.
Wikander 1988: C. Wikander, Acquarossa I.2, The Painted architectural Terracottas. Typolo-gical and decorative analysis, Stockholm 1988.
zaccaria ruggiu 2003: A. zaccaria ruggiu, More regio vivere. Il banchetto aristocratico e la casa romana di età arcaica, Roma 2003.
zevi 2000: F. zevi, «Roma arcaica e Ostia. Una riconsiderazione del problema», in I. berLingò et Al. (a cura di), Damarato. Studi di antichità classica offerti a Paola Pelagatti, Milano 2000, pp. 233-243.
zevi 2002: F. zevi, «Origini di Ostia», in c. bruun, a. gaLLina zevi (a cura di), Ostia e Por-tus nelle loro relazioni con Roma. Atti del Convegno all’Institutum Romanum Finlandiae (Roma 1999), Roma 2002, pp. 11-32.
ziFFerero 2012: A. ziFFerero, «Il primo vino degli Etruschi: vitigni, vigneti e modi di consu-mo», in A. MandoLesi, M. sannibaLe (a cura di), Etruschi. L’ideale eroico e il vino lucen-te, catalogo della mostra di Asti, Milano 2012, pp. 67-75.
zuchtriegeL 2012: G zuchtriegeL, «Riflessioni a margine dei vecchi scavi al santuario orien-tale di Gabii: nuovi dati sulla fase iniziale del culto», in E. Marroni (a cura di), Sacra Nomi-nis Latini. I santuari del Lazio arcaico e repubblicani. Atti del Convegno Internazionale, (Roma 2009), Ostraka 2012, pp. 243-246.
SUMMARY
Knowledge of the economy and the social structure of Veii and its territory in the Ori-entalizing period has been enriched as a result of an extensive excavation in the necropolis of Via A. D’Avack (Rome, Municipio XX) discovered in 2008 along the ancient via Veientana. The cemetery constitutes an interesting new study case that has afforded us the possibility to investigate a group of 8 aristocratic chamber tombs (7th century BC.) and significant traces of agricultural landscape. Among these, tomb 3 belongs to a prominent person whose grave goods define the image of a rich landowner who is at the same time engaged in sea trade. The naukleros in his underworld journey was accompanied by a rich banquet set as used in aristocratic circles. The ceremonial kantharos displaying engraved decoration shows the most complex navigation scene known to us so far in the art of Etruria.