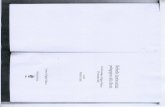Sui valori di 'nam' nell''Adbreuiatus liber' di Cezio Faventino
Transcript of Sui valori di 'nam' nell''Adbreuiatus liber' di Cezio Faventino
Aevum Antiquum N.S.11 (2011), pp. 33-53
DaviD Paniagua
SUI VALORI DI NAM NELL’ADBREVIATVS LIBER DI CEZIO FAVENTINO*
1. Lo studio dei segnali discorsivi1
Fra gli studiosi della lingua latina è un’idea ampiamente condivisa che il Fun-zionalismo di Dik e, soprattutto, la Grammatica Funzionale, sviluppata da Pinkster e continuata e specializzata da altri nomi illustri come Bolkenstein, Rosén, Risselada o Kroon – per menzionarne soltanto alcuni – sia riuscita a fornire una descrizione della struttura grammaticale della lingua latina molto più compiuta e accurata di quanto non fosse mai stato fatto prima2.
Uno dei contributi più notevoli apportato da questa metodologia di studio è stato il superamento del livello proposizionale come ambito strutturale di analisi, grazie allo sviluppo di una proposta gerarchica sulla struttura del discorso che va dalla parola alla frase e dalla frase al testo, al discorso codificato per iscritto; insomma, dalla microstruttura alla macrostruttura del discorso. In questo senso, non è esagerato asserire che gli studi dei cosiddetti segnali discorsivi (discourse particles) realizzati in particolare da Caroline Kroon3 e successivamente arricchiti da Hannah Rosén4, hanno rappresentato una svolta per la descrizione grammaticale e per la percezione pragmatica e semantica di questi elementi della lingua latina. Ed è stata indubbiamente una svolta, perché i ben noti nam, enim, autem, uero, at, ergo, ecc., che popolano ogni angolo della geografia testuale latina, avevano tradizionalmente resistito a qualsiasi tentativo di definizione esaustiva.
Certamente definire il significato di un segnale discorsivo in qualunque lingua è sempre un’impresa ardua. Scritto nei tempi in cui i segnali discorsivi ancora
* Questo contributo fa parte dell’attività di ricerca svoltasi nell’ambito del Progetto «DigilibLT: Digital Library of Late Latin Texts», grazie al finanziamento di un Assegno di Ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro».
1 A proposito dei segnali discorsivi latini, reca un enorme aiuto la bibliografia complessiva raccol-ta da J. Schrickx, disponibile in rete, URL: http://latinparticles.userweb.mwn.de (09/02/13), che oltre ad offrire un elenco esaustivo e ordinato degli studi esistenti sull’argomento, dimostra il grande interesse degli studiosi verso questi elementi della lingua negli ultimi tempi.
2 C. Kroon, Discourse Particles in Latin. A Study of nam, enim, autem, uero and at, Amsterdam 1995.
3 H. Rosén, Coherence, sentence modification, and sentence-part modification – the contribution of particles, in New Perspectives on Historical Latin Syntax, Volume 1. Syntax of the Sentence, ed. by Ph. Baldi and P. Cuzzolin, Berlin-New York 2009, pp. 317-441.©
201
4 V
ita
e Pe
nsie
ro /
Pub
blic
azio
ni d
ell’U
nive
rsit
à C
atto
lica
del S
acro
Cuo
re
34 DAVID PANIAGUA
si chiamavano «particelle»5, l’epocale studio di Denniston su questi elementi nella lingua greca partiva, appunto, dalla constatazione chiara di questa dif-ficoltà :
«Difficult as it is to arrive at a satisfactory definition of particle, an attempt must be made at the outset. I will define it as a word expressing a mode of thought, consi-dered either in isolation or in relation to another thought, or a mood of emotion».
Allo stesso modo, dalla difficoltà intrinseca allo studio di questo ambito della lingua, partiva anche Fraenkel in uno studio sempre riguardante le particelle in greco6:
«A study intended to contribute to the knowledge on Greek particles … meets with difficulties and drawbacks. […] For what kind of observations, apart from purely morphological statements could one make on words like ajllav, ajrav, mhvn, dhv, oun, without having to furnish an abundant quantity of instances in which particles occur and the context from which their use and meaning becomes clear?»,
e soltanto alla fine del suo contributo veniva a concludere7:
«A particle, therefore, is a word without a meaning which, consequently without giving names, is able to discharge emotion, to make known intentions, to connect related clauses. Reasonably particles should have their appropriate place in gram-mar at the beginning of etymology, as words which are not yet signs or names; se-condly at the beginning of syntax, as words which already make known intentions and relations, of which the actual syntax is the intellectual realization, or, at the end of all this – where syntax with its means does not suffice anymore».
Non è un fatto casuale che questi siano, per l’appunto, gli elementi più diffi-cili da imparare in una lingua straniera, e quindi una vera e propria prova del nove di dimestichezza linguistica. Quando si è in grado di riconoscere in una lingua straniera l’uso erroneo di un segnale discorsivo, il livello di padronanza di detta lingua è altissimo8. In ogni caso, i segnali discorsivi sono quegli ele-menti che fanno sì che un testo sia davvero un testo, con una concatenazione
5 J.D. Denniston, The Greek Particles, Oxford 19522 (1934), p. XXXVI.6 J.J. Fraenkel, A Question in Connection with Greek Particles, Mnemosyne 13 (1947), p. 183.7 Fraenkel, A Question, art. cit., p. 201.8 E, in senso complementare, la segnalazione di Svartvik (J. Svartvik, ‘Well’ in conversation, in Stu-
dies in English Linguistics for Randolph Quirk, ed. by S. Greenbaum, G. Leech and J. Svartvik, London 1980, p. 171, apud S. Müller, Discourse Markers in Native and Non-native English Discourse, Amster-dam-Philadelphia 2005, p. 2): «if a foreign language learner says ‘five sheeps’ or ‘he goed’, he can be corrected by practically every native speaker. If, on the other hand, he omits a ‘well’, the likely reaction will be that he is dogmatic, impolite, awkward to talk to, etc. but a native speaker cannot pinpoint an ‘error’», sottolinea il fatto che, anche se l’uso dei segnali discorsivi nella lingua è un segno di padronanza linguistica, non saperli usare non è necessariamente un errore grammaticale, bensì una mancanza di competenza linguistica nell’ambito della coerenza pragmatica comunicativa.
SUI VALORI DI NAM NELL’ADBREVIATVS LIBER DI CEZIO FAVENTINO 35
logica e un’articolazione coerente, e non semplicemente un mucchio di frasi accostate l’una dopo l’altra9.
Dal punto di vista grammaticale, si sa che più alto è il livello a cui viene codificata linguisticamente un’informazione, meno concreta essa diventa. Se in un estremo si trova l’informazione lessicale codificata in un sostantivo, espres-sione massima della precisione, dove si verifica una corrispondenza perfetta fra significante e significato – per fare uso di una terminologia tradizionale –, nell’estremo opposto, ancora un passo al di là delle congiunzioni, si trova l’informazione relazionale codificata nei segnali discorsivi: un’informazione codificata in parole normalmente indeclinabili e di piccola entità fonica, che serve ad articolare concettualmente e pragmaticamente il testo con il contesto extradiscorsivo oppure con il discorso stesso, che non ha un referente determinato e che, di conseguenza, non ha un significato concreto, bensì un valore semantico-relazionale contestuale (vale a dire, non sono parole ‘autosemantiche’)10.
Per questo motivo i dizionari odiano i segnali discorsivi, perché quello che offrono i dizionari sono significati, non le sempre sfuggenti descrizioni dei valori semantico-relazionali di tipo contestuale. Come diceva Fraenkel occorre sempre procurare una quantità abbondante di informazioni addizionali sul contesto al proposito di chiarirne sia il senso che l’uso.
Ed è qui dove, nel caso di un corpus language come la lingua latina, recano un aiuto incalcolabile le banche dati di testi, che offrono un servizio ormai imprescindibile per lo studio di tutte le occorrenze e possibilità testimoniate all’interno del corpus stesso, finalizzato a fornire una descrizione globale del sistema11.
9 I segnali discorsivi sono uno degli elementi più importanti in qualsiasi tipo di risposta alla domanda «che cosa determina che un testo sia tale e non semplicemente una raccolta fatta a caso di frasi isolate messe assieme?» (vd. D. Schiffrin, Discourse Markers: Language, Meaning, and Context, in The Handbook of Discourse Analysis, ed. by D. Schiffrin, D. Tannen and H.E. Hamilton, Oxford 2001, p. 55).
10 Cf., ad esempio, la proposta di definizione di Schenkeveld (D.M. Schenkeveld, From particula to particle – the genesis of a class of words, in L’héritage des grammairiens latins de l’Antiquité aux Lumières. Actes du Colloque de Chantilly, Paris 1987, ed. I. Rosier, Paris 1988, p. 81) «... particles are thought to be indeclinable words, most times small ones, which syntactically combine parts of sentences as well as sentences themselves, semantically lack a referent and therefore have no meaning, only a semantic value, by which emotions are expressed and utterances are qualified, whereas pragmatically they relate what is said in discourse to its context, that of the listener included», oppure la definizione proposta dalla stessa Kroon, Discourse Particles in Latin, op. cit., p. 35: «particles are those invariable words which have in common that they fit their host unit into a wider perspective, which may be the surrounding verbal context and its implications, or the communicative situation in which the text is integrated».
11 In particolare, DigilibLT (<URL: digiliblt.lett.unipmn.it/>) non soltanto offre ora la possibilità di incorporare nello studio numerosi testi che prima non era possibile controllare attraverso strumenti digitali, permettendo quindi di arricchirlo, ma soprattutto, grazie al taglio cronologico del corpus di testi che lo forma, consente di estrarre dati significativi sul Latino di epoca tardoantica come forse non è mai stato possibile fare finora.
36 DAVID PANIAGUA
L’ottima descrizione funzionale dei segnali discorsivi formulata da Kroon12 può essere riassunta (per quanto, nel riassumere, se ne perda sicuramente gran parte della ricchezza) come segue,
presentational ‘connective’*
interactional‘situating’**
interactional‘connective’
causal / consecutive nam, igitur enim ergo
adversative autem uero at
* Presentational particles: segnali che servono al proposito di presentare e organizzare l’informazione del discorso. Concantenano due sequenze di informazione di dimensioni variabili.
** Interactional particles: segnali che servono a interagire pragmaticamente con il letto-re. Fungono da strumento nel processo di interazione scritto-re/lettore.
Nam. Significato basico (Basic meaning*): sussidiarietà. Effetti collaterali (Side-effects**): causalità, avversatività, affermazione.
Enim. Significato basico: consenso. Effetti collaterali: causalità, rinforzamento, focalizzazione, avversatività lieve, risultato.
Autem. Significato basico: discontinuità tematica. Effetti collaterali: rafforzamento dell’intenzione illocutiva del parlante, avversatività, causalità.
Vero. Significato basico: realtà, verità. Effetti collaterali: connessione avversativa, indicazione dell’organizzazione del testo, enfasi.
Igitur. Significato basico: transizione a un nuovo evento importante nella strutturazione sequenziale delle idee, dopo l’adempimento nel contesto prece- dente di una condizione necessaria.
12 Kroon, Discourse Particles in Latin, op. cit.; C. Kroon, Discourse particles, tense, and the structure of Latin narrative texts, in Latin in use, ed. by R. Risselada, Amsterdam 1998, pp. 37-62; C. Kroon, A framework for the description of Latin discourse markers, Journal of Pragmatics 30 (1998), pp. 205-223.
SUI VALORI DI NAM NELL’ADBREVIATVS LIBER DI CEZIO FAVENTINO 37
Ergo. Marca unità testuali che, sulla base del contesto virtualmente conosciuto, han-no una funzione di ‘monitoraggio’ nel discorso. Espande il discorso per evitare un potenziale malinteso del lettore oppure fornisce una ricapitolazione di eventi precedenti nel senso di adempimento dell’attesa del lettore.
At. Significato basico: discontinuità tematica, quando l’autore vuole presentare nuovi contenuti che sono sorprendenti o contrari alle attese del lettore.
* Basic meaning: «funzione basica individuale, nettamente definita», «tratto distintivo».** Side-effects: «concetto unificatore per una molteplicità variegata di usi»
A proposito di questa teoria, sono stati segnalati due limiti non del tutto in-dipendenti fra di loro:
1) il limite relativo alle tipologie dei testi considerati: un corpus formato sostanzialmente da Plauto e Terenzio, Cicerone, parte degli storici classici, Petronio e il Seneca delle Lettere a Lucilio13;
2) l’assenza di un campione di testi sufficientemente largo, che permetta di sviluppare una descrizione dei fenomeni in chiave più decisamente diacronica.
Rosén14, cosciente della limitazione dell’approccio di Kroon15, ha incorporato in una recentissima revisione dell’argomento il testo della Lex XII Tabularum, Ennio e Catone, per quanto riguarda il margine cronologico inferiore, e le Res Gestae di Ammiano Marcellino e la Peregrinatio Egeriae, nel margine cronolo-gico superiore. L’allargamento (e non soltanto in diacronia, ma anche in sin-cronia16) del corpus di testi impiegato da Rosén nella sua analisi comporta di
13 Kroon, Discourse Particles in Latin, op. cit., p. 3: «The research... is based on Latin literary texts from about 200 BC to about 200 AD, with special reference to Latin comedy (Plautus and Terence), the complete works of Cicero (letters, orations, philosophical discussions, rhetoric), historiography (notably Caesar, Sallust, Livy, Curtius and Tacitus), the ‘novel’ Satyricon by Petronius and Seneca’s Letters to Lucilius».
14 Rosén, Coherence, art. cit.15 In un lavoro pioneristico come quello di Kroon i limiti precedentemente accennati, riferiti
al piano intensivo-sincronico (quantità di testi studiati del periodo prescelto) ed estensivo-diacronico (allargamento dei margini cronologici), sono perfettamente comprensibili. Quindi, la segnalazione di tali limiti, lungi dall’essere una critica allo studio di Kroon, mira piuttosto ad indicare in quale direzione dovrebbe essere implementato il suo fecondo studio al proposito di raggiungere risultati sempre più completi. D’altronde è anche naturale che l’allargamento del corpus di testi studiati debba comportare l’individuazione di nuovi tratti meno sporgenti, talvolta poco frequenti o specifici di certe epoche, op-pure caratteristici di certe tradizioni testuali particolari.
16 In aggiunta all’incorporazione dei testi arcaici e dei testi tardoantichi appena menzionati, Ro-sén allarga anche il corpus di testi latini del periodo compreso fra il I a.C e il I d.C. mediante l’aggiunta dei poeti Catullo, Virgilio, Orazio, e dei prosatori Quintiliano e Plinio il Giovane.
38 DAVID PANIAGUA
certo un arricchimento della prospettiva, rispetto allo studio di base di Kroon. È senz’altro un importante passo avanti. Ma è anche vero che i campioni impiegati per l’analisi del Latino tardo, vale a dire l’opera di Ammiano Mar-cellino e la Peregrinatio, costituiscono un banco di prova parziale e limitato. L’incorporazione di nuovi testi tardoantichi dovrà recare sicuramente ulteriori spunti di interesse.
Anche Langslow17 ha applicato con buoni risultati questo modello funzionale di analisi ai testi medici latini, superando in questo modo le limi-tazioni tipologiche e cronologiche dei testi studiati da Kroon e aggiungendo un fattore di grande interesse nella ricerca, perché in effetti – è lui stesso a dichiararlo – il discorso caratteristicamente semplice e razionale dei testi tecnici è particolarmente adatto a indagini linguistiche di questa natura. Ma forse il contributo più prezioso di Langslow è stato il livello di esaustività nell’analisi applicato allo studio, che ha dimostrato la necessità di una disamina minuziosa, quasi chirurgica, dei singoli usi dei segnali per raggiungere una descrizione funzionale davvero pienamente affidabile.
In questa prospettiva, lo scopo del presente contributo non è dunque altro che quello di allargare ancora di più l’universo di testi studiati finora, incorporando alla considerazione l’opuscolo di Cezio Faventino, un testo che si trova sicuramente oltre i limiti cronologici dello splendido studio di Kroon e che, per di più, in quanto testo tecnico, fornisce un altro esempio del discorso semplice e razionale di questo tipo di testi. Per di più, il caso di Faventino ha un valore aggiunto: la stretta e continua dipendenza del testo di Faventino dal De architectura di Vitruvio, che viene utilizzato come fonte dall’autore, procura un punto di riferimento su cui misurare in dettaglio le formulazioni dell’Adbreuiatus liber. In particolare, il caso di studio che ospitano queste pagine è circoscritto all’uso di nam in quest’opera. Il numero relativamente basso di occorrenze del termine permetterà di raggiungere quel livello di dettaglio che lo studio di Langslow ha rilevato ormai irrinunciabile.
2. Cezio Faventino
Prima di passare alla disamina delle singole occorrenze di nam nell’opera di Faventino, sarà forse opportuno fare un brevissimo cenno alla posizione di questo autore poco conosciuto e della sua opera nella storia della letteratura e della cultura latina.
Uno dei pregi del progetto DigilibLT è la volontà di offrire agli utenti del sito web non soltanto i preziosi testi tardo-latini in edizione elettronica in formato XML ma anche delle schede introduttive relative ai singoli autori e
17 D. Langslow, Latin discourse particles, “Medical Latin” and “Classical Latin”, Mnemosyne 53 (2000), pp. 537-560.
SUI VALORI DI NAM NELL’ADBREVIATVS LIBER DI CEZIO FAVENTINO 39
alle singole opere ivi compresi. Le schede riguardanti lo scrittore latino Cezio Faventino e la sua opera, Artis architectonicae priuatis usibus adbreuiatus liber, forniscono un buon inquadramento generale. Perciò qui mi permetterò di combinare le informazione fornite dal sito DigilibLT nelle schede relative all’autore e all’opera18.
Marco Cezio Faventino è probabilmente databile nel III secolo d.C., sebbene i margini cronologici oggettivi per la sua datazione presentino come terminus post quem Vitruvio, la cui opera De architectura è utilizzata come fonte da Cezio, e come terminus ante quem Palladio, che, a sua volta, utilizza l’opera di Faventino.
Faventino compose un compendio di architettura, trasmessoci sotto tre titoli diversi: Artis architectonicae priuatis usibus adbreuiatus liber, Capitula artis architectonicae de diuersis fabricis e De diuersis fabricis architectonicae, di cui il primo è quello generalmente recepito dagli studiosi.
L’opera è stata costruita sostanzialmente come una rielaborazione abbreviata della fonte principale, il De architectura di Vitruvio, di cui risulta pressoché una versione epitomata. Il compendio si apre con una prefazione in cui Cezio Faventino spiega le motivazioni che l’hanno spinto a comporre la sua opera, presenta le conoscenze teoriche generali sull’ars aedificandi (1-2) e poi offre le indicazioni opportune relative all’acqua (3-7), ai materiali di costruzione (8-12), ai diversi tipi di costruzione (13-17), ai lavori di rifi-nitura e di ritocco (18-27) e agli strumenti di misurazione (28-29). Sulla fortuna antica dell’opera, basterà dire che essa fu impiegata direttamente da Palladio nella stesura del suo Opus agriculturae e da Isidoro di Siviglia nei libri XVII e XIX delle Etymologiae, anche se nessuno dei due dichiara espli-citamente la fonte.
3. La descrizione funzionale di nam
È già stato segnalato precedentemente che lo studio di Kroon sui segnali di-scorsivi nei testi narrativi aveva prodotto una descrizione di nam come «pre-sentational particle», vale a dire come segnale che serve a presentare e organiz-zare l’informazione del discorso, concatenando due sequenze di informazione di dimensioni variabili a livello sovra-proposizionale. Il comportamento para-digmatico di nam prevede la transizione dalla linea argomentativa principale a qualche elemento sussidiario, che viene introdotto allo scopo di aggiungere qualche spiegazione o qualche chiarimento alla formulazione precedente. Per l’appunto questa funzione di sussidiarietà troverebbe corrispondenza prototi-
18 URL: http://digiliblt.lett.unipmn.it/opera.php?gruppo=opere&iniziale=all&id=dlt000084 (15/08/2013). Entrambe le schede di DigilibLT, come anche l’edizione digitale del testo di Faventino, sono state elaborate da D. Paniagua.
40 DAVID PANIAGUA
picamente nell’impiego di forme verbali nei tempi secondari come l’imperfet-to o il piuccheperfetto19, sebbene, come ha messo in rilievo Kroon20, la ten-denza di un tale predominio dei tempi secondari non sempre trovi riscontro nei testi.
La distribuzione dei valori semantico-pragmatici di Kroon (sussidiarietà come valore centrale, con degli effetti collaterali in forma di causalità, avversatività, affermazione) trova però alcuni ostacoli, come ha segnalato Langslow per i testi medici. Sulla scia dei risultati ottenuti da Langslow, anche Rosén ha indicato come (certi) testi tecnici si comportino in un modo un po’ diverso in confronto con i testi studiati da Kroon21.
Un esempio palese di questo diverso comportamento si pone quando viene considerata la distribuzione quantitativa22 di nam e di enim nella tradi-zione agronomica: 23
Catone De agricultura
varrone Res rusticae
Columella23
Res rustica
Nam 12 48 654
Enim 0 222 231
Quindi, probabilmente, come dice Rosén24, nell’uso di nam/enim all’interno dei testi agronomici menzionati sono coinvolti anche fattori di tipo stilistico e forse cronologici. Eppure il solo confronto relativo di cifre non può essere mai sufficiente.
Nel caso di Faventino25, uno dei tratti definitori della sua opera è quello di essere stata costruita nella sua maggior parte con dei mattoni preesistenti, presi direttamente e senza grande rielaborazione formale dal De architectura
19 E. Tarriño, Adverbios y partículas, in Sintaxis del latín clásico, coord. J.M. Baños Baños, Madrid 2009, p. 371.
20 Kroon, Discourse particles, tense, and the structure, art. cit., pp. 52 e 57-60.21 Rosén, Coherence, art. cit., p. 401 «... within one and the same genre – and presumably register
– in the TECHNICAL language of household and medical manuals, the use of enim and nam sharply diverges».
22 La ricerca per i testi classici è stata eseguita sul database CLCLT di Brepols. L’utente di questo database è consapevole della necessità di distinguere fra hits e occorrenze del termine ricercato. Il nume-ro di hits non è sempre pari al numero di occorrenze; qualora due occorrenze del termine compaiano in posizione ravvicinata il database presenta un solo testo con le due occorrenze evidenziate, ma il tutto è considerato come un solo hit.
23 Sfortunatamente, il database CLCLT di Brepols non dispone della recentissima edizione critica della Res rustica curata da Rodgers, per cui le occorrenze registrate potrebbero non corrispondere perfet-tamente al nuovo testo oxoniense di Columella. In ogni caso, è presumibile che l’eventuale variazione sia di entità minima.
24 Rosén, Coherence, art. cit., p. 401, che non considera la distribuzione di nam /enim nell’opera di Columella, ma soltanto in Catone e Varrone.
25 Edizione di riferimento, M.-Th. Cam, M. Cetius Faventinus, Abrégé d’architecture privée, texte établi, traduit et commenté, Paris 2001 (Collection des Universités de France).
SUI VALORI DI NAM NELL’ADBREVIATVS LIBER DI CEZIO FAVENTINO 41
di Vitruvio. Il confronto generale nell’uso dei segnali discorsivi in entrambe le opere offre, anche a prima vista, dei risultati notevoli, specie quando si tratta non soltanto di un’impostazione e di un contenuto simile, ma addirittura spesso dello stesso testo riproposto ipsis uerbis:
vitruvio Cezio Faventino
Nam 20 13
Enim 210 29
Igitur 34 0
Ergo 79 29
Autem 713 42
Vero 153 14
At 14 0
Le cifre del quadro acquistano un senso più completo se si prende atto che l’opera di Vitruvio è, più o meno, dieci volte più estesa di quella di Faventi-no26. Una tale percentuale potrebbe grosso modo spiegare le corrispondenze relative fra l’uso di enim (210/29), uero (153/14), e forse anche di autem (713/42), ma non è in grado di dare una spiegazione al fatto che Faventino non impieghi mai né igitur né at. Lo stesso vale anche per quanto riguarda il fatto che la percentuale di uso di nam di Faventino sia enormemente elevata rispetto all’indice di uso dello stesso segnale discorsivo nell’opera di Vitruvio, con cui sicuramente non mantiene il rapporto di proporzionalità esistente nel caso di enim, uero e, forse anche, autem. Naturalmente non si possono estra-polare in modo avventato le cifre in una diretta regola aritmetica; bisogna aver presente che il testo di Vitruvio contiene ben dieci prefazioni, mentre il testo di Faventino ne ha una sola, e questo può spiegare alcune di queste anomalie. Ma in ogni caso su questo particolare occorrerebbe ancora uno studio più approfondito.
Comunque sia, questa apparentemente anormale prossimità quantitativa nell’uso di nam fra Vitruvio e Cezio Faventino non fa altro che enfatizzare l’importanza che Faventino attribuisce a questo segnale discorsivo. Tale parti-colarità accresce la pertinenza dello studio particolareggiato dell’uso di nam nell’Adbreuiatus liber.
26 Il testo di Vitruvio è composto approssimativamente da ± 58.000 parole (occurrences), mentre quello di Faventino da ± 5.500. Le cifre relative al testo di Vitruvio sono quelle fornite nelle statistiche da Intratext, URL: http://www.intratext.com/y/LAT0188.HTM; quelle relative a Faventino sono state ottenute con un conteggio automatico del testo elettronico fornito da DigilibLT, URL: http://digiliblt.lett.unipmn.it/xtf/view?docId=dlt000084/ dlt000084.xml;query=faventinus;brand=default.
42 DAVID PANIAGUA
4. Faventino e nam
Nel liber di Faventino ci sono 13 occorrenze27 di questo segnale discorsivo, ri-conducibili a diverse tipologie semantico-relazionali, che passeremo in rasse-gna qui di seguito.
4.1. Nam come sviluppo di un elemento della proposizione precedente: dal valore esplicativo al valore causale (= quod)
In un primo gruppo rientrano quelle occorrenze di nam in cui il segnale di-scorsivo si comporta nel modo ‘convenzionale’, ossia marcando la transizione dalla linea argomentativa principale a qualche elemento sussidiario. Come è stato indicato prima, questa transizione ha lo scopo di aggiungere qualche chiarimento relativo all’informazione fornita nella formulazione precedente; un chiarimento che può assumere un gamma di possibilità semantiche che va dalla spiegazione fino all’espressione della causalità, con un ampio territo-rio intermedio dove è difficile distinguere una frontiera nitida fra queste due possibilità.
In linea di massima, almeno per quanto riguarda l’usus di Faventino, pare che quando nam cerca di espandere un singolo elemento della formulazione precedente, ne prevalga un valore più nettamente esplicativo, mentre invece quando intende chiarire l’insieme dell’informazione presentata nella formulazione precedente, ci sia una tendenza più decisamente causale nella semantica di nam. Inoltre, la presenza di modalità deontiche nella formulazione principale contribuisce nettamente a rinforzare un valore sussidiario causale di nam, fino al punto di favorire situazioni in cui nam sarebbe sostituibile con una congiunzione causale come quod.
(1) Omnia enim pulchro decore ac uenusta utilitate fieri poterunt si ante huius artis peritus ordo discatur. Nam architecturae partes sunt octo, quae sunt ordinatio, dispositio, uenustas, mensura, distributio, aedificatio, conlocatio, machinatio (I 1).
(2) Ex his Graeci quinque uocabulis studium architecturae esse docuerunt. Nam ordinationem tavxin, dispositionem diavqesin, uenustatem et decorem eujruqmivan, modulorum mensuras summetrivan, distributionem oijkonomivan appellauerunt (I 1).
Nel testo (1) lo scopo di nam è quello di espandere l’ordo peritus (huius artis) che Faventino propone come condizione per fieri omnia pulchro decore et uenusta utilitate. Una volta formulata la premessa, l’autore ritiene necessario comple-
27 Esiste un quattordicesimo nam nell’opera di Faventino, al paragrafo XXIII, che però è stato espunto dal testo e che, di conseguenza, non entrerà nella presente considerazione: Obseruandum tamen erit ne gypsum impensae adiungatur. Siticulosa enim materia, dum cito arescit, uicinum coronarium opus, politionibus parietum et camerarum <cum> superinducitur, [nam] corrumpit. L’espunzione risale a Krohn (F. Krohn, Vitruvii De Architectura Libri Decem, Leipzig 1912), che espungeva anche corrumpit. L’inter-vento critico su nam è stato poi accolto anche da Cam.
SUI VALORI DI NAM NELL’ADBREVIATVS LIBER DI CEZIO FAVENTINO 43
tare l’informazione spiegando quale sia quell’ordo peritus artis a cui ha fatto cenno e lo farà enumerando gli otto elementi che lo costituiscono: ordinatio, dispositio, uenustas, ecc.
Lo stesso vale per il testo (2), dove la proposizione introdotta da nam rap-presenta un’informazione sussidiaria rispetto alla formulazione precedente. In effetti, dopo aver dichiarato che l’insegnamento dell’architettura fra i Greci era fondato su cinque elementi, l’autore va un passo oltre ed enumera i quinque uocabula in greco appena menzionati (tavxin, diavqesin, eujruqmivan, summe-trivan, oijkonomivan), e per di più spiega le equivalenze latine di questi termini.
Nei due casi nam espande un elemento informativo della proposizione anteriore (ordo; quinque uocabula) in modo tale da spiegarne i singoli elementi costitutivi. In questo modo non delude l’attesa del lettore, che vede una spiegazione in dettaglio degli elementi sottolineati dall’autore.
(3) Fit etiam in uno horologio duplex elegantiae subtilitas. Nam dextra ac sinistra extrinsecus in lateribus eius quinae lineae directae notantur, et ternae partes circu-lorum aequali interuallo sic fiunt ut una proxima sit angulis posterioribus, ubi stili ponentur qui umbra sua horas designent, altera mediam planitiem detineat, tertia prope oram contingat. Has enim partes circulorum hieme, uere et aestate, sic ut interius, gnomonis umbra sequitur... (XXIX 4).
(4) Legitur etiam horas sic comparari debere: primam, sextam, septimam et duodeci-mam uno spatio mensuraque disponendas; secundam, quintam, octauam et undeci-mam pari aequalitate ordinandas; tertiam, quartam, nonam <et decimam> simili ratione edendas. Est et alia de modo et mensuris horarum comparatio, quam prolixitatis causa praetereundam aestimaui, quoniam haec diligentia ad paucos prudentes perti-net. Nam omnes fere, sicut supra memoratum est, quota sit solum requirunt (XXIX 4).
Nel testo (3) nam ha come funzione quella di spiegare nel dettaglio in che cosa consista esattamente la duplex elegantiae subtilitas dello horologium. Di-fatti, nam avvia la descrizione precisa di come veniva disegnato questo parti-colare tipo di orologio, definito subsidiary dial da Pattenden (1979, p. 208). Quindi in questo caso nam sviluppa la proposizione completa per spiegare il modo in cui si produce quella duplex subtilitas.
Nel testo (4) il segnale nam introduce una proposizione che svolge una funzione sussidiaria rispetto alla subordinata causale quoniam haec diligentia ad paucos prudentes pertinet. Nam viene a ribadire la validità dell’affermazione precedente, attraverso una riformulazione del contenuto espresso nella causale. Spiega come, in effetti, la grande maggioranza delle persone sia unicamente interessata a conoscere quale sia l’ora, e non quale sia tutto il sistema geometrico di distribuzione delle ore nell’area dell’orologio. In questo modo, attraverso un’espansione della causale, viene rinforzata la giustificazione di Faventino per aver omesso (pretereundam existimaui) il secondo sistema di distribuzione delle ore nell’orologio.
44 DAVID PANIAGUA
(5) Latericii parietes tribus inductionibus prius solidentur, ut opus tectorium sine uitio accipiant. Nam, si recentes structurae et inductiones fuerint et non ante sic-cauerint, cum arescere coeperint, scissuris uenustatem operis corrumpent (XI 1).
(6) Sed fossiciae recentes statim in structuras mitti debent; fortius enim com-prehendunt caementa. Nam, si sub sole diutius fuerint aut imbribus pruinisque solutae, et terrosae et euanidae fiunt (VIII 10).
In (5) e (6) le proposizioni introdotte da nam offrono la spiegazione/causa che giustifica le prescrizioni date nella proposizione precedente e quindi sono, in qualche misura, condizionate dalle modalità deontiche ivi espresse (soliden-tur; mitti debent). Nel testo (6) nam riprende, naturalmente, la formulazione principale «fossiciae recentes statim in structuras mitti debent» come si evince dalla contrapposizione esplicita recentes /si diutius. La spiegazione dell’istruzio-ne formulata diventa una giustificazione dell’istruzione stessa, cioè il motivo che giustifica la necessità di eseguire l’istruzione come prescritto, e quindi in certo modo offre risposta a una implicita domanda «cur?».
In termini molto simili possono essere definiti i testi (7-9).
(7) Hiberna ergo triclinia hibernum occidentem spectare debent, quoniam uesper-tino lumine opus est. Nam sol occidens non solum inluminat, sed pro ui caloris tepidas facit regiones (XIV 1).
Nel testo (7) nam funziona come nesso causale dopo quoniam (cioè risponde a «cur?»). Il passo di Vitruvio utilizzato come fonte da Faventino dimostra come egli abbia scelto consapevolmente il segnale nam per esprimere una considerazione che nel testo vitruviano si presentava semplicemente come causa, introdotta da un praeterea quod. Lo scopo del testo è spiegare perché sia necessario orientare i triclinia hiberna, cioè le sale da pranzo dove si mangiava in inverno, verso l’ovest.
Hiberna triclinia et balnearia uti occidentem hibernum spectent, ideo quod uesper-tino lumine opus est uti, praeterea quod etiam sol occidens aduersus habens splen-dorem, calorem remittens efficit uespertino tempore regionem tepidiorem (Vitr. VI 4, 1).
Quindi, la struttura ideo quod... praeterea quod... di Vitruvio, con due subor-dinate causali, è riformulata da Faventino attraverso l’uso di quoniam... nam..., dove nam non sarebbe altro che una forma equivalente al praeterea quod vitruviano.
Un uso simile si trova nelle frasi successive del capitolo XIV del liber di Fa-ventino, nel testo (8),
SUI VALORI DI NAM NELL’ADBREVIATVS LIBER DI CEZIO FAVENTINO 45
(8) Cubicula et bibliothecae ad orientem spectare debent; usus enim matutinum postu-lat lumen. Nam quaecumque loca Africum spectant umore uitiantur, quoniam uenti umidi spirantes madidos flatus omnia pallore corrumpunt (XIV 1).
ma in questo caso nam riprende l’uso dello stesso segnale discorsivo da parte di Vitruvio, che dice:
Cubicula et bybliothecae ad orientem spectare debent; usus enim matutinum postulat lumen, item in bybliothecis libri non putrescent. Nam quaecumque ad meridiem et occidentem spectant, ab tiniis et umore libri uitiantur, quod uenti umidi aduenientes procreant eas et alunt infundentesque umidos spiritus pallore uolumina conrumpunt (Vitr. VI 4, 1).
Faventino ha adoperato il testo vitruviano senza introdurre modifiche sostan-ziali. Ha soppresso l’allusione alla putrefazione dei libri, qualora le biblioteche fossero orientate in un senso diverso, e al tarlo, ma per il resto la ripresa del-la formulazione vitruviana è pressoché letterale. Quindi Faventino mantiene l’uso di nam e solo nel caso del quod causale opera una variazione sinonimica mediante l’introduzione del nesso quoniam. Difatti, non è avventato pensare che la sostituzione quod > nam del testo (7) possa essere stata condizionata (e giustificata) in certa misura da questo passo vitruviano, dove una simile relazione semantica viene espressa non attraverso quod, bensì attraverso nam.
(9) Item danda est opera ne axes quercei cum aesculis commisceantur. Nam quercus, cum accepto umore siccescere coeperit, arcuatur et limas inutiles operi efficiet, aesculus diligenter composite ad perpetuitatem durabit (XIX 1).
Il testo (9) di Faventino presenta le stesse caratteristiche dei testi (7) e (8). In esso, Faventino riprende il testo vitruviano quasi ad litteram e questo permette di individuare indubbiamente il valore dato a nam come causale, cioè come forma alternativa al quod causale della fonte:
Item danda est opera ne commisceantur axes aesculini quercu, quod quercei simul umo-rem perceperunt se torquentes rimas faciunt in pauimentis (Vitr. VII 1, 2).
Si tratta, di conseguenza, di un altro caso di sostituzione quod > nam senza modificare l’espressione semantica causale.
4.2. Nam come segnale di transizione tematica (= autem)
Molto più interessante risulta invece il valore assunto da nam nell’opera di Fa-ventino come marcatore di transizione tematica, con un valore equivalente a quello di autem. Il valore di transizione tematica di nam era stato segnalato da Kroon, che però asseriva che autem e nam come segnali di transizione tema-
46 DAVID PANIAGUA
tica sarebbero associati a diverse funzioni discorsive primarie: nam servirebbe a stabilire una transizione sussidiaria dipendente da un elemento tematico centrale, mentre autem non avrebbe questo valore di sussidiarietà28, bensì di continuazione neutrale del discorso. Ma nei due casi in cui un nam di Faven-tino riproduce specularmente la presenza di autem nel testo vitruviano pare che non venga rispettata questa distinzione teorica:
(10) Cedrus, si umore non corrumpatur, eandem habet uirtutem (sc. cupressi et pini). Sed quomodo de pino resina decurrit, sic et ex ea oleum, quod cedria dicitur. Si libri aut clusa ex eo inungantur, numquam tineis aut carie soluentur. Multis ita-que templis propter aeternitatem ex ea lacunaria sunt facta. Nam folia eius cupresso similia sunt. Nascitur maxime in Creta et in Africa et in Syriae regionibus (XII 2).
(11) Glebae itaque, cum ex metallis primum exciduntur, argenti uiui guttas expri-munt, quas artifices ad plures usus colligunt. Neque enim argentum neque aes sine his inaurari potest. Nam confusae in unum ita ut quattuor sextariorum mensuram habeant, centum librarum pondus efficient (XXVII 6).
Nel testo (10) l’informazione sulle foglie del cedro introdotta da nam sembre-rebbe, a prima vista, in qualche modo collegata all’informazione precedente sul-la cedria (l’olio del cedro) e sulle sue proprietà per conservare il legno dal tarlo e dalla putrefazione. Invece nam introduce una nuova notizia relativa al cedro, del tutto indipendente dalla considerazione precedente. Il testo base di Vitruvio fornisce la chiave per intendere la relazione strutturale fra le diverse notizie:
Item cedrus et iuniperus easdem habent uirtutes et utilitates (sc. cupressi et pinus), sed quemadmodum ex cupresso et pinu resina, ex cedro oleum quod cedreum dici-tur nascitur, quo reliquae res cum sunt unctae, uti etiam libri, a tineis et carie non laeduntur. Arboris autem eius sunt similes cupresseae foliaturae, materies uena di-recta. Ephesi in aede simulacrum Dianae, etiam lacunaria et ibi in ceteris nobilibus fanis propter aeternitatem sunt facta. Nascuntur autem eae arbores maxime Cretae et Africae et nonnullis Syriae regionibus (Vitr. II 9, 13).
All’interno dell’esposizione relativa alla cedrus, Vitruvio costruisce la notizia sulla base di quattro nuclei di informazione:
28 Kroon, Discourse Particles in Latin, op. cit., p. 162: «... this shared use of autem and nam as markers of thematic transitions is associated with essentially different primary discourse functions. Nam pertains primarily to central – subsidiary relations between communicative units – [...] it is not surpri-sing that nam, in some of its occurrences, appears to be used as a text-organizational marker of thematic breaks. This happens at the introduction of a new, subsidiary move. Autem… is connected exclusively with thematic units, irrespective of the communicative organization of the discourse. The primary discourse function of autem can hence be described as purely text organizational: it involves a neutral continuation of the discourse, without the connotation of subsidiarity (afterthought, supplementation) that is characteristic of nam».
SUI VALORI DI NAM NELL’ADBREVIATVS LIBER DI CEZIO FAVENTINO 47
1a. considerazione generale sulla similitudine della cedrus con la cupres-sus e la pinus,
1b. caratteristica distintiva della cedrus nel fatto che non ha resina ma un olio denominato cedreum/cedria, che ha delle utilità pratiche contro il tarlo e la putrefazione,
2. caratteristiche delle foglie della cedrus,3. utilizzo del legno della cedrus in templi per la sua straordinaria
durata,4. regioni in cui si trova la cedrus.
Nel testo vitruviano la transizione dal primo al secondo nucleo e dal terzo al quarto viene marcata dall’uso di autem e in questo modo la mappatura del rapporto fra la prima notizia e la seconda è perfettamente chiara per il lettore.
Faventino, dal canto suo, ha modificato la struttura della notizia sulla cedrus. Il primo nucleo d’informazione è conservato in prima sede, ma poi è anticipato il terzo elemento del testo vitruviano (che era semplicemente giustapposto al secondo, senza una chiaro rapporto logico con esso) e viene espresso il rapporto di coerenza discorsiva con l’informazione relativa al cedreum/cedria attraverso l’impiego del segnale itaque. Quindi Faventino sta-bilisce che il terzo nucleo di informazione del testo vitruviano è in qualche modo conseguenza del primo nucleo, vale a dire, che l’utilizzo del legno della cedrus per l’elaborazione dei lacunaria di molti templi è dovuto al fatto della presenza in esso del cedreum/cedria. La stessa protezione conferita dal cedreum/cedria ai libri contro il tarlo e contro la putrefazione è applicata im-plicitamente al legno, che viene quindi impiegato nei soffitti a cassettoni propter aeternitatem. Questo rapporto logico non trova riscontro nel testo di Vitruvio, che offre le notizie sulle proprietà del cedreum e sull’impiego del legno come materiale di costruzione del simulacrum Dianae e dei lacunaria come informazioni indipendenti senza collegamento apparente fra di loro.
La reinterpretazione del testo vitruviano eseguita da Faventino mantiene sempre i quattro nuclei di informazione del testo base; ma oltra alla riformu-lazione logica dei nuclei 1 e 3, essa implica anche l’introduzione di nam al posto dell’autem che marca la transizione dal nucleo 1 al nucleo 2, e la cancellazione dell’autem che marca la transizione dal nucleo 3 al nucleo 4. Quindi, nam viene qui usato per esprimere una transizione tematica non sussidiaria, con lo stesso valore dell’autem di Vitruvio.
La stessa cosa accade nel testo (11), dove Faventino segue da vicino la scia del testo vitruviano. In VII 8, 1-4, all’interno della sezione dedicata all’esposizio-ne dei colori, Vitruvio spiega il modo di elaborazione del minium, le rationes minii. Ecco il testo del De architectura:
Foditur enim glaeba quae dicitur, antequam tractationibus ad minium perueniant, uena uti ferrum, magis subrufo colore, habens circa se rubrum puluerem. cum id foditur, ex plagis ferramentorum crebras emittit lacrimas argenti uiui, quae a
48 DAVID PANIAGUA
fossoribus statim colliguntur. hae glaebae, cum collectae sunt, in officina propter umoris plenitatem coiciuntur in fornacem, ut interarescant, et is qui ex his ab ignis uapore fumus suscitatur, cum resedit in solum furni, inuenitur esse argentum uiu-um. exemptis glaebis guttae eae, quae residebunt, propter breuitates non possunt colligi, sed in uas aquae conuerruntur et ibi inter se congruunt et una confundun-tur. id autem cum sint quattuor sextariorum mensurae, cum expenduntur, inue-nientur esse pondo centum. cum in aliquo uase est confusum, si supra id lapideum centenarium pondus inponatur, natat in summo neque eum liquorem potest onere suo premere nec elidere nec dissipare. centenario sublato si ibi auri scripulum inpo-natur, non natabit, sed ad imum per se deprimetur. ita non amplitudine ponderis sed genere singularum rerum grauitatem esse non est negandum. id autem multis rebus est ad usum expeditum. neque enim argentum neque aes sine eo potest recte inaurari (Vitr. VII 8, 1-4).
La prima informazione di Vitruvio riguarda il trasudare di gocce di argentum uiuum quando le glebae vengono colpite con gli strumenti impiegati per l’e-strazione. Parimenti, quando le glebae vengono depositate nelle fornaci allo scopo di prosciugarne la umoris plenitas, i vapori esalati, una volta temperati e posati sulla superficie delle fornaci, diventano piccolissime gocce di mercurio (argentum uiuum), che saranno raccolte in un recipiente dove si accorperanno in unum. Un secondo nucleo di informazione relativo alla densità e, quindi, al peso specifico del prodotto è introdotto da Vitruvio attraverso il segnale discorsivo autem; in effetti, quattro sestarii della sostanza hanno un peso di cento libbre e, se ci si posa sopra una pietra di cento libbre, essa galleggia, mentre invece un solo scripulum di oro affonda – dimostrazione del fatto che la densità dei corpi è più importante dei pesi stessi. Infine, Vitruvio introdu-ce un terzo nucleo di informazione, ancora annunciato da un altro autem. Questo terzo nucleo riguarda le diverse utilità pratiche del mercurio, tra le quali viene messa in primo piano la necessità di questo elemento per dorare l’argento e il rame.
Partendo da questo testo, Faventino costruisce la sua notizia relativa al minium nella sezione parallela sui colori. In pratica, Faventino fonde la prima e la terza informazione del testo Vitruvio, prescindendo dai dettagli nella spie-gazione del processo che serve ad ottenere le gocce di mercurio. Quindi mette in rapporto diretto l’estrazione del mercurio (argenti uiui guttas exprimunt) con i diversi usi che gli vengono dati, tra i quali sottolinea sempre la doratura dell’argento e del rame. Il secondo nucleo di informazione vitruviano, invece, viene inserito da Faventino senza soluzione di continuità attraverso un quasi incomprensibile nam al posto del vitruviano autem. Si produce, dunque, una transizione tematica all’interno della cornice generale relativa al minium, in cui però le particolari caratteristiche della densità e del peso del mercurio non si capiscono perché Faventino ha tagliato la premessa. In ogni caso, come succedeva nel testo (8), Faventino ha impiegato nam in una posizione (e in un rapporto logico-argomentativo) in cui Vitruvio impiegava autem.
SUI VALORI DI NAM NELL’ADBREVIATVS LIBER DI CEZIO FAVENTINO 49
4.3. Nam (si) come enumeratore
(12) Canaliculus formae iuxta magnitudinem aquae dirigatur. Si planus locus fue-rit, [pede semis] infra caput aquae structura conlocetur et, si longior planitia fuerit, inter centenos uel LX pedes <sicilico> structura submittatur, ut animata aqua non pigro impetu decurrat. Nam si interualla montium fuerint, ad libramentum capitis aquae specus sub terra erit <fodiendus et> structura aut roboreis canalibus aquae ductus componatur. Quodsi concauae uallium demissiones impedient, structura solida uel arcuatili ad libramentum aquae occurratur, aut fistulis plumbeis aut ca-nalibus librate cursus dirigatur. Verum si altior locus fuerit unde aqua ducitur, aliquanto inferius planitia inflexa libretur, ut ueniens aqua fracto impetu lenius de-currat. Quodsi longius de monte ducetur, saepius flexuosas planities facies (VI 2).
Il testo (12) presenta un uso particolare di nam influenzato dalla condizionale che introduce. Si tratta un’enumerazione di possibilità si..., si..., nam si..., quodsi..., uerum si..., quodsi... e quindi pare che qui nam in compagnia di si abbia una funzione come marcatore di un item all’interno di un’enumerazio-ne. Nel testo non è semplice distinguere una sfumatura semantica diversa per nam si rispetto a quelle percepibili nei quodsi. Infatti, nel testo vitruviano l’allusione agli interualla montium come item nell’enumerazione delle diverse possibilità topografiche viene introdotta da quodsi:
Ea autem ductio, quae per fistulas plumbeas est futura, hanc habebit expeditionem. quodsi caput habeat libramenta ad moenia montesque medii non fuerint altiores, ut possint interpellare, sed interualla, necesse est substruere ad libramenta, que-madmodum in riuis et canalibus. sin autem non longa erit circumitio, circumduc-tionibus, sin autem ualles erunt perpetuae, in declinato loco cursus dirigentur. cum uenerint ad imum, non alte substruitur, ut sit libramentum quam longissimum; hoc autem erit uenter, quod Graeci appellant koilian. deinde cum uenerit aduer-sus cliuum, ex longo spatio uentris leniter tumescit, <ut> exprimatur in altitudi-nem summi cliui. quodsi non uenter in uallibus factus fuerit nec substructum ad libram factum, sed geniculus erit, erumpet et dissoluet fistularum commissuras (Vitr. VIII 6, 5-6).
Eppure, nonostante il particolare comportamento di questo nam (si) come marcatore di item all’interno di un’enumerazione, forse non è da trascurare il fatto che ancora una volta Faventino abbia deciso di sostituire un quod vitru-viano (sicuramente diverso dai precedenti, ma sempre e comunque un quod ) attraverso un nam.
4.4. Un nam incomprensibile + una spiegazione del perché lo sia
Il testo (13) contiene un nam che rappresenta una sfida per chiunque voglia avvicinarsi alla notizia di Faventino sulla cerussa e sugli effetti perniciosi del piombo sulla salute umana.
50 DAVID PANIAGUA
(13) Salubrior enim usus tubulorum materia inuenitur. Ex plumbo enim cerussa na-scitur, quae corporibus humanis nociua est. Exemplum autem huius plumbariorum deformitas probat, qui tractando plumbum exsucati sanguine foedo pallore mutan-tur. Nam cum fere omnes exstructas uasorum argenteorum uel aeneorum habeant mensas, tamen propter saporis integritatem fictilibus uasculis utuntur (VI 4).
Il problema fondamentale nel testo deriva dal modo in cui Faventino ha epi-tomato il testo fonte. È, dunque, necessario rileggere il testo di Vitruvio per intendere correttamente la notizia:
habent autem tubulorum ductiones ea commoda. primum in opere quod si quod uitium factum fuerit, quilibet id potest reficere. etiamque multo salubrior est ex tubulis aqua quam per fistulas, quod plumbum uidetur esse ideo uitiosum quod ex eo cerussa nascitur, haec autem dicitur esse nocens corporibus humanis. itaque quod ex eo procreatur <si> id est uitiosum, non est dubium quin ipsum quoque non sit salubre. exemplar autem ab artificibus plumbariis possumus accipere, quod palloribus occupatos habent corporis colores. namque cum fundendo plumbum flatur, uapor ex eo insidens corporis artus et in diem exurens eripit ex membris eorum sanguinis uirtutes. itaque minime fistulis plumbeis aqua duci uidetur, si uolumus eam habere salubrem. saporemque meliorem ex tubulis esse cotidianus potest indicare uictus, quod omnes structas cum habeant uasorum argenteorum mensas, tamen propter saporis integritatem fictilibus utuntur (Vitr. VIII 6, 10).
I tubi fittili, a dire di Vitruvio, sono particolarmente adatti alla conduzione dell’acqua e ciò per due motivi: 1) quando vengono fabbricati, se presentano qualche difetto, possono essere facilmente riparati, 2) sono più salutari che i tubi di piombo, dannosi per motivo della biacca (cerussa). Vitruvio passa poi a dimostrare l’effetto negativo del piombo sulla salute umana attraverso l’esempio palmare dei lavoratori del piombo, che soffrono le dannose conse-guenze di essere continuamente esposti agli effluvi del piombo quando viene riscaldato per essere soffiato. Quindi è sconsigliato l’utilizzo dei tubi di piom-bo per condurre l’acqua destinata al consumo o a qualsiasi altro uso che possa recare effetti negativi sulla salute. Inoltre, aggiunge Vitruvio, l’argilla rende un sapore più gradevole; questo è dimostrato dalla pratica quotidiana, dove sono i recipienti fittili ad essere usati per il cibo, anche quando i tavoli sono colmi di recipienti di argento. Ed è così propter saporis integritatem.
Ma la coerenza lampante dell’esposizione vitruviana scompare nel testo di Faventino. L’inizio enfatizza l’uso salutare dei tubi di argilla, giacché i tubi di piombo hanno il problema della biacca, che è nociva alla salute, come dimo-stra l’esempio dei lavoratori del piombo. Fino a questo punto Faventino segue pedissequamente il testo di Vitruvio, senza difficoltà. Ma una volta compiuta la sintesi della descrizione degli effetti della biacca sui plumbarii, Faventino salta la conclusione di Vitruvio che conferma l’uso preferibile dei tubi fittili (itaque... salubrem) e salta anche la parte iniziale del ragionamento finale, rela-tivo al miglior sapore conferito ai cibi dai recipienti fittili (ex tubulis). Quindi,
SUI VALORI DI NAM NELL’ADBREVIATVS LIBER DI CEZIO FAVENTINO 51
Faventino perde completamente la premessa saporemque meliorem ex tubulis esse cotidianus potest indicare uictus, forse per una svista. Infatti non è da escludere un salto d’occhio mentre leggeva il testo vitruviano, da uirtutes a uictus. Comun-que sia, il risultato è che egli aggiunge l’explicatio ma non l’explicandum, e di conseguenza propone un testo assolutamente incomprensibile.
Ma perfino nel modo di presentare un testo incomprensibile è interessante osservare la dinamica di riformulazione di Faventino: il nesso causale quod è diventato nam, è stato modificato l’ordo uerborum (omnes structas cum habeant uasorum argenteorum mensas > cum fere omnes exstructas uasorum argenteorum uel aeneorum habeant mensas), structas appare come exstructas, omnes è ribassato a fere omnes, e invece uasorum argenteorum è ampliato in uasorum argenteorum uel aeneorum. Di tutte queste modifiche – interessanti allo scopo di rendere più chiara la tecnica epitomatoria di Faventino – quella che interessa qui è, naturalmente, la sostituzione di quod per nam. Una tale sostituzione pare a prima vista sorprendente. Ma se la si guarda con un po’ di prospettiva, dietro la sostituzione quod > nam forse si cela l’intenzione di Faventino di riprodurre il testo di Vitruvio introducendo la stessa variazione quod > nam che aveva già introdotto nei testi (7) e (9), forse anche in (12). Un testo ricostruito ipoteticamente come segue
*<saporemque meliorem ex tubulis esse cotidianus potest indicare uictus,> nam cum fere omnes exstructas uasorum argenteorum uel aeneorum habeant mensas, tamen propter saporis integritatem fictilibus uasculis utuntur,
sarebbe stato del tutto possibile e, in tale caso, il passo sarebbe andato a fare parte dell’elenco di casi di sostituzione quod > nam.
Ma così come è stato conservato il testo di Faventino, il nam non è com-prensibile, dal momento che per qualche motivo è caduto il testo di cui è sussidiaria la formulazione introdotta da nam.
5. A modo di conclusione
Questa rassegna degli usi di nam nell’Adbreuiatus liber di Faventino consente di concludere con qualche osservazione di carattere generale.
L’uso predominante di nam nell’opera (1-9) è conforme al valore seman-tico relazionale principale (basic meaning) di nam nella lingua latina, di sussi-diarietà rispetto a una formulazione precedente sia come forma di espressio-ne di una spiegazione, sia come forma di espressione di una causa, sia come forma di espressione sfumata, a metà strada fra entrambe.
D’altro canto, si trovano anche usi di nam poco frequenti e con tratti singolari nei casi in cui nam marca una relazione semantico-contestuale che nel testo di Vitruvio era invece marcata da autem (10-11). Quindi, in questi
52 DAVID PANIAGUA
casi si verifica un fenomeno di apparente intercambiabilità nam/autem, a meno che il fenomeno possa essere giustificato pensando che Faventino abbia ri-concettualizzato i rapporti semantici fra le informazioni che in Vitruvio sono introdotte da autem e le informazioni precedenti, in modo tale da trasformare questi rapporti semantici non più in una transizione tematica (autem), bensì in una transizione sussidiaria dipendente da un elemento tematico centrale.
Un tratto distintivo della tecnica epitomatoria di Faventino prevede l’eventuale uso di nam per sostituire un quod del testo fonte (7 e 9, forse anche 12), così come anche per riportare autem (10-11). Questa caratteristica della riscrittura vitruviana di Faventino sicuramente spiega l’elevata percentuale di occorrenze di nam nell’Adbreuiatus liber in confronto con il testo vitruviano.
Infine, la disamina delle occorrenze di nam nel manuale di Faventino enfa-tizza un’altra particolarità di cui si deve prendere atto in qualsiasi approccio a un testo latino: la possibilità dell’errore nel testo, talvolta involontario, talvolta dovuto alle vicissitudini della trasmissione, talvolta inspiegabile. Se per un ca-priccio della fortuna il De architectura di Vitruvio non fosse sopravvissuto al setaccio del tempo, oggi non saremmo più in grado di capire esattamente il processo che ha reso possibile la presenza di nam nel passo (13). E, di conse-guenza, lo studioso sarebbe costretto a formulare strane eccezioni di uso per spiegare la sua soltanto apparentemente enigmatica carica semantica.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
M.-Th. Cam, M. Cetius Faventinus, Abrégé d’architecture privée, texte établi, traduit et com-menté, Paris 2001 (Collection des Universités de France).
J. D. Denniston, The Greek Particles, Oxford 19522 (1934). J.J. Fraenkel, A Question in Connection with Greek Particles, Mnemosyne 13 (1947),
pp. 183-201.F. Krohn, Vitruvii De Architectura Libri Decem, Leipzig 1912.C. Kroon, Discourse Particles in Latin. A Study of nam, enim, autem, uero and at, Am-
sterdam 1995.C. Kroon, Discourse particles, tense, and the structure of Latin narrative texts, in Latin in
use, ed. by R. Risselada, Amsterdam 1998, pp. 37-62.C. Kroon, A framework for the description of Latin discourse markers, Journal of Pragma-
tics 30 (1998), pp. 205-223.D. Langslow, Latin discourse particles, “Medical Latin” and “Classical Latin”, Mnemosyne
53 (2000), pp. 537-560.S. Müller, Discourse Markers in Native and Non-native English Discourse, Amsterdam-
Philadelphia 2006.P. Pattenden, Sundials in Cetius Faventinus, Classical Quarterly 29 (1979), pp. 203-212.H. Rosén, Coherence, sentence modification, and sentence-part modification – the contribu-
tion of particles, in New Perspectives on Historical Latin Syntax, Volume 1. Syntax of the Sentence, ed. by Ph. Baldi and P. Cuzzolin, Berlin-New York 2009, pp. 317-441.
SUI VALORI DI NAM NELL’ADBREVIATVS LIBER DI CEZIO FAVENTINO 53
D. Schiffrin, Discourse Markers: Language, Meaning, and Context, in The Handbook of Di-scourse Analysis, ed. by D. Schiffrin, D. Tannen and H.E. Hamilton, Oxford 2001, pp. 54-75.
D.M. Schenkeveld, From particula to particle – the genesis of a class of words, in L’héritage des grammairiens latins de l’Antiquité aux Lumières. Actes du Colloque de Chantilly, Paris 1987, ed. I. Rosier, Paris 1988, pp. 81-93.
J. Svartvik, ‘Well’ in conversation, in Studies in English Linguistics for Randolph Quirk, ed. by S. Greenbaum, G. Leech and J. Svartvik, London 1980, pp. 167-177.
E. Tarriño, Adverbios y partículas, in Sintaxis del latín clásico, coord. J. M. Baños Baños, Madrid 2009, pp. 349-374.
M. Urgelles-Coll, The Syntax and Semantics of Discourse Markers, London-New York 2010. H. Weydt, What are particles good for?, in Approaches to Discourse Particles, ed. by K. Fischer,
Amsterdam 2006, pp. 205-217.URL: digiliblt.unipmn.itURL: http://www.intratext.comURL: http://latinparticles.userweb.mwn.de