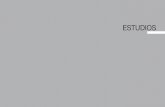"Ecclesiae tuae perfice augmentum". La seconda orazione di consacrazione del crisma nell’ "ordo...
Transcript of "Ecclesiae tuae perfice augmentum". La seconda orazione di consacrazione del crisma nell’ "ordo...
Ecclesiae tuae perfice augmentum. La seconda orazione di consacrazione del crisma nell’ordo benedicendi oleum cathecumenorum et
infirmorum et conficiendi chrisma del 1971Luca Girello
Dopo la riforma piana della settimana santa e la ricostituzione della messa crismale è emersa la necessità di una più approfondita riflessione sui riti degli oli, portata avanti dai lavori del Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, perché fosse possibile riscoprirne lo spessore pasquale ed ecclesia-le. A tal fine si rivalutò l’unica orazione di consacrazione del crisma, usata dalla secolare tradizione romana, e si reputò giusto creare ad hoc una seconda formu-la, in perfetta armonia con il mistero pasquale e i testi conciliari, da introdurre nel nuovo Ordo benedicendi oleum cathecumenorum et infirmorum et conficiendi chrisma1, promulgato il 3 dicembre 1970 e pubblicato nel 1971.
Il presente studio, partendo da un rapido approccio ermeneutico, che com-prenda l’olio profumato inserito dentro il suo contesto antropologico, biblico, storico e celebrativo, compie un’analisi di tipo critico-letterario della seconda formula del crisma, volta a indagare la struttura del testo e le sue fonti scrittu-ristiche, patristiche, liturgiche e magisteriali, per approdare infine a una sua più piena comprensione teologica.
1 Il contesto della nuova formula di consacrazione del crisma
Sono molti gli ambiti in cui l’olio dice qualcosa di più di se stesso – com’è proprio del simbolo in genere – andando oltre il suo senso superficiale e apren-do altre vie ermeneutiche non meno importanti. In modo particolare si posso-no individuare le due più decisive, che C. Valenziano chiama “assimilazione” e “accensione”2. L’olio è così collegato alle attività che lo coinvolgono: in esso è
Luca Girello, presbitero della Diocesi di Vigevano, licenziato in sacra liturgia al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo in Roma, attualmente direttore dell’Ufficio liturgico diocesano e docente negli studi teologici riuniti dei seminari di Crema-Cremona-Lodi-Vigevano.
1 D’ora in poi indicato nel corpo del testo con la sigla OBO.2 Cf. C. Valenziano, Liturgia e antropologia, Edizioni Dehoniane, Bologna 1997, 245.
Ecclesia orans 30 (2013) 185-233
186
significato che l’uomo può assimilare ciò che sazia o ciò che guarisce o ciò che gli conferisce un incarico speciale; e inoltre può accendere se stesso e il mondo circostante per mezzo della luce, della speranza e della bellezza. Il crisma, come un “concentrato” del denso simbolo dell’olio con la peculiare caratteristica del profumo, ha il potere di raggiungere contemporaneamente più persone e di toc-care immediatamente la loro corporeità, risvegliando la coscienza al significato che quel profumo può evocare.
Nell’esperienza biblica il significato antropologico dell’olio si specifica ulte-riormente. L’idea di assimilazione (di nutrimento e medicamento) si lega alla cura sovrabbondante che Dio ha per i suoi figli; l’idea di accensione (di lampade e della pelle) si sposa con la speranza e con la gioia che la fede in Dio fa ardere nel credente; l’attività/vitalità è dono di Dio per i vivi e anche per i defunti; il profumo rende chiara alla coscienza l’urgenza della continua operosità della propria consacrazione alla causa della fede e alla lode al Creatore. In sintesi, l’olio assume in sé la simbologia della provvidenza divina, che dona in abbondanza all’umanità tutto ciò che è necessario per condurre una vita piena e appagante. All’unzione come dono dall’alto l’uomo biblico risponde, entrando in una vera relazione con Dio, com’è possibile rinvenire in moltissime pericopi3.
Il Nuovo Testamento aggiunge solo due passi a riguardo dell’olio, 2Cor 1,21 e 1Gv 2,20.27. Essi non sono purtroppo fondamento certo di un uso liturgico apostolico dell’unzione, ma neppure la escludono4. Considerando che già l’An-tico Testamento conosce l’unguento per la consacrazione di cose e di persone, di cui la comunità cristiana dei primi secoli ha fin da subito scritto5, non stupisce il riconoscere che l’utilizzo liturgico dell’unzione venga attestato ben presto. Anzi, l’unzione legata al battesimo è strettamente inerente all’acqua battesimale, tanto da costituirne un’unica realtà, quella della rinascita da acqua e Spirito6, quella per cui acqua e Spirito sono concordi.
Il legame liturgico tra il crisma e l’iniziazione cristiana è un tema peculiare del periodo patristico, che collega la vita del cristiano con la vita di Cristo e in-
3 Cf. G. P. De Santis, Il simbolismo dell’olio nei sacramenti dell’iniziazione cristiana, Vive-rein, Roma 2008, 39-72.
4 Cf. C. Militello, La Chiesa “il corpo crismato”, Edizioni Dehoniane, Bologna 2003, 636.5 Cf. P. Sorci, «La benedizione dell’olio degli infermi nel contesto della messa crismale. “Sit
oleum tuum sanctum, Domine, nobis a te benedictum”», in Celebrare il sacramento dell’unzione degli infermi, edd. A. Grillo-E. Sapori, CLV, Roma 2005, 170-172. Il riferimento qui è alla lette-ratura apocrifa, che può essere assimilata come indizio di riflessione proto cristiana sulle Scritture. Insiste sul tema dell’unzione collegata al battesimo.
6 Cf. E. Lanne, «L’acqua e l’unzione nelle chiese orientali», in I simboli dell’iniziazione cri-stiana, ed. G. Farnedi (Studia anselmiana 87, Analecta Liturgica 7), Benedictina, Roma 1983, 156.
Luca Girello
187
terpreta entrambe alla luce del mistero pasquale. Un esempio concreto è riscon-trabile nelle catechesi mistagogiche del IV secolo, in cui i neofiti vengono istruiti sul significato delle unzioni ricevute nella liturgia7.
L’olio e l’unzione così intesi ben presto si poterono applicare anche ad altri ambiti della preghiera ecclesiale, perché la luce della Pasqua potesse illuminare e indirizzare tutta l’attività della comunità cristiana, fino ad oggi.
L’olio profumato ha acquisito dunque un significato pasquale ben preciso, legato alla celebrazione dei sacramenti e allo stretto legame tra Cristo e i cristia-ni; un significato che è stato ripreso dai lavori del concilio Vaticano II ed è stato ulteriormente illuminato. Infatti, con il costituirsi del Consilium ad exsequen-dam Constitutionem de sacra Liturgia si è avviato, oltre a tutto il resto, anche il lavoro di riforma del rito di consacrazione del crisma, perché si ritenne che la prima formula, pur antica e pienamente romana, aveva bisogno di un’integrazio-ne, che potesse rendere pienamente ragione del poliedrico significato dell’olio misto ad aromi. Alla base di questa affermazione ci sta lo studio di Pierre Jounel, il quale insiste nel dire che la seconda formula è complementare alla prima, per-ché si sofferma di più sul Nuovo Testamento, o meglio sull’esito della predica-zione evangelica, che è il costituirsi del mistero della Chiesa, cosa che l’antica formula non specificava in modo così ampio e chiaro8. Emerge anche lo stretto collegamento della seconda formula del crisma con i documenti del Concilio Vaticano II, per cui essa si pone come un’applicazione pratica dell’ampia visione cristologica ed ecclesiologica scaturita dalla riflessione conciliare: qui è possibile ritrovare la motivazione ultima della “novità” della seconda formula.
Individuata la motivazione, domandiamoci ora come il Consilium ha portato avanti l’incarico di riforma dell’Ordo degli oli. Per rispondere, è doveroso percor-rere, seppur velocemente, il lento e qualificato iter di riforma. I dati necessari a ricostruire il percorso sono rintracciabili nel “diario” di Annibale Bugnini9 e nel-
7 Cf. G. Caputa, «Lo Spirito Santo e il sacerdozio dei fedeli secondo alcuni Padri della Chiesa di Palestina», in Spiritus spiritalia nobis dona potenter infundit. A proposito di tematiche liturgico-pneumatologiche, ed. E. Carr, Centro Studi S. Anselmo, Roma 2005, 167-171.
8 «Après avoir souligné la profondeur de l’antique prière de consécration du chrême, com-ment justifier l’élaboration d’un second formulaire? C’est qu’il a semblé souhaitable d’avoir une prière qui fasse la part plus grande au Nouveau Testament et à l’évocation du mystère de l’Église. Le texte nouveau est complémentaire de l’ancien», P. Jounel, «La consécration du chrême et la bénédiction des saintes huiles», La Maison Dieu 112 (1972) 77. Cf. anche R. Cabié, «L’ini-ziazione cristiana», in La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia, vol. III I Sacramenti, ed. A.G. Martimort, Queriniana, Brescia 1987, 113; P. Sorci, «La solenne benedizione del crisma in oriente e in occidente», Rivista Liturgica 76 (1989) 273.
9 Cf. A. Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 1997, 770-774.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
188
la ripresa sintetica di tutti gli schemi del Consilium compiuta da Piero Marini10, dai quali emerge un quadro piuttosto elaborato, indice di un’indagine teologica portata avanti con rigore e competenza, senza alcuna improvvisazione.
Per dare risposte circa la funzione del crisma, il Consilium ha costituito il Coetus XXI “De Pontificali II-III” per la riforma dei libri II e III del Pontificale, che cominciò a lavorare fin da subito, dedicando all’Ordo degli oli anni di ricerca e discussione, tra l’inizio del 1964 e il settembre del 1970. Il gruppo già nei primi mesi produsse molto materiale, che venne esaminato nella riunione dei relatori della primavera del 1966; tuttavia esso non fu considerato sufficientemente ma-turo per essere presentato al Consilium. Per questo motivo nella VII adunanza generale del 14 ottobre 1966 furono proposti e approvati solo i principi concor-dati tra i relatori. Successivamente i lavori sono proseguiti con maggior disten-sione, attendendo anche il risultato delle ricerche di altri gruppi cointeressati alla materia, e hanno approdato all’approvazione definitiva nella XII adunanza generale del 13 novembre 1969; prodotto quindi un ultimo schema del Coetus il 23 maggio 1970, i testi furono mandati in esame alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale diede il nulla osta, con alcune osservazioni sulle formule e sul ministro. Il 9 settembre il nuovo Ordo degli oli è stato presentato a Paolo VI, che lo ha approvato il 22 settembre 1970.
I lavori, protrattisi per quasi sei anni, hanno prodotto i seguenti nove sche-mi11:
1) Schema n. 48 (De Pontificali 1; OBO 1) del 6 novembre 1964.2) Schema n. 49 (De Pontificali 2; OBO 2) del 28 novembre 1964.3) Schema n. 56 (De Pontificali 3; OBO 3) del 7 gennaio 1965.4) Schema n. 151 (De Pontificali 8; OBO 4) del 2 aprile 1966.5) Schema n. 158 (De Pontificali 9; OBO 5) del 25 aprile 1966.6) Schema n. 181 (De Pontificali 13; OBO 6) del 25 agosto 1966, cui seguono
le notazioni Addenda del 21 settembre 1966. Si tratta dello schema più artico-lato e corposo, in cui ogni argomento viene esposto tramite il riferimento alle fonti liturgiche romane e talvolta alla prassi liturgica delle altre chiese. Il capitolo III e i quesiti dall’undicesimo al quindicesimo trattano del crisma. È interessante notare che al capitolo V De ritu et textu proposito si dice che il consenso unanime dei membri del Coetus chiedeva una profonda revisione dei testi delle benedi-
10 Cf. P. Marini, «Elenco degli Schemata del “Consilium” e della Congregazione per il culto divino (marzo1964 – luglio 1975)», Notitiae 18 (1982) 453-772, in particolare le pagine 691-694.
11 Si tratta di testi non pubblicati che mi sono stati inviati in formato digitale da Trier, dal Rettore della Facoltà Teologica, il molto Rev.do Prof. Dr. Klaus Peter Dannecker, che qui riceve sentiti ringraziamenti.
Luca Girello
189
zioni degli oli, ma solamente per ripristinare la genuina semplicità del modello romano antico, eliminando gli appesantimenti medievali; restava fermo che non sembrava opportuno cambiare la venerabile formula romana tradizionale12. Lo schema propone poi una bozza di “rubriche” del nuovo Ordo. Tutto questo è stato portato alla VII adunanza generale del Consilium nel mese di ottobre 1966, ma non ha ricevuto né riprovazione né approvazione.
7) Schema n. 192 (De Pontificali 14; OBO 7) del 4 ottobre 1966.8) Schema n. 354 (De Pontificali 20; OBO 8) del 22 ottobre 1969. Di fonda-
mentale importanza, lo schema, come quelli precedenti, dichiara come da con-servare e preferire l’antica formula del crisma, e tuttavia ne propone un’altra per manifestare con più chiarezza gli effetti dell’unzione crismale13. Quest’altra for-mula venne elaborata in lingua francese da Pierre Jounel, come lo stesso schema precisa, e costituisce la fonte diretta della formula del nuovo Ordo degli oli, che in questa sede vogliamo analizzare. Essa presenta un testo molto più lungo e arti-colato rispetto a quello definitivo in latino, come si vedrà nelle prossime pagine.
9) Schema n. 368 (De Pontificali 23; OBO 9) del 23 maggio 1970. Si tratta dell’ultimo schema preparato dal Coetus, che presenta i caratteri della definitivi-tà e che assomiglia molto al testo finale dei praenotanda dell’OBO. Per quanto ri-guarda il crisma, compare la seconda formula di consacrazione14, ormai in latino, impostata sul testo proposto da P. Jounel, ma differente in diversi punti. Anche questa nuova versione della nostra formula, che si pone tra l’originale in francese e la definitiva dell’OBO, sarà studiata nelle prossime pagine.
2 Il testo della seconda formula del crisma e sua analisi letteraria
Come scoperto dall’analisi degli Schemata del Coetus XXI del Consilium, il nostro testo ha subito un’evoluzione da un originale francese a una prima tradu-zione latina, fino a quella definitiva. Al fine di evidenziare la genesi della formu-
12 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra Liturgia, Coetus a studiis 21, Schemata, 181, de Pontificali 13, 25 agosto 1966, 7 (Non pubblicato. L’originale è nell’Archivio della Congregazione per il Culto Divino = CCD).
13 «Formula vero venerabilis consecrationis Chrismatis videtur servanda. Attamen alia nova ad libitum proponitur, in qua meliori et proximiori modo effectus unctionis S. Chrismatis expri-mitur», Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra Liturgia, Coetus a studiis 21, Schemata, 354, de Pontificali 20, 22 ottobre 1969, 7 (Non pubblicato. L’originale è nell’Archivio della CCD).
14 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra Liturgia, Coetus a studiis 21, Schemata, 368, de Pontificali 23, 23 maggio 1970, 7-8 (Non pubblicato. L’originale è nell’Archivio della CCD).
Ecclesiae tuae perfice augmentum
190
la, anzitutto è opportuno mettere in sinossi tali tre successivi passaggi. Il testo viene già suddiviso in sezioni, per argomento, di cui poi si dirà.
Testo in Schema 354 (22.X.1969) Testo in Schema n.368 (23.V.1970) Testo definitivo (OBO 1971)proposto da P. JOUNEL in corsivo le parti più o meno passate nel >
INVOCAZIONE Deus sacramentorum auctor Deus sacramentorum auctor vitaeque largitor, vitaeque largitor,Nous te rendons grâce gratias agimus gratias agimusDieu éternel et tout-puissant ineffabili pietati tuae, ineffabili pietati tuae,
ANAMNESI1 (Antico Testamento)
pour le mystère qui sanctificationis olei qui sanctificationis oleide l’huile de consécration mysterium, mysteriumque tu as préfiguré in antiquo foedere in antiquo fœderesous l’ancienne alliance adumbratum, adumbrasti,et fait resplendir novissimis temporibus dans les temps nouveaux. resplendere fecisti. C’est ainsi Tu enim, Domine, que tu as ordonné à ton serviteur Moise Moysi famulo tuo praecepisti ut Aaron eiusque filios de te consacrer des prêtres, sacerdotes tibi consecraret unctione que tu as chargé Samuel et Samueli iussisti ut David de oindre ce que tu avais choisis quem populi tui ducem elegeras chefs de ton peuple, in regem Israel ungeretur. que tu as manifesté Prophetas autem tuos les charismes de ton Esprit ut in nomine tuo loquerentur mystica unctione praeparasti divinitus à travers les prophètes et in eis tui Spiritus dona qui parlaient en ton nom. mirabiliter praesignasti.
ANAMNESI2 (Vita di Cristo)Mais c’est dans ton Fils bien-aimé, Sed, ubi venit temporum plenitudo, et ubi venit temporum plenitudo,Père très saint, in dilecto Filio tuo, in dilecto Filio tuoque, venue la plénitude des temps, Pater sancte, haec munera singulariter effulgere voluisti singulariter effulgere voluisti.tu as dévoilé toutes les puissances atque sanctificationis abundantiusde l’Esprit sanctificateur. revelasti virtutes.Tu as oint ton Verbe d’une huile Oleo enim laetitiae d’allégresse, le constituant Christ, Verbum tuum, dans le sein de la Vierge Marie; in sinu Virginis Mariae, et tandis que tu le présentais Christum tuum constituisti, comme ton Unique, et ascendentem ex Iordanis aquis lors de son baptême dans le Jourdain, Spiritu manifeste demisso, tu as voulu que l’Esprit Filium dilectionis tuae reposât visiblement sur lui. clare proclamasti.
Luca Girello
191Ecclesiae tuae perfice augmentum
Tu révélais ainsi Sic, paterna voce ac superna unctione en Jésus de Nazareth Iesum Nazarenum signasti le Prophète envoyé pour annoncer Prophetam, qui salutis nuntium la bonne nouvelle aux pauvres, pauperibus afferret, le souverain Prêtre qui rachèterait summum sacerdotem, qui les hommes dans son sang, proprio sanguine homines redimeret le Berger qui atque bonum Pastorem, qui oves suas pasceret in dilectione le conduirait aux sources de la vie. et ad fontes vitae perduceret.
ANAMNESI3 (Mistero pasquale)En accomplissant Cum vero Cum enimdans le mystère de sa Pâque Filius tuus, Dominus noster, Filius tuus, Dominus noster,l’œuvre du salut du monde, paschali sacramento paschali sacramentoton Fils notre Seigneur humanum genus salvum fecisset humanum genus salvum fecisset,remplit l’Eglise Ecclesiam tuam replevit Ecclesiam tuam replevitde ce même Esprit, eodem Spiritu Sancto, Spiritu Sancto, et caelestibus muneribus et caelestibus muneribus mirabiliter instruxit, mirabiliter instruxit,afin de se l’unir ut eam sibi sponsam immaculatam comme une Épouse immaculée coniungeret perpetuo et de continuer par elle et per eam salutis opus ut per eam salutis opusson œuvre dans le monde. in mundo compleretur. in mundo compleretur.
ANAMNESI4 (Economia sacramentale)Dés lors Exinde, Exindele mystère de l’onction a solis ortu usque ad occasum, recevrait, du levant au couchant, sacro chrismatis mysterio sacro chrismatis mysterioles richesses de grâce divitias gratiarum tuarum divitias gratiarum tuarumque tu dispenses par l’Eglise. hominibus ita dispensas, hominibus ita dispensas,Marqué du chrême ut filii tui, ut filii tui,au sortir des eaux saintes du baptême, ex baptismatis lavacro renati, baptismatis lavacro renati,et confirmé dans l’Esprit Spiritus unctione firmentur, Spiritus unctione firmentur,par une nouvelle onction, le chrétienserait configuré au Christ et, Christo tuo conformes effecti, et, Christo tuo conformes effecti,et recevrait part à sa mission eius propheticum, sacerdotale eius propheticum, sacerdotaleprophétique, sacerdotale et royale; regaleque munus participent. regaleque munus participent.imprégné de l’Esprit, Quibus repleti virtutibus, il répandrait la bonne odeur du Christ, salutem cunctis gentibus annuntient annonçant à tous le message du salut, tibi hostiam spiritalem faisant de sa vie semetipsos exhibeant une oblation spirituelle, in odorem suavitatis, aidant ses frères fratresque ad lumen veritatis à marcher vers la lumière. alacriter adducant. (L’effusion de l’huile sainte sur l’évêque manifesterait en lui le grand prêtre et le pasteur
192
du peuple de la nouvelle alliance, tandis que la consécration des mains du prêtre montrerait que celui-ci est établi pour sanctifier le peuple et offrir à Dieu le sacrifice de l’Eglise. Répandue sur l’autel, l’huile sainte révélerait en lui le symbole du Christ autel et victime de son sacrifice; marquant les murs d’un édifice matériel, elle le consacrerait pour abriter l’Eglise vivante, l’assemblée des baptisés.)
EPICLESI (con le richieste)C’est pourquoi, Te igitur Te igiturnous t’en prions, Seigneur, deprecamur, Domine, deprecamur, Domine,daigne faire ut, per tuae gratiae virtutem ut per tuae gratiae virtutem,de cette huile parfumée haec aromatis et olei commixtio haec aromatis et olei commixtiole signe et l’instrument fiat nobis fiat nobisdes bénédictions benedictionis tuae benedictionis tuae sacramentum: sacramentum;que tu répands dans ton Eglise; daigne envoyer in fratres nostros, in fratres nostros,ton Esprit avec tous ses charismes hac unctione conspersos, hac unctione conspersos,en ceux Sancti Spiritus dona Sancti Spiritus donaqui recevront l’onction, largiter effunde; largiter effunde;(rendre saints loca vel res, loca vel res,aux yeux des hommes sacris oleis signata, sacris oleis signata,les objets et les lieux splendore sanctitatis exorna; splendore sanctitatis exorna;qui en seront marqués) daigne surtout sed in primis, sed in primis,faire de ton Eglise le temple de ton Esprit, le Corps vivant de ton Christ. Par ce mystère de l’onction huius unguenti mysterio, huius unguenti mysterio,opère sa croissance, Ecclesiae tuae perfice augmentum, Ecclesiae tuae perfice augmentum,jusqu’à ce donec ad illam plenitudinis donec ad illam plenitudinisqu’elle atteigne la mesure crescat mensuram crescat mensuram,que tu as fixée quam tu ipse sapienter ordinasti. à sa plénitude,
DOSSOLOGIAet que, tous les signes disparaissant, Tunc, signa evanescent et discutientur tenebrae;
tu, vero, aeterna luce refulgens, qua tu, aeterna luce refulgens,tu sois tout en tous par le Christ, omnia omnibus eris cum Christo omnia omnibus eris cum Christodans l’Esprit, in Spiritu Sancto in Spiritu Sancto,pour les siècles des siècles. per omnia saecula saeculorum. per omnia saecula saeculorum.
Luca Girello
193
2.1 Confronto con l’originale francese e la prima versione latina
Dalla sinossi dei tre testi emergono alcuni dati parecchio rilevanti per la com-prensione del testo definitivo del 1971. La prima colonna a sinistra presenta il testo francese, piuttosto lungo e articolato, composto da Pierre Jounel e offerto alla valutazione del Consilium nello Schema 354 del 22 ottobre 1969. Presenta due sezioni, che lo stesso Schema mette tra parentesi: si tratta di esemplificazio-ni concrete dell’utilizzo dell’olio, poi non confluite nel testo definitivo. La più lunga (da L’effusion de l’huile sainte a l’assemblée des baptisés) costituisce la con-clusione della parte anamnetica della formula e parla dell’effusione del crisma sul vescovo, sui presbiteri, sull’altare e sulle pareti di una Chiesa. La più breve (da rendre saints a seront marqués) è inserita nella parte epicletica e chiede che oggetti e luoghi in generale, toccati dal crisma, possano essere resi santi dinanzi agli occhi degli uomini. La colonna centrale riporta più o meno lo stesso testo francese, tradotto in latino. Per questo ne conserva la lunghezza, sebbene faccia la scelta di eliminare tutte le esemplificazioni sacramentali contenute nella pa-rentesi più lunga e termini duplicati di un medesimo concetto. Altre scelte poi sono importanti nella redazione dello Schema 368.
La prima è la decisione di ampliare alcune parti, creando aggiunte ex novo, che nella seconda colonna – solo per le parti che interessano – sono evidenziate sottolineando il testo. Compare, infatti, l’incipit con l’invocazione a Dio sacra-mentorum auctor vitaeque largitor e l’indirizzo alla sua ineffabili pietati; si inseri-sce l’espressione sintetica haec munera singulariter effulgere voluisti, che riassume tutte le meraviglie compiute dal Padre nel Figlio quando venne la pienezza dei tempi; si sottolineano gli aiuti divini che la Chiesa riceve dallo Spirito, quando ne viene adombrata (et caelestibus muneribus mirabiliter instruxit). Inoltre si tro-vano alcune espressioni più brevi e, forse, di minore importanza, che però non bisogna tacere: quando si parla dello Spirito effuso nel mistero pasquale, si spe-cifica che la Chiesa è di Dio (tuam); nel momento della richiesta di consacrare il crisma (definito ora come commixtio di olio e aromi), si invoca la potenza della grazia e si parla di un intervento divino “per noi”, esprimendo meglio la relazione tra i due interlocutori della preghiera, Dio e la Chiesa locale radunata; infine, nella conclusione si puntualizza il divenire storico della pienezza ecclesiale, di-cendo l’eterno splendore dell’éschaton dopo il diradarsi delle tenebre del tempo.
La seconda scelta importante, che la seconda colonna compie rispetto alla prima, è la resa dei medesimi concetti presenti nel testo di partenza, ma con altri termini. Probabilmente questo cambiamento lessicale è dovuto non solo a motivi stilistici, ma anche a una più o meno consapevole opzione teologica. Ad esempio l’olio de consécration è reso con sanctificationis e non con consecrationis,
Ecclesiae tuae perfice augmentum
194
mentre l’espressione mystère (della sua Pasqua) viene tradotto con paschali sacra-mento, dando spazio per pensare e dire la differenza e la somiglianza tra i “sinoni-mi” utilizzati; nella parte epicletica poi “coloro” che riceveranno l’unzione (ceux qui recevront l’onction) sono indicati con fratres nostros; nella richiesta conclusi-va sulla crescita della Chiesa si passa dal verbo “operare” (opère sa croissance) a quello del “portare a compimento” (perfice augmentum), che aggiunge un valore molto più intenso al semplice “fare” del francese.
Un’altra scelta, che il latino dello Schema 368 compie, è il passaggio dal singolare al plurale, mentre si parla della dispensazione della grazia sacramen-tale agli uomini nell’ultima parte dell’anamnesi; infatti laddove il francese ha le chrétien serait configuré au Christ, la seconda colonna riporta filii tui […] Christo tuo conformes effecti. Questo dichiara non solo il cristiano con il nome di “figlio”, che meglio indica cosa operano in lui i sacramenti dell’iniziazione cristiana, ma anche la realtà comunionale della vita ecclesiale, in cui i sacramenti sono ricevuti non dai singoli, ma da una comunità.
2.2 Informazioni strutturali generali
La terza colonna, quella che corrisponde al compimento dell’iter letterario del nostro testo, deve essere letta secondo tutte le indicazioni già date per la se-conda. Valgono perciò le considerazioni, espresse in precedenza, sulle scelte re-dazionali principali, che bisogna tenere ben presenti. Esse saranno riconsiderate all’interno della sintesi teologica. Ora invece ci si deve soffermare sulle peculia-rità della colonna di destra.
“Le sezioni” anzitutto balzano agli occhi come prima informazione strut-turale generale. L’anamnesi viene considerata in quattro momenti: l’olio nell’e-conomia veterotestamentaria (Anamnesi1), considerato nella vita ordinaria di Gesù (Anamnesi2), nell’evento centrale della Pasqua con l’invio dello Spirito (Anamnesi3) e nella continuazione ecclesiale dell’opera salvifica per mezzo dei sacramenti (Anamnesi4). Successivamente si apre l’epiclesi con la richiesta dell’effusione dello Spirito sia sul crisma sia su persone-luoghi-cose sia soprat-tutto sulla Chiesa. Il tutto è incluso tra l’invocazione iniziale a Dio, “autore” dei sacramenti, e la dossologia conclusiva. All’interno delle sezioni un aspetto macroscopico colpisce lo sguardo. Se la seconda colonna aveva già ridotto al-cune espressioni rispetto all’originale francese – aggiungendone però altre – la terza colonna risulta invece estremamente concisa, avendo compiuto drastiche epurazioni del testo latino dello Schema 368, principalmente dentro la sezione degli episodi biblici. Anche questa scelta comporta conseguenze specifiche, di cui bisogna tenere conto.
Luca Girello
195
“I nessi congiuntivi”15 costituiscono poi un’ulteriore informazione struttura-le importante. Essi vengono posti all’inizio di ogni sezione: qui in Anamnesi1, et in Anamnesi2, enim in Anamnesi3, exinde in Anamnesi4, igitur in Epiclesi, qua nella Dossologia. Considerandoli attentamente, si può capire che tutti quelli presenti nell’anamnesi si “rincorrono” a ritroso dall’exinde fino al qui: l’econo-mia sacramentale (Anamnesi4) deriva dal dono pasquale dello Spirito di Cristo (Anamnesi3), che è il culmine della rivelazione neotestamentaria (Anamnesi2) prefigurata già nell’antica alleanza (Anamnesi1) e più precisamente nel sancti-ficationis olei mysterium, complemento oggetto di adumbrasti e di effulgere vo-luisti. Inoltre tutto questo rimanda al verbo gratias agimus che regge il qui di Anamnesi1 e che, quindi, risulta essere il verbo principale di tutta l’anamnesi. Da ciò emerge quindi che tutto l’elemento anamnetico è un grande rendimen-to di grazie per il mistero del crisma. Il nesso igitur dell’epiclesi rimanda, pure lui, a ciò che è stato espresso precedentemente, permettendo alla richiesta dello Spirito di inserirsi pienamente nel movimento generale di gratitudine di tutta la preghiera. Anche il qua che introduce la dossologia, strettamente connesso con l’ultima domanda dell’epiclesi e perciò con tutto il resto, innalza nuovamente il tono del rendimento di grazie e allarga lo sguardo oltre il compimento del miste-ro dell’olio, quando Dio sarà tutto in tutte le cose.
È notevole questo riferimento generale di tutta la preghiera al gratias agimus, perché ci dice che l’intenzione del Consilium era di conservare alla formula la tonalità tradizionale e secolare del rendimento di grazie, ovvero di conservare l’idea del prefazio16, sebbene ora senza dialogo iniziale e senza le usuali parole vere dignum et iustum17.
“La punteggiatura” del testo definitivo è l’ultimo elemento da considerare. Sembrerebbe una semplice curiosità, ma in realtà è possibile riconoscervi precise implicazioni teologiche. Infatti i punti fermi nel testo sono solamente quattro. Leggendo dall’inizio della formula, il primo punto fermo si trova solo al termine di Anamnesi2. Possiamo interpretare questa scelta come la volontà di dire l’unità dei due testamenti: tra loro non ci sono dei punti, ma continuità, e ciò che prima l’olio indicava, ora non viene alterato, ma pienamente illuminato dalla venuta
15 In sinossi segnalati nella terza colonna in maiuscoletto.16 Cf. Pontificale Romanum, editio typica 1961-1962, pars III, 13-17, ed. M. Sodi - A. Tonio-
lo, LEV, Città del Vaticano 2008, 321-325; il quale riprende l’eucologia dei libri liturgici prece-denti e dei sacramentari antichi.
17 Il dialogo e il vere dignum sono stati eliminati dalla prima formula dietro proposta del coetus XXI, come si legge in Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra Litur-gia, Coetus a studiis 21, Schemata, 181, de Pontificali 13, Addenda, 21 settembre 1966, 3. Gli schemi successivi non ne fanno più parola, nemmeno per chiedere il parere dei consultori.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
196
del Figlio, il quale quindi ci dice come interpretare tutte le unzioni del passato; già solo il suo soprannome, il Cristo, l’Unto, è tutto un programma. Per questo non c’è bisogno di ricordare tutti gli esempi scritturistici. Il secondo punto fer-mo si trova alla fine di Anamnesi3 e spinge l’orante a fermarsi sull’ultima parola della sezione, compleretur, che dice la finalità dell’opera salvifica inaugurata dal mistero pasquale; Cristo la porta a compimento nel mondo mediante la Chiesa: qui sta il proseguimento della rivelazione biblica. Il terzo punto fermo poi al termine di Anamnesi4 offre un’ulteriore specificazione a quanto appena detto: Cristo si rivela nella Chiesa ai singoli uomini, che vengono resi partecipi del suo munus e, quindi, assimilati a Cristo stesso, fatti suo corpo. L’ultimo punto fermo è quello conclusivo, che associa l’epiclesi e le richieste e la dossologia in un unicum. Si vuole così porre l’accento sul fatto che la venuta dello Spirito per mezzo dell’unzione, toccando le persone, le cose e i luoghi, senza soluzione di continuità tocca necessariamente l’intera Chiesa.
2.3 Scelte testuali e contenuti specifici
Da quanto detto finora, emerge un quadro testuale sempre più ricco, del qua-le si dà ora una prima veloce sintesi, che sarà però sviluppata nelle considerazioni teologiche conclusive.
L’incipit della formula trasforma il Dieu éternel et tout-puissant di P. Jounel in Deus sacramentorum auctor vitaeque largitor, che non solo utilizza un’espres-sione più coerente con ciò che avviene nella messa crismale18, ma conduce alla teologia dei Padri della Chiesa, in modo speciale a quella ambrosiana. Il gratias agimus, che regge l’intera formula, si rivolge anzitutto alla pietas divina, inte-sa secondo l’accezione antica di giustizia e misericordia di un Padre affidabile, come testimoniato anche dai sacramentari19. La preghiera è già certa di ottenere ciò che chiede sulla base della fede, tanto che la prima cosa da fare – e da portare avanti per tutto il testo – è mostrarsi grati a Dio per tutto ciò che si degna fare per l’uomo.
La sezione Anamnesi1 si apre con la menzione del suo oggetto, il sanctificatio-nis olei mysterium, oggetto anche dell’intera preghiera; la consécration francese è resa con il termine più ampio e allusivo di sanctificatio dei fedeli, cui mirava tutta l’economia veterotestamentaria. Infatti i riferimenti all’Antico Testamento sono
18 Cf. A. Ward, «Some Sources of the Second Formula for the Consecration of Chrism», Notitiae 46 (2010) 556.
19 Cf. A. Blaise, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Réimpression anastatique, Brepols, Turnhout 1993, 625.
Luca Girello
197
stati racchiusi nella stringatissima espressione in antiquo foedere adumbrasti, elu-dendo il richiamo alle antiche unzioni: quella sacerdotale di Aronne e dei suoi figli (che la seconda colonna si era invece premurata di specificare, colmando la dimenticanza della prima), quella regale di Davide e quella profetica di coloro che devono parlare in nome di Dio. Non serve più dire cosa accadde in passato, dal momento che tutte le attese si sono compiute e questi versetti dell’antica alleanza sono un’ombra di realtà future. Essi rimangono dunque solamente sullo sfondo della formula20.
La sezione Anamnesi2 risulta ancora più schematica della precedente, perché i rimandi neotestamentari all’unzione di Gesù (incarnazione del Verbo e battesi-mo al Giordano), vengono totalmente ignorati, per risolvere tutto il lungo passo sulla vita ordinaria di Cristo nell’espressione (sanctificationis olei mysterium) ubi venit temporum plenitudo, in dilecto Filio tuo singulariter effulgere voluisti. È in-teressante notare che si tratta di una sintesi mirabile, che rimanda a molti passi principali del Nuovo Testamento – come si dirà a proposito delle fonti bibliche.
La sezione Anamnesi3 racconta il mistero pasquale, chiave di lettura di tutto quanto Gesù ha detto, fatto e vissuto. Il paschali sacramento, che rimanda ancora una volta all’epoca patristica e ai grandi sacramentari, non è visto nell’evento di morte e risurrezione, ma principalmente nell’invio dello Spirito Santo e, quindi, nel collegamento con la Chiesa.
La sezione Anamnesi4 comincia con exinde, traduzione del francese dès lors. Il suo significato può essere sia temporale (“da allora”) sia causale (“perciò”), per indicare che l’invio dello Spirito a Pasqua è la forza dirompente, che ha inaugu-rato un nuovo tempo. Lo Spirito provoca la successiva dinamicità intra-ecclesia-le e continua a condurla verso la sua compiutezza. Così gli uomini sono dotati della ricchezza delle grazie divine, che vengono “disposte” da Dio (hominibus ita dispensas) non astrattamente, ma mediante sacro chrismatis mysterio. Nel crisma l’uomo può vedere il sigillo dell’abbondanza dell’amore di Dio per lui e coloro che sono “figli” per l’immersione battesimale vengono confermati con l’unzione dello Spirito, per diventare della forma di Cristo, assumendo i compiti sacerdo-tale, profetico e regale, che rimandano agli esempi elusi dell’Antico Testamento in Anamnesi1. Il nostro testo, forse per ragioni di sinteticità (riemerge il genio romano), rinuncia ad esemplificare questi compiti, come fanno invece la versione francese e la prima redazione latina. Pertanto l’opera salvifica, che lo Spirito San-to porta a compimento nel mondo mediante l’opera della Chiesa, consiste nella “distribuzione” dei sacramenti a partire ovviamente da quelli che introducono
20 Cf. G. Ferraro, «La seconda formula della consacrazione del crisma», Ephemerides Li-turgicae 125 (2011) 131.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
198
l’uomo nella vita cristiana, per rendere i cristiani come il “prolungamento” di Cristo nel mondo.
L’epiclesi si apre con la richiesta dell’intervento dello Spirito, invocato impli-citamente come la dynamis divina per mezzo delle parole tuae gratiae virtutem, introdotte ex novo dalla versione latina. La potenza dello Spirito risulta operare più effetti, a più livelli. Anzitutto compie la trasformazione del crisma, che viene solennemente svelato come un “sacramento”, ancor prima della celebrazione dei singoli sacramenti, alludendo quindi al concetto antico di una sacramentalità ampia, ripresa anche dal Concilio Vaticano II. In seguito l’opera dello Spirito è invocata sulle persone che riceveranno l’unzione e quindi si chiede lo splendo-re della santità – altra modalità per intendere la medesima terza Persona della Trinità – per le cose e i luoghi segnati dall’unzione, in modo tale che la mate-rialità delle sub-creazioni umane (fondamentalmente altari e chiese) possa in qualche modo veicolare il mistero “bello” della presenza divina. L’ultima richie-sta dell’epiclesi, la più importante come si evince dall’in primis con cui comin-cia, riguarda la trasformazione della intera Chiesa. Essa avviene per il mysterium dell’unguento. È da notare che questa stessa espressione viene qui evocata per la terza volta, come già si era compiuto in Anamnesi1 (a proposito della rivelazione biblica) e in Anamnesi4 (a proposito dell’opera sacramentale): ora si parla del compimento di tutto ciò che Dio ha posto in atto nella rivelazione e continua a compiere nei sacramenti, ovvero si parla della “misura” della perfezione eccle-siale, alludendo alla teologia paolina del corpo di Efesini 4. Per questo il testo latino toglie le esplicite menzioni francesi a tale teologia (le temple de ton Esprit, le Corps vivant de ton Christ), per lasciare il tutto custodito in poche sintetiche parole. A proposito è da considerare anche il fatto che il verbo principale è quel perfice, indicante una realtà già presente, già in atto (l’unità della Chiesa corpo-tempio), ma pur bisognosa di raggiungere la sua pienezza.
La dossologia conclusiva di per sé non esplicita una lode trinitaria, ma invoca la conclusione della storia, quando a Dio sarà sottomessa ogni cosa, secondo la prima lettera ai Corinzi 15. È quindi la stessa pienezza della Chiesa – per cui si chiedeva l’intervento dello Spirito in primis – a costituire la lode somma e infinita alla Trinità al termine del tempo. Allora, nell’escatologia compiuta, ci sarà spazio solamente per una grande luce, dal momento che la nostra formula introduce il tema dell’eterno splendore divino (aeterna luce refulgens), che nel testo francese mancava. Nella prima versione latina era posto il contrasto con i signa evanescent et discutientur tenebrae, indicando opposizione tra questo mon-do e il regno futuro; l’OBO invece toglie il riferimento alle tenebre attuali e pone una graduale e viva continuità tra l’accrescersi della Chiesa e l’intensificarsi della luce.
Luca Girello
199
2.4 Fonti e riferimenti
Ci addentriamo nel discorso sulle fonti della nostra formula. Esse si confi-gurano come allusioni o citazioni di tipo biblico, patristico-teologico, liturgico e magisteriale, emergenti dalla forma letteraria del testo. Questo non significa necessariamente che gli estensori della formula (P. Jounel e chi ha curato la prima e la seconda versione latina) avessero la determinazione cosciente di attingere a quelle fonti: esse potrebbero costituire semplicemente il loro background cultu-rale. Poiché tuttavia questo loro retaggio viene consegnato ai posteri e dona un preciso senso teologico all’orazione, ora è bene tenerne conto. Il presente studio ha indagato con molta cura e molto tempo tutte le possibili fonti del testo. In questa sede però non ci soffermiamo a descriverle, ma solo ad elencarle, per la-sciare intendere la grande ricchezza della nuova formula dell’OBO. Di seguito vengono date le informazioni generali sulle tipologie di fonti e poi si delinea un quadro sinottico delle singole espressioni della formula, utilizzando il numero 1 per le fonti bibliche, il 2 per quelle patristiche-teologiche, il 3 per quelle liturgi-che, il 4 per quelle magisteriali.
Nella sintesi teologica conclusiva saranno tutte riprese, sebbene non più ci-tate esplicitamente.
2.4.1 Fonti scritturistiche
Oltre al fatto che la parte anamnetica della formula è un rimando continuo a episodi biblici ed evangelici in modo particolare, tutta la preghiera è global-mente intrisa di richiami alle sacre Scritture, come si vede anche ad uno sguardo superficiale dal quadro sinottico sottostante. Si utilizza ovviamente il testo della Vulgata21, che era in uso anche negli anni in cui la formula venne creata e tradotta e che costituisce il terreno su cui lo stesso P. Jounel si è formato ed è vissuto. Si anticipa che la lettera agli Efesini in modo particolare è insistentemente presente.
2.4.2 Fonti patristiche e teologiche
Sembra non ci siano allusioni a passi interi o al pensiero peculiare di qualche padre, ma è plausibile far risalire alcune espressioni della formula ad altrettante espressioni simili contenute nelle opere dei padri della Chiesa, oppure di auto-ri cristiani successivi, principalmente medievali. Tali espressioni non sono state rintracciate nei testi eucologici (almeno all’interno dei libri liturgici principali)
21 Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem, 2 voll., ed. R. Weber, Württembergische Bibel-anstalt, Stuttgart 1969. Dello stesso volume si utilizzano anche le sigle per i singoli libri biblici.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
200
e, quindi, rimandano in modo mediato o immediato a scrittori ecclesiastici, che possono a giusta ragione essere considerati fonti della preghiera in esame.
2.4.3 Fonti liturgiche
Le ascendenze liturgiche sono state cercate essenzialmente nei tre principali sacramentari22, nel Missale Romanum 1962 e nel Pontificale Romanum del 1961-1962, fonti che probabilmente anche i padri del Consilium avevano a disposi-zione.
Una fonte liturgica particolare – di cui si accenna soltanto qui – è la pre-ghiera bizantina del myron. Pierre Jounel – estensore, come abbiamo visto, della formula in esame – in un suo articolo del 1972 ha scritto che la nuova preghiera romana di consacrazione del crisma si avvicina molto a quella bizantina per il confezionamento del myron23. Essa può quindi essere considerata a priori una fonte della nostra orazione. Lo stesso P. Jounel specifica che il punto di eviden-te somiglianza è quello in cui si fa riferimento all’unzione veterotestamentaria, quella “sotto la Legge”, che – accennata solo velocemente – riceve piena luce nel Nuovo Testamento24.
2.4.4 Fonti magisteriali
Le fonti magisteriali della seconda formula di consacrazione del crisma si assestano – come si può supporre – sui documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e, in parte, anche sulla Mystici Corporis di Pio XII. La ricerca è av-venuta anche nei documenti del Concilio Tridentino, nel quale però non sono state rinvenute minime tracce letterarie e contenutistiche. Il Vaticano II dunque costituisce non solo il punto di riferimento più vicino nel tempo alla creazione
22 Sacramentarium veronense, ed. L.C. Mohlberg (Rerum Ecclesiasticarum Documenta. Series maior, Fontes I), Herder, Roma 31978; Liber sacramentorum romanae aeclesiae ordinis anni circuli, ed. L.C. Mohlberg (Rerum Ecclesiasticarum Documenta. Series maior, Fontes IV), Herder, Roma 31981; Le Sacramentaire Grégorien: Ses principales formes d’après les plus anciens manuscrits, 3 voll., ed. J. Deshusses, Editions universitaires, Fribourg 31992. In questa sede si utilizzano le sigle (Ve, GeV, GrH) seguite dal numero dell’orazione.
23 La nouvelle prière se veut, elle, résolument christologique et ecclésiale, ce en quoi elle se rapproche davantage de la prière byzantine de consécration du myron [...] La seconde prière romaine présente, elle aussi, les usages de l’huile sous la Loi comme une simple annonce du mystère du Christ, Jounel, «La consécration du chrême et la bénédiction des saintes huiles», 78.
24 Cf. il testo riportato e tradotto in francese in un articolo di Miguel Arranz, M. Arranz, «La consécration du saint myron. Les sacrements de l’ancien Euchologe constantinopolitain», Orientalia Christiana Periodica 55 (1989) 317-338.
Luca Girello
201
della formula, ma anche il terreno teologico su cui la riflessione sugli oli e sui sa-cramenti ha potuto germogliare e sbocciare in novità di intenti. Per questo mo-tivo non stupisce ritrovare riferimenti ai documenti conciliari in numerosissimi punti della preghiera, sebbene poi si debba cercare di comprendere quali tra essi possano essere considerati davvero una fonte letteraria. Qui ci si sofferma non sulla prima parte della formula (invocazione, anamnesi1 e anamnesi2), che non ha riscontro immediato nei testi magisteriali – se non per riprendere affermazio-ni bibliche già evidenziate –, ma principalmente sulle parole che descrivono il mistero pasquale (anamnesi3) e sull’epiclesi.
In totale abbiamo citazioni/allusioni a Lumen gentium – LG (8), Ad gentes – AG (5), Sacrosanctum Concilium – SC (2), Mystici corporis (2), Apostolicam actuositatem – AA (2), Unitatis redintegratio – UR (2). È presente anche un ri-ferimento ai documenti Dei Verbum – DV, Gaudium et spes – GS, Gravissimum educationis – GE e Presbyterorum ordinis – PO.
A) sacramentorum auctor
2) Le parole con cui l’incipit della formula si rivolge a Dio sono una citazio-ne precisa di Ambrogio di Milano, l’unico tra i Padri latini che utilizza questa espressione. La si ritrova nel libro IV de sacramentis capitolo III,1025, dove a pro-posito della anteriorità dei sacramenti cristiani rispetto ai misteri giudaici si par-la di Melchisedek, definito auctor sacramentorum perché tipo di Cristo; e anche al capitolo IV,1326, dove si applica l’espressione direttamente a Gesù Cristo. Lo stesso avviene in Tommaso d’Aquino, nella trattazione sulla confermazione27. Ruperto di Deutz invece utilizza il termine non per Cristo, ma per lo Spirito Santo, nel X libro del suo De divinis officiis al capitolo 1828.
B) ineffabili pietati
1) La pietas di Dio si ritrova in Is 11,2 che rimanda allo Spirito del virgulto del tronco di Iesse; l’altro neotestamentario in 1Tim 3,16, dove si parla del pie-tatis sacramentum, il piano eterno che Dio ha manifestato in Gesù.
25 Cf. Ambrosius, Des sacrements, IV, III, 10, ed. B. Botte (Sources Chrétiennes 25bis), Cerf, Paris 1961, 106.
26 Cf. Ambrosius, Des sacrements, ed. B. Botte (SCh 25bis), 108.27 Cf. Tomas Aquinas, La somma teologica, III, 72,1,4, vol. 27, Edizioni Studio Domeni-
cano, Bologna 1984.28 Cf. Rupertus Tuitiensis, De divinis officiis, X,18, ed. H. Haacke (Corpus Christiano-
rum Continuatio mediaevalis 7), Brepols, Turnholti 1967, 354.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
202
3) È possibile fare riferimento a due orazioni di GeV (confluite identiche in GrH) per le liturgie dell’ottava della Pasqua, GeV 485 (GrH 446) e GeV 516 (GrH 451). L’eucologia parla qui di pietatis tuae ineffabile sacramentum, che – pur non identico sintatticamente alla nostra espressione di partenza – si riferisce alla Chiesa, rinnovata e implementata dai neofiti.
C) sanctificationis olei mysterium
1) Nel libro dell’Esodo l’olio è spesso accostato all’azione santificatrice: vie-ne creato con arte di profumiere proprio per essere sanctificationis unguentum in Ex 37,29, usato per rendere puro l’altare (Ex 29,36), per consacrare luoghi e oggetti del culto e il sommo sacerdote (Ex 30,25-32).
2) Una simile espressione è in Ambrogio29: non una fonte, ma un possibile testo ispiratore, dal momento che si parla di coloro che sono stati privilegiati per l’ammissione ai sacramenti e cioè accolti alla mensa eucaristica, dove ricevono anche l’oleum sanctificationis.
D) ubi venit temporum plenitudo
1) Si tratta della citazione – sebbene non letterale – di Gal 4,4, che dice la venuta del Figlio nel mondo, per il quale viene partecipata all’uomo l’adozione filiale. C’è anche un rimando a Eph 1,10 sul piano eterno di Dio in dispensatione plenitudinis temporum.
E) in dilecto Filio tuo
1) L’espressione rimanda alla figura dello sposo del Cantico dei Cantici30 e a quella del padrone della vigna di Is 5,1 (da leggere in parallelo al figlio del pa-drone, descritto da Gesù nella parabola dei vignaioli omicidi di Lc 20,13), come anche alla teologia giovannea del rapporto confidenziale tra il Padre e il Figlio, a Mt 12,18, e a Col 1,13. L’espressione cita poi diversi passi: il battesimo di Gesù31, la trasfigurazione32, Ef 1,6 che parla del divino disegno dell’adozione filiale.
29 Cf. Ambrosius, Explanatio Psalmorum XII, Ps. 35, 19, 2, ed. M. Petschenig (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 64), Vindobonae 1999, 63.
30 Cf. ad esempio Ct 1,12 e 5,1, nei quali si dice anche del profumo dello sposo.31 Cf. Mt 3,17; Mc 1,11; Lc 3,22. 32 Cf. Mt 17,5 e Lc 9,35. Si veda anche 2Pt 1,17.
Luca Girello
203
F) paschali sacramento
3) La centralità del sacramentum paschale – espressione di Leone Magno33 – ricorre in numerosissime antiche orazioni, che non è possibile elencare. Esse non costituiscono forse una fonte diretta della nostra orazione, ma possono essere con-siderate come il background, su cui anche la liturgia post-conciliare si è costruita.
G) caelestibus muneribus
1) Non possiamo parlare di una fonte biblica di queste parole. C’è però una curiosità, forse non estranea alla nostra analisi: il termine caelestibus in tutta la Vulgata ha cinque uniche occorrenze, collocate solo nella Lettera agli Efesini. Di tutte è bene sottolineare Eph 1,3, che parla della benedizione “spirituale” ri-cevuta in caelestibus in Christo, suggerendo un collegamento coi soprannaturali muneribus, di cui Dio ha arricchito la Chiesa.
H) ut salutis opus in mundo compleretur
1) Nella Bibbia l’accostamento tra il verbo complere e il sostantivo opus non è ovvio34. C’è però un versetto, teologicamente impegnativo, in cui gli stessi ter-mini sono sbilanciati verso il significato di “compimento”: si tratta di Gn 2,2 (complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat).
4) Le fonti magisteriali di tutta la prima parte dell’orazione fino a complere-tur sono diverse. Riecheggia anzitutto il globale sguardo di Dei verbum 1735 che invita a riconoscere l’ampiezza del mistero pasquale, che costituisce l’opera per eccellenza, portata a compimento (complevit). Poi un passo36 della Mystici Cor-poris di Pio XII sottolinea l’aspetto pneumatologico della pasqua. Entrando più in profondità nelle allusioni magisteriali: Lumen gentium 937 parla dei mezzi di
33 Cf. Leo Magnus, Tractatus septem et nonaginta, 45,2; 47,1; 50,3; 55,5; 65,2; 70,6; 71,1; 72,1, ed. A. Chavasse (Corpus Christianorum. Series latina 138 A), Brepols, Turnholti 1973.
34 Cf. ad esempio Gn 11,16; Ex 5,13; Nm 11,23; Dt 30,12; Ios 22,5; solo per esprimere il concetto di “conservare il proposito”.
35 «Christus […] morte, resurrectione et gloriosa ascensione missioneque Spiritus Sancti opus suum complevit», Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Constitu-tio dogmatica de divina revelatione Dei Verbum (18 novembris 1965) 17», AAS 58 (1966) 826.
36 «[…] Redemptoris nostri Spiritus est, qui ceu fons gratiarum, donorum, ac charismatum omnium, perpetuo et intime Ecclesiam replet et in ea operatur», Pius XII, «Litterae encyclicae Mystici corporis Christi», AAS 35 (1943) 223.
37 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Constitutio dog-matica de ecclesia Lumen gentium (21 novembris 1964) 9», AAS 57 (1965) 14.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
204
cui Cristo ha dotato (instruxit) la Chiesa; al n. 3438 usa ancora il verbo instruere, collegandolo con l’avverbio mirabiliter, come accade anche nella nostra formula, dopo aver indicato i battezzati come unti dallo Spirito e così partecipi del munus sacerdotale; Sacrosanctum concilium 639 parla di apostoli colmati (repletos) dello Spirito e inviati ad annunciare il mistero pasquale, portando avanti l’opus salu-tis; Gaudium et spes 3240 non utilizza le medesime espressioni del nostro testo e tuttavia si assesta senza dubbio sulle stesse aree semantiche della nostra formula, specialmente quelle dell’epiclesi; Ad gentes 741 parla del salutare opus di Dio, che viene portato avanti e completato per mezzo della Chiesa (per eam completur), perché tutto l’humanum genus possa diventare un solo corpo di Cristo e crescere nell’unità; AG 442 accenna al fatto che il salutiferum opus che Cristo opera per mezzo dello Spirito ha come scopo la dilatatio della Chiesa.
I) sacro chrismatis mysterio
2) Un’allusione abbastanza precisa è riscontrabile in Pier Damiani, che nel suo Sermo 10 In Cena Domini parla diffusamente del crisma e dei sacramenti della Chiesa. Utilizza in più occasioni mysterium chrismatis43 e il suo sinonimo chrismatis sacramentum.
L) divitias gratiarum tuarum
1) Nella ricerca lungo tutto il testo della Vulgata la fonte dell’accostamento di divitiae e di gratia è unicamente la Lettera agli Efesini. In 1,7 si ha la remissio-ne dei peccati e la salvezza ottenuta secundum divitias gratiae eius. Eph 2,7 dice l’eccedenza della misericordia di Dio verso gli uomini, o meglio verso i credenti che sono diventati partecipi di Cristo mediante la condivisione del suo mistero
38 Cf. Concilium Vaticanum II, «Lumen gentium (21 novembris 1964) 34», AAS 57 (1965) 40.
39 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Constitutio de sa-cra liturgia Sacrosanctum Concilium (4 decembris 1963) 6», AAS 56 (1964) 100.
40 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Constitutio pa-storalis de ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes (7 decembris 1965) 32», AAS 58 (1966) 1051.
41 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Decretum de acti-vitate missionali ecclesiae Ad gentes (7 decembris 1965) 7», AAS 58 (1966) 956.
42 Cf. Concilium Vaticanum II, «Ad gentes (7 decembris 1965) 4», AAS 58 (1966) 950.43 Cf. ad esempio Petrus Damiani, Sermones, X, 4, ed. I. Lucchesi (Corpus Christianorum
Continuatio mediaevalis 57), Brepols, Turnholti 1983, 51-52.
Luca Girello
205
pasquale: chi è con-resuscitato con Lui, con-siede nei cieli e quindi manifesta le abundantes divitias gratiae suae.
M) hominibus ita dispensas
1) Il verbo dispensare non è riscontrabile nelle Scritture. Esiste il sostantivo dispensatio, che ha per soggetto sottinteso Dio solamente in quattro passi; due di questi ci interessano e sono entrambi nella Lettera agli Efesini (1,10; 3,9): parlano del sacramentum di Dio, nascosto nell’eternità, presente nella creazione, manifestato con la volontà di ricondurre a Cristo tutto ciò che esiste.
3) Sebbene non una fonte letteraria del nostro testo, la benedizione nuziale può essere assunta come una fonte liturgica abbastanza sicura. Leggiamo infatti in GeV 1446 (GrH 835) che Dio nel suo piano provvidenziale e per mezzo della sua grazia ha disposto (dispensat) un duplice effetto al matrimonio: che la gene-razione carnale arricchisca il mondo e che la rigenerazione in Cristo conduca ad un aumento della Chiesa (regeneratio ad ecclesiae perducat augmentum).
N) baptismatis lavacro renati
1) Renascor è utilizzato tre volte nel dialogo con Nicodemo (Io 3,3-5) e dalla prima Lettera di Pietro 1,23. Lavacrum è usato da Eph 5,26 e dalla Lettera a Tito 3,5, dove – con più attinenza con il nostro studio – si dice la piena dedizione di Cristo alla sua comunità come quella dello sposo per la sua consorte, amore estremo che porta alla piena trasformazione della Chiesa.
O) Christo tuo conformes effecti
1) Abbiamo qui un’allusione a Rom 8,29, in cui si parla della predestinazio-ne dei fedeli a trasformarsi nella medesima forma del Figlio.
3) La liturgia romana presenta la stessa affermazione nell’azione liturgica pomeridiana del venerdì santo, quando la colletta che apre la celebrazione della passione e morte del Signore chiede di diventare conformi a Cristo, per portar-ne l’immagine. Si tratta di GeV 398, poi confluita nei messali plenari e giunta fino all’epoca recente.
4) Ci sono almeno due riferimenti conciliari che utilizzano le stesse parole, tra l’altro in contesti che ruotano attorno alla figura dei laici. Apostolicam ac-tuositatem 1644 ricorda a tutti i battezzati che, anche attraverso l’esercizio del
44 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Decretum de apo-stolatu laicorum Apostolicam actuositatem (18 novembris 1965) 16», AAS 58 (1966) 852.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
206
culto pubblico della Chiesa, ciascuno si conforma al Cristo “paziente” (Christo patienti conformes efficiuntur). LG 4045 poi, parlando della generale santità della Chiesa che a poco a poco cresce, ricorda che ogni fedele segue le orme di Cristo e si conforma così alla sua immagine (eiusque imagini conformes effecti).
P) eius propheticum, sacerdotale regaleque munus participent
3) Il triplice munus viene introdotto nell’eucologia romana unicamente da GeV 378, ovvero dalla prima formula del crisma, da cui anche la seconda ha pre-so le mosse.
4) Lo stesso triplice munus cristiano proprio di tutti i battezzati – al di là dei testi in cui è descritto nei singoli aspetti – è definito come un unicum in LG 3146 (de munere Christi sacerdotali, prophetico et regali suo modo participes facti) e in AA in modo particolare il n. 247.
Q) haec aromatis et olei commixtio fiat nobis
1) La mistura di olio e aromi è descritta in Esodo 30,22-25 e definita unguen-tum compositum. Questi versetti tuttavia non possono essere considerati fonte letteraria della formula, la quale può essere invece pensata come un’allusione alla narrazione della sepoltura di Gesù: in Io 19,39 si legge infatti che Nicodemo portò una mixturam murrae et aloes per il corpo del Signore.
R) hac unctione conspersos
1) Nella Vulgata il verbo conspergere è presente a proposito dei sacrifici dell’An-tico Testamento, o meglio delle oblazioni fatte con farina/pani. Solo due ver-setti uniscono conspergere, unctio e oleum: Nm 6,15 (specifico sul nazireato) e soprattutto Lv 7,12, dove il concetto viene ribadito tre volte in un solo versetto. Questo potrebbe essere una fonte della terminologia della formula.
45 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Constitutio dog-matica de ecclesia Lumen gentium (21 novembris 1964) 40», AAS 57 (1965) 45.
46 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Lumen gentium (21 novembris 1964) 31», AAS 57 (1965), 37.
47 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Apostolicam actuo-sitatem (18 novembris 1965) 2», AAS 58 (1966) 838.
Luca Girello
207
S) sancti Spiritus dona
2) Dell’utilizzo di questa espressione ci sono esempi molto interessanti in Beda il Venerabile. Nel Commento al Cantico dei Cantici nel libro I, capitolo 148 a pro-posito di Ct 1,1349 descrive l’origine e l’utilizzo del crisma, legato alla figura dello Sposo; per mezzo della sua carne ricolma dello Spirito, concede i suoi doni ai cre-denti. Ancora, nel commento al vangelo di Marco, al capitolo 14 del libro IV50, interpreta la salita al monte degli ulivi dopo la cena pasquale come il typos della elevazione degli uomini agli altissimi doni dello Spirito mediante i sacramenti.
Pier Damiani nell’omelia In Cena Domini di cui si è detto, ovvero all’interno del commento sul crisma, fa riferimento in tre occasioni ai doni dello Spirito51, parlando del mistero dell’unità della Chiesa52 e collegando doni e olio53.
4) Poiché si parla di larga effusione dei doni dello Spirito, sembra esserci un’allusione a LG 754, che li riferisce alla ricchezza di Dio dispensatore di tali doni. A suffragare questa ipotesi sta anche il fatto che qui si fa riferimento all’e-dificazione della Chiesa.
T) loca vel res, sacris oleis signata, splendore sanctitatis exorna
3) Il verbo exornare ha almeno quattro ricorrenze del tutto simili nel Ve55, nelle quali – non a caso – il termine viene sempre collegato con la santità, che diventa ornamento del corpo della Chiesa.
U) ecclesiae tuae perfice augmentum
1) Il vocabolo augmentum riferito alla Chiesa ha chiare ascendenze bibliche, riscontrabili nella teologia paolina del corpus, ovvero in Eph 4,16 e in Col 2,19,
48 Cf. Beda Venerabilis, In Cantica canticorum libri VI, I,1,2, ed. D. Hurst (Corpus Chri-stianorum. Series latina 119B), Brepols, Turnholti 1983, 192.
49 Cf. Beda Venerabilis, In Cantica canticorum, I,1,13, ed. D. Hurst (CCL 119B), 206.50 Cf. Beda Venerabilis, In Marci evangelium expositio, IV,14,26, ed. D. Hurst (Corpus
Christianorum. Series latina 120), Brepols, Turnholti 1960, 613.51 Cf. Petrus Damiani, Sermones, X,3, ed. I. Lucchesi (Corpus Christianorum Continua-
tio medievalis 57), Brepols, Turnholti 1983, 51.52 Cf. Petrus Damiani, Sermones, X,6, ed. I. Lucchesi (CCCM 57), 53.53 Cf. Petrus Damiani, Sermones, X,7, ed. I. Lucchesi (CCCM 57), 53-54.54 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Lumen gentium
(21 novembris 1964) 7», AAS 57 (1965) 10.55 Cf. Ve 98, Ve 285, Ve 676, Ve 682.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
208
chiara fonte letteraria della nostra formula. La radice verbale dello stesso vocabo-lo (augere) è rintracciabile in alcuni passi dell’Antico Testamento, che riportano augurio e benedizione per Israele, per chiedere la crescita numerica del popolo di Dio, come in Gn 47,27 e 48,4, in Ps 104,24 (versione dalla LXX) e in 1Par 21,3. Negli Atti degli Apostoli56 anche per il nuovo popolo di Dio si usa lo stesso verbo, non più però per indicare il desiderio della crescita, bensì per constatarla: è cosa in atto per opera di Dio stesso.
2) Il termine augmentum dalla patristica e dai medievali è utilizzato rarissima-mente. È presente in Cesario di Arles, che in un suo sermone sull’episodio biblico del profeta Eliseo presso una vedova (cf. 2Re 4,1-7) dice che la vedova che versa l’olio nei vasi dei vicini diventa il simbolo della Chiesa che mediante l’augmen-tum olei diffonde la carità anche alle genti pagane e così ottiene salvezza per sé e la conversione delle genti. Esse nel battesimo et crismam et oleum benedictionis accipiunt, ut iam non vasa vacua, sed deo plena, et templum dei esse mereantur57. C’è quindi un legame tra l’aumento dell’olio e l’aumento della Chiesa, tra la carità diffusa e i sacramenti dell’iniziazione. Un secondo esempio patristico si trova nel commento al Cantico dei Cantici di Apponio, il cui libro VIII, capitolo 5658, parla dell’augmentum ecclesiae, chiamata “corpo di Cristo”.
3) L’aumento della Chiesa è un tema piuttosto caro all’eucologia antica, so-prattutto attorno agli eventi pasquali (cf. ad esempio GeV 510 e Ve 217). La ri-chiesta del perfezionamento della compagine ecclesiale è testimoniata anche da altri particolari formulari. Oltre a quello della benedizione nuziale di GeV 1446 e GrH 835, già visto in precedenza, si può citare la preghiera di ordinazione del diacono di GrH 32 (= GeV 152 e Ve 951), per cui la Chiesa cresce nell’accrescersi del tempio e delle sue funzioni, per mezzo dei ministeri. Parimenti è interessante notare come la stessa tematica si ritrovi espressa con la richiesta ut merito et numero populus augeatur a riguardo del ministero presbiterale, collegato con il giovedì san-to (GeV 375) o con la celebrazione dell’anniversario dell’ordinazione (GeV 1373).
4) Già la Mystici corporis59 ha sottolineato con forza, sulla scorta della patri-stica e della scolastica, che – per la comunicazione dello Spirito – tutto ciò che è
56 Act 2,47: «Dominus autem augebat qui salvi fierent quotidie in idipsum». Act 5,14: «Magis autem augebatur credentium in Domino multitudo virorum ac mulierum».
57 Cf. Caesarius Arelatensis, Sermones, CCXXIII, 1-2, ed. G. Morin (Corpus Christia-norum. Series latina 103), Brepols, Turnholti 1953, 528.
58 Cf. Apponius, In canticum Canticorum expositio, VIII, 56, ed. B. de Vregille - L. Neyrand (Corpus Christianorum. Series latina 19), Brepols, Turnholti 1986, 205.
59 Cf. Pius XII, «Litterae encyclicae Mystici corporis Christi (29 iunii 1943)», AAS 35 (1943) 230-231.
Luca Girello
209
nel capo passa alle membra, in modo tale che la Chiesa intera sia costituita come la pienezza e il completamento del Redentore. Pio XII non usa qui il termine augmentum, ma il senso del passo è piuttosto chiaro e l’utilizzo del verbo per-ficere ci rende persuasi che siamo in presenza di un documento conosciuto dall’estensore della nostra formula. LG 860 poi fa un paragone tra il mistero dell’incarnazione e il mistero della Chiesa; il fine è la crescita della Chiesa tutta intera (ad augmentum corporis inservit), unico corpo di Cristo terreno e celeste. Infine Gravissimum educationis 261 dice che i figli di Dio maturano per mezzo anzitutto dell’azione liturgica e perseguono il loro compimento, ovvero il rag-giungimento dell’uomo perfetto in aetatem plenitudinis Christi e il contributo all’augmentum del suo corpo.
V) donec ad illam plenitudinis crescat mensuram
1) Si tratta di una citazione quasi letterale di Eph 4,13, sempre all’interno della teologia della Chiesa-corpo di Cristo, di cui Paolo sta insegnando l’unità. Al fine della aedificationem corporis Christi ciascun credente ha la sua parte. Al-tri rimandi biblici in Eph 1,10 dove la pienezza della dispensatio divina è nella riconduzione di tutte le cose a Cristo, e in Eph 1,23 che, riconoscendo Cristo capo della Chiesa, dice questa plenitudo eius dentro il compimento di tutte le cose (omnia in omnibus).
3) Questa espressione della nostra formula ha anche una fonte liturgica. Si tratta della preghiera di ordinazione dei presbiteri di GeV 148, che collega il ministero ordinato con il diuturno lavoro di trasformazione sacramentale delle realtà terrene.
4) Le parole conclusive dell’epiclesi ricorrono spesso nei testi magisteriali, in: SC 262 (la liturgia compie l’edificazione della Chiesa), LG 1363, LG 1764, AG
60 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Lumen gentium (21 novembris 1964) 8», 11.
61 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Declaratio de edu-catione christiana Gravissimum educationis (28 octobris 1965) 2», AAS 58 (1966) 730.
62 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Sacrosanctum Concilium (4 decembris 1963) 2», 98.
63 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Lumen gentium (21 novembris 1964) 13», 17-18.
64 Cf. Concilium Vaticanum II, «Lumen gentium (21 novembris 1964) 17», 21.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
210
965, AG 3666. AG 3967 è specifica sul ministero presbiterale: esso è dedicato al servizio dell’eucaristia, che porta a compimento (perficit) la Chiesa, e pertan-to non può non sentire quanto ancora manca alla pienezza del compimento, quanto si debba ancora crescere (allo stesso modo si veda Presbyterorum ordinis 2268). Infine resta da citare Unitatis redintegratio: il paragrafo 269 dice che per la predicazione del vangelo e per l’amministrazione dei sacramenti – dato estrema-mente importante per il nostro discorso – Dio vuole che il suo popolo cresca e che la comunione al suo interno si completi (perficit) nella piena unità; Unitatis Redintegratio 370 ribadisce che il popolo cresce in Cristo fino al raggiungimento del suo compimento (usquedum ad totam aeternae gloriae plenitudinem) nella Gerusalemme celeste.
3 Elementi teologici emergenti dal testo della Formula
Dall’analisi compiuta si possono evincere alcuni elementi di teologia litur-gica che concorrono a leggere in profondità l’intenzione della Chiesa, quando prega sul crisma e lo utilizza.
Poiché la seconda formula è complementare alla prima, gli elementi teologi-ci che qui vengono presentati non esauriscono di certo l’argomento71. Tuttavia anche questi vanno presi in seria considerazione, perché emergono allo stesso modo dalla lex orandi della Chiesa.
65 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Ad gentes (7 de-cembris 1965) 9», 958.
66 Cf. Concilium Vaticanum II, «Ad gentes (7 decembris 1965) 36», AAS 58 (1966) 983.
67 Cf. Concilium Vaticanum II, «Ad gentes (7 decembris 1965) 39», AAS 58 (1966) 986.
68 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Decretum de presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis (7 decembris 1965) 22», AAS 58 (1966) 1023.
69 Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Decretum de oe-cumenismo Unitatis redintegratio (21 novembris 1964) 2», AAS 57 (1965) 92.
70 Cf. Concilium Vaticanum II, «Unitatis redintegratio (21 novembris 1964) 3», 94.71 «Le Consilium étudiait une refonte plus profonde de l’antique Ordo romain. Il ne s’agissait
pas seulement d’en réviser le formulaire, mais de réfléchir sur la théologie de l’onction chrismale, de voir comment cette onction exprime le don de l’Esprit et la configuration au Christ […] S’il n’apporte pas la réponse à toutes les questions soulevées par les rites d’onction dans la liturgie des sacrements, du moins les théologiens peuvent-ils y alimenter leur réflexion et les pasteurs en éclairer leur action», Jounel, «La consécration du chrême et la bénédiction des saintes huiles», 70.71.
Luca Girello
211
3.1 L’augmentum ecclesiae è il centro della formula
Certo, assumere tutti i dati teologici che emergono da un testo non breve come quello in esame, potrebbe diventare un’operazione lunga e infeconda e facilmente scadere in una lista di tematiche più o meno coerenti. Non è quello che si vuole operare qui, desiderando invece tracciare un percorso teologico uni-tario. Così, poiché durante l’analisi dei capitoli precedenti si è compreso che una lettura principalmente ecclesiologica della nostra formula è possibile e auspica-bile, si è imposta in modo sempre più evidente l’espressione ecclesiae tuae perfice augmentum. Essa, come si era intuito fin dall’inizio, può essere presa come la chiave di volta dell’intera seconda preghiera di consacrazione del crisma. Rap-presenta, infatti, il culmine delle richieste dell’epiclesi e la motivazione della dos-sologia conclusiva; procedendo poi a ritroso, si evidenzia come il punto di arrivo del mistero del crisma, delineato a cerchi concentrici lungo la totalità dell’anam-nesi; inoltre essa è sussurrata anche dall’incipit e viene quindi fin da subito inglo-bata nel generale moto di gratitudine della formula.
Insomma, s’intende ora prendere come criterio teologico “l’aumento della Chiesa” e vedere come esso venga sviluppato all’interno delle sezioni della nostra preghiera, perché in quello è possibile ravvisare il motivo per cui il rito romano chiede a Dio il crisma.
Per ordinare meglio il discorso si è scelto di utilizzare un andamento trinita-rio72, gravitando principalmente attorno alla figura del Padre nell’invocazione, attorno a quella del Figlio nell’anamnesi e attorno a quella dello Spirito nell’ epiclesi, sebbene resti chiara l’unicità dell’economia salvifica e l’intreccio delle operazioni personali.
3.2 Epiclesi e dossologia chiedono l’augmentum ecclesiae
Partiamo proprio dalla parte sull’augmentum ecclesiae, quale fonte d’irradia-zione del motivo ecclesiologico di tutta la preghiera. Perciò si considera anzitut-to l’epiclesi, che contiene oltre all’invocazione dello Spirito Santo anche i vari effetti che l’orazione gli chiede di operare.
L’effetto principale (segnalato dall’in primis della formula) è il culmine delle altre richieste e diventa pure il collegamento (segnalato dal qua relativo) con la dossologia conclusiva. Esiste quindi un complesso di operazioni peculiari, su-
72 G. Ferraro aveva detto che l’orazione è tutta “incentrata” sulla Trinità: cf. Ferraro, «La seconda formula della consacrazione del crisma», 129. Pur nell’eccessività di questa espressione, tuttavia si deve ammettere che è possibile riconoscere nel testo la netta presenza delle tre Persone, sebbene non a compartimenti stagni.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
212
scitate dalla formula e realizzate dallo Spirito, che alimentano incessantemente l’identità e la qualità della Chiesa, fino al raggiungimento di una perfezione tale, per cui la storia raggiunge la sua acme ed entra finalmente nella sua pienezza escatologica.
3.2.1 Lo Spirito è nel crisma: sacramentum benedictionis
Al fine di completare la Chiesa, oggetto e apice dell’epiclesi e della dossolo-gia – mediante l’olio profumato (huius unguenti mysterio) – è lo Spirito il primo protagonista, invocato sul crisma perché la sua opera raggiunga anche le persone (hac unctione conspersos), le cose e i luoghi (sacris oleis signata). Si vede l’insisten-za con cui l’unzione crismale viene ribadita per ben tre volte, a sottolineare la perfetta interdipendenza tra crisma e Spirito73; sembra quasi che la preghiera ci dica che l’uno non può restare senza l’altro.
In effetti, osservando la prima formula del crisma, notiamo che la tradizio-ne ha chiesto per secoli che la benedizione divina scendesse sul crisma. Nella nuova formula invece c’è qualcosa di più: si chiede che la potenza della grazia divina (per tuae gratiae virtutem, ovvero lo Spirito dynamis divina) trasformi la mistura di olio e profumo nel benedictionis sacramentum. Non scende la be-nedizione sul crisma, ma esso stesso diventa benedizione: l’elemento naturale diventa segno strumento e presenza dell’intervento potente e grazioso di Dio, tanto che dove viene usato il crisma, lì lo Spirito è presente, è operante, è tra-sformante.
Il crisma diventa dunque sacramento74. Ciò che tocca, secondo l’intenzione della Chiesa diventa sacramento a sua volta, perché laddove lo si usa, lo Spirito è presenza efficace e la sua opera continua, la stessa opera che il Nuovo Testa-mento ha rivelato: mostrare la verità tutta intera, ovvero rendere presente Cristo stesso. Il crisma infatti rende presente Cristo nelle realtà per le quali viene usato.
73 Riteniamo perciò del tutto infondata la posizione di A. Rose (cf. A. Rose, «La significa-tion de la messe chrismale», Questions Liturgiques 69 (1988) 57). La formula non è per nulla vaga e, anzi, il rapporto tra Spirito e crisma risulta profondissimo, anche grazie agli effetti menzionati.
74 Già Agostino parlando ai neofiti dice che i cristiani ricevono l’acqua nel battesimo e il fuoco mediante l’olio, che è sacramento dello Spirito (Quid ergo significat ignis, hoc est chrisma olei? Etenim ignis nutritor Spiritus Sancti est sacramentum), cf. Augustinus, Discorsi, vol. 4/1, Sermo habitus die sancto Paschae ad infantes de Sacramentis 227, Città Nuova, Roma 1984, 386. Nella Liturgia delle Ore in traduzione italiana inoltre si trova un’espressione dell’inno del tempo pasquale dopo l’ascensione, che chiama lo Spirito Santo direttamente con il nome di “crisma”: «Dagli splendori eterni / scende il crisma profetico / che consacra gli apostoli / araldi del vange-lo», Ufficio Divino rinnovato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Paolo VI, Liturgia delle Ore secondo il rito romano, vol. 2, LEV, Città del Vaticano 1989, 850.
Luca Girello
213
Tali realtà sono molto concrete75, ovvero i cristiani e poi anche l’altare, la chiesa-edificio, i vescovi e i presbiteri. La concretezza materiale di persone-cose-luoghi viene assunta a portatrice di realtà celesti e il mistero stesso di Dio la penetra, per “consacrare” queste realtà alla nuova identità cristiana. La formula sta dunque descrivendo una dimensione sacramentale molto ampia, allude alla sacramen-talità dell’intera realtà ecclesiale, traducendo in termini eucologici l’impianto teologico del Concilio Vaticano II.
3.2.2 Lo Spirito suscita un solo corpo ecclesiale di Cristo
Se lo scopo del dono del crisma alla Chiesa è perché vi possa vedere il bene-dictionis sacramentum per il fine del suo aumento, dobbiamo ora soffermarci su questa finalità. Cosa significa in modo più approfondito l’augmentum ecclesiae secondo il dettato della formula?
Anzitutto notiamo che la “creatura dell’olio” viene chiamata commixtio, un termine che rimanda alla mixtura che Nicodemo portò per la sepoltura del Si-gnore (cf. Io 19,39) e che dirige subito la memoria alle parole stesse di Gesù sul preziosissimo unguento profumato sparso da Maria sui suoi piedi (cf. Io 12,7). La mistura di olio e profumi è per il corpo del Signore, offerto alla morte per i suoi. Il crisma di cui si chiede la benedizione con queste parole, è esattamente per la stessa finalità: è destinato al corpo del Signore, ovvero alla sua Chiesa. E come quell’unguento serviva a onorare il corpo di Gesù, come gesto di affetto perché potesse sentire l’amore dei suoi nell’affrontare il viaggio attraverso la morte, così il crisma sparso sul corpo ecclesiale significa l’amore che unisce la sorte del capo alla sorte delle membra, immerse nella stessa morte del Signore, con-sepolte in-sieme a Lui, per poter camminare anche nella sua vita (cf. Rom 6,3-4).
Questo corpo dunque è costituito da uomini e donne resi un’unica cosa proprio nel segno dell’olio. Ciò è dimostrato dal fatto che essi sono detti con-spersos di crisma, ovvero come avvolti interamente, che – pur potendo ricor-dare il tradizionale concetto dell’unzione di tutta la persona, significata dalla testa, su cui ognuno singolarmente riceve l’unzione – tuttavia, in verità, lascia più profondamente intuire la realtà di un unico corpo collettivo unto. Infatti le parole usate dalla formula rimandano a quelle di Lv 7,12 sull’offerta della “vittima” di comunione (lex hostiae pacificorum) offerta per il rendimento di grazie: questo sacrificio – non altro che pane azzimo – viene cosparso di olio.
75 «Con l’incarnazione la presenza di Dio, più che pensata e interiorizzata spiritualmente, va trovata materialmente e toccata sensibilmente nell’esteriorità. Il primato non è della riflessione, ma dell’incontro e del racconto della corporeità del Logos che è Gesù», G. Busani, «Corpi chiamati a formare un corpo», in Assemblea santa, ed. G. Boselli, Qiqajon, Magnano 2009, 40.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
214
Interessante notare la profonda analogia nascosta in questo versetto. L’analo-gia tra il sacrificio antico e quello di Cristo (che assume in sé e spiega tutte le tipologie sacrificali dell’antica alleanza, come descrive la Lettera agli Ebrei) e tra l’incruenta vittima di pane offerta per la comunione degli uomini con Dio e l’eucaristia (pane e corpo del Signore) è la stessa analogia presente tra Cristo/eucaristia e la Chiesa. Anch’essa, comunità concreta di uomini e donne viventi qui e ora, come fosse un unico pane azzimo, si offre sull’altare. Anch’essa deve essere prima cosparsa di crisma, in modo tale che ricevendo l’eucaristia, sacra-mento di pace (hostia pacificorum), la Chiesa stessa diventi sempre più il corpo del Signore, pure lei sacramento di pace per se stessa (unità interna) e per tutti gli uomini (segno di unità)76.
La pace e l’unità sono due elementi pressantemente ribaditi anche dalla Lettera agli Efesini77, una delle principali fonti scritturistiche della nostra for-mula. Alla base di tutta la dinamica ecclesiologica della preghiera c’è infatti la teologia paolina del corpo di Ef 4, la quale insiste a ripetere le parole «uno solo» per tutta la realtà divina ed ecclesiale. Per mezzo del vincolo della pace si conserva l’unità dello Spirito e delle membra, tutte impegnate nel tendere ad consummationem, all’uomo perfetto che è Cristo, compimento di ogni cosa. Qui si esprime l’augmentum che il crisma sostiene e porta a compimento.
La stessa teologia è stata ripresa e approfondita anche da Mystici Corporis e da Lumen gentium 8, fondamentali per la nostra formula. Pio XII sulla scorta della tradizione, soprattutto della dottrina agostiniana del Christus totus, ha ricordato che le membra derivano tutto dal capo e ne costituiscono la pienezza e il complemento, ne sono la perfectio. La Lumen gentium poi sulla scorta del magistero precedente ha instaurato una mirabile relazione tra l’indissolubile unità di umanità e divinità in Cristo e la medesima unione della compagine sociale della Chiesa con lo Spirito Santo: l’elemento divino vivifica e compie l’unificazione, in modo tale che le due realtà siano “uno solo”, distinte ma mai separabili.
Infine c’è un altro dato che meriterebbe molto più spazio e che qui ha in-vece soltanto un cenno molto veloce. Dalla teologia del corpo ecclesiale, così com’è presentato nella nuova formula del crisma, si apre anche un’altra pista di riflessione sulla teologia del laicato. I laici sono intesi dalla nostra preghiera
76 Fin dall’epoca patristica la comunione ecclesiale è stata più volte valutata e descritta con nomi diversi. «Ma il sinonimo più frequente è pace/pax/eirene, che implica benevolenza, alleanza, unione», E. Castellucci, La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia, Cittadella Editrice, Assisi 2008, 156.
77 Cf. Eph 2,14-18 e anche Eph 4,3 che apre la meravigliosa pericope sull’unità del corpo ecclesiale.
Luca Girello
215
non come un gruppo a sé, che deve ricevere una giustificazione particolare. Protagonisti sono considerati tutti i cristiani, senza specificazioni ulteriori78. Tutti i battezzati-crismati ammessi attorno all’unico altare, serviti dal ministe-ro ordinato, adombrati nel mistero della Chiesa-edificio, diventano a poco a poco e sempre più il corpo di Cristo, «il sacramento di pace», la Chiesa una-santa79. Sono essi in primo piano, chiamati dal vescovo semplicemente fratres nostros, posti come protagonisti della fede e della liturgia, oltre che dell’an-nuncio.
Siamo così dinanzi al mistero dell’unico popolo sacerdotale indiviso, consa-crato per via dei sacramenti a essere sacramento del Consacrato per eccellenza. Le vocazioni speciali si estraniano dal comune modo di essere cristiani solamen-te al fine di edificare quest’unico corpo ecclesiale; sono quindi esse che vanno come giustificate a partire dalla ordinaria dimensione del laicato80.
3.2.3 Il crisma suscita la risposta del corpo ecclesiale
Dalla teologia del corpo della Lettera agli Efesini impariamo anche che l’au-gmentum ecclesiae non è solo dono dall’alto, ma comporta che tutte le realtà ec-clesiali facciano la loro parte per corrispondere allo Spirito. La nostra formula infatti procede a evidenziare gli ambiti di applicazione del sacramento del crisma al fine dell’unità ecclesiale.
Introducendo una novità rispetto alla formula tradizionale, l’augmentum viene anzitutto collegato con la santità delle cose e dei luoghi, l’altare e la chiesa. Questi sono i luoghi in cui il corpo ecclesiale di Cristo si manifesta come “uno solo” agli occhi di una circoscrizione territoriale. La cattedrale e il suo altare sono il “sacramento” dell’unità della Chiesa locale: da loro prendono senso e a loro sono collegate tutte le comunità sparse nella diocesi con il loro edificio di culto e il loro altare. Le cose segnate con il crisma sono dunque connesse con le persone che le frequentano e dicono la concreta unità della Chiesa.
Perciò quando la formula concepisce queste cose come sante (splendore san-
78 «La messa crismale, proprio perché diretta alla consacrazione del crisma, celebra lo sta-tuto cristico-pneumatico del popolo di Dio, la sua articolazione carismatico-ministeriale. Tutti i battezzati, nessuno escluso, devono acquisire coscienza e tradurre operativamente il segno dell’un-zione, espressione ridondante del loro appartenere al corpo crismato di Cristo, alla sua Chiesa», Militello, La Chiesa “il corpo crismato”, 722.
79 Cf. Ufficio Divino rinnovato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e pro-mulgato da Paolo VI, Liturgia delle Ore secondo il rito romano, vol. 3, LEV, Città del Vaticano 1989, 1666.
80 Cf. Castellucci, La famiglia di Dio nel mondo, 574.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
216
ctitatis exorna), in realtà scopriamo che il crisma suscita la santità delle persone, che attorno all’altare e nella chiesa vengono convocate e radunate. Quanto più i cristiani vivono la realtà del crisma dato a loro, tanto più risplende la loro bel-lezza interiore, la loro santità; e quanto più i cristiani crescono in santità, tanto più la Chiesa cresce.
Questa santità poi non deve essere immediatamente riferibile ad una retta condotta morale o ad una perfezione umana: l’essere partecipi del triplice mu-nus non va visto in rifermento a compiti da svolgere, ma solo in relazione a quel Christo tuo conformes effecti. È importante anzitutto che ogni credente si senta parte di Cristo, o meglio che tutti siano della sua stessa forma, che tutti siano Cristo, perché già stati costituiti in Lui. La Chiesa aumenta nella santità, aumen-tando nell’unità, nella misura in cui si scopre corpo di Cristo e vive camminando secondo lo Spirito.
Tale identità ecclesiale, pur essendosi già realizzata per l’opera salvifica, tut-tavia non è mai acquisita una volta per tutte, ma deve essere costantemente rav-vivata. Così, la Chiesa intera e i singoli che la compongono sono invitati a per-correre due vie, una “solenne” e una ordinaria, entrambe – non a caso – associate all’opera del crisma.
Da un lato, la via “solenne” alla lettera è l’evento vissuto “una volta all’anno”, ovvero la consacrazione del crisma stesso nella ricca celebrazione corrispondente81, vera epifania della Chiesa locale. Esso viene consegnato alla Chiesa diocesana con ritmo annuale, per non rischiare di dimenticare il suo valore, associando sempre la ricezione del crisma all’unità della vita in Cristo, dei sacramenti, della comunità.
Dall’altro lato, la via ordinaria attraverso la quale il crisma ravviva l’identità di corpo ecclesiale di Cristo è costituita dai sacramenti e dalla liturgia in genere, che a più livelli operano l’augmentum ecclesiae. Il livello di base è costituito dai sa-cramenti che presuppongono l’uso del crisma. Sebbene ricevuti soltanto in modo singolare (due volte in tutta la vita82), tuttavia essi permangono continuativamente nell’esperienza di fede personale e comunitaria dei fedeli, tanto che la tradizione ha parlato del loro “carattere sacramentale” indelebile, che abilita i battezzati-crismati all’esercizio della loro appartenenza alla Chiesa. Non va taciuto che la base scrittu-ristica di questo “sigillo spirituale” è – non a caso – ancora una volta la Lettera agli Efesini (1,13; 4,30) insieme a 2Cor 1,22. Oltre a questo, che potremmo definire come il “background crismale” di ogni credente, c’è poi il vissuto sacramentale abi-
81 Cf. le considerazioni teologiche di Militello, La Chiesa “il corpo crismato”, 719; e anche di P. Sorci, «Il sacerdozio comune si manifesta e si realizza in pienezza nell’assemblea che cele-bra», Rivista Liturgica 97 (2010) 377.
82 Ovviamente, tre per i presbiteri e quattro per i vescovi.
Luca Girello
217
tuale, più volte ricordato anche dalle fonti della nostra formula; ad esempio diversi documenti conciliari83 mostrano che tutti i christifideles vivono normalmente la loro fede in Cristo mediante il culto pubblico. Il matrimonio poi è finalizzato a fare della coppia cristiana il luogo di promozione della generazione e della rigene-razione, che conduce ad un aumento della Chiesa84. Applicando Ef 4 ai diaconi e ai presbiteri, i sacramentari antichi indicano che i ministri sono proprio ordinati ad animare e a spronare la Chiesa a crescere come popolo di Dio85; idea che si ritrova allo stesso modo anche nel Concilio Vaticano II86.
3.2.4 Nel crisma lo Spirito presenta la Chiesa come sacramento di unità
Un’ultima valutazione va fatta infine sull’esito del discorso sull’augmentum ecclesiae, così come la dossologia conclusiva della nostra formula suggerisce. L’o-rizzonte è pienamente ecclesiale e riguarda il popolo di Dio, ma si apre necessa-riamente a tutti “quelli di fuori”. Anche le genti ancora non cristiane vengono inglobate nel grande dinamismo ecclesiale. Infatti l’opera del popolo sacerdo-tale, che diventa una cosa sola nel mistero del crisma, comporta la chiamata a ricondurre tutta l’umanità dispersa all’unità di un solo gregge e un solo Pastore. L’augmentum comporta che l’effusione dello Spirito raggiunga le genti perché siano piene di Dio, perché concorrano a loro volta all’unità, portando le loro peculiari ricchezze87.
3.3 L’anamnesi rivela l’augmentum ecclesiae
Passiamo ora alla sezione centrale della nostra formula. Poiché l’epiclesi co-mincia con un igitur, un nesso congiuntivo che trae le conseguenze dal discorso precedente, spiegando meglio o esemplificando quello che è stato già detto, si capisce che è pensabile e anche doveroso collegare strettamente l’epiclesi all’a-namnesi. Così facendo, il mistero dell’augmentum ecclesiae – attuato dallo Spiri-to – ha la possibilità di essere compreso e valutato anche alla luce della memoria dell’intera opera della salvezza, legata alla figura del Figlio, sebbene suscitata e condotta da tutta la Trinità.
83 Cf. AG 36, UR 2, GE 2.84 Cf. GeV 1146 (GrH 835).85 Cf. GrH 32 (= GeV 152 e Ve 951), GeV 375 e GeV 1373.86 Cf. AG 39 e PO 22.87 Cf. SC 2, AG 9 e LG 13.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
218
3.3.1 Il Figlio prepara la pasqua al fine dell’augmentum ecclesiae
Valutare l’anamnesi e la seconda Persona della Trinità alla luce dell’augmen-tum non è dunque un’operazione estranea all’intendimento della formula. Anzi, ci inseriamo così nel solco dei commentatori precedenti88, i quali confermano che la nuova orazione aggiunge ciò che la prima aveva tralasciato, ovvero l’aspet-to cristologico e quello ecclesiologico insieme, pensati a giusta ragione come il cuore della preghiera.
La figura di Cristo89, al centro delle quattro sezioni in cui abbiamo suddiviso l’anamnesi, anzitutto in Anamnesi1 viene preannunciata dalle ombre dell’Anti-co Testamento, secondo il metodo tipologico già applicato dalla teologia paoli-na90. Tale adumbratio è però solo accennata, come fa anche la preghiera bizantina sul myron, fonte della nostra orazione. Non è più necessario infatti soffermarsi a dire ciò che accadeva sotto la Legge, perché essa è soltanto preparatoria alla pie-nezza dei tempi. Così il Figlio ci dice come interpretare le unzioni antiche: esse lasciano il posto all’unzione nuova, al sanctificationis olei mysterium.
In che modo la formula presenta l’Unto? Come viene descritto il Figlio? Il testo è molto sobrio. Si parla solo del dono dello Spirito. Eppure c’è un partico-lare che apre una pista di riflessione molto più ampia di quanto non appaia a uno sguardo superficiale. Le parole della formula descrivono il Cristo soltanto con il titolo di Filius dilectus; un titolo però non indifferente, neppure generico, ma recante con sé innumerevoli rimandi biblici. Si segnalano qui i più importanti. Siamo in presenza del titolo con cui il Padre in persona chiama Gesù sia nella scena del battesimo al Giordano, sia in quella della trasfigurazione sul Tabor, sia nella parabola dei vignaioli omicidi, momenti chiave della rivelazione del Figlio, anche in riferimento alla sua crocifissione; inoltre Egli è il Figlio amato dal Padre, perché dà la vita per le sue pecore (cf. Io 10,14-17); e ancora, anche Paolo usa le stesse parole in Eph 1,6 dove descrive il disegno divino dell’adozione
88 Cf. Jounel, «La consécration du chrême et la bénédiction des saintes huiles», 77-78; Sorci, «La solenne benedizione del crisma in oriente e in occidente», 273; P. Zecchini, «Il simbolo dell’olio», Liturgia 37 (2003) 482; P. Sorci, «La benedizione dell’olio degli infermi nel contesto della messa crismale», 187.
89 In questa sede non si ripercorrono tutti i dati su Cristo che l’anamnesi ci lascia intendere, perché (a cinquant’anni di distanza dal Concilio) il dato cristologico – al contrario di quello pneu-matologico ed ecclesiologico – è ormai entrato pienamente e profondamente nella mens teologica della Chiesa e si rischierebbe di scadere nella banalità. Qui si passano in rassegna velocemente le varie informazioni ricevute dalla lex orandi e ci si sofferma su quelle che hanno stretta attinenza con l’augmentum.
90 Cf. la Lettera ai Colossesi e quella agli Ebrei.
Luca Girello
219
filiale in Cristo91, per cui tutti gli uomini sono predestinati a entrare nella sua pienezza e tutte le cose ad essere ricondotte a Lui unico capo. In sintesi ciò che conosciamo del Figlio a partire da un semplice aggettivo è esattamente tutto ciò che il testo francese e la prima traduzione latina descrivevano con prolissità: il battesimo, l’annunciazione e la passione. Anzi, la nuova formula implicitamente esprime molto di più, pur senza ripetere gli episodi evangelici. È dunque avvenu-ta un’operazione piuttosto singolare: gli estensori del testo definitivo dell’OBO hanno ritenuto che non servisse dire altro che dilectus Filius. Qui sta il cuore di Anamnesi1-2, dato che lo scopo della venuta e dell’opera del Figlio è quello di fare di tutti gli uomini altrettanti figli amati. Ancor meglio, la finalità ultima è conformare tutti gli uomini allo stesso Figlio amato, operazione che Cristo ha reso possibile mediante la sua pasqua.
Infatti la sezione Anamnesi3 comincia con un enim: è nella Pasqua che l’un-zione con il crisma assume valore e comprensibilità, se letta alla singolare luce (singulariter effulgere voluisti) del Figlio diletto sofferente-risorto-glorificato.
Egli ha voluto racchiudere la sua intera esistenza – adombrata nell’Antico Testamento – nel solo mistero pasquale, che la nostra formula spiega con una mirabile sintesi. Essa non si sofferma infatti sulla croce e sulla risurrezione, ma si volge direttamente all’esito degli eventi di Gerusalemme: il Kyrios ha effuso lo Spirito Santo perché a poco a poco riempisse e completasse il gruppo dei suoi fe-deli, rendendoli capaci di vedere la presenza di Cristo in mezzo a loro. Lo scopo ultimo è quello di suscitare l’umanità nuova modellata sulla sua (humanum ge-nus salvum), o meglio di generare il corpo nuovo modellato sul suo, addirittura il suo corpo stesso che continua a vivere, ovvero la Chiesa. È la comunità cristiana ad essere così concepita come prosecuzione e completamento delle azioni e del-le parole di Cristo (per eam opus salutis in mundo compleretur), dotata di tutti i mezzi spirituali per conseguire questo fine, mezzi che sono rappresentati dal primo fra tutti, ovvero dal crisma.
Inoltre ancora una volta secondo la Lettera agli Efesini92 scopriamo che ciò che il Redentore ha compiuto comporta una benedizione spirituale preparata da sempre, all’opera già nella creazione93, che annuncia il riposo di Dio. Quando tale
91 Dentro la filiazione adottiva rientra anche l’invio del Figlio nato da donna descritto in Gal 4,4. Si può allora intravedere in queste parole anche un’allusione al mistero dell’incarnazione del Verbo.
92 Cf. Eph 1,3 e anche Gn 2,2.93 Cf. anche Eph 3,9. Si fa notare che questo passaggio potrebbe supplire al fatto che la secon-
da formula del crisma abbia tagliato la parte sulla creazione, presente invece nella prima formula (creazione dell’olivo).
Ecclesiae tuae perfice augmentum
220
benedizione viene donata in Cristo (coelestibus muneribus) alla comunità dei suoi, questa entra dentro il progetto eterno di Dio e si realizza il riposo del settimo gior-no. L’olio profumato, donando alla Chiesa l’abbondante ricchezza della grazia (di-vitias gratiarum tuarum come in Eph 2,7), la fa entrare in questo riposo attraverso i sacramenti, per cui già ora è con-resuscitata con Cristo e con-siede nei cieli: la pasqua è già compiuta. E la Chiesa, proprio perché riceve il crisma, riceve l’opus di Cristo, riceve il compimento, che pian piano la trasforma.
Ci viene così suggerito che la rivelazione biblica (Anamnesi1-2-3) viene dotata di attualità, contemporaneità e concretezza esattamente nell’opera della Chiesa (ciò che viene descritto in Anamnesi4), per la quale la pasqua di Cristo continua a raggiungere gli uomini.
Infatti, a uno sguardo approfondito notiamo che il mistero pasquale è descritto in Anamnesi3 solo con l’evento della pentecoste. Questo può essere interpretato come la prova che la formula tace appositamente la morte-risurrezione, perché or-mai lo Spirito ha reso la Chiesa il luogo della celebrazione e della manifestazione del mistero di morte-risurrezione: è in essa che il Cristo pasquale viene celebrato, attinto e vissuto, anche e soprattutto per mezzo del culto pubblico94.
3.3.2 La pasqua del Figlio opera l’augmentum ecclesiae nei sacramenti
Da quanto detto scopriamo allora che la lex orandi dell’anamnesi della no-stra formula è una traduzione eucologica del famoso aforisma di Leone Magno: Quod Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit95. Ciò che la formula ci ha mostrato del Redentore (Anamnesi1-2-3) è passato nei riti sacra-mentali (Anamnesi4). Infatti, diventare parte del Figlio amato, o meglio diven-tare lo stesso Figlio amato, suo corpo, è possibile attraverso lo Spirito e, quindi, attraverso il dono del crisma, che la nuova preghiera consegna alla Chiesa.
La sezione Anamnesi4 comincia con un exinde, che ci apre alla comprensione del sacro chrismatis mysterio. Nel crisma, ricapitolazione di tutta la ricchezza delle grazie divine, è sacramentalmente presente la potenza di Dio, lo Spirito, che di-spiega la dispensatio nella storia, l’eterno piano provvidenziale stabilito dal Padre nel Cristo, volto alla conformazione degli uomini nel Figlio (Christo tuo conformes effecti). Lo Spirito opera per il crisma la predestinazione della Chiesa ad essere Lui, come dice anche Rom 8,29 e la colletta della celebrazione del venerdì santo (cf. la parte sulle fonti della formula). Attraverso ciò che il crisma dona, la Chiesa può
94 Cf. LG 40 e AA 16.95 Leo Magnus, Tractatus septem et nonaginta, 74,2, ed. A. Chavasse (Corpus Christiano-
rum. Series latina 138 A), 457.
Luca Girello
221
dunque entrare sacramentalmente dentro la morte di Cristo, per partecipare pie-namente al mysterium paschale, sedendo al convivio del Figlio.
Nel tempo successivo alla vita terrena del Figlio è nella liturgia ecclesiale che la pasqua è fruibile agli uomini, per Sacrificium et Sacramenta96, attraverso l’inizia-zione cristiana in modo specifico; ma anche attraverso la generica sacramentalità sottintesa dell’olio profumato in tutti i suoi usi e significati, come detto nel pa-ragrafo sull’epiclesi. Così tutti i christifideles, senza nessuna separazione tra laici, religiosi e ministri ordinati (è stata eliminata la parte del testo francese che descri-veva queste differenze), possono essere qui chiamati filii dei perché figli nel Figlio e parte dell’unica grande famiglia di Dio. Essi hanno la medesima dignità, sono partecipi dell’identità e del modus vivendi profetico sacerdotale regale di Cristo97.
Mentre il testo francese e il primo latino parlano dell’annuncio della salvezza (munus propheticum), dell’offerta di se stessi (munus sacerdotale) e del portare i fratelli alla verità (munus regale), quello definitivo dell’OBO non specifica altro. Esso sembra sottintendere che queste realtà passano attraverso la partecipazione ai riti della Chiesa, per mezzo dei quali è possibile contribuire attivamente al continuo aumento della Chiesa98.
3.3.3 Il corpo ecclesiale del Figlio aumenta in modo sensibile
Dopo quanto detto, occorre ribadire che la liturgia non è una “esperienza” disincarnata e solamente spirituale99. La partecipazione attiva non significa la-sciarsi trasportare in una dimensione ultraterrena; non significa inginocchiarsi dinanzi ad un “mistero”, da interiorizzare solo mentalmente; neppure sentirsi in-vestiti dal senso religioso di un rito o di un luogo. Secondo la nostra formula tut-ti gli iniziati all’esistenza cristiana per mezzo del crisma sono abilitati non solo ad animare le realtà temporali o all’esercizio della morale cattolica (che ne sono
96 Cf. SC 6. Allo stesso modo si può anche fare cenno al più famoso «per ritus et preces» di SC n. 48.
97 «Il crisma e con esso il gesto dell’unzione sono dunque la chiave interpretativa della digni-tà, della costituzione cristico-pneumatica. Sia che si evochi l’iniziazione cristiana, sia che si guardi al sacerdozio ordinato è evidente l’esplicita connessione della preparazione-consacrazione del cri-sma e del gesto dell’unzione allo Spirito e alla sua azione potente innanzitutto su Cristo Signore e, in lui, nei cristiani», Militello, La Chiesa “il corpo crismato”, 722.
98 Cf. LG 31 e AA 2.99 «Anche quando la teologia di scuola si è fatta astratta […] la prassi sacramentale in par-
ticolare non ha mai smesso di essere un’esercitazione dei sensi e dei corpi non in vista di un loro superamento, ma della loro apertura, del loro orientamento», G. Busani, «Corpi chiamati a formare un corpo», 39.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
222
se mai una conseguenza)100, ma all’azione liturgica, che non è più prerogativa di alcuni privilegiati. Tutti i battezzati-crismati, costantemente vitalizzati dal-la partecipazione liturgica, di cui sono protagonisti, sono per mezzo del crisma spronati all’augmentum per divenire sempre più ciò che sono: la Chiesa, ovvero il corpo del Figlio. Essi in quanto comunità del Risorto e mai come singoli101 «per sacrificium et sacramenta» portano avanti l’opus salutis, realizzato dal mi-stero pasquale e dallo Spirito condotto a pienezza. Sono quindi partecipi del sacerdozio di Cristo a un livello anche celebrativo-rituale, con la loro presenza ministeriale e con la loro partecipazione dinamica e operativa102.
La comunità concreta costituisce l’assemblea celebrante103, unico soggetto della liturgia. Quando infatti SC dice che ogni celebrazione è opus Christi sacer-dotis eiusque Corporis, quod est Ecclesia104, non intende che è i soggetti sono due, o peggio che è il Cristo a celebrare, assorbendo in sé la comunità, annullandola. Al contrario è la Chiesa che celebra come corpo ecclesiale di Cristo, l’Uno e l’al-tra sono “uno solo”: l’Uno è la pienezza e l’altra è in aumento verso la pienezza. Questo mistero è grande in riferimento a Cristo e alla Chiesa (cf. Ef 5,32).
Qui è possibile leggere in modo positivo105 e ad ampio spettro anche l’inseri-mento da parte di Paolo VI del tema sacerdotale, esattamente come fa P. Jounel106.
100 Cf. C. Militello, «L’assemblea liturgica gerarchicamente ordinata: soggetto celebran-te», in L’assemblea liturgica, ed. G. Cavagnoli, Messaggero di S. Antonio, Padova 2005, 116; D. Sartore, «Ecclesiologia e liturgia: principi metodologici e fondamenti teologici di un rappor-to», in Ecclesiologia e liturgia, Atti della X Settimana di studio dell’Associazione Professori di Li-turgia, Marietti, Casale Monferrato 1982, 20-21; Sorci, «Il sacerdozio comune si manifesta e si realizza in pienezza nell’assemblea che celebra», 379.
101 Cf. G. Ruppi, «L’assemblea liturgica epifania della ministerialità della Chiesa», Liturgia 32 (1998) 284.
102 Cf. G. Cavagnoli, «Il modo di intendere la chiesa nell’ottica dell’assemblea liturgica», in L’assemblea liturgica, ed. G. Cavagnoli, Messaggero di S. Antonio, Padova 2005, 97.
103 “Celebrante” non “presidente”: non le spetta infatti la presidenza dei riti, e tuttavia ne è vero soggetto. Il n. 42 del documento Redemptionis Sacramentum invita a usare l’espressione con cautela, per evitare fraintendimenti, ma non lo vieta; cf. Congregatio de cultu et discipli-na sacramentorum, Instructio de quibusdam observandis et vitandis circa sanctissimam Eu-charistiam Redemptionis Sacramentum (25 martii 2004), AAS 96 (2004) 564. In sede accademica è auspicabile invece approfondire l’argomento; cf. A. Grillo, «Comunità e rito. I presupposti teorici e culturali di una teologia dell’assemblea celebrante», in L’assemblea liturgica, ed. G. Cava-gnoli, Messaggero di S. Antonio, Padova 2005, 214.
104 SC 7.105 P. Sorci lo valuta invece negativamente, come intromissione solo devozionale. Cf. Sorci,
«La solenne benedizione del crisma in oriente e in occidente», 269.106 Cf. Jounel, «La consécration du chrême et la bénédiction des saintes huiles», 73-74.
Luca Girello
223
C’è infatti un’unità tra tutti i cristiani, ciascuno sacerdote a suo modo, c’è una relazione fitta tra tutti i consacrati. Anzi – pur nella diversità dei carismi e delle operazioni – tutti sono l’Unico Consacrato che continua a vivere e a operare nel tempo, secondo una visione ecclesiologica molto ampia e molto antica107.
Inoltre a livello celebrativo-rituale è possibile segnalare meglio la continuità tra la pasqua e i sacramenti ecclesiali attraverso la collocazione tradizionale della consacrazione del crisma al termine della comunione. C’è una profonda con-tinuità tra l’olio che si consacra per l’augmentum ecclesiae e l’eucaristia appena ricevuta che nella comunità radunata sta compiendo il suo effetto. Essa ha cre-ato la comunione tra i presenti e Dio, essendo sacramento dell’unità ecclesiale; allo stesso modo il crisma attinge forza e senso dal Pane spezzato e condiviso, per aumentare nella Chiesa la coscienza e l’identità di essere pure lei il corpo di Cristo che continua a vivere nel tempo108, spezzato nella carità e condiviso per la gioia del mondo. La dimensione sacramentale del vissuto cristiano ha così una spiegazione e una visibilità molto più puntuale. Con G. Busani concludiamo che «i corpi sono chiamati a formare un corpo nel senso più profondo di collocarsi in un corpo a cui appartengono (passato), e di tendere a un corpo verso cui cam-minano (attesa). La comunione è allo stesso tempo un presupposto (dal corpo ai corpi) e un compimento (dai corpi al corpo). Così si giustifica l’ecclesiologia dell’assemblea santa: corpi che diventano corpo»109.
3.4 L’invocazione sintetizza l’augmentum ecclesiae
Nel nostro percorso a ritroso dall’epiclesi-dossologia alle quattro sezioni dell’anamnesi abbiamo notato come i nessi congiuntivi creino una trama di rela-zioni teologiche tra le varie parti, attraversate da un solo “filo rosso” conduttore.
107 Cf. le considerazioni di G. Caputa parlando dei Padri di Palestina vissuti tra il II e il VI se-colo in G. Caputa, «Lo Spirito Santo e il sacerdozio dei fedeli secondo alcuni Padri della Chiesa di Palestina» in Spiritus spiritalia nobis dona potenter infundit. A proposito di tematiche liturgico-pneumatologiche, ed. E. Carr, Centro Studi S. Anselmo, Roma 2005, 160. Lo stesso autore a pro-posito di Beda, il quale richiama Agostino, dice ancor più esplicitamente: «Non solo i vescovi e i presbiteri, ma tutti i cristiani vengono giustamente chiamati sacerdoti perché membra dell’unico Sacerdote, e cristi a motivo del mistico crisma, il quale è segno dello Spirito Santo», G. Caputa, «La grazia dello Spirito Santo nei sacramenti dell’iniziazione secondo san Beda», Ecclesia Orans 22 (2005) 138.
108 «Poiché essa si riunisce insieme per compiere – non in modo esclusivo, ma principale – il gesto che effettua la koinonìa tra Cristo e gli uomini, è tramite suo che questi diventano il corpo di Cristo, membri ciascuno per la sua parte», P. Grelot, Regole e tradizioni del cristianesimo primi-tivo, Piemme, Milano 1998, 242.
109 Busani, «Corpi chiamati a formare un corpo», 45.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
224
Per lo stesso motivo possiamo compiere l’ultimo passaggio fino all’invocazione della formula, caratterizzata dalla figura del Padre cui è indirizzata tutta la pre-ghiera. Egli è il protagonista indiscusso, a partire dal qui all’inizio di Anamne-si1 che inaugura un costante riferimento alla sua Persona: una serie di aggettivi possessivi ci ricordano che ogni cosa viene a Lui e porta a Lui. Anzitutto “suo” è il Figlio, di cui prepara la rivelazione, il mistero pasquale e la continuazione nel corpo ecclesiale; e poi “sua” è la Chiesa, ripiena di Spirito; “sue” le ricche grazie della dispensatio; “suoi” i figli raggiunti dai sacramenti; “suo” l’Unto sacerdote-profeta-re; “sua” la potente grazia che trasforma la commixtio di olio e profumi in crisma e la costituisce sacramentum della “sua” benedizione. Infine “sua” di nuovo è la Chiesa, di cui si chiede l’augmentum.
Addentriamoci ora un po’ di più nell’invocazione della formula per evincere gli ultimi elementi di teologia liturgica che la preghiera e la fede della Chiesa qui esprimono.
3.4.1 Il Padre ama il corpo (ecclesiale) del Figlio e gli dà vita
Il Padre è fedele e porta a compimento il suo progetto. Per questo anzitutto può essere invocato non più con il titolo di «Dio eterno e onnipotente» (come faceva il testo di P. Jounel), ma con l’indirizzo alla sua ineffabilis pietas, perché è Padre e ha voluto intrecciare con l’umanità un legame di amore eterno nel Cristo, un legame immeritato e per questo indicibile; un legame che nulla può spezzare, al quale ogni uomo è invitato a rispondere con affetto filiale e con at-teggiamento stupito. Ecco quindi la possibilità di inserire subito all’inizio della preghiera quel gratias agimus, verbo che regge tutta la formula. Si ringrazia un Padre siffatto per la sua fedeltà al Figlio, e quindi per la sua fedeltà all’uomo ricreato nel Figlio. Si ringrazia per l’immensa opera salvifica, che si concentra in qualcosa di così povero e apparentemente insignificante, ovvero il crisma, conte-nente tutta la benedizione divina e la capacità di trasformare persone-cose-luo-ghi fino al loro perfezionamento. L’atteggiamento è ottimistico, pieno di fede, già certo di possedere le realtà che vengono richieste, le quali perciò sono già ottenute, perché il Padre sa che la Chiesa ne ha bisogno.
Inoltre sullo sfondo ci sta un ritmo eucaristico, che a un livello generale rende al rito di consacrazione del crisma la sua struttura tradizionale e antichissima di rendimento di grazie sulla scorta dell’eucaristia, facendo intendere una correla-zione profonda tra questa e l’olio profumato; ad un livello più intimo dice lo stile eucaristico che deve animare tutta la Chiesa e ogni singolo battezzato, uno stile che è sia oblativo nell’imitazione della carità di Gesù sia celebrativo nel com-piere ritualmente quello che Lui ha fatto. Così la forma eucaristica – oblativa
Luca Girello
225
e celebrativa insieme e mai disgiunte – è forma della fede-fiducia della Chiesa, acquisita e vissuta e perfezionata grazie al mistero dell’olio di santificazione. Esso porta a compimento l’augmentum ecclesiae rendendo a poco a poco la comunità dei credenti più profondamente simile a Cristo (aumento qualitativo) spanden-dosi quale profumo soave.
La lex orandi dunque spiega l’intervento economico di Dio, affermando che il Padre sta al principio di tutta la dispensatio storica e sacramentale, è il suscita-tore dell’opus salutis, e sta anche come compimento della Chiesa, dell’umanità e della storia.
Qui possiamo intravedere pure l’identità stessa del Padre, che eternamente ama il Figlio e gli dà vita. Allo stesso modo Egli eternamente ama anche gli uomi-ni, fatti a immagine e somiglianza di Lui e resi figli sempre più conformi al Figlio mediante lo Spirito, attraverso la celebrazione dei sacramenti (sacramentorum auctor); nella Chiesa ama il Figlio, e viceversa, perché vengono a costituire la me-desima realtà. Inoltre il Padre a questi uomini amati – alla Chiesa-Figlio – dà il crisma (vitaeque largitor) sacramento della sua stessa abbondante vitalità divina, fino a raggiungere la pienezza dell’unico corpo. Finché Dio sarà tutto in tutti.
3.4.2 Il Padre dona il crisma per la liturgia e la carità
L’incipit dell’orazione è una citazione patristica. Indipendentemente da quanto ne siano stati più o meno consapevoli gli estensori del testo, evincia-mo fin dalle prime battute della formula la teologia della continuità. La Chiesa odierna, in altre parole, non è altro che la medesima Chiesa delle origini, la me-desima comunità cristiana che cresce a poco a poco lungo la storia degli uomi-ni, annunciando e vivendo lo stesso mistero secondo la volontà del suo Signore, rimanendo nel solco della tradizione precedente. Questa operazione introduce gli oranti a uno sguardo più ampio sulla realtà ecclesiale. La richiesta del crisma si pone fin da subito come richiesta di tutto il popolo di Dio pellegrinante nel tempo, che domanda con quel vitae largitor ciò che gli è di vitale importanza per continuare a camminare nell’unità. Le fonti del testo indicano questo come lo Spirito (Ambrogio) o come il Cristo (Fulgenzio di Ruspe). Qui è addirittura il Padre ad essere interpellato: Egli, garante dell’unità trinitaria, viene preso come garante anche dell’unità ecclesiale e alla sua innefabilis pietas, già testata nelle Scritture110, si affida questa domanda.
Il movimento ascendente della preghiera della Chiesa è in perfetto equilibrio con il movimento discendente del dono del crisma. L’olio profumato viene ad
110 Cf. Is 11,2 e 1Tim 3,16.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
226
assumere la caratteristica di “chiave di volta” del popolo di Dio; per suo mezzo – ovvero per mezzo dei sacramenti in cui viene usato e, per sineddoche, dei segni sacri in genere – la comunità riceve coesione e cammina verso l’unità. Per questo eleva il rendimento di grazie al Padre. L’atteggiamento eucaristico, che pervade tutta la formula, sottolinea che l’eucaristia di fatto pervade tutto l’opus salutis, perché è preparata dal Padre, adombrata nell’Antico Testamento, rivelata piena-mente da Cristo e realizzata nel mistero pasquale, continuata sacramentalmente dallo Spirito e dalla Chiesa, divenuta centro e dinamica della comunità intera e dei singoli cristiani. È infatti sacramento del corpo di Cristo e anche sacramento dell’unità ecclesiale, corpo ecclesiale che si costruisce sempre di più111. Dentro questo movimento eucaristico viene consacrato anche il crisma, con il medesimo scopo.
Di nuovo notiamo una profonda relazione tra l’olio profumato e l’eucaristia: nel crisma secondo la tradizione c’è come un’abilitazione al culto112, che voglia-mo leggere in un senso anche pratico113, connesso con i riti in cui viene usato. Nell’iniziazione cristiana infatti i cristiani vengono introdotti alla regolare e fedele celebrazione eucaristica; sono poi condotti a riconoscere il sacramento della presenza del Pastore che li raduna in unità e li serve e spezza il Pane per loro (ordine sacro); e sono invitati infine a sedere attorno all’unico altare, sacramento dell’unica Pietra Angolare edificato nella casa della comunità, per diventare sem-pre più la realtà dell’unica Chiesa adombrata nell’edificio (consacrazione della chiesa e dell’altare).
Il Padre vuole dunque che il crisma entri dentro la dinamica del sacramentum unitatis e lo completi114 rendendolo fruibile, esattamente come l’invio e l’opera
111 La comunità «è già da sempre questo corpo. Lo Spirito di Gesù Cristo, promesso per la fine dei tempi, si è già riversato su di lei rendendola un “unico corpo”. E tuttavia deve nutrire la consapevolezza di trovarsi ancora in cammino per diventare questo “unico corpo”», G. Lohfink, Dio ha bisogno della Chiesa? Sulla teologia del popolo di Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, 303.
112 Tra le fonti magisteriali della formula indicate cf. LG 34, dove i laici sono detti partecipi del munus sacerdotale perché partecipi della celebrazione eucaristica, per la quale si offrono come Cristo.
113 «Il sacerdozio regale dei fedeli dice intimo rapporto con la vita liturgica della Chiesa e soprattutto con l’Eucaristia. L’universalismo sacerdotale cristiano conserva intatto tutto il suo valore e tutta la sua concretezza, al di là di ogni interpretazione metaforica», A. Elberti, «Ac-cipe signaculum doni Spiritus Sancti. La confermazione: fonte del sacerdozio regale dei fedeli?», Gregorianum 72 (1991) 511.
114 «Lo Spirito “anima” della Chiesa, perfeziona la fede del cristiano, ma anche della Chiesa, nel senso che unifica le membra del Corpo di Cristo “ecclesiale” allo stesso modo in cui è all’opera nel corpo “sacramentale”», N. Bux, «L’olio simbolo dello Spirito Santo», in I simboli dell’inizia-
Luca Girello
227
dello Spirito completa l’opera del Figlio e lo rende accessibile anche a chi non è a Lui contemporaneo. Come la pentecoste ha dilatato la pasqua oltre i confini dei Dodici e ha reso (liturgicamente) i discepoli “un cuore solo e un’anima sola”, perché mediante la carità il Cristo potesse essere manifestato e riconosciuto e po-tessero anche essere radunati i dispersi, allo stesso modo il crisma rende il corpo ecclesiale di Cristo profumo soave che si sparge tra gli uomini e così attira tutti allo Sposo dell’umanità.
Questo processo avviene continuamente e progressivamente mediante la li-turgia e la carità: una liturgia che è la prima carità (ad intra verso il Cristo, cioè verso la Chiesa) che ogni cristiano è chiamato a fare, lasciandosi edificare in una comunità e acquisendone il profumo; e una carità (ad extra verso gli altri uomi-ni) che è una messa in pratica della liturgia, per spandere quel profumo.
Potremmo definire la celebrazione eucaristica anche come un costante “atti-vatore della percezione dell’olio profumato”, che permette ai cristiani di rendersi conto di ciò che sono. Nell’eucaristia i battezzati-crismati non tanto a oriente o in una croce di legno o di metallo, ma verso l’altare cosparso del crisma volgono lo sguardo; su quella stessa mensa si consuma il sacramentum unitatis, lì il crisma spande il suo aroma più intenso. Inoltre i fedeli si sentono avvolti dal profumo del crisma che ha unto le pareti dell’edificio in cui si trovano, le quali non sono più barriere architettoniche, ma il recinto del piccolo gregge chiamato ad acco-gliere anche le pecore “di fuori”, perché vi sia un solo Gregge e un solo Pastore. Nell’eucaristia dunque i cristiani avvertono forte la fragranza dello stesso olio che – da loro ricevuto almeno due volte, sul capo e sulla fronte – pervade la loro carne e la loro anima e li sprona a percepirsi come una cosa sola115, resi come Cristo, abilitati a servire e a dare la vita.
Qui sta l’intesa immediata tra il Santo e i cristiani, per via dell’istruzione rice-vuta dallo Spirito a proposito del comandamento nuovo (cf. 1 Io 2,20.27). Qui il crisma – come anticipato a proposito del significato antropologico dell’unzione – viene riscoperto come olio assimilato per la missione cristiana, come unguento capace di riaccendere la bella speranza ricevuta nel battesimo, come aroma che conduce al risveglio della coscienza ecclesiale116.
zione cristiana, ed. G. Farnedi (Studia anselmiana 87, Analecta Liturgica 7), Benedictina, Roma 1983, 134.
115 The presence of the risen Christ in the assembled church smelling the liturgy serves to deepen appreciation of myrrh in particular and the sense of smell in general as a cohering social agent in acts of communal thanksgiving, M.F. Connell, «The Gift of Myrrh to a Church that Smells», Studia Liturgica 37 (2007) 228.
116 Anche nella liturgia delle ore (GeV 1584) si parla di un risvegliarsi dei sensi, connesso con la dedizione al culto e alla conoscenza del nome di Dio.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
228
Il crisma diventa dunque ancora una volta un sacramento nel senso ampio del termine, sacramento della presenza dello Spirito, che conforma al Cristo pasqua-le tutti coloro che gli appartengono, rendendoli Lui. Essi sono partecipi del suo sacerdozio, che esercitano nella liturgia, fonte e culmine di tutta la vita ecclesiale. Questo è l’insegnamento della più antica tradizione liturgica, che la lex orandi della nuova formula ha voluto riproporre anche ai contemporanei117.
3.4.3 Il Padre “autore” dei sacramenti e della Chiesa
Per concludere, c’è un piccolo particolare da non lasciare sotto silenzio. Dal-lo studio delle fonti del nostro testo è emerso che la tradizione ha sempre dato il titolo di auctor sacramentorum solamente al Figlio (Ambrogio, Tommaso d’A-quino) in quanto istitutore dei riti sacramentali; solamente la voce di Ruperto di Deutz si è spinta a chiamare con lo stesso titolo anche lo Spirito, virtus che opera in tutti i sacramenti. Alla nostra attuale conoscenza nessuno aveva mai provato a definire il Padre in questo modo. Soltanto la seconda formula del crisma intro-duce questa nuova dicitura.
Se a uno sguardo dogmatico l’espressione può lasciare perplessi, non bisogna però dimenticare tutto ciò che è stato scritto nelle pagine precedenti. Non stupi-sce vedere riferito al Padre anche l’inizio dell’opera sacramentale, perché questa non è altro che il suo eterno disegno che si dispiega da Cristo alla Chiesa nella potenza dello Spirito.
Tuttavia non sembra che qui il termine sia usato tout-court per esprimere la volontà istitutrice del Padre. Anzi, di nuovo è curioso costatare che il titolo di autore collegato con il Padre non sia altro che un artificio letterario per ri-badire sempre la medesima cosa, ovvero creare fin da subito una connessione con l’aumento della Chiesa. In che senso questo avviene? Secondo il metodo filologico-letterario c’è un legame tra quell’auctor e l’augmentum: entrambi i ter-mini condividono la stessa radice del verbo augeo, entrambi si riferiscono all’a-rea semantica della crescita, dell’amplificazione, della fecondità, della ricchezza, dell’innalzamento. Pertanto sacramentorum auctor in questo caso non si riferisce tanto all’origine dei sacramenti, quanto piuttosto allo scopo per cui essi vengono dal Padre pensati e messi in atto.
Il Padre viene invocato fin da subito come colui che mediante il mistero dell’o-lio di santificazione fa crescere la Chiesa verso il compimento, amplificandola qua-litativamente e anche quantitativamente fino alla piena fecondità, arricchendola
117 Cf. Sorci, «Il sacerdozio comune si manifesta e si realizza in pienezza nell’assemblea che celebra», 384.
Luca Girello
229
di doni e carismi perché diventi sempre di più se stessa, conformandosi al suo fine ultimo. Il vescovo, dando voce a tutti i fedeli della Diocesi di cui è custode, già nell’incipit della formula lascia intuire alla Chiesa radunata attorno a lui che la pre-ghiera che si sta innalzando riguarda i sacramenti e la possibilità che questi siano lo strumento dell’innalzamento e del miglioramento di tutta la comunità. Pertanto la Chiesa è invitata già da subito a tendere l’orecchio, a osservare l’ampolla del crisma, a sentirne la fragranza, a utilizzare la sua sensibilità, la sua concretezza, per riconoscere il sacramento dello Spirito del Risorto, che le dona la vita e la verità.
Il Padre risulta dunque essere colui che spinge la Chiesa verso l’augmentum e per questo motivo le dona il crisma e quindi tutti i sacramenti della nuova pasqua.
Conclusione
Come già riconosciuto da P. Jounel118, l’Ordo benedicendi oleum cathecume-norum et infirmorum et conficiendi chrisma non è considerato uno dei principali riti della liturgia, ma aiuta a illuminare il mistero di Cristo e della Chiesa. Abbia-mo però scoperto nell’OBO una ricchezza immane, che meriterebbe un ulteriore approfondimento119.
Nel nostro percorso a cerchi concentrici siamo andati sempre più in profondi-tà nelle implicazioni antropologiche, bibliche, liturgiche, teologiche della nostra orazione sul crisma e abbiamo scoperto come al cuore di questa formula ci stia principalmente quell’ecclesiae tuae perfice augmentum, centro propulsore della di-namica strutturale, lessicale e semantica della nuova preghiera della Chiesa sull’o-lio profumato. Si è scoperto dunque il nesso inscindibile tra la Chiesa e il crisma, finalizzato a generare, supportare, abbellire ed espandere l’unico corpo di Cristo.
118 L’Ordo de la consécration du chrême et de la bénédiction des huiles n’est pas un des rites majeurs de la liturgie. Du moins ses formes et ses prières, soigneusement harmonisées avec les rites rénovés de l’initiation chrétienne et du sacrements des malades, nous aident-elles à mieux comprendre la relation du baptême, de la confirmation et de l’onction des malades au mystère du Christ, tandis que la concélébration de l’évêque et de son presbyterium met en lumière le mystère de l’Eglise locale comme sacrement du Christ. Cela suffit, semble-t-il, pour souhaiter que de nombreux chrétiens puis-sent découvrir dans cette liturgie une lumière nouvelle sur leur vie sacramentelle», Jounel, «La consécration du chrême et la bénédiction des saintes huiles, 83.
119 Dispiace costatare che tale ricchezza è strettamente collegata con il testo latino pubblicato nel 1971. La traduzione italiana ufficiale del 1980, ad esempio, non rende quasi per nulla tutti i collegamenti interni alla formula e la centralità dell’aumento della Chiesa con le sue implicazioni teologiche. Si auspica per il futuro una traduzione più letterale della seconda formula, come ave-va già fatto S. Mazzarello all’indomani della pubblicazione dell’OBO: cf. S. Mazzarello, «Il nuovo rito per la benedizione dell’olio dei catecumeni e degli infermi e per la consacrazione del crisma», Liturgia 5 (1971) 143-144.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
230
È proprio nell’immagine della Chiesa-corpo che trova ragione e senso la presenza e l’opera dello Spirito Santo, che porta avanti il piano della salvezza nella contemporaneità dell’opera sacramentale. Così consacrare il crisma ogni anno significa dare sempre di nuovo alla comunità cristiana l’efficacia dello Spirito che in continuazione discende sul corpo ecclesiale di Cristo, com’era disceso sul corpo di Gesù al battesimo al Giordano. Su di Lui lo Spirito non creava nulla ex novo (il Figlio era già Dio), ma si è mostrato posandosi a modo di colomba sulla sua carne per “aumentare” la rivelazione del mistero di Cristo e illuminarne la comprensione. Alla stessa stregua anche il dono del crisma, che il giovedì santo di nuovo discende sulla Chiesa, non rende la Chiesa qualcosa che già non sia: essa è già il corpo di Cristo per l’intervento di grazia ricevuto da Dio. Il crisma è dato invece per aumentare la rivelazione del mistero di Cristo in lei, ne illumina la comprensione. Il crisma, “sacramento” dello Spirito, tocca “la carne della Chiesa”120 e la rende consapevole di essere il Cristo stesso che continua a camminare in questo tempo e in questo luogo, mentre si fa attenta e grata alla voce del Padre che la rassicura: “Tu sei il mio Figlio amato”.
L’evangelista Luca nel suo racconto del battesimo aggiunge una notazione che non ha riscontro altrove: la discesa dello Spirito avviene corporali specie (cf. Lc 3,22), secondo una visione “corporale”. Perché soltanto Luca ha questo par-ticolare? Possiamo azzardare un’ipotesi. Aggiunge questa parola forse perché egli conosce bene Paolo e la sua dottrina della Chiesa corpo di Cristo; e anche forse perché della Chiesa parla nel libro degli Atti proprio a partire da quello «che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesi-mo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret» (cf. Act 10,37-38). Sta di fatto che questo termine richiama il discorso di Eph 4 e per noi instaura un magnifico collegamento tra la sorte di Gesù e quella della sua Chiesa.
Infatti per via del battesimo è possibile vedere e riconoscere un solo corpo come anche uno solo è lo Spirito (cf. Ef 4,4). C’è un solo “Cristo totale” nel quale ogni battezzato può riconoscersi, proprio per via del dono del crisma.
È su questo mirabile mistero che la seconda formula del crisma ci ha condot-ti, facendo emergere l’olio profumato come un potente strumento anamnetico perché la Chiesa possa sempre riprendere coscienza della sua vera identità di corpo del Signore, non nel senso di esserne solamente le membra, semplici mez-zi operativi passivi; ma anzi nel senso di essere realmente Cristo stesso che con-tinua a vivere e a operare in modo attivo. Tale impostazione è stata già avviata da SC n.7 per quanto riguarda il culto: la presenza di Cristo è reale anche nell’as-
120 Cf. J.M. Tillard, Carne della chiesa, carne di Cristo, Qiqajon, Magnano 2006.
Luca Girello
231
semblea che prega e loda. Occorre andare oltre il solo momento celebrativo ed entrare nel mistero di una Chiesa che è sempre consapevole di essere corpo di Cristo121, proprio come accadeva all’epoca dei Padri. Agostino commentando il Salmo 26 lascia questo ben noto insegnamento:
Erano unti allora solo il re ed il sacerdote: queste due erano a quel tempo le persone che venivano unte. Nelle due persone era prefigurato il futuro unico re e sacerdote, l’unico Cristo rivestito dell’uno e dell’altro ufficio, chiamato appunto Cristo per l’unzione/crisma. Ma non soltanto fu unto il nostro Capo: lo siamo stati anche noi, il suo corpo. […] Quale agnello immacolato ci ha redento, versando il suo sangue, incorporando noi a se stesso, facendoci sue membra, in modo che anche noi, in Lui, fossimo Cristo. Perciò l’unzione riguarda tutti i cristiani; mentre nei tempi passati del Vecchio Testamento essa spettava solo a due persone. Di conse-guenza è manifesto che noi siamo il Corpo di Cristo, perché tutti siamo unti; e tutti noi in Lui siamo di Cristo e siamo Cristo, poiché in certo qual modo il Cristo totale è Capo e corpo122.
L’Ipponate esprime chiaramente la coincidenza tra Chiesa e Cristo e la pro-va di questa identità sta nell’unzione con il crisma che tutti i battezzati ricevono. C’è però quel “in certo qual modo” (quodammodo) conclusivo, che introduce anche una non perfetta capacità di comprendere come Capo e corpo formino una cosa sola. È come se si dicesse che la Chiesa è certamente Cristo, ma ancora le mancasse qualcosa per esserlo perfettamente123. Qui dunque possiamo legge-re la dinamica dell’augmentum ecclesiae, per la quale essa grazie ai sacramenti e principalmente all’eucaristia diventa a poco a poco ciò che già è.
Infatti Agostino in un’omelia ai neofiti prosegue nel ragionamento, creando un necessario sillogismo:
121 Ad esempio, l’identità tra Cristo e la Chiesa è cosa talmente acquisita da Leone Magno e dai fedeli del suo tempo, da poter essere applicabile persino nel contesto della polemica antinestoriana. Infatti in un’omelia il santo Papa può parlare anche ai semplici fedeli dell’unione perfetta di divinità e umanità in Cristo, in base a ciò che stava sotto gli occhi di tutti e i suoi ascoltatori potevano ben capire: l’unità tra la persona del Signore e i suoi santi (la Chiesa) forma «l’unico e identico Cristo». Ecco le sue parole: Non est ergo dubium, dilectissimi, naturam humanam in tantam conexionem a Filio Dei esse susceptam, ut non solum in illo homine qui est primogenitus totius creaturae, sed etiam in omnibus sanctis suis unus idemque sit Christus, Leo Magnus, Tractatus septem et nonaginta, 63,3, ed. A. Chavasse (Corpus Christianorum. Series latina 138 A), 383-384.
122 Cf. in latino Augustinus, Esposizioni sui Salmi, vol. 1, In eumdem Psalmum 26 enarratio II, 2, Città Nuova, Roma 21982, 358, 360.
123 Cf. E. Mazza, La celebrazione eucaristica. Genesi del rito e sviluppo dell’interpretazione, EDB, Bologna 2003, 148-152.
Ecclesiae tuae perfice augmentum
232
Se voi li (pane e vino) avete ricevuti bene, voi stessi siete quel che avete ricevuto. […] C’è stato il battesimo e siete stati come impastati con l’acqua per prendere la forma del pane. Ma ancora non si ha il pane se non c’è il fuoco. E che cosa esprime il fuoco, cioè l’unzione dell’olio? Infatti l’olio, che è alimento per il fuoco, è il segno sacramentale dello Spirito Santo. […] Dunque viene lo Spirito Santo, il fuoco dopo l’acqua e voi diventate pane, cioè corpo di Cristo124.
Se la Chiesa è Cristo e se Cristo è nel sacramento della mensa, ne consegue an-che un parallelismo tra la comunità cristiana e l’eucaristia ricevuta, che vengono addirittura a coincidere; a tal punto che la Chiesa può essere considerata come il pane per la celebrazione eucaristica. Esso è se stesso, è pane, se ci sono l’acqua e il fuoco. Anche la Chiesa è se stessa, è Pane, ovvero Corpo di Cristo, se oltre al battesimo riceve l’olio, Spiritus Sancti sacramentum. Dunque nella partecipa-zione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana gli uomini diventano Cristo pur rimanendo se stessi; poi nella continua comunione al Pane eucaristico ogni volta “aumentano” la loro identità, diventando sempre più Cristo e meno se stessi, im-parando a rendere vero il mistero che celebrano, ovvero ad essere sempre più una cosa sola, a diventare sempre più l’unico corpo ecclesiale. Spiega infatti Agostino in un’altra omelia:
Se voi dunque siete il corpo e le membra di Cristo, sulla mensa del Signore è deposto il mistero di voi: ricevete il mistero di voi. A ciò che siete rispondete: Amen e rispondendo lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: Il Corpo di Cristo, e tu rispondi: Amen. Sii membro del corpo di Cristo, perché sia veritiero il tuo Amen. […] Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete125.
In conclusione c’è un solo corpo ecclesiale, che è Cristo stesso, il cui miste-ro è già tutto presente e, nel contempo, è ancora da svelare appieno, è ancora da portare a compimento, è in continuo “aumento” anche per mezzo dell’opera dell’olio profumato. Nella liturgia il crisma trova il suo primo terreno fecondo. Nella liturgia i cristiani, mai come singoli ma inseriti nella comunità intera, pro-gressivamente prendono consapevolezza di se stessi ed espandono a poco a poco il soave odore della loro splendida identità.
La Chiesa dunque, riattivata dall’aroma ricevuto e ridonato nei sacramenti, nell’altare e nell’edificio del suo radunarsi, cammina ancora oggi nell’opera che il suo Signore e Capo le ha consegnato, si lascia ancora oggi trasformare dalla
124 Cf. in latino Augustinus, Discorsi, vol. 4/1, Sermo habitus die sancto Paschae ad infantes de Sacramentis 227, Città Nuova, Roma 1984, 386. 388.
125 Cf. in latino Augustinus, Discorsi, vol. 4/2, Sermo in die Pentecostes ad infantes de Sacra-mento 272, Città Nuova, Roma 1984, 1042, 1044.
Luca Girello
233
potenza dello Spirito del Risorto che la riunisce da un confine all’altro della ter-ra e la compatta in un solo corpo. Ancora oggi viene sempre spinta verso il suo compimento, che si sta realizzando in continuo augmentum. Esso sarà raggiunto quando «ogni cristiano acquisirà il mistero dell’unzione come chiave interpre-tativa del suo essere e del suo agire ecclesiale. Allora, consapevole del sigillo dello Spirito, ne effonderà la fragranza secondo il dono ricevuto»126. La Chiesa allora sarà più pronta ad accogliere lo Sposo che le aprirà le porte della Città eterna, quale Sposa promessa; e i due saranno per l’eternità una sola carne risorta e glo-riosa.
Prima che accada il perfetto compimento di tutte le cose, nel crisma che le è donato ogni anno anche per mezzo della seconda formula, da noi studiata, la comunità dei battezzati-crismati nella sua interezza viene sempre di nuovo in-serita dentro la preghiera sacerdotale di Cristo (cf. Io 17, specialmente i versetti 20-23), perché tutti – credenti presenti e futuri – siano consummati in unum e persino il “mondo” conosca il Figlio e si lasci amare dal Padre con lo stesso eterno amore.
126 Militello, La Chiesa “il corpo crismato”, 718.
Ecclesiae tuae perfice augmentum