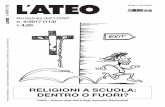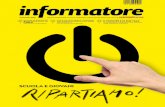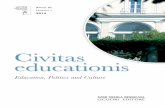Le biblioteche italiane durante il fascismo: strutture, rapporti, personaggi.
Società, rapporti ecologici e segregazione: l'approccio della Scuola di Chicago
Transcript of Società, rapporti ecologici e segregazione: l'approccio della Scuola di Chicago
Società, rapporti ecologici e segregazione: l’approccio della Scuola di Chicago
Gennaro Avallone
in Sociologia, 1/2015: 53-60
1. IntroduzioneIl concetto di segregazione elaborato dalla Scuola sociologia di Chicago è parte di un
insieme di categorie applicate all'analisi della distribuzione spaziale delle popolazioninelle aree urbane, anche se esso è stato utilizzato anche nelle ricerche sulla razza e suirapporti razziali nella società americana. Il testo seguente, basato sull'analisi dellepubblicazioni dei sociologi della Scuola, ricostruisce il contesto teorico nel quale questoconcetto è stato costruito ed utilizzato, in connessione con l'ecologia, una disciplina cheagli inizi del '900 privilegia lo studio dei rapporti spaziali competitivi tra le specievegetali, e con altri concetti, tra cui quelli di città, area naturale, mobilità,disorganizzazione e controllo sociale. Nel corso del testo e nelle conclusioni sonopresentati alcuni dei limiti dell'impostazione ecologica della Scuola e dei contenutiassociati al concetto di segregazione.
2. La città: un mondo naturale impianificabile e incontrollabile
Nell'articolo introduttivo all'analisi della città del 1915, Robert Park evidenziò il suocarattere strutturalmente impianificabile. La città è un prodotto instabile di un processonon programmabile, le cui trasformazioni sfuggono alle indicazioni ed ai vincoli delpiano regolatore:
nel nostro sistema fondato sulla proprietà privata è impossibile prevedere il grado di concentrazionedella popolazione in una data area. La città non può fissare il valore dei terreni, e viene lasciato per lo piùall'iniziativa privata il compito di determinarne i confini come anche di localizzare le aree residenziali equelle industriali. Gusto e tornaconto personale, interessi professionali ed economici tendonoinvariabilmente a segregare e perciò a classificare la popolazione delle grandi città (Park, 1995 ma 1915,4).
L'articolo individuò uno dei caratteri specifici dell'urbanizzazione capitalistica,sottoposta alla continua spinta al superamento di ogni ostacolo, compresi quelli definitiin ambito normativo ed amministrativo, da parte dei rapporti di concorrenza e deiprocessi di distruzione creatrice, funzionali all'accumulazione ed alla valorizzazionedegli investimenti e della rendita (Harvey, 1998). La forza delle norme del governoterritoriale non è sufficiente né ad arginare l'insediamento nello spazio dei capitali,quando esso si propone, né a regolare i valori dei terreni. Di conseguenza, la gestionedemocratica dello spazio a cui rinvia il piano regolatore, motivata dal fatto che lo spazioè un bene comune, viene sottoposta alla legge del valore (del terreno), che trasforma lospazio in una merce e, quindi, in un bene privato. Lo spazio diviene, così, lo spazio delcatasto, un insieme parcellizzato di aree private non governabile nell'ambito di unprogetto collettivo e, dunque, in ultima istanza, impianificabile.
Park osservò che l'iniziativa privata nello spazio non si limita agli aspetti economicidell'agire e, dunque, ai caratteri capitalistici della valorizzazione fondiaria ed
1
immobiliare. Lo spazio è trasformato in maniera imprevedibile anche dalla forza deigusti e delle tendenze personali. Il piano regolatore stabilisce limiti ai cambiamentiarbitrari, ma, in realtà, esso non può arrestare “le dinamiche proprie della naturaumana”, che procedono conferendo alla struttura fisica e sociale della città “dellecaratteristiche più difficili da controllare” (Park, 1995 ma 1915, 4).
L'analisi di Robert Park mostra la politica urbanistica fondata sul piano in unacondizione di crisi permanente. Essa è la risultante di un campo di forze dinamico piùche di una razionalità superiore basata su parametri tecnici, in cui le spinte eterogeneedei molteplici interessi privati scompongono ogni possibile visione unitaria della città. Ivincoli ed i confini legali ed amministrativi non arrestano l'azione delle forze naturali,cioè delle forze private, coincidenti principalmente, sebbene non esclusivamente, conquelle economiche: "in questo modo la città acquisisce un'organizzazione che nonrisponde a un progetto e non è soggetta a un controllo” (Park, 1995 ma 1915, 4). Ilcarattere di imprevedibilità, in cui l'azione sociale disarticola qualunque vincoloistituzionale, ha un risvolto della medaglia nel fatto che la stessa struttura urbana,prodotta dagli esseri umani, si impone su di essi come una forza estranea. La città sipresenta nella sua pienezza in quanto risulta:
il più riuscito tentativo da parte dell’uomo di plasmare il mondo in cui vive in funzione delle sue piùintime aspirazioni. Ma se da una parte la città è il mondo creato dall’uomo, dall’altra è anche il mondo incui è condannato a vivere. Così, costruendo la città l’uomo ha ricostruito, indirettamente e senzarendersene pienamente conto, se stesso (Park, 1967, 3).
A differenza di David Harvey, per il quale questa lettura rinvia al fatto chel'urbanizzazione è un prodotto socio-politico che “dipende dall'esercizio di un poterecollettivo” (Harvey, 2008, 23), per Robert Park e gli altri esponenti della Scuola questaconsiderazione conferma il carattere naturale del processo urbano. La città è l'esito, incontinuo cambiamento, dell'azione spontanea delle forze individuali, culturali edeconomiche; dunque, di un processo indipendente e naturale, non politico, nonprogrammato né controllabile, determinato, in definitiva, dai rapporti di forza vigenti. Inquesto senso, la città si manifesta come un meccanismo impersonale che agisce,imponendosi, sulla popolazione che la abita. Secondo questa analisi la produzione dellacittà avviene attraverso azioni e retroazioni spontanee, che influenzano la stessadistribuzione spaziale della popolazione al suo interno. Una conseguenza fondamentaledi questo processo inconsapevole è la costruzione della città come una strutturaecologica, composta da un insieme di aree individuate come 'naturali', in quanto definiteda specifici e distinti caratteri, anche essi non pianificabili.
In questa rappresentazione delle forze che 'fanno' la città e la sua geografia sociale erazziale non emergono, però, differenze né asimmetrie. Con un gioco di parole, si puòdire che l'analisi urbana della Scuola di Chicago non si chiede come sono i rapporti diforza tra le forze in campo. Le forze naturali sembrano tutte uguali tra loro e, tutte allostesso modo, prive di potere per fronteggiare gli effetti dei processi ai quali partecipano.In modo omogeneo, tutte sono sottoposte ad una forza superiore, al meccanismospontaneo, incontrollato e impersonale che governa le dinamiche ecologiche, dunque ladistribuzione nello spazio, di popolazioni ed attività umane. In questo modo, ledisuguaglianze di potere politico ed economico tra i diversi attori urbani scompaiono eresta una indistinta ed anonima popolazione governata da un meccanismo impersonaleche condanna o premia ciecamente i suoi membri. Di conseguenza, le stessedisuguaglianze, seppure individuate, risultano incontrollabili, oltre che necessarie, in
2
quanto naturali.L'insieme dei caratteri riconosciuti alla città ed ai processi di urbanizzazione è
coerente con l'approccio dell'ecologia umana adottato dai sociologi della Scuola diChicago, attraverso il quale essi hanno combinato insieme differenti concetti, tra cuiquello di segregazione.
3. L'approccio dell'ecologia umana
L'ecologia umana è lo studio delle relazioni spaziali e temporali che si sviluppano trai membri della società. Essa analizza come e perché una popolazione è distribuitaattraverso lo spazio, individuando le principali forze influenti sui processi di selezione eadattamento (McKenzie, 1999 ma 1925).
L'approccio ecologico della Scuola fu ispirato dagli studi di alcuni botanici edecologi e specialmente dal testo di Frederic Edward Clements (1916). Quest'ultimoaveva sviluppato una teoria in cui aveva individuato la successione in un'area spazialecome un processo che si realizza attraverso sei fasi, consecutive o in rapporto diinterazione tra loro. Le fasi individuate erano: (1) la nudazione [nudation], (2) lamigrazione, (3) l'ecesi, (4) la competizione, (5) la reazione e (6) la stabilizzazione.
Secondo questo modello l'inizio della successione si realizza con lo sviluppo di unsubstrato nudo, nel quale, successivamente, si verifica la migrazione di propaguli, che,nella fase dell'ecesi, si stabiliscono, dando vita alla crescita iniziale di vegetazione. Lafase della competizione si realizza quando una vegetazione risulta insediata e capace didiffondersi, concorrendo con altre specie per lo spazio ed i nutrienti. A questa segue lareazione, quando cambiamenti autogenici agiscono sull'habitat determinando lasostituzione di una comunità con un'altra, fino al suo punto di stabilizzazione e alconseguente sviluppo di una comunità climax. Il processo di successione dà vita, indefinitiva, alla collocazione nello spazio di nuove comunità vegetali.
Questa teoria fu ritradotta dagli studiosi di Chicago nell'ambito delle ricerche sugliinsediamenti umani, muovendo dall'ipotesi secondo cui:
i processi di competizione, segregazione e accomodamento messi in evidenza nella descrizione dellacomunità vegetale sono abbastanza comparabili con gli stessi processi nelle comunità animali ed umane(Park e Burgess, 1921, 163).
Nell'ambito della Scuola fu soprattutto Ernest Burgess ad usare questa analogia percostruire un modello generale di sviluppo delle città, riconoscendo nel processo diinvasione e successione la tendenza fondamentale dell'espansione urbana. In manierasimile alla sequenza individuata da Clements, questo processo si realizza attraverso uninsieme di fasi, corrispondenti all'invasione, alla reazione, all'abbandono ed al climax:
la successione come processo è stata studiata e il suo principale percorso è stato tracciato in quanto (1)invasione, che inizia spesso come una penetrazione graduale e inosservata, seguita da (2) una reazione,resistenza mite o violenta degli abitanti della comunità, e infine risulta (3) nell'afflusso di nuovi arrivati edil rapido abbandono dell'area da parte dei suoi vecchi residenti, e (4) nel climax, o raggiungimento di unnuovo equilibrio della comune stabilità (Burgess, 1928, 112).
Il modello di Burgess segnala che la sequenza invasione-successione ha al suo centrodue momenti transitori, raramente ricordati: la reazione, corrispondente alla fase di
3
resistenza da parte del gruppo che viene invaso, e il momento nel quale c'è la doppiainfluenza dei nuovi arrivati e di quelli, invasi, che abbandonano lo spazio.L'individuazione di questi momenti mostra che la successione non è un processopacifico né, tanto meno, impersonale, ed implica il contatto sociale. La città èattraversata da continue spinte di invasione e successione, che danno luogo a conflitti eresistenze e non solo ad interazioni competitive prive di riconoscimento sociale.
L'individuazione di questa articolazione processuale e sociale della sequenzainvasione-successione non è sufficiente, però, per i sociologi della Scuola, perintrodurre nell'analisi urbana il riferimento sia a forze ed attori dotati di intenzionalitàproprie sia, soprattutto, ai rapporti ed ai fattori politico-economici ed economico-sociali.È il principio della competizione a guidare le analisi della Scuola di Chicago,coerentemente con la centralità riconosciuta al concetto di lotta per l'esistenza:
questa lotta per l'esistenza, in una forma o in un'altra, è infatti essenziale per l'esistenza della società.Competizione, segregazione e accomodamento servono a conservare le distanze sociali, a fissare gli statused a preservare l'indipendenza dell'individuo nella relazione sociale (Park e Burgess, 1921, 163).
Per i sociologi di Chicago il rapporto tra competizione, quindi lotta per l'esistenza, esegregazione, dunque separazione delle popolazioni, è un rapporto di forte connessione.La città è un prodotto ecologico, dunque è l'esito di processi competitivi e adattivi chedistribuiscono la popolazione, classificandola in un insieme di aree naturali e segregate(McKenzie, 1999 ma 1925).
La competizione, però, non ha un carattere assoluto (Gaziano, 1996), in quanto “laconcezione ecologica della società è quella di una società creata dalla cooperazionecompetitiva” (Park e Burgess, 1921, 558). Per i sociologi di Chicago è necessario“difendere la società” e questo avviene, coerentemente con l'ecologia dinamica diClements, attraverso un ordinato svolgimento dei rapporti di competizione. Nella loroanalisi si risolveva in questo modo quello che individuavano come il principaleproblema politico di ogni società: “come assicurare i massimi valori di competizione,cioè la libertà, l'iniziativa e l'originalità personale, e, al tempo stesso, controllare leenergie che la competizione ha rilasciato, nell'interesse della comunità” (Park e Burgess,1921, 513). In questa visione ogni elemento trova la sua spontanea collocazione e ilmodello invasione-successione, orientato finalisticamente al raggiungimento del climaxed al ristabilimento dell'ordine dopo i processi di perturbazione, lo conferma.
La rilevanza del tema della lotta per l'esistenza, sebbene mitigata da elementi dicooperazione, è stata criticata da molti studiosi, anche all'interno della teoriadell'ecologia umana. Amos Hawley (1950), in particolare, ha rilevato un'esagerazionenel riferimento alla centralità di questo tema e delle relazioni sociali che esso comportae “dove l'ecologia tradizionale mette in rilievo la competizione come meccanismo diadattamento nei sistemi umani, Hawley afferma che le relazioni ecologiche riflettono unprocesso interattivo di competizione ed interdipendenza” (Irwin, 2010, 347). In realtà, lastessa prospettiva di Hawley ha ignorato gli altri principi organizzativi propri dellecomunità ecologiche, guidate soprattutto da rapporti di cooperazione, interdipendenza,ciclicità, flessibilità e diversità, mentre, al loro interno, il principio della competizionerisulta secondaria. Questi principi si sono affermati negli studi ecologiciprevalentemente nella seconda metà del XX secolo (Worster, 1990; 1994). Tuttavia,alcuni di essi, in particolare quelli di simbiosi e di cooperazione per il bene comune,erano stati individuati, seppure in forma preliminare, già da alcuni biologi ed ecologi,attivi anche nella città di Chicago, come nel caso di Henry C. Cowles (Gaziano, 1996).
4
In base a questo articolato insieme di principi ecologici, ogni comunità costituisce, esi alimenta di, una rete della vita. Di conseguenza, il territorio risulta non un insieme dirisorse che ogni specie al suo interno deve accaparrarsi lottando contro le altre,giungendo anche alla loro soppressione, ma lo spazio di vita comune di grandi quantitàdi specie. Questa condizione di biodiversità è, tra l'altro, un presupposto per lasopravvivenza di ogni specie e della comunità ecologia in cui ognuna vive. Secondoquesto aggiornato paradigma, l'analisi dei sociologi di Chicago risulta fortementeparziale perché si concentra solo sulla competizione, un principio di funzionamentoecologico secondario, che, se assoluto, abbatte l'essenziale biodiversità.
4. Le aree naturali e la segregazione spaziale
Dalle analisi dei sociologi della Scuola emerge che la lotta per l'esistenza determinala distribuzione della popolazione in aree naturali, in quanto:
l'effetto generale dei continui processi di invasione e accomodamento suddivide la comunitàsviluppata in aree ben definite, ciascuna con una propria capacità selettiva e una propria cultura. Questeunità della vita comunitaria possono essere chiamate "aree naturali"' o formazioni, per usare un termine diecologia vegetale (McKenzie, 1999 ma 1925, 71)”.
Sintetizzando la proposta analitica dei sociologi di Chicago risulta che i fattori inbase ai quali la popolazione si suddivide nello spazio sono tre: l'appartenenza razziale eetnico-nazionale, il valore del terreno e l'occupazione, il valore simbolico delle aree.
Il primo fattore evidenzia la rilevanza dell'immigrazione per gli studiosi di Chicago,attirati, e preoccupati, dai processi di segregazione spaziale di popolazioni etnicamentee culturalmente omogenee. Fu Park (1926, 6) a riconoscere che:
tali segregazioni della popolazione avevano luogo, primariamente, sulla base del linguaggio e dellacultura e, secondariamente, sulla base della razza.
Per Park, La città si colorava in base alla collocazione spaziale dei suoi diversigruppi nazionali e razziali, differenziati in aree naturali che divenivano:
strutture urbane di transizione in cui le differenze sociali si conservavano come modelli distinti in unapiù ampia, indifferenziata società. [...] Tali 'aree naturali' erano 'zone' ecologiche, che ospitavanodifferenti stili di vita e costumi (Deegan, 2001, 15)”.
La città diveniva, in questo modo, un insieme di città dentro alla città, ognuna conuna popolazione “selezionata” (Park, 1999 ma 1925, 13).
Il secondo fattore si riferisce alla tendenza delle popolazioni a concentrarsi in areespaziali con un comune profilo socio-economico. Questo processo è favorito dalladifferenziazione del valore dei terreni, che concentra i gruppi umani in baseall'occupazione ed alla posizione economica individuale, tanto che, nelle areeinteressate da investimenti volti alla rigenerazione urbana, "le classi più povere vengonoescluse in seguito all'accresciuto valore del terreno" (Park, 1999 ma 1925, 9). Parkosservò una stretta connessione tra lavoro e posizione spaziale e, dunque, tra statussociale e status spaziale:
il punto è che il cambio di occupazione, il successo o il fallimento personale - in breve, i cambiamenti
5
di status economico e sociale - tendono ad essere registrati in cambiamenti di luogo. L'organizzazionefisica o ecologica della comunità, nel lungo periodo, riflette quella occupazionale e culturale. La selezionesociale e la segregazione, che creano i gruppi naturali, determinano al tempo stesso le aree naturali dellacittà (Park, 1926, 7).
Il terzo fattore si riferisce al valore simbolico delle aree spaziali e, insieme, deigruppi nazionali e degli individui che le abitano. Questo aspetto fu evidenziato neiriferimenti allo status delle popolazioni segregate e individuato, indirettamente, neglistudi che evidenziarono il desiderio di fuga dalle aree segregate, cioè dalle aree naturalietichettate negativamente.
Un'immagine sintetica dei fattori indicati fu elaborata da Louis Wirth (1998 ma 1938,77), per il quale:
densità, valore del terreno, livello degli affitti, accessibilità, salubrità, prestigio, considerazioniestetiche, assenza di fastidi come rumore, fumo e sporcizia determinano la desiderabilità delle varie zonedella città come luoghi di insediamento per aree differenti della popolazione. Il luogo e la natura dellavoro, la consistenza delle entrate, le caratteristiche razziali ed etniche, lo status sociale, le consuetudini,le abitudini, i gusti, le preferenze ed i pregiudizi sono tra i fattori che determinano la selezione e ladistribuzione della popolazione urbana lungo stanziamenti più o meno distinti.
L'intreccio dei fattori elencati alimenta un processo di separazione della popolazionee la costituzione di specifiche aree territoriali di segregazione, sulla base di affinitàeconomiche e culturali, dando vita, in maniera non intenzionale e non pianificabile, adaree segregate: "Robert Park e la Scuola di Chicago concepivano le “aree naturali”come aree geografiche determinate da forze subculturali ed economiche non pianificate"(Sassen, 2007, 477).
L'analisi sviluppata mostra che gli studiosi di Chicago usarono il concetto disegregazione in modo descrittivo, riferendosi con esso ad ogni tipo di area omogeneacon specifiche caratteristiche sociali, culturali o relative all'origine nazionale, compresal'area di concentrazione delle classi ricche, la Gold Coast studiata da Zorbaugh (1929).
La struttura spaziale è prodotta dalla competizione, che gerarchizza lo spazio e lepopolazioni in base ai valori dei terreni, determinando un insieme di aree naturali esegregate, ognuna delle quali “agisce come una forza selettiva o magnetica che attrae glielementi della popolazione a essa appropriati e respinge le unità incongrue, tracciandosuddivisioni biologiche e culturali nella popolazione urbana” (McKenzie, 1999 ma1925, 72). In questa visione, la città è naturalmente uno spazio disuguale, con areeprivilegiate ed aree subordinate, nelle quali la collocazione non avviene in base ad unascelta ma “secondo differenze razziali, di lingua, reddito e status sociale” (Wirth, 1998ma 1938, 80). Solitamente, gli individui non scelgono le aree segregate, ma vengonoscelti da esse.
Quando le aree segregate corrispondono a quelle di valore economico, sociale esimbolico più basso si tende a scappare. Ad esempio, nella ricerca sul ghetto ebraico,Wirth (1968 ma 1929) registrò l'abbandono da parte dei suoi abitanti in corrispondenzadi miglioramenti della propria posizione socio-economica. Nella recensione congiuntaal testo ed a quello di Zorbaugh (1929), Mckenzie (1929) sottolineò che il ghetto “èsempre in un processo di dissoluzione” perché i suoi abitanti sono continuamente infuga da esso. In realtà, questo processo di fuga e di crisi fu associato, dalla Scuola diChicago, a tutte le aree segregate economicamente e simbolicamente svalutate. Essefurono definite come un crocevia socio-spaziale: aree in cui i nuovi arrivati transitano,ma nessuno vuole sostare in modo definitivo.
6
La ricerca sul ghetto ebraico mostrò chiaramente che la tendenza alla concentrazionespaziale in aree omogenee dal punto di vista culturale non resiste sotto la pressione diun'altra tendenza, quella alla differenziazione socio-economica, che alimenta i processidi mobilità sociale individuale, familiare o di piccolo gruppo. Quella dell'appartenenzanazionale o regionale e dei sentimenti di comunanza culturale o religiosa è unavariabile che incide sui processi di mobilità e segregazione spaziale della popolazionepiù debole della collocazione economica, della forza del denaro e dell'appartenenzasimbolico-materiale e di ceto. In definitiva, il processo di mobilità sociale viene seguitodalla mobilità spaziale e impedisce la struttuazione di legami su base etnico-razziale oterritoriale.
Questa analisi viene rafforzata dal riferimento ai processi di resistenza, individuatinel modello della successione di Burgess, verso i comportamenti dei nuovi arrivati,riconosciuti come invasori ed alieni. Essi mostrano, al pari della variabile relativa alvalore del terreno, come le affinità di ceto e di posizione sociale siano forze chedisarticolano le solidarietà basate sulla comune appartenenza nazionale o razziale. Laricerca di Frazier (1930) indicò, in modo emblematico, che la resistenza a nuovi ingressinelle aree di residenza veniva agita non solo dai bianchi verso i neri, ma ancheall'interno della stessa popolazione nera, da parte dei membri delle classi alte. In questostudio si evidenziò che i membri delle classi sociali superiori, indifferentementedall'appartenenza razziale al gruppo bianco o a quello nero, erano raggruppati in areespecifiche (figura 1) ed organizzati contro i "vicini indesiderati" al fine di evitarecambiamenti nel carattere dei loro quartieri. Anticipando i futuri processi disegregazione delle nuove borghesie all'interno delle gated communities, Frazier (1930)individuò un altro tipo di fuga, dunque: quella dei ricchi dalla parte povera dellapopolazione.
L'elemento nazionale, dell'appartenenza etnica, così come quello della comunecollocazione spaziale cedono davanti ai cambiamenti della condizione socio-economicae della mobilità sociale individuale. Le relazioni e le solidarietà di tipo comunitario sidisgregano mentre si dispiegano i processi di affermazione individuale, che trovano unatraduzione nei cambiamenti della collocazione spaziale degli individui e dei gruppisociali, attraverso la fuga o la resistenza ai nuovi arrivati.
Figura 1. Distribuzione delle residenze dei 110 neri di classe sociale superiore in WoodlawnCommunity (Chicago)
Fonte: Frazier (1930)
7
La tendenza alla fuga dalle aree segregate, connessa ai processi di mobilità sociale,conferma la forza dei fattori economici nella costruzione dello spazio urbano e, con essi,la centralità delle relazioni di competizione e, dunque, delle possibilità di successopotenzialmente attivabili da tutti. Il desiderio di fuga e di mobilità sociale in un contestodi lotta per la vita assume un carattere democratico. Esso può essere alimentato evissuto da ognuno, in uno spazio di opportunità apparentemente privo di ostacoliinsuperabili: la città è l'ambito di vita in cui ognuno può trovare “ il tipo di ambiente incui può svilupparsi e sentirsi a proprio agio” (Park, 1999 ma 1925, 39), ma anchemigliorare la propria collocazione sociale e, insieme, spaziale, senza limiti al suoprogredire.
In questa interpretazione, la città assomiglia alla frontiera da conquistare, in cui ogniindividuo ha la sua opportunità da cogliere all'interno di rapporti di competizione che locostringono ad andare avanti per evitare che la meta verso cui è rivolto scompaiaall'orizzonte (Wirth, 1968 ma 1929). Al tempo stesso, le solidarietà nazionali, razziali,sociali e spaziali si indeboliscono sotto i colpi delle spinte della mobilità socialeindividuale. Nonostante le turbolenze associate a questo tipo di mutamento radicale, ecerti dell'evoluzione verso un nuovo ordine, i sociologi della Scuola di Chicago simostrano favorevoli ad una tendenza che premia l'individualismo in alternativa aprocessi di aggregazione comunitaria ed organizzazione collettiva. Questa opzioneteorica e politica dei membri della Scuola è evidente esplicitamente nelle analisi di Parksulle questioni interrazziali, vissute, al pari di Booker Washington, con preoccupazione(Rauty, 2008). Secondo Park, infatti:
è evidente a tutti che dove gli individui della stessa razza e quindi dello stesso temperamento sonoassociati, gli interessi temperamentali tenderanno a rafforzarsi l'uno con gli altri, e l'attenzione dei membridel gruppo sarà più completamente focalizzata sugli specifici oggetti e valori che corrispondono altemperamento razziale. […] Dall'altro lato, quando la segregazione razziale si rompe ed i membri delgruppo razziale sono dispersi, si verificherà l'effetto opposto (Park e Burgess, 1921, 138).
La segregazione è una conseguenza necessaria dello sviluppo economico e sociale,ma anche un problema sociale e politico da ridurre, perché, come evidenziato, adesempio, da Bogardus (1930, 76) nel caso degli immigrati messicani, “uno degli auto-evidenti risultati della segregazione è il fallimento degli immigrati messicani a divenirecittadini americani”. La segregazione spaziale, come la concorrenza, richiede di esseremitigata, favorendo l'assimilazione, in modo da limitare le tensioni sociali, etniche erazziali.
5. Segregazione, mobilità, disorganizzazione e controllo sociale
Le aree di segregazione sono le aree di maggiore mobilità, perché sono le areedeterminate e modificate dai processi di invasione e successione e dalla tendenza allafuga o da quella, contraria, alla resistenza del privilegio razziale o sociale.
Le ricerche della Scuola di Chicago registrarono per le aree di segregazione un altotasso di mobilità in ingresso ed uscita. In questo senso, il riferimento alla teoriaecologica si tradusse anche in un metodo di ricerca, basato sul “tracciare su una mappala localizzazione degli individui aventi certe caratteristiche in comune” (Becker, 1929,203), ma anche i movimenti delle popolazioni. Ernest Burgess (1928), ad esempio,
8
fattore specifico dell'instabile ordine della città. La mobilità era associata alcambiamento, al ritmo della vita produttiva e commerciale - in questo senso costituiva ilpolso della comunità (Burgess, 1999 ma 1925) - ma anche all'accelerazione della crisidei gruppi primari e delle loro forme di controllo. La mobilità era individuata come unfattore che influenzava i valori dei terreni, accrescendoli nelle zone in cui siintensificava, così come l'incremento dei tassi di devianza:
Le attività che Burgess etichettava come mobilità implicano progresso o regresso, opportunità eminaccia. Burgess vedeva la mobilità come uno stimolo centrale alla crescita positiva dell'individuo edella città, ma avvertiva che quando la mobilità degli individui diveniva scollegata, e disorganizzata,dall'insieme (la città, la società) essa diveniva pericolosa e patologica - un vizio narcisistico” (Cresswell,2001, 67).
Le aree segregate, in quanto mobili, instabili, transitorie, sono le aree delladisorganizzazione sociale e individuale. Questo è uno dei motivi principali per cui laScuola le elegge a luogo privilegiato di ricerca, dedicando ad esse una parte delle suemonografie ma anche una parte del famoso schema radiale elaborato da Burgess,nonostante Chicago fosse molto più vasta ed articolata.
La rappresentazione offerta nelle ricerche della segregazione non è mai disperata,perché risulta sempre mediata dall'approccio evoluzionista, presente anche nel modelloecologico di Clements. La crisi sociale non è mai definitiva, ma, al contrario, anticipa imutamenti e, quindi, una nuova stabilità. Per la Scuola, la segregazione erainevitabilmente prodotta dalla crescita della città; era considerata un prodotto necessariodella vita urbana, un effetto collaterale, in quanto “tutti i mutamenti sociali sonopreceduti da un certo grado di disorganizzazione sociale ed individuale [...] seguitoordinariamente[...] da una riorganizzazione (Park e Burgess, 1921, 46).
In definitiva, la città risponde ad un ordine evolutivo dinamico, che, nella crisiprodotta dalla perturbazione indotta dalle migrazioni, ricostruisce continuamente leforme del controllo sociale (Castells, 1978):
per la Scuola di Chicago, la questione centrale era come le associazioni di ordine secondario – gruppidi pari, sub-culture, associazioni volontarie e simili – sostituivano le associazioni primarie della famigliae del luogo che erano state rotte dal caos e dall’instabilità della moderna vita urbana (Savage, 2005, 358).
Nella visione della Scuola di Chicago, la città è il prodotto instabile della mobilità,della separazione e della competizione, attraversata da processi di segregazione cheinteressano, principalmente, la popolazione immigrata ed implicano la crisi del controllosociale ed i fenomeni di devianza. Il ghetto e le altre aree segregate non abitate dalleclassi sociali più ricche sono le aree fuori standard, caratterizzate dalla concentrazionedella povertà e di comportamenti devianti o eccentrici: “dove la mobilità è maggiore edove di conseguenza i controlli primari vengono meno del tutto - come nella zona dideterioramento della città moderna - si sviluppano aree di corruzione, di promiscuità edi vizio” (Burgess, 1999 ma 1925, 55-56).
In definitiva, le aree segregate corrispondevano alle enclave socio-spaziali delnegativo, qualificate dai più alti tassi di mobilità interna e verso l'esterno, didisorganizzazione e crisi sociale e di devianza:
dalla prima Scuola di Chicago di ecologia umana [...], gli analisti hanno accettato come un dato difatto che il ghetto può essere analizzato in modo soddisfacente essenzialmente in termini privativi,rilevando i suoi limiti e problemi e quelli dei suoi residenti e specificando come (e quanto) entrambi
10
divergano dalla società ‘mainstream’ misurata mediante i cosiddetti standard della ‘classe media’(Wacquant, 1997, 345).
6. Conclusioni: il fatalismo della disuguaglianza
Le analisi della distribuzione spaziale della popolazione realizzate dai sociologiriconosciuti come membri della Scuola di Chicago condividono una doppia prospettiva:una di tipo evoluzionista-progressista e l'altra di tipo assimilazionista.
La prima è fortemente collegata all'analisi ecologica di Clements, per la quale lo“sviluppo [è] sempre progressivo [e] la successione è intrinsecamente edinevitabilmente progressiva. [...] In ogni momento in cui si verifica un movimento essoè sempre nella direzione del climax” (Clements, 1916, 145). Il raggiungimento dellostadio finale, corrispondente nelle società urbane alla riorganizzazione dell'ordine, èinevitabile, così come lo sono la mobilità sociale e, insieme, la povertà, ladisorganizzazione sociale e la segregazione spaziale. Si individua all'opera un'ideologiaevoluzionista, per la quale una parte della popolazione migliorerà sicuramente le propriecondizioni socio-economiche di partenza, mentre un'altra parte diventerà un rifiuto, unrifiuto umano, al pari dei rifiuti, crescenti, prodotti dalla città. Il progresso si verifica, sidetermina, ma con un volto duale, con la convivenza di un lato negativo ed unopositivo, con i suoi vincitori e le sue vittime.
La seconda prospettiva riguarda l'altrettanto inevitabile assimilazione degli immigratinel nuovo contesto di vita. Secondo un punto di vista etnocentrico, essa si realizzaattraverso “il ciclo delle relazioni razziali che prende la forma, per esprimerloastrattamente, del contatto, della competizione, dell'accomodamento e dell'eventualeassimilazione” (Park, 1950, 150).
Per entrambe le prospettive, i processi di segregazione, dunque di selezione,separazione ed isolamento parziale delle popolazioni, sono un male necessario mapasseggero della vita urbana contemporanea. Essi determinano aree di transizione, dallequali i gruppi e gli individui immigrati passano per andare altrove. Per gli stessisociologi di Chicago questo non vuol dire che tutti transitano e riescono ad emanciparsida esse. I processi di intrappolamento, di definitiva demoralizzazione e didisorganizzazione mietono vittime, producono fisiologici rifiuti umani, analogamente aquanto accade nelle comunità vegetali, in cui la competizione divide i vivi dai morti.Questa complessiva prospettiva teorica, seguendo anche l'interpretazione della storicaAlice O' Connor, rappresenta “‘povertà, ‘disorganizzazione’ sociale e segregazionecome esiti 'inevitabili’ dei quasi biotici ‘processi della crescita urbana’” (Wacquant,1997, 345) e, in modo fatalistico, riconosce l'ineluttabile meccanismo attivo nella vitadella città moderna produttori di vincitori e sconfitti.
La combinazione delle due prospettive colloca i processi urbani in un generalemeccanismo di fissità e movimento, costruendo l'idea che tutto sia possibile, che nellacittà a tanti può accadere di abitare nel ghetto, nelle aree segregate, così come per tuttic'è la potenziale uscita. Se ognuno è posto in rapporto di competizione con gli altri epuò individualmente abbandonare l'area segregata, quindi migliorare la propriacollocazione socio-spaziale, allora il tema del conflitto si riduce al conflitto temporaneoper lo spazio, perché prevale l'idea della mobilità, di una mobilità che ricostruiscel'ordine.
I sociologi di Chicago assunsero la medesima prospettiva dell'ecologia dei primi del'900, concentrata sull'ipotesi della tendenza evolutiva delle comunità verso il climax,
11
insieme a quella finalistica dell'assimilazione delle popolazioni immigrate e lacombinarono, normativamente, con il riconoscimento della diseguaglianza e dellasegregazione socio-spaziale come principi strutturali dell'organizzazione urbana.
In questa doppia prospettiva ad essere privilegiata è l'organizzazione sociale, il cuimovimento costante verso l'ordine è indifferente ai destini degli individui e dei gruppiumani. La città è un meccanismo impersonale, alimentato da forze cieche e interessatesoltanto alla sua riproduzione dinamica e adattiva ai mutamenti. La sua produzione dipovertà, abbandoni e solitudini non turba questo meccanismo, che, al contrario, se nealimenta. All'interno dell'orizzonte teorico individuato, si afferma un'idea fatalisticadella città e della vita associata al suo interno, secondo la quale la tendenzaall'assimilazione – in quanto esito finale determinato - convive con i necessari efisiologici fallimenti sociali ed esistenziali della parte della popolazione perdente nellalotta per la sopravvivenza. La prospettiva evoluzionista ed assimilazionista salva lasocietà e l'organizzazione urbana e condanna una parte dei suoi protagonisti. Il fatalismodella vittoria e della sconfitta sociale costituisce una necessità per la macchina societariaed urbana: i processi di mobilità sociale e quindi spaziale ascendenti si realizzanoinsieme a quelli di scivolamento verso il basso o di stasi, ai quali si associano condizionidi segregazione spaziale e disorganizzazione individuale o sociale.
La Scuola di Chicago elaborò un'analisi fondata sul carattere naturale, dunquenecessario, dei processi, non lasciando spazio ad altri fattori di spiegazione ocomprensione dei fenomeni sociali. I rapporti di competizione e di adattamento diindividui e gruppi alla macchina impersonale della città occupano l'intero spazio teoricoelaborato e, di conseguenza, la considerazione dei rapporti socio-produttivi e di poterecome fattori esplicativi è del tutto assente.
I rilievi critici all'intero impianto teorico fondato sull'approccio ecologico-competitivo non cancellano la rilevanza dell'analisi della distribuzione spaziale, oltreche dei metodi, proposta dalla Scuola di Chicago e da altri anticipatori (Rauty, 1997),soprattutto se essa viene combinata con impostazioni teoriche che riconoscono larilevanza dei rapporti di forza e dei processi economici e politici nella determinazionedegli assetti urbani e delle relazioni socio-spaziali. Un esempio di questa applicazione siritrova nel lavoro condotto da Mike Davis (1999), che ha riproposto lo schema radialeelaborato da Burgess per rappresentare i nuovi processi di organizzazione, distribuzione,separazione e segregazione delle popolazioni e delle funzioni urbane, in particolare diquelle legate al controllo sociale e militare, nella metropoli di Los Angeles. Egli hariattualizzato il metodo cartografico ed ecologico della Scuola di Chicago, associandolonon ad un'idea di naturalità dei processi socio-spaziali ma ad un'analisi delle dinamichedi controllo sociale e politico e di gerarchizzazione delle popolazioni.
L'esempio della ricerca di Mike Davis conferma l'utilità del concetto di segregazionee, più in generale, dello studio della distribuzione spaziale della popolazione perstudiare la struttura urbana contemporanea, così come l'attualità di alcuni indicatorielaborati dalla Scuola di Chicago, in particolare quelli relativi ai valori dei terreni, allamobilità ed alla concentrazione spaziale su base etnico-nazionale, razziale o sociale. Ilriferimento all'approccio della Scuola risulta problematico se, invece, resta impigliatonelle prospettive naturaliste ed assimilazioniste, che escludono i riferimenti alla storicitàdelle condizioni di vita ed ai rapporti di produzione e di potere.
Riferimenti bibliografici
12
Becker H.P., 1929, Review of Gold Coast and Slum. A Sociological Study ofChicago's near North Side by Harvey Warren Zorbaugh, Annals of the AmericanAcademy of Political and Social Science, 145, 202-203.
Bogardus, E. S., 1930, The Mexican Immigrant and Segregation, American Journalof Sociology, 1930, 36, 74-80.
Burgess E.W., 1928, Residential Segregation in American Cities, Annals of theAmerican Academy of Political and Social Science, 140, 105-115.
Castells M., 1978, City, Class and Power, St. Martins Press, Londra, New York,MacMillan.
Clements F.E., 1916, Plant Succession. An analysis of the development, CarnegieInstitution of Washington, Washington.
Cresswell T., 2001, The tramp in America, Reaktion books, Londra.Davis M., 1999, The Ecology of Fear. Los Angeles and the Imagination of Disaster,
Vintage, New York.Deegan M.J., 2001, The Chicago School of ethnography in Atkinson O.A. et al. (a
cura di), Handbook of ethnography, Sage, Londra, 11-25.Frazier E.F., 1930, Occupational Classes Among Negroes in Cities in American
Journal of Sociology, 35(5), 718-738. Gaziano E., Ecological Metaphors as Scientific Boundary Work: Innovation and
Authority in Interwar Sociology and Biology, American Journal of Sociology, 101(4),874-907.
Harvey D., 1998, L'esperienza urbana, Il Saggiatore, Roma.Harvey D., 2008, The Right to the City, New Left Review, 53, 23-40. Hawley A., 1950, Human Ecology: A Theory of Community Structure. The Ronald
Press Company, New York.Irwin M.D., 2010, Hawley Amos in Hutchison, R. (a cura di), Encyclopedia of urban
studies. Thousand Oaks, CA, Sage Publications, 346-348.McKenzie R.D., 1999, L'approccio ecologico allo studio della comunità umana, 59-
72 in Park R., Burgess E. e McKenzie R.D., La città, Edizioni di Comunità, Torino. McKenzie R.D., 1929, The Gold Coast and the Slum. by Harvey W. Zorbaugh; The
Ghetto. by Louis Wirth Review, in American Journal of Sociology, 35(3), 486-487.Park R., 1995 ma 1915, La città: suggerimenti per la ricerca sul comportamento
umano nell'ambiente urbano, in Rauty R. (a cura di), Società e metropoli. La scuolasociologica di Chicago, Donzelli, Roma, 3-19.
Park R., 1926, The Concept of Position in Sociology, Papers and Proceedings of theAmerican Sociological Society, 20, 1-14.
Park R., 1950, Race and Culture, The Free Press, Glencoe.Park R., 1967, On Social Control and Collective Behavior. Selected papers,
University of Chicago Press, Chicago.Park R. e Burgess E., 1921, Introduction to the Science of Sociology, Chicago
University Press, Chicago.Rauty, R., 1997, Anticipazioni. Percorsi della ricerca sociale statunitense tra XIX e
XX secolo, Gentile, Salerno. Rauty R., W.E.B. Du Bois. Negri per Sempre. L'identità nera tra costruzione della
sociologia e linea del colore, Armando, Roma, 2008. Sassen S., 2007, Urban sociology in the 21st Century, in Bryant C.D. e Peck D.L. (a
cura di), 21st Century Sociology. A reference handbook, Sage, Thousand Oaks, 476-486.
13
Savage M., 2005, Urban Sociology in the Third Generation, Tim May, Beth Perry,Patrick Le Galès, Saskia Sassen and Mike Savage, The Future of Urban Sociology,Sociology, 39, 343-370.
Wirth L., 1968 ma 1929, Il ghetto, Edizioni di Comunità, Milano.Wirth L., 1998 ma 1938, L'urbanesimo come modo di vita, Armando, Roma.Wacquant L., 1997, Three Pernicious Premises in the Study of the American Ghetto,
International Journal of Urban and Regional Research, 20(3), 341-353.Worster D., 1990, The Ecology of Order and Chaos, Environmental History Review,
14(1/2), 1-18.Worster D., 1994, Nature's Economy: A History of Ecological Ideas, Cambridge
University Press, Cambridge. Zorbaugh H.W., 1929, The Gold Coast and the Slum. A Sociological Study of
Chicago's near North Side, The University of Chicago Press, Chicago.
14