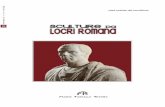I messaggeri del Gran Re in Erodoto VIII 98, 2. Un’eco eschilea e le glosse dei commentatori antichi
SIMBOLOTTI C., Tradizione giuridica longobarda. Un inedito frammento della Lombarda con glosse...
Transcript of SIMBOLOTTI C., Tradizione giuridica longobarda. Un inedito frammento della Lombarda con glosse...
Rivista Internazionale di Diritto Comune 23 (2012) 223-255
223
CHIARA SIMBOLOTTI
Tradizione giuridica longobarda. Un inedito frammento della Lombarda con glosse
(Torino, BNU, F. IV. 1 fr. 11)
1. Provenienza e vicende storiche
Il bifolio F. IV. 1 fr. 11, conservato presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, è un frammento membranaceo, finora inedito, che fa parte di una serie di carte bobbiensi ivi pervenute grazie all’impegno di Amedeo Peyron, docente di Letterature orientali e classiche dell’Ateneo torinese, che nel 1820 ricevette dal Ministero dell’Interno l’incarico di recarsi a Bobbio alla ricerca di codici dispersi1. Eccetto la provenienza dall’importante cenobio emiliano, nulla si sa del frammento prima che arrivasse a Torino; pure, il codice di cui faceva parte dovette andare perso o smembrato al più tardi nel XVI secolo, giacché da quel momento il foglio superstite fu utilizzato per un certo tempo come guardia di un protocollo2
* Dottore di ricerca in Filologia germanica – Università di Torino.
, circostanza che sembra trovare conferma in due caratteristiche della pergamena di cui diremo.
** Desidero ringraziare il professor Luca Loschiavo per aver reso possibile questa pubblicazione e avermi guidato con i suoi consigli; ringrazio inoltre il professor Alessandro Vitale Brovarone, la professoressa Elisa Mongiano e il dottor Edoardo Garis per l’aiuto datomi a risolvere i dubbi di trascrizione del manoscritto. Sono inoltre sentitamente riconoscente al Dr. Martin Fassnacht dell’Institut für neutestamentliche Textforschung, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, per avermi fornito le immagini digitali del frammento qui riprodotto.
1 Cfr. G. Ottino, I Codici Bobbiesi nella Biblioteca Nazionale di Torino indicati e descritti da Giuseppe Ottino (Torino-Palermo, Carlo Clausen, 1890) VI. In generale sull’attività dello scriptorium e della biblioteca del monastero di Bobbio in età longobarda e sulla decadenza di questi si veda A. Zironi, Il monastero longobardo di Bobbio. Crocevia di uomini, manoscritti e culture (Istituzioni e società, 3; Spoleto, Fondazione CISAM - Centro Italiano Studi sull’Alto Medioevo, 2004) 47-76. Lo studioso tratta anche di diversi manoscritti bobbiensi (cfr. anche ibidem 121-166) ma, nella fattispecie, non di F. IV. 1 fr. 11.
2 Cfr. F. Patetta, Le Ordalie. Studio di Storia del Diritto e Scienza del Diritto Comparato (Torino, Fratelli Bocca Editori, 1890) n. 2, 294.
CHIARA SIMBOLOTTI
224
Conservato nello stesso faldone miscellaneo3 che contiene l’assai più noto Codex Taurinensis (F. IV. 1 fr. 10) – i quattro fogli di un palinsesto che tramanda nella scriptio inferior, sotto le Homeliae in Ezechielem di Gregorio Magno, parti della traduzione ulfilana in gotico della Bibbia –, il frammento 11, come pure gli altri della cartella, reca ben visibili i segni del fuoco e dell’acqua di spegnimento, riportati durante l’incendio che colpì duramente la sede storica della biblioteca4 nella notte tra il 25 e il 26 Gennaio 1904 distruggendone ben cinque sale, tra cui quella dei manoscritti5. Carlo Cipolla, che a seguito del grave evento pubblicò un inventario dei codici sopravvissuti6, indica come il faldone F. IV. 1 si fosse conservato integro, ma in cattive condizioni, ad eccezione dei fascicoli 1, 5, 8 e 15, che si erano mantenuti in buono o in discreto stato7. Entro le prime due decadi del Novecento8
3 Cfr. Ottino, I Codici Bobbiesi, 22. Ottino descrive in generale il contenuto del
faldone F. IV. 1 come “varia fragmenta codicum”, una miscellanea di diciassette frammenti già numerati progressivamente da I a XVII. Anche Carlo Cipolla parla del contenuto miscellaneo di F. IV. 1, contenente pergamene provenienti da manoscritti differenti e di epoca diversa. Cfr. C. Cipolla, Codici Bobbiesi della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (Milano, Ulrico Hoepli Editore Libraio della Real Casa, 1907) 75.
, l’intero faldone subì un
4 Allora denominata Regia Biblioteca Universitaria, aveva sede al tempo nel palazzo dell’Università in Via Po 17. Il 15 Ottobre del 1973 fu trasferita nell’odierna sede in Piazza Carlo Alberto 3.
5 Per una sintesi dei fatti riguardanti l’incendio e i successivi interventi di recupero dei fondi librari si vedano A. Giaccaria, I manoscritti danneggiati nell’incendio del 1904. Mostra di recuperi e restauri: Torino Febbraio-Marzo 1986 (Quaderni della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, 9; Torino, Turingraf, 1986) particolarmente 5-10 e Id., ‘Nuove identificazioni di manoscritti greci e latini della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino’, Aevum 81, fasc. 2 (2007) 429-483 (qui 429-433). Inoltre G. Gorrini, L’incendio della Biblioteca Nazionale di Torino (Torino-Genova, Edizioni Renzo Streglio e C.ia, 1905).
6 Cfr. C. Cipolla – G. De Sanctis – C. Frati, ‘Inventario dei codici superstiti greci e latini antichi della Biblioteca Nazionale di Torino’, Rivista di Filologia e d’Istruzione classica (1904) 385-588. In particolare la sezione curata da Cipolla e Frati alle pagine 436-456 fu ripubblicata in appendice al lavoro bilingue in italiano e francese di Giovanni Gorrini. Cfr. Gorrini, L’incendio della Biblioteca 273-292.
7 Cfr. Cipolla – De Sanctis – Frati, ‘Inventario dei codici’ 439 o Gorrini, L’incendio della Biblioteca 277.
8 Entro il 1912 – secondo un’indicazione presente nello schedone della biblioteca relativo a questa cartella – e sicuramente prima del 1922, dal momento che in F. Cosentini – A. Sorbelli (edd.), Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia. Vol. XXVIII Torino (Firenze, Libreria Editrice Leo S. Olschki, 1922) 91, il faldone F. IV. 1 è registrato col numero di serie R 882, ove R indica appunto l’avvenuto restauro. Tuttavia in questo catalogo i diversi frammenti che
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
225
restauro conservativo ad opera del laboratorio di Carlo Marré9
2. Considerazioni codicologiche e paleografiche
che ne determinò l’attuale condizionamento. Benché quindi Cipolla non avesse incluso il nostro testimone tra quelli meno lesionati, possiamo constatare che lo stato di conservazione del manoscritto è relativamente buono, specialmente per quanto riguarda il testo principale che risulta piuttosto agevole da leggere; non così tuttavia per determinate glosse interlineari e marginali – soprattutto, ma non soltanto, quelle sui margini superiori a 1r e 2v – laddove il supporto subì danni tanto rilevanti da rendere assai faticosamente e non completamente decifrabile lo scritto.
All’interno della cartella d’inizio Novecento, in cartone e tela di colore viola scuro, a sua volta posta in un moderno contenitore a scatola in cartone rivestito di tela chiara, il frammento 11 è conservato disteso, protetto come tutti gli altri da una propria camicia cartacea, segnata a matita blu e rossa F. IV. 1 (11). Nello stesso fascicolo è presente anche un foglio cartaceo di guardia, disteso rispetto a un’originaria piegatura in due e incollato su uno spesso supporto cartaceo10; tale foglio reca sulla prima facciata un timbro in rosso della biblioteca e l’indicazione in grafia ottocentesca: Fragmentum XI. Duo folia membranacea in 4°. Frag. Legum Longobardicarum F. IV. 111
Il bifolium pergamenaceo si compone dunque di due carte, la cui numerazione, apposta sia sul retto che sul verso agli angoli inferiori esterni delle pagine
; un secondo foglio di carta di dimensioni inferiori, contenente appunti tratti dal Codex Eporedianus XXXIV è montato su un analogo supporto cartaceo, in modo che tuttavia risultino visibili sia il retto che il verso. Entrambi, come pure il bifoglio membranaceo, mostrano evidenti bruciature dovute al catastrofico evento del 1904.
12
compongono la miscellanea sono identificati con un numero differente rispetto a quello della segnatura tradizionale e in particolare il frammento 11, oggetto del nostro interesse, è indicato come numero 4. Sull’inaccuratezza di questo inventario si veda A. Giaccaria, ‘I fondi medievali della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino’, Pluteus 2 (1984) 175-194 (qui 188).
, è un intervento recenziore eseguito al lapis in cifre
9 Cfr. Giaccaria, ‘I fondi medievali’ 179. 10 Il verso del foglio è dunque inaccessibile ma in trasparenza risulta vuoto. 11 Più sotto a matita viene ripresa l’intestazione: Legum longobardicarum
fragm[...], parzialmente compromessa dalla bruciatura. 12 A 1r sul margine esterno del foglio, in basso, oltre alla cartulazione è ripresa
al lapis anche l’indicazione: F. IV. 1 Frammento XI.
CHIARA SIMBOLOTTI
226
arabe (1r, 1v, 2r, 2v)13. La membrana misura circa mm. 250×33214 e presenta una rigatura a secco, tracciata dal lato carne, che appronta 32 rettrici e due intercolumni laterali semplici. La distanza tra le rettrici è di mm. 6 e la dimensione degli intercolumni di mm. 5. Su entrambi i margini esterni sono ancora ben individuabili i segni del punctorium usati per guidare la rigatura. Rispetto alle righe previste, a 2r si riscontra tuttavia la presenza di una linea di scrittura in più, inserita tra la dodicesima e la tredicesima rettrice. Caratteristiche rilevabili sulla pergamena sono poi due notabilia, rispettivamente nel margine esterno del fol. 2r15 e nel margine interno del fol. 2v16, costituiti dal termine nota in forma di monogramma; inoltre sui margini interno ed esterno del fol. 2r, all’altezza rispettivamente della prima e della seconda linea di scrittura, si rilevano isolate una ō ̣e una g·, mentre nel margine interno a circa metà altezza della carta l’espressione non legitur è scritta in caratteri capitali di dimensioni tra loro differenti che si sovrappongono condividendo uno o più tratti. Infine sul margine superiore del foglio 2v si legge un numero in cifre arabe, forse 180217
A dimostrare l’uso del bifoglio quale guardia di un protocollo, come accennato in precedenza, oltre all’iscrizione capovolta presente nel margine inferiore del foglio 2v: Protocollo 1578 B, sarebbero le serie – due coppie su ciascuna carta, convergenti a due a due dai margini esterni verso il centro dello specchio di scrittura – di minutissimi fori dalla forma piuttosto regolare. Le serie appaiono speculari tra le due carte e, operando un’ipotetica piegatura del foglio a metà secondo la linea di
.
13 Il bifoglio cartaceo di guardia e la pagina di appunti sono invece numerati
al lapis con cifre romane (I, II). 14 È interessante notare che in Ottino (cfr. Ottino, I Codici Bobbiesi 24)
vengono fornite a proposito di F. IV. 1 fr. 11 le seguenti misure in centimetri 26,5×18. Benché Giaccaria segnali le frequenti imprecisioni di questo catalogo (cfr. Giaccaria, ‘I fondi medievali’ 189), una tale differenza rispetto a quanto qui segnalato non sembra potersi ascrivere a una svista; evidentemente Ottino annotò le dimensioni della singola carta – la metà del bifoglio – che, se confrontate con le attuali tenendo conto di dover raddoppiare la misura della lunghezza, rendono l’idea di quanto i margini siano stati intaccati dal fuoco.
15 All’altezza delle linee 25 e 26. 16 All’altezza delle linee 5 e 6. 17 In verità si leggono molto chiaramente soltanto le prime tre cifre, mentre il
2, non distintamente visibile, sembrerebbe un po’ scostato rispetto ai numeri che lo precedono; inoltre si scorge l’eliminazione di una cifra davanti allo 0, probabilmente un 3. In generale potrebbe trattarsi di un’antica segnatura, ma non vi è certezza. Infine nell’angolo superiore esterno di 2v si trova traccia della foliazione propria del codice cui il bifoglio apparteneva. Apparentemente è un numero a tre cifre – forse 153 – tracciato ad inchiostro, di cui si distinguono chiaramente solo 1 e 5.
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
227
cucitura, sembrerebbero sovrapponibili. Molto probabilmente si tratta dei segni lasciati dai punti che fissavano le stringhe di chiusura di una cartella protettiva, così ottenuta riutilizzando una pergamena considerata ormai di scarto. Sono inoltre ben visibili piccoli risarcimenti in pergamena applicati durante il restauro a rinforzo di punti fragili o particolarmente danneggiati, specialmente nel margine superiore. Segnalo specificamente due lacerazioni così riparate, la cui presenza compromette parzialmente il testo della glossa: la prima di forma allungata – mm. 20×3 circa – si estende obliquamente a partire dal margine esterno di 1r/v, la seconda – mm. 7×5 circa – si trova sul margine superiore della stessa.
L’aspetto sobrio mancante di ornamentazione18, la presenza di glosse esplicative e allegazioni in margine e in interlinea, nonché l’uso delle maniculae19 volte ad attrarre l’attenzione su alcuni passaggi in particolare del testo legislativo, suggeriscono in generale una funzione del manoscritto eminentemente pratica di consultazione e studio. La fitta e minuta grafia carolina dello scritto è realizzata con un inchiostro di colore marrone-bruno, l’uso del colore rosso è limitato alle rubriche e ad alcuni capolettera maiuscoli20
Ascritto tout court al XII secolo
. Segnalo infine la presenza di alcuni emendamenti ben visibili, eseguiti dall’ulteriore mano di un revisore che agì utilizzando un inchiostro più scuro.
21
18 Neppure i capolettera, alcuni nemmeno rubricati, recano alcuna traccia di
ornamentazione, limitandosi a presentare solo un modulo maggiore.
, il manoscritto non ebbe nel tempo alcuna collocazione cronologica più precisa; tale indicazione, tuttavia, pur molto probabilmente non contraria al vero, appare in effetti assai ampia e poco significativa, specie considerando gli importanti mutamenti grafici
19 Riguardo a questi segni ausiliari: due sono al fol. 1r ad indicare passi dei capitoli 21 e 92 di Liutprando, quattro al fol. 1v per attrarre l’attenzione su passaggi dei capitoli 118 e 136 ancora di Liutprando, uno è al fol. 2r in conclusione del capitolo 137 di Rotari e infine uno è al fol. 2v a segnalare il capitolo 16 di questo stesso sovrano.
20 In particolare sono tracciate in inchiostro rosso al fol. 1r le R iniziali maiuscole di Recolimus (linee 6 e 32), al fol. 1v l’iniziale I di Item (linea 24), al fol. 2r i capolettera maiuscoli R, S, N di Rex, Siquis, Nullus (linee: 5, 6, 10, 12, 13, 15, 19, 24, 27) e la rubrica R de homicidio seruorum uel aldiorum (margine esterno, linea 4); al fol. 2v le iniziale maiuscole R e S di Rex e Siquis (linee: 8, 15, 20, 28) e le rubriche R de sepulchro uiolato et de eo qui hominem mortuum expoliauerit e R ne ad regem uenientibus iniuria fiat (margine interno, linee: 7, 8, 19, 20).
21 Cfr. Ottino, I Codici Bobbiesi 24; Patetta, Le Ordalie 294 e F. Patetta, ‘Nuove ipotesi sulla patria della così detta Lombarda’, Studi sulle fonti giuridiche medievali (Torino, Bottega d’Erasmo, 1967) 927-956 (qui 939); già in Festschrift Heinrich Brunner zum siebzigsten Geburtstag dargebracht von Schülern und Verehrern (Weimar, H. Böhlaus Nachfolger, 1910) 349-378 (qui 361).
CHIARA SIMBOLOTTI
228
avvenuti durante questo secolo. Consci delle notevoli difficoltà nell’attribuire una data ai manoscritti in carolina, particolarmente per quanto concerne i secoli XI e XII, e dell’opportunità di applicare i criteri di datazione con prudenza ed elasticità22, non sembra dunque ragionevole pretendere di datare con esattezza la grafia del frammento; piuttosto, sulla scorta delle indicazioni di B. Bishoff, A. Petrucci, A. Pratesi23, pare soprattutto interessante evidenziare determinati tratti coesistenti nel manoscritto, alcuni proprii ancora della carolina dell’XI secolo, altri già appartenenti al suo sviluppo tra l’XI e le prime decadi del XII. Chiaramente le osservazioni paleografiche devono prendere in considerazione tanto il testo principale, quanto le glosse, le quali è molto probabile – ma non scontato – siano di mano differente e inoltre si deve ricordare che solo in parte esse sono chiaramente leggibili. Innanzitutto la grafia del frammento ha ormai acquisito un andamento diritto, essendosi persa quell’inclinazione verso sinistra tipica delle prime fasi di questo stile scrittorio, una perdita iniziata già nel passaggio tra il X e l’XI secolo; l’aspetto delle lettere è ormai meno arrotondato e tuttavia il chiaroscuro non è accentuato, né si è ancora sviluppata quell’anglosità e spezzatura delle linee, preludio alla gotica. Fra le caratteristiche grafiche di maggiore interesse noteremo che sia nel testo sia nella glossa non è ancora in uso il doppio apice nel caso di ii accostate per distinguerle dalla u, un fenomeno che comincia ad affermarsi in Italia a partire dalla fine dell’XI secolo e canonizzatosi dopo la metà del successivo24. La ȩ cedigliata il cui uso regolare per il dittongo æ si sviluppò proprio durante l’XI secolo, compare qui per -ae in fine di parola, evidentemente non ancora soppiantata dalla semplice e. All’interno di parola, l’uso di r rotonda a forma di 2 dopo la o, un tratto sviluppatosi tra la fine dell’XI secolo e gli inizi del seguente, non si presenta ancora con regolarità, mentre il compendio -rum – realizzato come r in forma di 2 con elemento di base dritto sul rigo intersecato da un tratto inclinato a sinistra – è già usato qui oltre che per la desinenza del genitivo plurale maschile -orum, anche per il femminile -arum – nelle glosse –, una caratteristica questa emersa entro le prime due decadi del XII secolo25
22 Cfr. A. Petrucci, ‘Censimento dei codici dei secoli XI-XII. Istruzioni per la
datazione’, Studi Medievali, III serie, IX (1968) 1115-1126 (qui 1115-1117).
. Sono troppo esigue le occorrenze per valutare l’impiego della s in forma maiuscola a fine rigo,
23 B. Bischoff, Paleografia Latina. Antichità e Medioevo (Padova, Editrice Antenore, 1992) 169-183; P. Cherubini – A. Pratesi, Paleografia Latina. L’avventura grafica del mondo occidentale (Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 2010) 399-402; Petrucci, ‘Censimento dei codici’ 1115-1125.
24 Cfr. Bischoff, Paleografia Latina 176. 25 Cfr. Cherubini – Pratesi, Paleografia Latina 401.
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
229
mentre per quanto riguarda il suo uso in fine di parola, cosa che potrebbe rappresentare un tratto recenziore26, pare prevalente ma non esclusivo nel testo principale, mentre nelle glosse in tale posizione sembrerebbe più frequente la s minuscola. Un altro elemento porterebbe poi a non inoltrarsi troppo all’interno del XII secolo ovvero il fatto che quasi non si incontri27 il ɔ retroversus compendiario della sillaba con-, cum-28 (XII sec.). Al contrario un tratto recenziore è rappresentato dall’uso costante della nota tironiana 7 per la congiunzione et29, che qui non lascia spazio al segno &30
Si delinea dunque una situazione in cui, mentre alcuni tratti tipici della grafia carolina più tarda, sviluppatisi a fine XI e nel corso del XII secolo, ancora non prevalgono o non appaiono affatto, altre caratteristiche più arcaiche permangono. Peraltro la sopravvivenza di elementi conservativi non è necessariamente un criterio significativo per retrodatare un testimone, essa potrebbe dipendere dallo stile personale dello scriba, dalla sua età e formazione o dall’influsso del modello a disposizione del copista, il che è forse tanto più verosimile per quanto riguarda il testo principale – la materia edittale che si vuole rispettare e tramandare intatta tanto nel contenuto, quanto nelle forme – mentre per le glosse esplicative forse lo scriba potrebbe essersi concesso maggiore libertà scrittoria. In conclusione, da quanto osservato, parrebbe quindi ragionevole collocare cronologicamente il frammento in una fase di transizione tra la fine dell’XI e i primi decenni del XII secolo.
. La tipica legatura a ponte si riscontra solo per il nesso st e non per ct. Essa ha una forma che sale sul rigo piuttosto stretta e allungata, secondo l’aspetto che aveva sviluppato già durante la prima metà dell’XI secolo; il tratto orizzontale della t tende ad accostarsi e talvolta a toccare l’asta della s.
3. Il contenuto del manoscritto
Il contenuto del bifoglio venne individuato e segnalato in modo molto generico al momento della sua catalogazione ad opera di chi, nel tempo, lavorò ai vari riordini della biblioteca, come si evince dagli inventari a
26 Cfr. Petrucci, ‘Censimento dei codici’ 1123. 27 L’ho riscontrato solo due volte in contigerit e consilio nella problematica
glossa marginale di 1r (cfr., glossa (a), a 240 del presente lavoro). 28 Cfr. Cherubini – Pratesi, Paleografia Latina 401 e Petrucci, ‘Censimento dei
codici’ 1123-1124. 29 Cfr. Cherubini – Pratesi, Paleografia Latina 400. 30 La nota tironiana 7 è usata per et anche in fine di parola (es. s7 per set/sed,
hab7 per habet).
CHIARA SIMBOLOTTI
230
nostra disposizione31. Fu tuttavia Federico Patetta a determinare più esattamente la sua sostanza. Egli accennò una prima volta al frammento in due note del suo saggio sull’ordalia32, parlando in quell’occasione prima di una serie di larghi estratti dall’Expositio al Liber Papiensis, poi di frammenti della raccolta legislativa nota come Lombarda33
31 Nell’Appendice al Pasini, al foglio 109r, il frammento è indicato alla voce
Leges come: Legum Langobardicarum fragmenta (V in theca), con l’odierna segnatura. L’Appendice al Pasini è la continuazione del catalogo pubblicato da Giuseppe Pasini nel 1759 (Catalogo del Pasini). Essa si conserva nel manoscritto Cons. Mss. 8 Pasini 1/3 della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, che è tuttavia privo di indicazioni circa la data di compilazione e l’autore (cfr. Ottino, I Codici Bobbiesi VII). Riguardo l’attribuzione dell’Appendice a Bernardino Peyron, nipote di Amedeo, e la possibile datazione al periodo 1860-1865, si veda Giaccaria, ‘I fondi medievali’ 187 e S. Bellocchio – V. Dolcetti Corazza, ‘Il Codex Taurinensis F. IV. 1 fr. 10’, Le rune. Epigrafia e letteratura. IX Seminario Avanzato in Filologia Germanica, edd. V. Dolcetti Corazza – R. Gendre (Bibliotheca Germanica. Studi e testi, 26; Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2009) 65-115 (qui 87). In Ottino, I Codici Bobbiesi 24, a proposito del fr. 11 viene indicato: “XI. Lex Lombarda vulgata. Frammento di codice del secolo XII. Membranaceo, 26,5×18. Carte due, con glosse interlineari e marginali, contiene: Libro I, Titolo IX, cap. 20-24. Titolo X, legge finale. Titolo XI, cap. 1-9”.
. Lo
32 Cfr. Patetta, Le Ordalie, n. 2, 294 e n. 3, 438. 33 Riguardo tali raccolte normative, Liber Papiensis e Lombarda, che fiorirono
in diverse redazioni tra l’XI e il XII secolo, riordinando la materia giuridica degli editti dei sovrani longobardi e integrandola con quella tratta dai capitolari imperiali per l’Italia (Capitulare Italicum) – da Rotari (636-652) fino a Enrico II di Sassonia (1014-1024) –, oltre a quanto esposto nelle prefazioni delle edizioni presenti negli MGH – cfr. A. Boretius, Liber Legis Langobardorum Papiensis dictus, edente Alfredo Boretio I.U.D., Leges Langobardorum. Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, auspiciis Societatis aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi edidit Georgius Heinricus Pertz, serenissimo Borussiae regi a consil. regim. int. bibliothecae regiae praefectus, Legum tomus IIII (in Folio) (Hannoverae, Impensis bibliopolii aulici Hahniani, 1868) XLVI-XCVIII e F. Bluhme Leges Langobardorum XCVIII-CXI – si consultino le rispettive voci curate da Guido Astuti per il Novissimo Digesto Italiano. Cfr. G. Astuti, ‘Liber Papiensis’ e ‘Lombarda’, Novissimo Digesto Italiano, vol. IX, edd. A. Azara – E. Eula (Torino, UTET - Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1963) rispettivamente 829-830 e 1068-1070. Si vedano inoltre: G. Astuti, Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti. Età romano-barbarica (Padova, CEDAM - Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1968) 157-170 e 358-376; M. Bellomo, Società e Istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell’Età moderna (Catania-Roma, Editrice Giannotta e Il Cigno Galileo Galilei. Edizioni di Arte e Scienza, 1991; I ed. Catania, Editrice Giannotta, 1976) 186-187; F. Calasso, Il Medio Evo del diritto. I. Le fonti (Milano, Dott. A. Giuffré Editore, 1954) 309-315; E. Cortese, Il diritto
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
231
studioso, più tardi, confermò definitivamente questa seconda identificazione nel suo contributo sulle ipotesi riguardo il luogo d’origine della Lombarda34
Certamente l’esiguità del materiale pervenuto e il suo carattere fortemente frammentario non rendono possibile un’ampia disamina circa la struttura e il contenuto del codice cui il foglio doveva appartenere; tuttavia si possono fare alcune considerazioni. Innazitutto risulta evidente che il frammento non costituiva il bifoglio centrale di un fascicolo, dal momento che tra 1v e 2r non c’è continuità di contenuto, rendendo chiaro che altri fogli si inframmezzavano tra le due carte. Dunque il foglio 1r/v tramanda una parte del capitolo 21 di Liutprando da “et in eo ordine” fino alla fine
, ascrivendo dunque il frammento torinese alla tradizione manoscritta di questa collezione nata tra XI e XII secolo dall’intento di riorganizzare sistematicamente il complesso normativo longobardo-franco.
35 e prosegue con i capitoli del medesimo sovrano: 62, 92, 118 e soltanto l’inizio del 136, da “Item annuntiatum est nobis” fino a “et nostris iu”36. Al foglio 2r/v si trovano invece la fine del capitolo 2 di Enrico I a partire da “penitentie subdatur”37
Malgrado lo iato tra le due carte – quantificabile almeno in un altro bifoglio – si arguisce immediatamente che le disposizioni dei tre sovrani
e a seguire i capitoli di Rotari: 129-137, 376, 16, 15, 17, 18.
nella storia medievale. II. Il basso Medioevo, (Roma, Il Cigno Galileo Galilei. Edizioni di Arte e Scienza, 1995) 16-22.
34 Cfr. Patetta, ‘Nuove ipotesi’, n. 2, 938-939. 35 Per la prima parte del capitolo cfr. Boretius, Liber Legis 417: “Si servus cum
voluntate domini sui hominem liberum occiderit et probatum fuerit, tunc ipse dominus eius omnes res suas amittat...”.
36 Per la restante parte del capitolo cfr. Boretius, Liber Legis 466: “... [iu]dicibus rectum paruit esse, ut ipse homo qui ibi mortuus est, quia non fuit animal, sed sensum racionabilem habuit, sicut homo debet habere, prospicere debuit, in quali loco se poneret ad standum aut quale pondus super se videbat, ideo reputet sibi duas partes precii de compositione sua, et terciam partem, quantum ipse secundum edicti tenorem appreciatus fuerit, componat ille qui ipsam aquam incaute auriebat, et det eam filiis aut propinquis parentibus vel qui ei heredes existunt, et sit causa finita absque omni faida vel dolo, quod nolendo factum est. Ille autem cuius puteus fuit nullam habeat calumpniam: quia, si ei calumpniam ingerimus, nullus postea permitteret de puteo suo aquam levare, et quia omnes homines puteos habere non possunt, reliqui qui pauperes sunt siti morerentur, et etiam iterantes necessitatem paterentur”.
37 Per la prima parte del capitolo cfr. Boretius, Liber Legis 582: “Quicumque propter cupiditatem rerum patrem aut matrem aut fratrem aut sororem vel nepotem vel alium propinquum suum per se aut per alium interfecerit, hereditas interfecti ad alios suos legitimos heredes perveniat. Interfectoris vero hereditas in fiscum redigatur, ipse vero ordinante episcopo publicae...”.
CHIARA SIMBOLOTTI
232
qui presentate sono organizzate per materia, dal momento che quasi tutti i capitoli trattano dell’omicidio nelle sue più varie declinazioni, volontario o involontario, dovuto ad incidente, per difesa o con dolo, perpetrato ai danni di liberi o servi, uomini, donne o minori. Tale reato è affrontato da 1r fino all’inizio di 2v ed è ben possibile dunque che esso potesse costituire l’argomento anche dei fogli inframmezzati e ora perduti; la qual cosa troverebbe parziale sostegno nella presenza, all’inizio di 2r, della parte finale della disposizione di Enrico I. Tale norma, a leggerne il testo per intero, tratta anch’essa di uccisione – quella dei familiari per motivi di eredità – evidentemente contribuendo all’impressione di continuità tematica. A 2v poi il contenuto cambia e le ultime quattro disposizioni di Rotari si discostano per tema dalle precedenti.
L’organizzazione, non cronologica ma sistematica dei capitoli ivi tràditi, conferma dunque pienamente l’identificazione proposta da Patetta. È parso allora utile procedere ad un raffronto in dettaglio tra la struttura interna del frammento e la disposizione della materia legislativa suddivisa per libri e titoli propria della Lombarda, per determinare a quale delle sue differenti tradizioni testuali – la redazione detta Cassinese e quella nota come Vulgata – il nostro frammento si avvicini maggiormente38
. L’analisi ha dimostrato come il contenuto del bifoglio segua perfettamente, pur operando in alcuni casi una selezione delle disposizioni giuridiche da trascrivere, la scansione della Vulgata, mentre sussista una certa discrepanza rispetto alla struttura della Cassinese. Una differenza che, per quanto concerne i capitoli presi in esame, a mio parere si configurerebbe come una maggiore ricerca di unitarietà tematica che accomuna il nostro frammento e la Vulgata, dal momento che entrambi, differentemente da quanto accade nella Cassinese, ordinano tutte le disposizioni riguardanti l’omicidio in gruppi contigui. Per ottenere una visione più chiara delle identità e delle differenze nella disposizione normativa si può osservare la seguente tavola:
38 Cfr. F. Bluhme, Legis Langobardorum libri tres sive syntagmata duo
Lombarda vulgo dicta ex libro Papiensi confecta, edente Friderico Bluhme icto, Leges Langobardorum 607-623 e 623-640.
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
233
F. IV. 1 fr. 11 Lombarda Cassinensis
Lombarda Vulgata
Liut. nn. 21, 62, 92, 118, 136, fol. 1r/v
nn. 20-24, lib. I, R 3 De homicidiis
nn. 20-24, lib. I tit. IX De homicidiis libero-rum hominum
Enr. I n. 2, fol. 2r
n. 4, lib. I, R 4 De parricidiis
n. 5, lib. I, tit. X De parricidiis
Rot. nn. 129-137, 376, fol. 2r/v De homici-dio seruorum uel aldiorum
nn. 1-2, lib. I, R 5 De sepulcro violato et homine mortuo expoliato
nn. 1-9, lib. I, tit. XI De homicidiis servorum vel aldiorum
Rot. nn. 16, 15, fol. 2v De sepulchro uiolato et de eo qui hominem mortuum expoliauerit
nn. 1-2, lib. I, R. 6 Ne quis ad regem venientibus iniuria fiat
nn. 1-2, lib. I, tit. XII De sepulcro violato et de eo qui hominem mor-tuum expoliaverit
Rot. nn. 17, 18, fol. 2v Ne ad regem uenientibus iniuria fiat
nn. 1-9, lib. I, R 18 De homicidiis servo-rum aut aldiorum
nn. 1-2, lib. I, tit. XIII Ne ad regem ve-nientibus iniuria fiat
Nell’ambito di questa prossimità di struttura tra le redazioni della
Lombarda e l’F. IV. 1 fr. 11, noterei ancora un elemento comune, ovvero l’inversione dei capitoli di Rotari 16 e 15, presentati così in ordine contrario non solo rispetto all’editto originario, ma anche al Liber Papiensis39
4. Le parole longobarde presenti in F. IV. 1 fr. 11
.
Grande è la distanza cronologica che separa questo frammento della Lombarda dagli editti emanati dai sovrani longobardi. Le raccolte legislative tarde, quale è questa ivi parzialmente conservata, testimoniano evidentemente l’interesse che la materia giuridica più antica continuò a rivestire ancora per lungo tempo dopo la fine del regno longobardo in Italia, nonché la sopravvivenza di un nucleo sociale che – come si evince pure dalla produzione documentale pubblica e privata – ancora professava di vivere secondo questa legge. Inevitabilmente tuttavia in tali collezioni recenziori vennero apportate modifiche testuali alle emanazioni originarie, introducendo mutamenti che se a livello
39 Si noterà tuttavia che la rubrica introduce le due disposizioni secondo il
corretto ordine.
CHIARA SIMBOLOTTI
234
giuridico, come sottolinea G. Astuti40, non hanno generalmente grande rilievo, possono però essere significativi a livello linguistico. È il caso, ad esempio, della sparizione di parole longobarde presenti nel testo edittale, sostituite nel tempo da una resa latina; nella fattispecie del nostro frammento si sono persi due specifici nomina actionis41: crapworfin “profanazione di sepolcro” e rairaub “spoliazione di cadavere”42
Per quanto concerne il lessico longobardo, comunque, il foglio F. IV. 1 fr. 11, per contenuto e brevità, non offre certamente nuovi apporti. I vocaboli qui conservati sono quelli da sempre proprii dei rispettivi capitoli di legge; si tratta pertanto di parole ormai ampiamente esaminate e discusse dagli studiosi, sia dal punto di vista etimologico e linguistico
, originariamente presenti nelle intitolazioni ai capitoli 15 e 16 di Rotari, ove queste due forme non assimilate alla declinazione erano però introdotte dalla preposizione de alla maniera latina. Nel manoscritto, secondo un uso ormai consolidato, i due termini sono sostituiti da un’unica rubrica: de sepulchro uiolato et de eo qui hominem mortuum expoliauerit.
43
40 Cfr. Astuti, Le fonti 158.
sia, nel caso di termini indicanti figure o istituti giuridici
41 Cfr. Bluhme, Edictus Langobardorum 15. 42 Cfr. N. Francovich Onesti, Vestigia longobarde in Italia (568-774). Lessico e
antroponimia (Roma, Artemide Edizioni, 1999) 74 e 112-113. 43 Non è certo il caso di indugiare qui sull’amplissima mole di studi dedicati
alle testimonianze linguistiche longobarde. Tali lavori, in mancanza di testi scritti in lingua longobarda, si sono rivolti alle sopravvivenze lessicali di questo idioma presenti appunto nel corpo giuridico, in quello documentale, nelle opere di carattere storico – in primis l’Historia Langobardorum di Paolo Diacono – nonché ai prestiti nelle lingue moderne, in particolare nei dialetti di diverse zone d’Italia e quindi nell’italiano, per finire con le sopravvivenze nell’onomastica e nella toponomastica. Tuttavia, pur al di là dei fini del presente contributo, pare corretto accennare ad alcuni vasti lavori che nel passato si volsero a riunire quanto più possibile del materiale linguistico longobardo: W. Bruckner, Die Sprache der Langobarden (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte der germanischen Völker, 75; Strassburg, Karl J. Trubner, 1895; rist. anast. Berlin, W. de Gruyter, 1969), C. Meyer, Sprache und Sprachdenkmäler der Langobarden: Quellen, Grammatik, Glossar (Bibliothek der ältesten deutschen Litteratur-Denkmäler, 14; Paderborn, Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh, 1877), e E. Gamillscheg, Romania germanica. Sprach- und Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des alten Romerreichs, vol. 2 (Berlin-Leipzig, W. de Gruyter, 1935). Tra i contributi più recenti ricordo invece M. V. Molinari, ‘Lessico germanico nelle leggi longobarde’, Linguistica e Filologia. Quaderni del dipartimento di linguistica e letterature comparate dell’Università di Bergamo 1 (1995) 5-20 e particolarmente il già citato Francovich Onesti, Vestigia longobarde; quest’ultimo raccoglie le testimonianze linguistiche del lessico comune e del corpus onomastico appartenenti al periodo che va dal VI
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
235
particolari, nel loro significato storico e sociale; di essi, dunque, non resterà che fare breve menzione.
Primo in ordine di apparizione è il termine guidrigild “controvalore”44, ovvero la riparazione in denaro delle lesioni personali e dell’omicidio, in base al grado sociale della vittima; un sistema di compensazione volto a scongiurare il ricorso alla faida. Nel frammento guidrigild si trova solo nelle glosse (a)45 e (g) al capitolo 21 di Liutprando e la forma qui attestata si connota come una variante più tarda – tuttavia indeclinata – e linguisticamente differente rispetto al parallelo wergild, ugualmente presente nelle leggi longobarde, specialmente in Rotari e Liutprando46. A seguire è gasindius “funzionario regio”, “seguace del re”47
secolo a tutto il regno longobardo in Italia (568-714). A questo studio rimando costantemente in nota per la discussione dei termini ivi tràditi. Dei molti lavori condotti sui longobardismi presenti nel materiale documentale ricordo tra tutti: P. Scardigli, ‘Appunti longobardi’, Goti e Longobardi. Studi di Filologia Germanica (Roma, Istituto italiano di Studi germanici, 1987) 191-246; già in Filologia e critica. Studi in onore di Vittorio Santoli, ed. P. Chiarini (Roma, Bulzoni Editore, 1976) 91-131, Id., ‘All’origine dei longobardismi in italiano’, Goti e Longobardi 269-293; già in Sprachliche Interferenz. Festschrift für Werner Betz zum 65. Geburtstag, edd. H. Kolb – H. Lauffer (Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1977) 335-354, Id., ‘Le parole longobarde per l’ecdotica dell’Editto di Rotari’, Goti e Longobardi 303-329; già in Medioevo e Rinascimento.
, che nel testo del capitolo 62 di Liutprando e nelle relative glosse (e) e (h) appare declinato secondo le forme latine del nominativo e dell’ablativo plurali gasindii e gasindiis. A questo proposito è
Annuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento dell’Università di Firenze 1 (1987) 53-73, G. Princi Braccini, ‘Germanismi editi e inediti nel Codice diplomatico longobardo: anticipi da uno spoglio integrale e commentato di fonti latine in vista di un Tesoro longobardo’, Quaderni del Dipartimento di Linguistica dell’Università degli Studi di Firenze 9 (1998/1999) 191-240 e Id., ‘Germanismi editi e inediti nel Cartulario di S. Benedetto di Conversano (901-1265)’, Quaderni del Dipartimento di Linguistica dell’Università degli Studi di Firenze 10 (2000) 1-41.
44Cfr. Francovich Onesti, Vestigia longobarde 131-132. 45 Per quanto si può leggere di questa glossa marginale fortemente
compromessa, il termine in questione appare qui due volte. Forse la prima delle occorrenze mostra la variante grafica uuidrigild, ma la lettura è assai incerta per il danno subito dalla pergamena.
46 Se infatti guidrigild (cfr. Francovich Onesti, Vestigia longobarde 131) è composto dall’avverbio germ. *wiþr(o) “contro” e dal sostantivo *gelða “compenso”, da cui proprio il senso di “controvalore”, il più antico wergild si forma dall’anteposizione a *gelða del sostantivo wer “uomo libero” (germ. *wera-z, wira-z), sottolineando dunque il concetto di una riparazione per il danno perpetrato contro la persona.
47 Cfr. Francovich Onesti, Vestigia longobarde 91.
CHIARA SIMBOLOTTI
236
interessante notare come al termine longobardo utilizzato nella disposizione legislativa non sia apposta alcuna annotazione esplicativa latina, mentre invece gasindiis e gasindii servano a chiosare in glossa minimis e maiores. Escludendo che i due termini latini risultassero tanto estranei da necessitare di una sorta di spiegazione in lingua longobarda, è chiaro che la glossa aveva la mera funzione di connettere quei generici maiores e minimi al particolare tipo di funzionario appena menzionato. Comunque l’uso del vocabolo longobardo da parte del glossatore è spia di una dimestichezza ancor viva almeno con alcune sopravvivenze di questo idioma.
L’assimilazione dei longobardismi alle forme del latino non è certo un’innovazione propria delle raccolte giuridiche recenziori, ma risale già ai testi originali. Se il detto guidrigild si mantiene indeclinato, non così accade per i nominativi castaldius “amministratore dei beni del re” e sculdasius “esattore”48 (Rotari 15); quest’ultimo addirittura mostra forma latinizzata non riscontrabile né nella tradizione manoscritta dell’editto, né in quella del Liber Papiensis49. Seguono la declinazione latina anche gli accusativi aldium “semilibero” e aldiam “semilibera” o “ancella”50 (Rotari 129 e 376), camphionem “combattente”, “duellante”51 appositamente assoldato per sostituire un contendente nel combattimento giudiziale (Liutprando 118 testo e glossa (i) e capitolo 2 di Enrico I). Si segnalano infine il sostantivo sala “casa padronale”, “pars dominica”52 (Rotari 133 e 136), usato all’ablativo nell’espressione de sala, il genitivo Longobardorum53, etnonimo presente al capitolo 118 di Liutprando e alla relativa glossa (k) e il particolare caso di asto54. Quest’ultimo è un termine morfologicamente difficile da classificare dal momento che può avere tre differenti funzioni55
Poche testimonianze, dunque, la cui sopravvivenza è tuttavia significativa in sé. Sia che tali longobardismi si fossero formalmente assimilati al latino, testimoniando una completa acquisizione nel lessico quotidiano, sia che avessero mantenuto la forma originaria, essi erano
, tutte rappresentate in questo frammento; al capitolo 118 di Liutprando e nelle relative glosse asto è infatti aggettivo nell’ablativo di modo asto animo “con animo malintenzionato” ovvero “apposta”, sostantivo in de asto iurare “giurare dell’intenzionalità” (f) e pure avverbio asto “volontariamente” (j).
48 Cfr. ibidem 92 e 118-119. 49 Cfr. Bluhme, Edictus Langobardorum, n. t, 15 e Boretius, Liber Legis 298. 50 Cfr. Francovich Onesti, Vestigia longobarde 54 e 57. 51 Cfr. ibidem 71-72. 52 Cfr. ibidem 113-114. 53 Cfr. ibidem 99. 54 Cfr. ibidem 65-66. 55 Cfr. ibidem 66.
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
237
evidentemente ancora tanto ben compresi da non essere solo riprodotti pedestremente copiando il testo degli editti, ma usati a proposito anche nelle annotazioni ad esso complementari.
5. Criteri di edizione di testo e glosse
Il presente lavoro, oltre che sulla Lombarda Vulgata edita da Friedrich Bluhme56, la quale si limita tuttavia ad indicare i soli titoli e gli incipit dei capitoli legislativi57, è stato condotto avendo a riferimento l’edizione del Liber Papiensis curata da Alfred Boretius58. Per ulteriori raffronti tra le disposizioni tramandate dal manoscritto e quelle degli editti di Rotari e Liutprando ho scelto il testo delle Leges Langobardorum a cura di F. Bluhme59, tenendo presente, all’occorrenza, anche il lavoro di Claudio Azzara e Stefano Gasparri60. Nella trascrizione del frammento ho seguito, pur adattandole alle esigenze del testo, le indicazioni editoriali fornite da S. Kuttner61
Ovviamente non ho eseguito una trascrizione del bifoglio di tipo strettamente diplomatico, ma ho comunque ritenuto utile indicare la scansione delle linee di scrittura apponendo il segno | ad ogni cambio di rigo. Il segno || segnala invece la fine del testo in una carta e il passaggio a quella successiva. Tuttavia, differentemente da quanto deciso per il testo normativo principale, nel trascrivere le glosse e le rubriche, per le quali non fu prevista una rigatura apposita del foglio ma vennero posizionate a margine o in interlinea, laddove esse si sviluppino su più linee non ho segnalato alcuna scansione. La foliazione è indicata all’inizio della trascrizione di ogni carta. I rimandi apicali alfabetici rinviano alle glosse disposte al di sotto del proprio capitolo legislativo di appartenenza; tali apici sono posizionati cercando di rispecchiare quanto più possibile la corrispondenza della glossa con il proprio referente testuale, ma a tale proposito ricordo che, non essendovi praticamente
.
56 Bluhme, Legis Langobardorum 623-640. 57 Per il testo dei singoli capitoli si rimanda infatti al Liber Papiensis, raccolta
con cui la Vulgata condivide il contenuto giuridico, sistemandolo però secondo un criterio per materia, anziché cronologico.
58 Boretius, Liber Legis 290-585. 59 Bluhme, Edictus Langobardorum 1-234. 60 Azzara – Gasparri (edd.), Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto
di un popolo germanico (Roma, Viella, 2005). 61 S. Kuttner, ‘Notes on the Presentation of Text and Apparatus in Editing
Works of the Decretists and Decretalists’, Traditio 15 (1959) 452-464.
CHIARA SIMBOLOTTI
238
segni di rimando nell’originale62
Poiché la trascrizione si basa sul solo F. IV. 1 fr. 11, ho seguito la grafia dell’originale senza proporre standardizzazioni grafiche; solo di fronte alle forme abbreviative per haec, prae-, quae, che, considerata la datazione tarda del testo, potrebbero sciogliersi in hec, pre-, que, ho scelto per chiarezza la grafia latina classica. Parimenti l’uso delle maiuscole tende a rispecchiare quanto presente nell’originale, salvo in qualche ovvio caso come i nomina sacra, gli antroponimi e gli etnonimi, per lo più minuscoli nel manoscritto
, le glosse – il cui inizio è segnalato da un paragrafale di forma angolare –, pur disposte in prossimità dei vocaboli o dei passi da commentare, non sono sempre agevolmente e univocamente collocabili. Di ogni glossa è inoltre indicata la posizione marginale o interlineare all’interno del foglio e rispetto al proprio riferimento. Gli apici numerici rimandano invece all’apparato critico.
63
Si è già detto delle difficoltà di lettura che il manoscritto presenta, specialmente in alcune sue parti maggiormente danneggiate dall’incendio; per questo motivo, laddove lo scritto risulti illeggibile, sono ricorsa all’uso del segno [...] che rappresenta genericamente la perdita di un certo numero, non precisamente quantificabile, di parole o lettere. La consistenza della lacuna, per quanto possibile, sarà eventualmente discussa in nota. Inoltre alcune glosse appena percettibili, di cui non si intravvede che una vaga traccia
. Inoltre ho introdotto sempre con la maiuscola – e riportato tra virgolette – le intitolazioni dei libri della Lombarda e gli incipit dei capitoli legislativi citati nelle allegazioni presenti in glossa. La punteggiatura è limitata all’indispensabile, cercando di mediare tra la conservazione dei modi testuali e la norma ortografica attuale.
64
62 Si nota tuttavia in tre occasioni l’uso evidente di un segno di rimando tra
testo e glossa realizzato con due o tre puntini posti sia sopra il referente testuale da glossare, sia sull’incipit della glossa stessa: a 1r, alla fine della decima linea di scrittura, tre punti connettono persona alla notazione marginale esterna libera e all’inizio della quattordicesima linea due puntini rimandano dal verbo seruire alla glossa in margine interno idest ualde seruire. A 2v, a metà circa della decima linea di scrittura, tre punti paiono mettere in relazione il testuale mortui con eo all’inizio della glossa interlineare sottostante.
poiché forse già erase in origine, ovviamente non vengono attribuite ad alcun referente testuale, ma di esse si da comunque conto in apparato. Di ogni capitolo legislativo è segnalata tra parentesi quadre la collocazione all’interno della Lombarda Vulgata, contestualmente è riportato il numero che la norma di legge ha
63 Nella fattispecie: Dei (1r/v), Euangelia, Euangelii (1r/v), Rothar (1v, 2r/v), Gallos (1v), Longobardorum (1v), Octonis (1v), Karoli e Liutprandi (2v). Solo il nome Rothar registra due casi in cui è scritto con iniziale maiuscola (2r/v).
64 Evanescenti brandelli o singole lettere.
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
239
nella propria raccolta edittale. Laddove poi vi sia divergenza, tra parentesi tonde è indicato il numero della disposizione all’interno del Liber Papiensis.
Ricordo infine che eventuali varianti rispetto al testo restituito nell’edizione di Boretius non vengono rilevate nella nota critica, allorquando si tratti di forme segnalate nell’apparato dell’editore tedesco come alternative accettabili presenti nei vari testimoni. Laddove invece risultassero forme erronee o quantomeno non attestate nella tradizione manoscritta, qualora si trattasse anche solo di una semplice inversione di vocaboli, se ne renderà conto.
Conspectus Siglorum
⟨⟩ [[]] […] | ||
completamento proposto dall’editore espunzioni scribali parti illeggibili fine linea di scrittura fine carta
EL Lomb. LP Carl. Enr. Liut. Rot. fol. interl. inf. interl. sup. marg. est. marg. inf. marg. int. marg. sup. n.
ed. Edictus Langobardorum di Friedrich Bluhme65
ed. Lombarda Vulgata di Friedrich Bluhme
66
ed. Liber Papiensis di Alfred Boretius
67
Carlo Magno Enrico I Liutprando Rotari foglio interlinea inferiore interlinea superiore margine esterno margine inferiore margine interno margine superiore nota
65 Bluhme, Edictus Langobardorum 1-234. 66 Bluhme, Legis Langobardorum 623-640. 67 Boretius, Liber Legis 290-585.
CHIARA SIMBOLOTTI
240
1r] [Lomb. I, IX, 20, Liut. 21] et(a) in eo1 [[uero]]2 ordine(b) sicut supra
adnexum est(c) et3 si dominus eius | negauerit(d) quod per ipsius consilium factum non fuisset(e), pu|rificet se ad legem Dei(f)4
et componat ipsum mortuum sicut | antea fuit consuetudo(g) et ipsum insuper seruum tradat(h) | in manibus parentum defuncti(i). |
a) Marg. sup. ed est.5
Siquis habens inimicum seruo suo dixerit ille taliter est michi inimicus, uide ne eum assalias set si te assalierit et te defendendo eum occidere poteris, non euadat et si ita contigerit dicebant antiqui q[...]
: Si seruus duorum vel plurimum [...] liberum hominem occiderit quamquam [...] singuli tamen domini res suas debent amittere [...].Si uero absque iussu dominorum liberum hominem occiderit singuli seru[...] [...]dentes pro portione serui uuidrigild componant [...] seruis p[...] occid[...] iussu unius domini [...] iubentibus, ille qui iussit res suas omnes amittat ceteris dominis dantibus guidrigild pr[...] pro [...] iubentis.
6 omnes res suas deberet amittere, ideo scilicet, quia ⟨seruus⟩7 consilio domini [...]8 ⟨per⟩petrauerat9
Nel marg. int.: supra titulum c. “Si seruus aut ancilla” [=Lomb. I, IX, 7] capitulum;
. Set exorbitabant quia haec lex non in alio casu omnes suas substantias perdere praecepit nisi quando seruus super alium ambulando homicidium fec[...] euidens inconueniens sequeretur.
b) interl. sup.: idest casu, scilicet cum fuit homicidium super alium ambulando;
1 et] manca in LP. 2 uero] espunto dallo scriba. 3 In interlinea si legge c̃p̃, un’abbreviatura non chiaramente collocabile, né
interpretabile. Essa è scritta infatti con un modulo piuttosto simile a quello del testo principale di cui però non fa sicuramente parte.
4 Dei] cfr. Patetta, Le Ordalie, n. 2, 294, che intende ad legem Dei come giuramento sui Vangeli.
5 Si tratta di una nota di difficilissima lettura a causa del danno subito dal supporto scrittorio, diverse sono le parti illeggibili e particolarmente problematiche risultano le prime due linee sul margine superiore.
6 Il foro nel margine esterno della membrana, di cui si è detto in precedenza, interrompe parzialmente il testo della glossa.
7 seruus] completato sulla base dell’edizione di A. Boretius (cfr. LP, cap. 21, 417); il testo in questo punto reca infatti un segno ormai poco identificabile.
8 Prima della lacuna del supporto un vocabolo risulta illeggibile. 9 perpetrauerat] il completamento è fatto sulla base dell’edizione di A.
Boretius che riporta: homicidium perpetraverat (cfr. LP, cap. 21, 417). Nel testo è leggibile -petrauerat, manca invece la parte iniziale del vocabolo a causa di una lacuna della pergamena.
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
241
c) interl. sup. e inf.: idest per supradictam legem “Siquis liber” set non amittat uel etiam sicut dicit “Siquis liber” [=Lomb. I, IX, 19] quod melius est;
d) marg. int.: infra “Qualiter quis se defendere”. “Si pro quacumque causa” [=Lomb. II, LV, 9];
e) interl. inf.: scilicet de consilio; f) interl. sup.: idest per sacramentum Euangelii lex uocantur [...]10
g) interl. sup.: idest guidrigild [...];
11
h) marg. int.: infra “De culpis seruorum” [=Lomb. I, XXXVI];
12
i) sul rigo e marg. est.: hoc detrahit uel addit legi, “Si seruus talem” infra “de culpis seruorum” [=Lomb. I, XXXVI, 5].
;
[Lomb. I, IX, 21, Liut. 62 (LP 61)] Recolimus qualiter iam statuimus
ut qui hominem liberum oc|cidere praesumpserit(a), ut res suas in integrum perdat et qui se de|fendendo hominem occiderit, componat secundum qualitatem per|sonȩ. Nunc autem statuere praeuidimus, quo modo sit ipsa quantitas(b)13 | consideranda. Consuetudo enim est ut pro minima persona quae(c) | [[quae]]14 exercitalis homo esse15 inuenitur cl solidos componatur et qui primus est(d), | ccc solidos. De gasindiis uero nostris uolumus ut quicumque | ex minimis(e) in tali ordine(f) occisus fuerit, pro eo | quod nobis deseruire(g) uidetur, cc solidos fiat compositus. Ma|iores(h) uero secundum quales personȩ fuerint, ut(i) in nostra conside|ratione uel successorum nostrorum debeat permanere, quomodo16 usque | ad ccc solidos compositio ipsa debeat17
ascendere. |
a) Interl. sup.: super alium ambulando et nulla iusta causa praecedente;
10 Di seguito e poi nell’interlinea sottostante, fino alla glossa successiva, si
percepiscono dei vocaboli praticamente illeggibili, forse erasi di proposito. Si intravvede apparentemente: quando [...] habuit m[...]s[...]pli est.
11 Come segnalato per la glossa precedente, anche qui seguono alcuni vocaboli non identificabili che si direbbero erasi volontariamente. Si distinguono appena: est [...] infra “Siquis [...]”.
12 Questa glossa è assai poco leggibile. 13 quantitas] LP qualitas. 14 quae] espunto dallo scriba perché reduplicato all’inizio del rigo successivo. 15 esse] aggiunto in interlinea, realizzato con segno convenzionale sopra in- di
inuenitur. 16 quomodo] -modo abbreviato e aggiunto in interlinea con segno di omissione
dal revisore. 17 debeat] -b- aggiunta in interlinea con segno di omissione dal revisore.
Tuttavia la lettera inserita sembra recare un’abbreviazione qui non appropriata.
CHIARA SIMBOLOTTI
242
b) interl. sup., inf. e marg. est.: persone qualitas quae hac in lege18
c) marg. est.: libera;
discernitur, non solum in homicidio a se defendente set etiam a nolente commisso tam in femina quam in masculo perspici debet;
d) interl. sup. e marg. est.: idest maior inter exercitales. e) interl. sup.: scilicet gasindiis. f) interl. sup., inf. e marg. est.: idest quod obtineat fieri compositio
secundum qualitatem persone uel aliter in tali ordine idest defendendo uel nolendo;
g) marg. int.: idest ualde seruire; h) interl. sup. e marg. est.: gasindii; i) interl. sup.: scilicet uolumus. [Lomb. I, IX, 22, Liut. 92 (LP 91)] Siquis liber homo in terra aliena
residens19 libellario | nomine, homicidium fecerit et fuga lapsus fuerit, tunc ille | in cuius terra ipse homicida laborauit aut20 inhabita|uit21 habeat spatium22 in mense uno ad23 ipsum hominem perqui|rendum24 et si eum inuenerit, habeat licentiam ipsum hominem, | quamuis liber sit, comprehendendi et tradendi in manu25 | illius cui homicidium fecit et si hoc non fecerit, dare debet | medietatem de omnibus rebus mobilibus, excepto26 tecto27, quas28 | in ipsa casa habuerit ipse homicida29. Quod si nec | hoc facere uoluerit30
18 hac in lege] LP in hac lege.
, ipse cuius terra est, dare debeat libel|lario nomine ipsam terram ei cui homicidium factum est, ut | reddat ei sicut
19 residens] corretto da resideret; -ret è espunto e sopra la seconda -e- è apposto il segno abbreviativo per la presenza di una nasale, -s finale è aggiunta in apice. Si tratta di un ripensamento del copista stesso.
20 ac] posto in interlinea dal revisore a sostituzione di un originario et. 21 laborauit aut inhabitauit] LP habitavit. 22 spatium] corretto da spatio; il revisore ha espunto -o e vi ha posto sopra -u
con segno abbreviativo per indicare la presenza della nasale. 23 ad] aggiunto in interlinea con segno di omissione dal revisore. 24 perquirendum] corretto da perquirendo; il revisore ha espunto -o e vi ha
posto sopra -u con segno abbreviativo per la presenza della nasale. Pure il segno di interpunzione susseguente è stato emendato.
25 comprehendendi et tradendi in manu] LP comprehendendum et tradendum in manus.
26 excepto] -ce- aggiunto in interlinea con segno di omissione dal revisore. 27 tecto] LP tectora e in nota la sola variante tecta. 28 quas] -a- aggiunto in interlinea sopra q- dalla mano del revisore. LP quae.
Evidentemente il relativo è concordato col solo femminile rebus, a meno di non pensare ad un errore grammaticale.
29 habuerit ipse homicida] LP ipse homicida habuit. 30 facere uoluerit] LP voluerit facere.
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
243
exinde31 reddebat32 qui ipsum homici|dium fecit. Tamen33 de his tribus capitulis in illius sit po|testate eligendi cuius terra est et faciat exinde qualiter uoluerit34
. |
[Lomb. I, IX, 23, Liut. 118 (LP 117)] Recolimus enim quod statuimus cum nostris iudicibus ||
1v] ut qui hominem liberum occidere praesumpserit(a), omnem
substantiam | suam amittat. Modo uero, dum repeterent singuli | homines quos forte aliqua duritia detinebat, quod(b) | parens eorum qui in lectulo mortuus1 fuerat2 per ue|nenum occisus esset, et dum per pugnam ipsam causam, | sicut antiqua fuerat consuetudo, querere dispone|bant grauis causa nobis esse comparuit, ut sub uno | scuto per pugnam omnem substantiam suam homo amitteret(c). | Ideoque statuere praeuidimus ut, si ammodo talis causa e|merserit, quod3 ille qui mortem parentis sui per pug|nam probare4 uoluerit, quod eum per uenenum occidisset, ob|seruatis his quae5 in anteriore edicto affiximus(d)6, ut per | Euangelia affirmet(e) quod asto animo causam ipsam non di|cat(f) vel querat7, nisi quod8
31 sicut exinde] LP ei exinde, sicut ille.
ei certa suspitio sit, postea potestatem habeat | querere per pugnam, sicut antiqua fuit consuetudo(g), | et si ei ferita
32 reddebat] sulla -a- cancellato segno abbreviativo della nasale per mano del copista.
33 Tamen] aggiunto abbreviato in interlinea dal revisore al di sopra di un uel inde espunto.
34 uoluerit] scritto in codino alla fine del rigo successivo. 1 mortuus] corretto da mortuis con -u- posto sopra -i- espunto. 2 qui in lectulo mortuus fuerat] LP qui in lectulo suo mortuus fuerat. 3 quod ille qui] LP ut ille qui; in alternativa nella tradizione manoscritta è
attestato quod ille quis. Nel manoscritto si evidenzia un emendamento; dopo la q- si rileva infatti una correzione su rasura che pare aver mutato in quod ille un originario qui illi.
4 probare uoluerit] LP querere voluerit. 5 obseruatis his quae] LP obseruato eo quod oppure obseruatis eis quae. La
variante del frammento è invece attestata nella tradizione manoscritta edittale (cfr. EL, cap. 118, nn. x, y, 156).
6 affiximus] la prima -f- aggiunta in interlinea dal copista sopra la a-. 7 non dicat uel querat] LP non querat. Nel manoscritto uel querat è aggiunto
in interlinea sopra dicat. 8 quod] aggiunto dal copista in interlinea con segno di omissione tra nisi e ei
certa.
CHIARA SIMBOLOTTI
244
uenerit(h) cui ipsum crimen9 mittitur, aut | ad camphionem(i) ipsius quem conductum habuerit, | non amittat omnem substantiam suam, set componat10 secundum qualita|tem personȩ, sicut antea fuit lex componendi(j); quia incerti | sumus de iudicio Dei11 et multos audiuimus per pug|nam sine iusta causa(k) suam causam perdere(l)12
, set propter consu|etudinem gentis nostrȩ Longobardorum, legem ipsam(m) | uetare non possumus. |
a) Marg. sup. e interl. inf.13
b) interl. sup. e marg. int.: scilicet dicendo;
: super eum ambulando uel nulla iusta causa praecedente;
c) marg. est.: Grauis14
d) marg. int.: infra “Qualiter quis se defendere”. “Siquis alium” [=Lomb. II, LV, 16];
causa est ut sub uno scuto homines substantiam suam amittere debeant;
e) interl. sup.: quotiens enim aliquis pugnam querit de asto iurare debet;
f) marg. est.: [...] hoc quod dicitur pugnam praecipit uidetur contra legem. Si liber homo set [...] et certum est aliquem homicidium commisisset super eum aumbulando et hic cum incertum est;
g) interl. sup.: scilicet ut duo tantum cum scutis et fustibus certarent;
h) interl. sup.: ita ut cadat15
i) interl. sup. e inf.: cum talis persona sit cui per camphionem pugnare licet ut puer uel ille qui est in decrepita etate ut in lege ulti “De parricidiis” [Lomb. I, X, 5], alioquin obuiaretur huic a lege Octonis “Laicorum uero nullum” infra “De aduocatis uicedominis [=Lomb. II,
;
9 ipsum crimen] LP crimen ipsum. 10 set componat] LP sed componat eum. 11 Dei] aggiunto dal revisore in interlinea con segno di omissione. 12 sine iusta causa suam causam perdere] LP sine iustitia causam suam
perdere. La variante del frammento è invece presente nella tradizione manoscritta edittale (cfr. EL, cap. 118, nn. l, m, 156).
13 Si tratta di una glossa praticamente illeggibile; penso tuttavia di poterne ricostruire il contenuto in base a ciò che si intravede all’inizio (super) e alla fine (-cedente) e confrontandolo con altri luoghi del testo, in particolare la glossa (a) del capitolo LOMB. I, IX, 21, Liut. 62 (LP 61).
14 Nel margine esterno, avanti la G- di Gravis si rileva la presenza di alcuni segni non più decifrabili.
15 ita ut cadat] di fatto è una glossa – cfr. anche Patetta, Le Ordalie, n. 3, 438 – pure all’aspetto sembrerebbe più un’aggiunta interlineare al testo principale. Il modulo delle lettere è infatti sensibilmente più grande rispetto a quello solitamente utilizzato per le notazioni marginali e interlineari.
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
245
XLVII, 11] et a lege “Quicumque” infra “Qualiter quis se defendere” [=Lomb. II, LV, 30];
j) marg. est.: scilicet Rothar quae est. “Siquis alii uenenum” [=Lomb. I, IX, 6]. Supra idest asto;
k) interl. sup. e inf.: ut in lege “De furtis”. “Siquis alium” [=Lomb. I, XXV, 59], uel dicit hoc propter Gallos cisalpine terrȩ, qui iniuste per pugnam Longobardorum causam, idest patriam16 suam amisere17
l) marg. est.: Multos audiuimus propter pugnam causam suam perdere. [...] te l[...] “Si liber homo se defendendo” [=Lomb. I, IX, 19] contradicit, qui enim ueneno alium occidit [...] iubendo occidit huic et illi derogatur per legem quicumque ueneficio [=Lomb. I, IX, 40];
;
m) marg. int.: idest consuetudinem uel pugnam. [Lomb. I, IX, 24, Liut. 136 (LP 135)] Item annuntiatum est nobis,
quod quidam18 habebat put|heum in curte sua et secundum consuetudinem furcam | et tollenum ad auriendam19 aquam. Ueniens autem alter20 homo, | stetit sub ipso tolleno, et cum21 uenisset quidam ad | auriendam aquam de ipso putheo et incaute | ipsum tollenum dimississet, uenit super eum qui sub | ipso stabat et mortuus est sub ipso22. Dum autem re|quisitio de morte eius fieret23, quis eum deberet compo|nere et relatum nobis24
fuisset, ita nobis et nostris iu ||
16 patriam] -i- aggiunta dal copista sopra la -a-. 17 amisere] sopra la a- sembra esserci un segno abbreviativo inutile. Inoltre a
proposito di questa intera glossa cfr. Patetta, ‘Nuove ipotesi’ n. 2, 938-939. Nel suo contributo circa nuove proposte di identificazione del luogo d’origine della Lex Lombarda, lo studioso nota come, in base alla suddivisione territoriale del tempo, questo riferimento alle “cisalpinae terrae” possa indicare tanto la Lombardia quanto il Piemonte.
18 quidam] LP quidam homo. 19 ad auriendam aquam] LP ad auriendum aquam. La variante del
frammento è invece presente nella tradizione manoscritta edittale (cfr. EL, cap. 136, n. k, 166).
20 alter] aggiunto in interlinea con segno di omissione. 21 et cum] LP cum autem. La variante del frammento è invece attestata nella
tradizione manoscritta edittale (cfr. EL, cap. 136, n. n, 166). 22 sub ipso] manca in EL e LP ove non è segnalato neppure come variante
testuale presente nei testimoni. 23 de morte eius fieret] LP eiusdem mortui facta fuerit. 24 relatum nobis] LP nobis relatum.
CHIARA SIMBOLOTTI
246
2r] [Lomb. I, X, 5, (LP Enr. 2)] penitentie subdatur1. Quod si ille cui
crimen arguitur2 | negare uoluerit, per se pugnam faciat, nec lice|at3
camphionem pro se dare, nisi decrepita etas, | aut iuvenilis, aut infirmitas pugnare prohibuerit. |
[Lomb. I, XI, 1, Rot. 129] R. DE HOMICIDIO SERUORUM UEL ALDIORUM4
Rex Rothar(a). Siquis aldium alienum occi|derit(b), componat solidos lx.
a) Marg. int.: infra “Qualiter quis se” capitulum uadie legis5
b) interl. sup., inf.: [...] et sic in sequentibus.
[=Lomb. II, LV, 5];
Marg. est.: Supra capitula homicidio liberorum nomine [=Lomb. I, IX]. Ist[...] non le[...] de homicidio [...] de homicidio seruorum uel aldiorum [=Lomb. I, XI]6
.
[Lomb. I, XI, 2, Rot. 130] Siquis seruum ministerialem pro|batum ut supra(a) aut doctum occiderit domi(b), componat solidos | l.
a) Interl. sup.: idest in prima lege “De plagis seruorum” [=Lomb. I,
VIII, 3]; b) interl. sup. e marg. est.: scilicet palam alioquin infirmata lege
supra posita “Siquis homicidium absconse perpetrauit” [=Lomb. I, IX, 3]. [Lomb. I, XI, 2, Rot. 131] De alio uero seruo7 ministeriali qui
secundus eius inuenitur(a) | esse8, tamen nomen ministeriale9 habet, siquis occiderit, componat solidos xxv10
1 subdatur] LP subdetur.
. |
2 Quod si ille cui crimen arguitur] LP Quod si ille qui crimine arguitur. 3 liceat] LP liceat ei. 4 Rubrica sita nel margine esterno all’altezza della quarta linea di scrittura. 5 Sopra questa glossa, nel margine interno all’altezza della seconda linea di
scrittura, è appena percettibile un’altra annotazione di cui si individuano con una certa sicurezza solo le parole abbreviate: idest est contra lege [...] et [...]; per il resto si intuisce la presenza di poche altre lettere. Poiché si trova in un punto della membrana apparentemente non compromesso, potrebbe forse essere stata eliminata di proposito.
6 Vale quanto detto alla nota precedente, salvo che in questo caso si riesce ad intravedere qualcosa in più. La parte interlineare è praticamente illeggibile, più nitida la prima riga marginale, mentre una seconda linea risulta appena percettibile. Si nota comunque la giustapposizione di più glosse brevi, poste una di seguito all’altra.
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
247
a) Interl. sup.: idest qui non ita eruditus est. [Lomb. I, XI, 3, Rot. 132] Siquis seruum alienum massarium |
occiderit, componat xx solidos11
. |
[Lomb. I, XI, 4, Rot. 133] Siquis(a) seruum alienum bobulcum de sala(b) | occiderit, componat solidos xx12
. |
a) Interl. sup.: uerna [...]13
b) interl. sup.: idest de domo donicata uel casa. ;
[Lomb. I, XI, 5, Rot. 134] Siquis(a) servum alienum rusticanum qui
sub | massario14
est occiderit, componat solidos xvi(b). |
a) Interl. sup.: Mirabile cum tantum pro morte componat quantum si ei ante stetisset;
b) marg. int.: capitula. [Lomb. I, XI, 6, Rot. 135] Siquis porcarium(a) alienum occiderit,
magistrum tamen il|lum, qui sub se discipulos habet duos aut iii aut | amplius, componat solidos l. De inferioribus autem porcariis, | siquis occiderit, componat solidos xxv. |
a) Interl. sup.: seruum. [Lomb. I, XI, 7, Rot. 136] Siquis pecorarium15, aut caprarium, seu
armentarium occiderit, | magistrum tamen16
7 seruo] manca in LP ma è attestato nella tradizione manoscritta dell’Editto
(cfr. EL, cap. 131, n. b, 30). Inoltre -u- appare ricavata modificando un’originaria a.
, componat solidos xx. Pro
8 secundus eius inuenitur esse] LP secundus ei invenitur. 9 ministeriale] LP ministerialis. 10 componat solidos xxv] scritto in codino alla fine del rigo successivo. 11 xx solidos] LP solidos xx. 12 componat solidos xx] scritto in codino alla fine del rigo successivo. 13 Il resto della breve glossa è illeggibile per via di una scoloritura che, in
piccola parte e senza gravi conseguenze, ha interessato anche il testo principale. 14 massario] la prima -s- aggiunta in interlinea. 15 pecorarium] corretto da porcarium con -e- aggiunto sopra -o- espunto,
nonché trasformazione di -rc- in -co- e aggiunta di segno abbreviativo per -r- al di sopra di -oa-.
16 Siquis pecorarium aut caprarium seu armentarium magistrum tamen occiderit] LP De pecorario, caprario seu armentario occiso magistro tamen siquis
CHIARA SIMBOLOTTI
248
discipulis autem, | qui sequentes sunt, siquis occiderit, componat solidos xvi. De | illis uero pastoribus dicimus, qui ad liberos homines seruiunt | et de sala propria exeunt. |
[Lomb. I, XI, 8, Rot. 137] Siquis infantem paruulum de seruo
massario(a) casu | faciente nolendo17 occiderit(b), arbitretur a iudice(c) et18 | secundum qualem habuit etatem, aut quale lucrum facere poterat, ita componatur(d)19
. |
a) Interl. sup. e inf.: similiter de infantibus [...]ecorum seruorum pena arbitrata est imponenda;
b) marg. int.: capitula haec uero nolendo cum supra uolendo; c) interl. sup. e inf. e marg est.: non exprimit çertam compositionem
ut supra quoniam uoluit distinguere uolendo uel nolendo delinquentes. Illos grauiori pena et ultra damnum extensa affligendo hos uero in sola damni ratione multando, quidem hodie recte considerantibus contra uidebitur punitis leuius grauius delinquentibus et hoc uilitate monente contra mentem certe legislatorum accidit. Cum enim nolendo peccantes da[...]one afflixerunt multomagis uolendo affligunt ea propter iustum est electione penȩ suprascriptȩ damn[...]es quae malit accipere domino tribui;
d) marg. est.: Nota. Quocumque modo datum damnum componi debere;
[Lomb. I, XI, 9, Rot. 376 (LP 377)] Nullus praesumat al|diam
alienam, aut ancillam quasi strigam, quae dicitur ma|sca occidere(a), quia christianis20 mentibus nullatenus est | credendum21
occiderit. Tuttavia LP segnala la presenza in alcuni testimoni della variante qui attestata, con la differenza dell’occorrere di porcarium al posto di pecorarium (cfr. LP, cap. 136, n. a, 311).
, nec possibile est, ut mulier hominem | uiuum intrinsecus possit commedere. Siquis deinceps | talem illicitam et nefandam rem perpetrare praesump|serit, si aldiam occiderit, componat pro statu eius solidos lx(b) ||
17 nolendo] manca in LP e non è segnalato neppure nella tradizione manoscritta edittale (cfr. EL, cap. 137, 31).
18 et] manca in LP. 19 -cere poterat, ita componatur] scritto in codino alla fine del rigo successivo. 20 christianis] la mano del correttore emendò christianis in humanis ponendo
in interlinea superiore huma in corrispondenza di christia-. La variante humanis non si riscontra né nella tradizione manoscritta di LP, né in quella dell’Editto di Rotari (cfr. EL, cap. 376, 87). Si nota inoltre che il correttore dovette agire prima dell’apposizione delle glosse, dal momento che le note interlineari dovettero qui adattarsi alla presenza di questa rettifica.
21 est credendum] LP credendum est.
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
249
a) marg. est.: Ista contradicit legem ii de iniuriis mulierum [=Lomb.
I, XVI, 2] uidetur enim precipere [...]. Set sane intellegentibus tantum de fornicatione perfici po[...].
b) marg. int.: Infra depositi capitulum22
[=Lomb. II, XXVI, 1];
2v] lx1, et insuper addat pro culpa solidos c(a), medieta|tem regi et
medietatem cuius aldia fuerit. Si autem ancilla | fuerit, componat pro statu eius sicut supra constitutum est. Siue2 mi|nisterialis(b) aut rusticana fuerit3, et insuper pro culpa | solidos lx, medietatem regi et medietatem cuius ancilla fuit4; si | uero iudex hoc malum5
perpetrare iusserit, ipse de suo | proprio penam suprascriptam componat(c). |
a) Marg. sup. e interl.: Non obuiat huic lex Liutprandi [=Liut. 131, LP 130] ex una causa alicui duas calumnias imponi prohibens quia illa loquitur quando ex uno facto idest maleficio plures nascuntur actiones. Set de hac culpa idest maleficio licet lx pro seruis et insuper c pro culpa componi praecipiat non idem dicere ex hoc maleficio concurrunt actiones set c solidos furis prioris pene exaggeratio uel illa est specialis in deposito;
b) marg. est.: [...] et superiores leges de occisione seruorum loquentes [...] pro ancilla ministeriali solidos xxv et ancilla ministeriali et probata l et pro rusticana solidos xx;
c) marg. int.: Nota. Qui iussu iudicis delinquit non teneri.
22 Attribuisco così tale glossa, pur non trovando tra questa allegazione e il
capitolo di legge in questione un nesso immediato che permetta di connetterla in modo più preciso. Si rileva però un legame tra questa glossa e quanto viene detto nell’annotazione marginale e interlineare apposta alle prime righe di 2v. Noto infine che al di sopra di questa glossa sono appena visibili le tracce di una precedente nota non più leggibile.
1 lx] reduplicato; è infatti già presente alla fine di 2r. 2 siue] LP si. Così in un primo tempo anche lo scriba del frammento, poi a si-
aggiunse -ue in interlinea con segno di omissione. 3 Dopo fuerit, sopra il ; si nota un segno di incerta interpretazione.
Analogamente avviene all’inizio dell’ultima linea di scrittura a 1v, sempre collocato sopra un segno di punteggitura.
4 fuit] LP fuerit. Nel testo fuit corretto da fuat sovrascrivendo una -i- alla -a-. 5 hoc malum] LP hoc opus malum. La variante del frammento è invece
attestata nella tradizione manoscritta dell’Editto (cfr. EL, cap. 376, testo e nn. v, w, 87).
CHIARA SIMBOLOTTI
250
[Lomb. I, XII, 1, Rot. 16] R. DE SEPULCHRO UIOLATO ET DE EO QUI HOMINEM MORTUUM EXPOLIAUERIT6. Rex Rothar. Siquis(a) hominem(b) | mortuum in flumine(c) aut foris(d) inuenerit et eum7 expo|liauerit(e) et celauerit componat parentibus mortui(f) solidos lxxx, | etsi eum inuenerit et exspoliauerit et mox uicinis pa|tefecerit et cognoscetur8
quia pro mercedis causa fecerit, | nam non furandi animo, reddat spolia quae super eum inuenit | et amplius ei calumpnia non generetur(g). |
a) Interl. sup.: liber uel seruus; b) interl. sup.: liberum uel seruum; c) interl. sup.: infra, dicta ratione; d) interl. sup.: scilicet in ripa fluminis; e) interl. a seguire eum e marg. int.: scilicet anima lucrandi
intercipiendi. Inoltre marg. int.: Supra “De homicidiis liberorum hominum”.
“Siquis hominem” [=Lomb. I, IX, 17]. Nel marg. est.: [...] h[...] qu[.]m hanc publicam occasionem exponit
illa crimina [...] publica9
[...] Infra “De eo qui p[...] in dampno inuenerit. “Siquis porcos” [=Lomb. I, XXIII, 7] capitulum. Set non obuiat, quia illa loquitur de rebus alterius heredis esse nullius. Res enim mortui in nullius bonis intelliguntur uel lex illa imponit penam nomine rerum malo ordine ablatarum haec uero nomine corporis expoliati;
.
f) interl. inf.: eo scilicet quod spoliauit eo uero quod malo ordine contractauit si petitum fuit sibi nonum reddat;
g) marg. est.: Infra “De his qui in ecclesiis confugium fecerint” capitulum “Siquis in” [=Lomb. II, XXXIX, 5]. Set illa de alio damno in emunitate commisso loquitur, quia lex illa quae est inuenta eorum fauore quibus damnum datur in emunitate, in hoc casu loqueretur tam quam fauore quorum [...] introductum ad eorum lesionem conuerteretur.
[Lomb. I, XII, 1, Rot. 15] Siquis(a) sepulturam hominis(b) mortui
ruperit(c) et corpus ex|poliauerit(d) aut foras(e)10
6 Rubrica sita su rigo e margine interno all’altezza delle linee settima e
ottava.
iactauerit, dcccc solidos
7 eum] manca in LP. 8 cognoscetur] LP cognoscitur. 9 Questa glossa si legge con difficoltà essendo molto scolorita. 10 foras] LP foris. La variante del frammento è invece attestata nella
tradizione manoscritta dell’Editto (cfr. EL, cap. 15, n. g, 15).
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
251
sit cul|pabilis(f) parentibus defuncti, et si parentes proximi non11 | fuerint, tunc castaldius regis aut sculdasius12
requi|rat culpam ipsam et ad curtem regis exigat. |
a) Interl. sup.: liber vel seruus; b) interl. sup.: liberi; c) marg. sup.13
Id est [...] sepulturam uiolauit aut tantum corpus expoliauit quod componi debeat haec lex non diffinit. Set si in emunitate [...]mque fecerit hanc compositionem faciat et dc solidos [...] emunitati componat. Si uero tantum ruperit et non expolia[...] [...]so, dc solidos in emunitate componat.
: liber [...] vel seruus neminis ob id quod inf[...] [...]p[...] defuncti lex iusta g[...] [...] x[...] specialiter fin[...] de sepultura liberi [...] de s[...] [...] facit.
d) marg. int. a seguire ex-: infra “De culpis seruorum”. “Si seruus talem” [=Lomb. I, XXXVI, 5] capitulum;
e) interl. sup.: scilicet extra sepulturam; f) interl. sup.: scilicet liber, de seruo uero itur per legem igitur. E a seguire sempre in interl. sup.: per hoc dici non potest de liberis
tantum loqui, generaliter enim incipit et specialiter finit. [Lomb. I, XIII, 1, Rot. 17] R. NE AD REGEM UENIENTIBUS INIURIA
FIAT14. Rex Rothar(a). Siquis ex baronibus(b) nostris ad | nos uenire uoluerit, securus ueniat et illesus | ad suos reuertatur, et nullus de aduersariis illius | aliquam15 iniuriam in itinere aut molestiam facere praesumat; | tantum est, ut ille qui ad regem uenire festinat ho|neste ueniat(c), et nullam lesionem aut dampnum | cuique16 in ipso itinere ad regem ueniendo aut rede|undo faciat. Nam si fecerit, sicut subter in hoc edicto | scriptum est(d), componat17
11 Nel margine esterno, all’altezza di questa diciassettesima linea di scrittura,
davanti a -pabilis compare il segno convenzionale per idest, senza altri riferimenti.
. |
12 sculdasius] LP sculdais. Il vocabolo non è latinizzato neppure nella tradizione manoscritta dell’Editto (cfr. EL, cap. 15, testo e n. t, 15).
13 Questa glossa marginale, analogamente a quella presente a 1r, è estremamente difficile da decifrare a causa dei danni subiti dalla membrana. Le perdite insanabili consistono ciascuna di più vocaboli.
14 Rubrica sita sul margine interno all’altezza delle linee diciannovesima e ventesima.
15 aliquam] LP aliquam ei. 16 cuique] così nel testo; rettamente invece LP cuicumque. 17 scriptum est, componat] LP constitutum est, componat. La variante del
frammento non è attestata nemmeno nella tradizione manoscritta dell’Editto (cfr. EL, cap. 17, testo e n. b, 16). Nel testo scriptum est, componat è in codino alla fine
CHIARA SIMBOLOTTI
252
a) Marg. est.: [...] explicito tractatu illo quo prohibetur iniuria fieri
mortuis, ponit illum ne iniuria fiat uiuis et primum ne uenientibus ad regem fiat;
b) interl. sup.: fidelibus; c) marg. int.: infra “De iterantibus” [=Lomb. III, IV, 3]; d) interl. sup.: Respexit ad compositiones plagarum et feritarum
quas post hanc legem “De plagis et feritis” [=Lomb. I, VII] fieri iussit. [Lomb. I, XII, 1, Rot. 18] Siquis ex aduersariis manu arma|ta18
super quemcumque hominem ad regem uenientem(a) iniecerit19, | pro(b) sua iniuria propter20
qualemcumque culpam uindican|dam, dcccc solidos sit culpabilis, medietatem regi et | medietatem cui iniuria illata fuerit. ||
a) Interl. sup., inf. e marg. int. e inf.: Capitula. Set hic ibat ad regem pro sua utilitate cum ille de quo sequens lex loquitur, iret pro missatico a rege sibi iniuncto. Idem est de redeunte secundum quosdam ad ea enim quae sepius contingunt iura aptantur set melius est ut uadat in praesentia regis per capitulum Karoli “De his qui legem obseruare contempserint ut per fideiussores in praesentia regis deducantur” [=LP Carl. 91], quemadmodum legis contemptor; qui sit legis contemptor uidere possumus per legem quae est: “Siquis ex baronibus” in hoc quod dicit “illesus reuertatur” [=Rot. 17];
b) marg. est.: [...] eis non fit iniuria set dominus per eos fieri uidetur.
Sommario: Il presente contributo pubblica per la prima volta il bifoglio noto come F. IV. 1 fr. 11 della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Il frammento membranaceo di provenienza bobbiese, databile tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo, tramanda, per intero o in parte, venti capitoli legislativi tratti dalla Lex Lombarda, secondo la redazione nota come Vulgata. Le disposizioni ivi tràdite, originariamente appartenenti alle raccolte edittali di Rotari e Liutprando e in un caso pure ai capitolari di Enrico I, sono in parte corredate da un apparato di glosse e allegazioni marginali e interlineari che
del rigo successivo; scriptum è emendato per mano del revisore in parte su rasura e in parte modificando forse un originario certum; -ip- sono aggiunti in interlinea con segno di omissione.
18 manu armata] LP manum armatam. 19 iniecerit] la seconda -i- appare un emendamento per mano del revisore. 20 propter] LP aut. La variante del frammento non è attestata neppure nei
testimoni dell’Editto (cfr. EL, cap. 18, n. e, 16). Inoltre propter scritto in foma abbreviata presenta un parziale intervento di mano del revisore ed è preceduto da una rasura.
TRADIZIONE GIURIDICA LONGOBARDA. UN INEDITO FRAMMENTO DELLA LOMBARDA CON GLOSSE
253
conferisce particolare interesse a questo pur brevissimo e tardo testimone della materia giuridica longobardo-franca. Oltre alla descrizione paleografica del frammento, si offre qui la trascrizione completa e l’edizione critica dei capitoli normativi e delle glosse corrispondenti.
Summary: This paper publishes for the first time the bifolium F. IV. 1 fr. 11 (Biblioteca Nazionale Universitaria, Turin). The membranaceous fragment, coming from the important cenobium of Bobbio, can be reasonably dated between the end of the XI and the beginnig of the XII century. It preserves, entirely or just in part, twenty chapters from the Lex Lombarda, according to the Vulgata redaction. Some of these legal dispositions taken from the edictal compilations of king Rothari and king Liutprand and in one occasion from the laws of king Henry I of Germany are accompanied by a set of marginal and interlinear glosses which give a particular interest to this testimony of the juridical matter of Lombards and Franks. These pages offer a complete transcription and a critical edition of the law chapters and their glosses apparatus, besides a paleographical description of the fragment.
Parole chiave: frammento pergamenaceo; testimone inedito; Editto di Rotari
e Liutprando; Lex Lombarda Vulgata; glosse interlineari e marginali; longobardismi
Key words: membranaceous fragment; unpublished text; Edict of Rothari and Liutprand; Lex Lombarda Vulgata; interlinear and marginal glosses; Lombard words